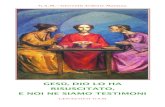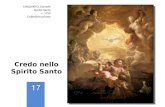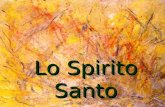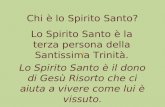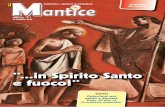"Noi e lo Spirito Santo" in At 5,29-32
-
Upload
theophylaktos -
Category
Documents
-
view
5 -
download
0
description
Transcript of "Noi e lo Spirito Santo" in At 5,29-32

Gregi Christi ministrantesStudi di letteratura cristiana antica
in onore di Pietro Meloni
a cura di
Antonio Piras e Gian Franco Saba
university press

© 2013PFTS University PressPontificia Facoltà Teologica della SardegnaVia Sanjust, 1309129 Cagliari
isbn 978-88-98146-11-6
In copertina: Pastor bonus, IV sec., Arles, Musée de l’Arles et de la Provence antiques(rielaborazione)

6
Indice generale
9 Presentazione Gian Franco Saba
12 Autori dei contributi
14 Bibliografia di Pietro Meloni
23 Il pastore, ministro della Parola e della carità. L’esempio del vescovo Ambrogio Enrico dal Covolo
39 A proposito dei temonarii nella costituzione 6,4,21 del Codice Teodosiano Fanny Del Chicca
81 Le Enarrationes in psalmos 110-118 di Agostino: questioni di critica testuale Franco Gori
101 Nota sulla dimensione agostiniana di un vescovo del tardoantico Vittorino Grossi
113 La controversia tra Cipriano e Stefano sul battesimo degli eretici. Qualche riflessione Daniele Madau
137 Aeterne rerum conditor. Musica e poesia in 150 anni di edizioni e studi (con excursus storiografico sugli inni santambrosiani) Giampaolo Mele
163 Gregorio di Nazianzo e la rondine che non fa primavera Cecilia Melis

7
187 Augustinus non breviatus. Riflessioni su alcuni aspetti di originalità in Fulgenzio di Ruspe Claudio Micaelli
207 Circolazione della cultura e scritti episcopali nel De viris illustribus di Eusebio Girolamo: Antonii monachi vita Giovanna Maria Pintus
221 «Noi e lo Spirito Santo» in At 5,29-32 Antonio Piras
233 San Giorgio vescovo di Suelli nella più antica tradizione agiografica Anna Maria Piredda

Gregi Christi ministrantes. Studi in onore di Pietro Meloni, Cagliari 2013, pp. 221-231.
«Noi e lo Spirito Santo» in At 5,29-32
Antonio PirasPontificia Facoltà Teologica della Sardegna
1. Il capitolo quinto degli Atti degli Apostoli, a partire dal v. 17, narra dell’arresto e dell’incarceramento degli apostoli su intervento delle autorità giudaiche in seguito alla loro attività evangelizzatrice e taumaturgica. Libe-rati insperatamente durante la notte da un ἄγγελος κυρίου, che avrebbe ordinato loro di recarsi al tempio a predicare, furono nuovamente arrestati e tradotti dinanzi al sinedrio. Qui in risposta alle accuse del sommo sacer-dote, che rinfacciava loro di aver trasgredito il divieto di insegnare e di far ricadere sulle stesse autorità la responsabilità della morte di Gesù, è inserito un breve discorso (5,29-32) pronunciato da Pietro anche a nome degli altri apostoli (ἀποκριθεὶς δὲ Πέτρος καὶ οἱ ἀπόστολοι):
«29Bisogna obbedire a Dio invece che agli uomini. 30Il Dio dei nostri padri ha risuscitato Gesù, che voi avete ucciso appendendolo a una croce. 31Dio lo ha innalzato alla sua destra come capo e salvatore, per dare a Israele con-versione e perdono dei peccati. 32E di questi fatti siamo testimoni noi e lo Spirito Santo, che Dio ha dato a quelli che gli obbediscono».
Se ci si attiene a questa traduzione, tratta dall’ultima versione ufficiale della cei1 e sostanzialmente conforme a tutte le traduzioni moderne, a partire
1 Conferenza Episcopale Italiana, La sacra Bibbia, Città del Vaticano 2008.

222 Antonio Piras
da quella di Lutero2, è lecito domandarsi che cosa intendesse esattamen-te Luca con l’espressione «di questi fatti siamo testimoni noi e lo Spirito Santo». Una frase del genere, se fosse stata davvero pronunciata da Pietro, sarebbe apparsa incomprensibile o perlomeno bizzarra ai membri del sine-drio, alla luce del genere delle πράξεις e anche ammettendo che l’autore del testo, ponendo quel breve intervento in bocca a Pietro, avesse in mente dei destinatari cristiani piuttosto che ebrei.
A tal riguardo non pare convincente la spiegazione di Robert W. Wall che, dando per scontato l’abbinamento apostoli-Spirito nel senso della testi-monianza, arriva a immaginare una provocazione di Pietro verso il sinedrio che non possiede il dono dello Spirito e pertanto non può capire il senso delle sue parole3. Il senso doveva invece apparire chiarissimo alle generazio-ni cristiane successive, a quella di Ireneo prima e poi a quelle postcostan-tiniane (non a caso, come vedremo, la Vulgata concorda con le moderne traduzioni), che, anche per ciò che concerne questo passo, vedevano nel binomio “noi e lo Spirito Santo” una sorta di legittimazione dall’alto della testimonianza degli apostoli. In At 5, fra l’altro, l’idea della testimonianza così abbinata non solo sarebbe precoce, ma fors’anche fuori luogo, laddove per esempio in Eb 2,3-4 appare storicamente più comprensibile.
Una più attenta analisi del testo greco ci consente peraltro di intravede-re un’altra possibilità interpretativa:
29Πειθαρχεῖν δεῖ θεῷ μᾶλλον ἢ ἀνθρώποις. 30ὁ θεὸς τῶν πατέρων ἡμῶν ἤγειρεν Ἰησοῦν ὃν ὑμεῖς διεψειρίσασθε κρεμάσαντες ἐπὶ ξύλου· 31τοῦτον ὁ θεὸς ἀρχηγὸν καὶ σωτῆρα ὕψωσεν τῇ δεξιᾷ αὐτοῦ [τοῦ] δοῦ-ναι μετάνοιαν τῷ Ἰσραὴλ καὶ ἄφεσιν ἁμαρτιῶν. 32καὶ ἡμεῖς ἐσμεν μάρ-τυρες τῶν ῥημάτων τούτων καὶ τὸ πνεῦμα (+ δὲ nonnulli codd.) τὸ ἅγιον ὃ ἔδωκεν ὁ θεὸς τοῖς πειθαρχοῦσιν αὐτῷ.
2 Cfr. Das Neue Testament unseres Herrn und Heilandes Iesu Christi nach der deutschen Übersetzung D. Martin Luthers, vierzehnte Auflage, Stuttgart 1901, p. 142: «Man muß Gott mehr gehorch-en denn den Menschen. Der Gott unserer Väter hat Jesus auferweckt, welchen ihr erwürgt habt und an das Holz gehängt. Den hat Gott durch seine rechte Hand erhöht zu einem Fürsten und Heiland, zu geben Israel Buße und Vergebung der Sünden. Und wir sind seine Zeugen über diese Worte und der Heilige Geist, welchen Gott gegeben hat denen, die ihm gehorchen».
3 R.W. Wall, Acts, in The New Interpreter’s Bible, X, Nashville 2002, p. 107: «More provocatively, however, Peter may well be suggesting that without the gift of the Holy Spirit, the Sanhedrin lacks the spiritual resources to understand the claims he has just made».

«Noi e lo Spirito Santo» in At 5,29-32 223
Così la xxvii edizione del Nestle-Aland4. Va ricordato che la tradizione del testo non presenta varianti significative, se si eccettua forse un δέ che otto codici documentano al v. 32 dopo τὸ πνεῦμα5. Non si può invece non osservare che ἡμεῖς e τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον sono troppo distanti tra loro per essere dei soggetti coordinati; se poi accogliamo il δέ dopo τὸ πνεῦμα, lo stacco tra i due termini è ancor più netto.
2. Tutto ciò fa pensare che l’espressione καὶ ἡμεῖς ἐσμεν μάρτυρες τῶν ῥημάτων τούτων sia in realtà un inciso all’interno del periodo e che per-tanto τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον non debba essere considerato un soggetto cor-relato al lontano ἡμεῖς, bensì un terzo complemento oggetto, parallelo a μετάνοιαν e ἄφεσιν, anch’esso dipendente da δοῦναι:
29Πειθαρχεῖν δεῖ θεῷ μᾶλλον ἢ ἀνθρώποις. 30ὁ θεὸς τῶν πατέρων ἡμῶν ἤγειρεν Ἰησοῦν ὃν ὑμεῖς διεψειρίσασθε κρεμάσαντες ἐπὶ ξύλου· 31τοῦτον ὁ θεὸς ἀρχηγὸν καὶ σωτῆρα ὕψωσεν τῇ δεξιᾷ αὐτοῦ δοῦναι μετάνοιαν τῷ Ἰσραὴλ καὶ ἄφεσιν ἁμαρτιῶν — 32καὶ ἡμεῖς ἐσμεν μάρ-τυρες τῶν ῥημάτων τούτων — καὶ τὸ πνεῦμα (δὲ) τὸ ἅγιον ὃ ἔδωκεν ὁ θεὸς τοῖς πειθαρχοῦσιν αὐτῷ.
«29Bisogna obbedire a Dio invece che agli uomini. 30Il Dio dei nostri padri ha risuscitato Gesù, che voi avete ucciso appendendolo a una croce. 31Dio lo ha innalzato alla sua destra come capo e salvatore, per dare a Israele con-versione e perdono dei peccati – 32e di questi fatti noi siamo testimoni – e lo Spirito Santo, che Dio ha dato a quelli che gli obbediscono».
Mentre la Vulgata geronimiana non si discosta dalle interpretazioni mo-derne, intendendo nos e spiritus sanctus come soggetti coordinati (et nos sumus testes horum uerborum et spiritus sanctus etqs.)6, diversi rami della Vetus Latina, compresa la testimonianza autorevole del codex Laudianus
4 Novum Testamentum Graece, post Eberhard et Erwin Nestle editione xxvii revisa communiter ediderunt B. et K. Aland, J. Karavidopoulos, C.M. Martini, B.M. Metzger, Stuttgart 2007.
5 Cfr. R. Swanson, New Testament Greek Manuscripts. Variant Readings Arranged in Horizontal Lines Against Codex Vaticanus. Acts, Sheffield-Pasadena (CA) 1998, pp. 81-83.
6 Per quanto sappia, tutti i commentari di Atti sono su questa linea: cfr. per es. F.F. Bruce, The Book of the Acts, revised edition, Grand Rapids (Michigan) 1988, pp. 112-113.

224 Antonio Piras
(e)7 e del codex Bezae Cantabrigiensis (d)8, sono sulla linea di quanto stia-mo intravedendo, segno evidente che già in età antica l’interpretazione del testo doveva apparire tutt’altro che univoca:
e: Hunc deus principem et saluatorem exaltauit dextra sua, dare poenitentiam Israel et remissionem peccatorum, et nos sumus eius testes uerborum horum, et spiritum autem sanctum, quem dedit deus oboedientibus sibi.
d: Hunc deus ducem et saluatorem exaltauit c<l>aritate sua, dare paeniten-tiam Israel et remissionem peccatorum in ipso, et nos ipsi testes sumus omnium uerborum horum, et spiritum sanctum, quem dedit deus hiis qui obtempe-rant ei.
Un altro testimone latino pregeronimiano, il palinsesto di Fleury (h) 9, documenta addirittura: et nos sumus eius testes uerborum horum et spiritus sancti etc.; il genitivo spiritus sancti è chiaramente ingiustificato, mancando
7 Oxford, Bodleian Library, Laudianus Gr. 35, sec. VI, codice bilingue vergato con tutta pro-babilità in Sardegna; sulla questione dibattuta dello scriptorium del manoscritto si veda ora M. Orrù, rec. a: “A. Lai, Il codice Laudiano greco 35. L’identità missionaria di un libro nell’Europa altomedievale, Cargeghe/SS 2011”, in «Byzantinische Zeitschrift» 105 (2012), pp. 860-862. Il testo del Laudianus è stato citato secondo l’edizione di O.K. Walther, Codex Laudianus G 35. A Re-Examination of the Manuscript: A Reproduction of the Text and an Accompanying Commentary, Diss. University of St. Andrews, 1980, II, ff. 40r-v. Cfr. P. Sabatier, Bibliorum sacrorum Latinae versiones antiquae seu Vetus Italica, III, Parisiis 1751, pp. 517-518. La variante nos sumus eius testes uerborum horum corrisponde al testo greco parallelo: καὶ ἡμεῖς ἐσμεν αὐτοῦ κτλ.
8 Cambridge, University Library, Nn. II 41, sec. V; cfr. F.H. Scrivener, Bezae Codex Canta-brigiensis, Cambridge 1864, p. 345. Le varianti del testo latino sono presenti anche nel testo greco di questo codice bilingue: claritate corrisponde a τῇ δόξῃ; in ipso a ἐν αὐτῷ; omnium a πάντων. Di tali varianti la prima e l’ultima sembrano proprie di questo codice, mantre la seconda è comune anche ad altri manoscritti: cfr. Swanson, New Testament Greek Manuscripts cit. p. 82; un testo affine si riscontra anche in Iren. lat. adv. haer. 3,12,5 hunc deus principem et saluatorem exaltauit gloria sua, dare poenitentiam Israel et remissionem peccatorum, et nos in eo testes sumus sermonum horum, et spiritus sanctus, quem dedit deus credentibus ei.
9 Paris, Bibliothèque Nationale de France, Parisinus lat. 6400G, sec. V, edito da E.S. Buchanan, The Four Gospels from the Codex Corbeiensis (ff or ff2 )... together with Fragments of the Catholic Epistles, of the Acts and of the Apocalypse from the Fleury Palimpsest (h), Oxford 1907, pp. 111-112: Hunc principem deus et saluatorem exaltauit gloria sua dare poenitentiam Israel et remis-sionem peccati in se, et nos quidem testes sumus omnium uerborum istorum et spiritus sancti quem dedit deus eis quicumque crediderint in eum. Il codex Floriacensis è datato al V secolo da B.M. Metzger, The Early Versions of the New Testament, Oxford 1977, pp. 314-315; mentre preferiva pensare al VII secolo C.R. Gregory, Textkritik des Neuen Testamentes, II, Leipzig 1902, p. 609.

«Noi e lo Spirito Santo» in At 5,29-32 225
di una effettiva corrispondenza col greco10, ma è comunque una riprova del fatto che il sintagma “noi e lo Spirito Santo” inteso come soggetto della frase era già allora ritenuta improbabile.
A tale interpretazione non credo costituisca una difficoltà la reduplica-zione del verbo δίδωμι (δοῦναι... ἔδωκεν), potendo facilmente spiegarsi o come una ripresa del verbo dopo l’inciso o nel senso della promessa dello Spirito come dono del Risorto che gli apostoli hanno già ricevuto.
3. Le testimonianze patristiche non ci sono di grande aiuto, essendo rap-presentate da un numero esiguo di testi, per di più orientati secondo un’esegesi che sembra ormai tradizionale. Il testo più antico è forse costitu-ito dall’Ireneo latino (adv. haer. 3,12,5), la cui datazione è peraltro oggetto di controversia e oscilla entro un’ampia forbice che va dal III al V secolo11; in ogni caso, alla riflessione di Ireneo, mirante a costruire in funzione an-tignostica una teologia della tradizione apostolica, non poteva non far gio-co un’esegesi del passo lucano che mettesse in rilievo l’abbinamento degli apostoli con lo Spirito e quindi una testimonianza da esso corroborata e “autorizzata”.
Più interessante, ancorché poco definito, è invece un passo di Cirillo di Gerusalemme, vissuto nella seconda metà del IV secolo. Nella diciassette-sima delle Catecheses ad inluminandos Cirillo, facendo riferimento ad At 5,32, parla più appropriatamente dello Spirito non tanto come testimone a latere degli apostoli, quanto piuttosto come dono dato da Dio a coloro che gli obbediscono:
Οἱ δώδεκα πάλιν ἀπόστολοι, διὰ τὸ κηρύσσειν τὸν Χριστὸν ὑπὸ τῶν ἀρχιερέων εἰς φυλακὴν ἐμβληθέντες καὶ ὑπὸ ἀγγέλου διὰ νυκτὸς παραδόξως ταύτης ἀπαλλαγέντες, καὶ εἰς δικαστήριον ἐκ τοῦ ἱεροῦ πρὸς αὐτοὺς ἀχθέντες, ἀδυσωπήτως ἐχρήσαντο τοῖς ἐλέγχοις ἐν τοῖς περὶ Χριστοῦ πρὸς αὐτοὺς εἰρημένοις, καὶ τοῦτο προσθέντες, ὅτι καὶ τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον ἔδωκεν ὁ θεὸς τοῖς πειθαρχούσιν αὐτῷ· καὶ δα-ρέντες ἐπορεύοντο μὲν χαίροντες, οὐκ ἐπαύοντο δὲ διδάσκοντες καὶ
10 Cfr. Metzger, Early Versions cit., p. 314-315: «The script [of the Fleury palimpsest] contains many errors, and the rendering into Latin is often very free, although the Greek text followed can usually be discerned».
11 Cfr. J. Quasten, Patrologia, trad. it. di N. Beghin, I, Casale Monferrato 1980, pp. 258-259.

226 Antonio Piras
εὐαγγελιζόμενοι τὸν Χριστὸν Ἰησοῦν. Οὐ μόνον δὲ ἐν τοῖς δώδεκα ἀποστόλοις ἡ τοῦ ἁγίου πνεύματος ἐνήγερσε χάρις, ἀλλὰ γὰρ καὶ ἐν τοῖς πρωτογόνοις τέκοις τῆς ποτε στείρας ἐκκλησίας ταύτης κτλ.
«I dodici apostoli, gettati di nuovo in prigione dai sommi sacerdoti per aver predicato il Cristo, furono inaspettatamente liberati nottetempo da un angelo; condotti dal tempio in tribunale, coraggiosamente biasimaro-no quanto era stato da loro detto riguardo al Cristo, aggiungendo anche che Dio aveva dato lo Spirito Santo a coloro che gli obbediscono. Dopo essere stati fustigati, se ne andarono con gioia senza smettere di insegnare e di annunciare Cristo Gesù. La grazia dello Spirito Santo agì non solo nei dodici apostoli, ma anche nei figli primogeniti di questa chiesa allora sterile etc.»12.
In questo brano lo Spirito, più che come testimone che garantisce la legit-timità e l’autenticità dell’annuncio degli apostoli, è presentato come dono che infonde loro la parresia e il coraggio della predicazione a dispetto dei divieti e delle minacce non solo verbali del sinedrio. E che il testo non alluda a una testimonianza legittimata, ma piuttosto alla forza evangelizza-trice donata dallo Spirito trova conferma nel fatto che la sua azione è stata efficace «non solo nei dodici apostoli, ma anche nei figli promogeniti di quella Chiesa allora sterile».
Qualche anno più tardi, Fausto di Riez, che pure cita At 5,31-32 secon-do una versione affine alla Vulgata, vi aggiunge a commento una significa-tiva osservazione:
Item cum dixissent apostoli de Iesu: Hunc deus principem et saluatorem exaltauit dextera sua ad dandam paenitentiam in Israel in remissionem peccatorum. Nos – inquit – sumus testes horum et spiritus sanctus, quem dedit deus omnibus oboedientibus sibi. Intellege hic sub ordine trinitatis non solum ad praedicandam, sed ad dandam paenitentiam a patre filium des-tinari et obtemperantibus spiritum sanctum, qui oboedientiam remuneretur, infundi13.
12 Cyr. Hier. catech. 17,23-24 (pg 33,994-996).13 Cfr. Faust. Reiens. spir. 1,10 p. 121 Engelbrecht (csel 21).

«Noi e lo Spirito Santo» in At 5,29-32 227
Fausto invita ad interpretare il testo in chiave trinitaria e sottolinea che il Padre ha inviato il Figlio per annunciare la conversione (ad praedicandam) e donare il perdono (ad dandam paenitentiam), mentre invia lo Spirito come premio della fedeltà a Dio (qui oboedientiam remuneretur). Come si vede, sono qui rappresentati tutti e tre i doni elargiti dal Padre, i primi due attraverso il Figlio, il terzo attraverso lo Spirito che è esso stesso dono.
Gli altri testi patristici che fanno riferimento esplicito al passo lucano, per esempio Fulgenzio di Ruspe14, testimoniano ormai l’interpretazione comune che, circa due secoli dopo, appare come suggellata dalla Retracta-tio in Actus Apostolorum di Beda15. Ecco infatti come questi commenta il passo biblico:
Et nos testes sumus horum uerborum et spiritus sanctus quem dedit deus omnibus oboedientibus sibi. Nos sumus testes quia gloriam resurrectionis eius uidimus [...]; testis est et spiritus sanctus quem deus omnibus in se credentibus dedit quia, ut magnalia dei uobis licet resultantibus inuincibiliter praedice-mus, ipse nos sua praesentia roborauit etqs.
Beda pone evidentemente in parallelo l’azione degli apostoli e la forza dello Spirito sul piano della sola testimonianza con una ripartizione della cita-zione biblica che cancella del tutto la presenza e quindi il senso dell’inciso.
4. Il sintagma “noi e lo Spirito Santo” è presente anche in At 15,28. Nella lettera “sinodale” consegnata a Paolo, Barnaba, Giuda Barsabba e Sila le raccomandazioni rivolte alla comunità cristiana di Antiochia di limitare le prescrizioni tradizionali all’astensione dalla carne delle vittime offerte agli idoli o dalla carne e dal sangue di animali morti per soffocamento o dai disordini sessuali vengono presentate come decisione degli apostoli e dello Spirito Santo (ἔδοξεν τῷ πνεύματι τῷ ἁγίῳ καὶ ἡμῖν κτλ.). Qui il sintagma, la cui solennità e autorità garantiranno una particolare fortuna nella formularità dei documenti sinodali e conciliari dal IV secolo in poi16,
14 Cfr. Fulg. c. Fabian. frg. 29,168 p. 820 Fraipont (ccl 91a).15 Beda retract. in Act. 5,24 p. 128 Laistner (ccl 121).16 Cfr. per es. J.T. Bretzke, Consecrated Phrases. A Latin Theological Dictionary, Collegeville
(Minnesota) 20133, p. 181; si veda inoltre K.R. Hagenbach, A History of Christian Doctrines, II, Edinburgh 1884, p. 21.

228 Antonio Piras
ricorre in un contesto assolutamente diverso ed è, si direbbe, al suo posto. Qui tanto i destinatari quanto il genere letterario è differente: ci si rivolge espressamente a una comunità di cristiani e si tratta di una decisione col-legiale, trasmessa per lettera, che ha i caratteri dell’autorità apostolica, non di una dichiarazione pronunciata dinanzi a un tribunale. Anzi, si potreb-be pensare che proprio At 15,28 abbia orientato l’esegesi vulgata di 5,32, analogamente a quanto è avvenuto in alcuni manoscritti latini pregeroni-miani17, e quindi nella versione gotica18, che attestano indebitamente la menzione dello Spirito nel prologo del vangelo di Luca (1,3), utilizzando quella che era ormai divenuta una «familiar connection»19 per rimarcare il carattere ispirato, e quindi canonico, del vangelo lucano:
ἔδοξε κἀμοὶ [καὶ τῷ πνεύματι τῷ ἁγίῳ] παρηκολυθηκότι ἄνωθεν πᾶσιν ἀκριβῶς καθεξῆς σοι γράψαι.
b e q: placuit et mihi et spiritui sancto adsecuto a principio omnibus diligen-ter ex ordine tibi scribere.
got: galeikaida jah mis jah ahmin weihamma fram anastodeinai allaim glaggwuba afarlaistjandin gahahjo þus meljan.
Tornando ad At 5,32, ci sono altri elementi che sembrano confermare la nostra lettura. I tre accusativi (μετάνοιαν, ἄφεσιν ἁμαρτιῶν, πνεῦμα τὸ ἅγιον) dipendenti dal verbo δοῦναι non a caso corrispondono ai tre doni presenti, direttamente o indirettamente, nei discorsi di Gesù risorto, ossia conversione, perdono dei peccati, promessa dello Spirito. Ma c’è di più. Se mettiamo a confronto il nostro brano con Lc 24,45-49, troveremo impres-
17 Si tratta dei codici b (Verona, Biblioteca Capitolare, VI [6], sec. V) e q (München, Bayerische Staatsbibliothek, Clm 6224, già Frisingensis 24): cfr. A. Jülicher, Itala. Das Neue Testament in altlateinischer Überlieferung nach den Handschriften, III. Lucas-Evangelium, zweite verbesserte Auflage, Berlin-New York 1976, p. 1. È assai probabile che questi testimoni latini abbiano seguito una Vorlage greca che documentava un testo conflato.
18 W. Streitberg, Die gotische Bibel, 7. Auflage mit einem Nachtrag von P. Scardigli, Heidelberg 2000, p. 85. Si ricorderà che la versione di Vulfila è anteriore alla Vulgata geronimiana e si basa su un modello greco identificabile col testo bizantino nella sua forma più antica, ciò che la ren-de un testimone di rilievo per la filologia biblica: cfr. A. Piras, Manuale di gotico. Avviamento alla lettura della versione gotica del Nuovo Testamento, Roma 2007, pp. 47-67.
19 L’espressione è di Wall, Acts cit. p. 107.

«Noi e lo Spirito Santo» in At 5,29-32 229
sionante la vicinanza dei due testi: il breve intervento di Pietro di fronte al sinedrio sembra seguire la falsariga del discorso di commiato di Gesù che Luca inserisce nella conclusione del suo vangelo, come se volesse instaurare un collegamento esplicito fra i due testi. La raccomandazione di Gesù agli apostoli di restare a Gerusalemme finché non fossero «rivestiti di potenza dall’alto» (Lc 24,49) si concretizzerà di lì a poco nell’arresto e nella testimo-nianza dinanzi al sinedrio. Ecco il testo di Lc 24,45-49:
45τότε διήνοιξεν αὐτῶν τὸν νοῦν τοῦ συνιέναι τὰς γραφάς· 46καὶ εἶπεν αὐτοῖς ὅτι οὕτως γέγραπται παθεῖν τὸν χριστὸν καὶ ἀναστῆναι ἐκ νε-κρῶν τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ, 47καὶ κηρυχθῆναι ἐπὶ τῷ ὀνόματι αὐτοῦ μετάνοι-αν εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν εἰς πάντα τὰ ἔθνη ἀρξάμενοι ἀπὸ Ἰερουσαλὴμ. 48ὑμεῖς μάρτυρες τούτων. 49καὶ [ἰδοὺ] ἐγὼ ἀποστέλλω τὴν ἐπαγγελίαν τοῦ πατρός μου ἐφ’ ὑμᾶς· ὑμεῖς δὲ καθίσατε ἐν τῇ πόλει ἕως οὗ ἐνδύση-σθε ἐξ ὕψους δύναμιν.
«Allora aprì loro la mente per comprendere le Scritture e disse loro: “Così sta scritto: il Cristo patirà e risorgerà dai morti il terzo giorno, e nel suo nome saranno predicati a tutti i popoli la conversione e il perdono dei pec-cati, cominciando da Gerusalemme. Di queste cose voi siete testimoni. Ed ecco, io mando sui di voi colui che il Padre mio ha promesso: ma voi restate in città, finché non siate rivestiti di potenza dall’alto».
Le forti affinità tra i due passi sono evidenti, al punto che la loro disposi-zione sinottica rivela chiaramente la medesima struttura:
1. Annuncio della promessa dei doni
2. PrimO dOnO: la conversione
3. secOndO dOnO: la remissione dei peccati
4. destinAtAriO: Israele / tutte le genti a partire da Gerusalemme
5. incisO: il compito della testimonianza degli apostoli
6. terzO dOnO: lo Spirito

230 Antonio Piras
At 5,31-32
1. δοῦναι
2. μετάνοιαν
3. καὶ ἄφεσιν ἁμαρτιῶν
4. τῷ Ἰσραὴλ
5. ἡμεῖς ἐσμεν μάρτυρες τῶν ῥημάτων τούτων
6. καὶ τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον ὃ ἔδωκεν ὁ θεὸς τοῖς πειθαρχοῦσιν αὐτῷ
Lc 24,47-49
1. κηρυχθῆναι ἐπὶ τῷ ὀνόματι αὐτοῦ
2. μετάνοιαν
3. εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν
4. εἰς πάντα τὰ ἔθνη ἀρξάμενοι ἀπὸ Ἰερουσαλὴμ
5. ὑμεῖς μάρτυρες τούτων
6. καὶ ἐγὼ ἀποστέλλω τὴν ἐπαγγελίαν τοῦ πατρός μου ἐφ’ ὑμᾶς
Al δοῦναι di At corrisponde in Lc il κηρυχθῆναι ἐπὶ τῷ ὀνόματι αὐτοῦ, nel senso che l’annuncio ha pur sempre per oggetto i doni del Risorto; la μετάνοια e l’ἄφεσις ἁμαρτιῶν, che in At sono coordinati tramite una congiunzione copulativa, in Lc risultano collegati secondo un nesso finale, ad esplicitare che la conversione ha come prospettiva il perdono dei pec-cati; la stessa conversione che in At appare destinata al solo Israele (ma è il contesto che lo richiede), nella visione universalistica di Lc è destinata a tutti le genti, a cominciare però da Gerusalemme, cioè da Israele che ne è, almeno cronologicamente, il primo destinatario. Come terzo dono in entrambi i brani è indicato lo Spirito Santo, menzionato espressamente (τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον) o additato come “promessa del padre” (τὴν ἐπαγγελίαν τοῦ πατρός μου). Ma ciò che per il nostro assunto acquista maggiore im-portanza è che il riferimento al compito della testimonianza degli apostoli è in entrambi i passi racchiuso entro un inciso che separa i due primi doni, conversione e perdono, dal terzo, ossia il dono dello Spirito. Questo compito è espresso in At in prima persona (è infatti Pietro che parla: ἡμεῖς ἐσμεν μάρτυρες τῶν ῥημάτων τούτων), in Lc in seconda persona (è Gesù che parla agli apostoli: ὑμεῖς μάρτυρες τούτων)20.
20 Sorprende l’affermazione di H. Conzelmann, Die Apostelgeschichte, Tübingen 1963, p. 42: «Das Nebeneinander des Zeugnisses der Apostel und des Geistes wird durch 2,32ff. und Lc 24,48f. erklärt». Infatti, è vero che i due passi devono essere messi in relazione, ma non nel senso che dice lo studioso tedesco.

«Noi e lo Spirito Santo» in At 5,29-32 231
In conclusione, la locuzione “noi e lo Spirito Santo”, che nel contesto di At 15,28 trova piena giustificazione21, è divenuta ben presto, in virtù della sua efficacia espressiva e della sua pregnanza semantica, una sorta di precomprensione e di stereotipo che ha finito per essere applicato non solo come formula autoritativa ai documenti conciliari, ma anche come chiave ermeneutica a quei passi come At 5,32 in cui a stento troverebbe una sua ragion d’essere22.
21 A conforto di questo passo si cita solitamente anche Gv 15,26-27: cfr. W.L. Lofthouse, The Holy Spirit in the Acts and the Fourth Gospel, «The Expository Times» 52 (1941), pp. 334-336.
22 Ringrazio i colleghi Antonio Pinna e Rita Lai della Pontificia Facoltà Teologica della Sardegna per aver discusso con me alcuni aspetti di questa breve nota.