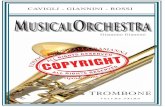Musical It A
description
Transcript of Musical It A

Musicalità
L11
2012-2013

Musicalità • Malloch chiama communicative musicality gli
elementi delle interazioni comunicative cooperative e co-dipendenti tra madre ed infante. Le sue dimensioni sono:
• Pulse: successione regolare di eventi nel tempo, ove per evento si intende l’inizio o la fine di una vocalizzazione, un momento a voce alta, un turno nella forma dell’intensità della voce della madre. Si misura con lo spettrografo

Communicative musicality
• Quality: è costituita dai contorni melodici e timbrici delle vocalizzazioni equivalenti al contorno e alla velocità del gesto corporeo.

Communicative musicality
• Narratives: costruite dalla precedenti unità, sono lo scambio empatico di involucri emotivi che evolvono nel condividere gesti, vocalizzazioni e lo scorrere del tempo. Esprimono la ricerca di creare significato in attività congiunte con l’altro. Si tratta di accedere alla strutture di un vero e proprio musical game con l’altro ove la temporalizzazione (su unità percettivamente riconoscibili) è un elemento vitale nelle vocalizzazioni che compongono l’evento narrativo.

nello sviluppo regolare del linguaggio
• la musicalità svolge il ruolo di anticipatore della
scansione metrico-sillabica degli enunciati
• Verso la fine dello stadio di lallazione variata appare
nelle produzioni del bambino una varietà di schemi di
accentazione e di intonazione: si parla di “gergo
espressivo” o “gibberish”, in quanto la sensazione
dell’adulto è che la lallazione suoni come “una lingua
straniera” ovvero sequenze di suoni linguistici che
non hanno un significato ma riproducono le
intonazioni dell’adulto.

Musica/linguaggio
• Melodia e ritmo sembrano essere neurologicamente dissociati (Falk 2000): l’emisfero destro elabora gli aspetti melodici, mentre l’emisfero sinistro il ritmo (Peretz 1993)
• Emisfero destro: interpreta gli aspetti melodici del linguaggio, il tono della voce, le connotazioni emotive ed affettive del parlato.
• profilo di dissociazione: ritmi più lenti a destra, più veloci a sinistra

Musica/linguaggio
• L’emisfero destro ha difficoltà ad analizzare le categorie fonetiche, mentre la discriminazione delle vocali sembra non costituire un problema (Zaidel 1977)
• L’emisfero destro sembra essere prevalentemente un analizzatore gestaltico di tratti acustici e non di tratti fonetici.
• Superiorità dell’orecchio destro, e dunque dell’emisfero sinistro, per sillabe formate CVC, dunque in relazione alla combinazione consonante/vocale, mentre le vocali sono percettivamente o bilaterali, o addirittura unilaterali sull’emisfero destro (Studdert-Kennedy e Shankweiler 1970).

Dissociazione dello stimolo
• le regioni uditive e associate al linguaggio dell’emisfero sinistro contengono un gran numero di larghe cellule piramidali che tipicamente esplicano il prorompere ritmico veloce a velocità gamma (30-50 Hz), mentre nella corteccia uditiva destra c’è una proporzione assai più grande di cellule piramidali più piccole. Ciò porterebbe a evidenziare la tendenza delle strutture dell’emisfero sinistro a spezzettare il flusso dei segnali uditivi ad una frequenza più alta e di quelle del destro a integrare tale flusso in periodi più lunghi.

Giraud et al. 2011 • Relazione fra le scale temprali presenti nel
parlato e le costanti temporali proprie delle oscillazioni neuronali corticali
• Costituisce sia il riflesso che i mezzi mediante i quali il cervello converte i ritmi del parlato in segmenti linguistici:
• Gamma 25-25 Hz
• Teta 4-8 Hz
• Delta 1-3 Hz
• Legame tra neurofisiologia, computo neurale, acustica e psicolinguistica

Giraud et al 2012
• Processo che trasforma il parlato continuo in unità discrete, su due scale temporali : le oscillazioni intrinseche nella corteccia uditiva A1 e A2 (BA 41 e 42) interagisce con l’attività generata da un segnale acustico afferente
• Incastro oscillatorio teta-gamma: la fase delle oscillazioni lente controlla le oscillazioni a velocità più alta, la loro fase

Identificare i confini
• La prosodia diviene, ancora in una fase pre-lessicale, la chiave per accedere all’identificazione dei confini dei costituenti sintagmatici, e dell’ordine delle parole
• la struttura fonologica scaturisce dall'esperienza cumulativa che consente il formarsi di categorizzazioni come forma di computo sulle regolarità statistiche presenti nel segnale del parlato, sulla base dell'accumulazione statistica piuttosto che di un codice predeterminato:
• la segmentazione è il risultato dell’intreccio oscillatorio che porta a integrare le diverse fasi:

Co-articolazione • L’unità linguistica iniziale è la parola olistica: anche se è prodotta come
una sequenza di gesti discreti, tuttavia tali gesti ancora non sono rappresentati come elementi fonetici indipendenti che possono essere usati liberamente in altri e differenti contesti
• Co-articolazione è il punto di partenza: le categorie fonologiche emergono
da processi neurodinamici autoorganizzantesi
• Categorie: il parlante inizialmente replica ciò che ode, e gradualmente le vocalizzazioni prodotte e percepite convergono e si stabilizzano su insiemi discreti di tratti acustico-articolatori, o categorie
• Col tempo, la variabilità viene disambiguata sulla base del contesto e tramite elementi che forniscono riconoscimento semantico. Lo stesso meccanismo è alla base dello sviluppo lessicale.

Differenziare
• Il riconoscimento avviene per differenziazione di unità sempre più piccole, trasducendo la variabilità in eventi multimodali, acustico-motorio-visivi
• Gli indici prosodici sono trasdotti in variazioni di frequenza e segnali temporali quando la covariazione può essere ridotta associando al suono la mappa dei gesti articolatori connessi
• La sillaba come elemento chiave • La formazione di vocali e consonanti da una unità prelinguistica di azione motoria.
Le unità salienti del parlato dal punto di vista percettivo sono le sillabe non i fonemi
• Le sillabe, portatrici di ritmo e melodia del parlato, sono schemi intricati di gesti simultanei e sovrapposti. (cfr. anche Liberman et al.1967).
• Per arrivare al linguaggio - che funziona sul principio composizionale – c’è bisogno di “un sistema neuro-anatomico integro di parti distinte muovibili indipendentemente che possono essere coordinate per effettuare sequenze rapide di azione motoria, e sono le azioni di queste parti individuali, i gesti, che costituiscono le unità di base del linguaggio” (Studdert-Kennedy e Goldstein 2005)

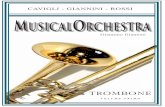





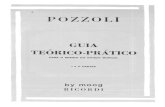
![[Solfeo] Pozzoli - Ditado Musical](https://static.fdocumenti.com/doc/165x107/55cf85a2550346484b902b7c/solfeo-pozzoli-ditado-musical.jpg)