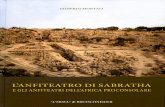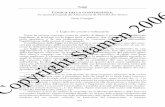Monografie - OAPEN · Da provincia romana a stato regionale, Genova 1992. 3 Quando il termine non...
Transcript of Monografie - OAPEN · Da provincia romana a stato regionale, Genova 1992. 3 Quando il termine non...
-
Monografie
3
-
MONOGRAFIE
1. Renato Bordone, Uno stato d'animo,
2002
2. Marina Gazzini, "Dare et habere". Il
mondo di un mercante milanese del
Quattrocento, 2002
READING
1. "Le storie e la memoria". In onore di
Arnold Esch, a cura di Roberto Delle
Donne, Andrea Zorzi, 2002
2. Papato e monachesimo "esente" nei
secoli centrali del Medioevo, a cura di
Nicolangelo D'Acunto, 2003
Reti Medievali E-book
-
Reti Medievali
Paola Guglielmotti
Ricerchesull'organizzazione del territorio
nella Liguria medievale
Firenze University Press2005
-
© 2005 Firenze University Press
Università degli Studi di FirenzeFirenze University PressBorgo Albizi, 2850122 Firenze, Italyhttp://epress.unifi.it/
Printed in Italy
Ricerche sull'organizzazione del territorio nella Liguria medievale / PaolaGuglielmotti. - Firenze : Firenze university press, 2005.(Reti Medievali. E-book, Monografie, 3)http://www.storia.unifi.it/_RM/e-book/titoli/guglielmotti.htmStampa a richiesta disponibile su http://epress.unifi.it
ISBN 88-8453-115-2 (online)ISBN 88-8453-116-0 (print)945.1804 (ed. 20)Liguria - Medioevo
-
Introduzione
I. Definizioni di territorio e protagonisti politici e sociali
a Genova nei secoli X-XI
1. Il comitatus Ianuensis2. Attorno ai villaggi3. Il territorio suburbano
II. Genova e i luoghi di nuova fondazione nella Liguria di
Levante del secolo XII
1. Le fondazioni2. Castrum e burgus
III. Nuove fondazioni signorili nella Liguria duecentesca
1. I promotori delle rifondazioni2. Il contesto di partenza3. Le fondazioni dei marchesi del Carretto4. Le fondazioni dei marchesi di Clavesana
IV. “Ad conservationem territorii et iurisdictionis loci”:
Rezzo tra autonomia della comunità e dipendenza signorile
1. Il contesto1.1 La principale raccolta documentaria1.2 Popolazione e partecipazione politica1.3 Risorse del suolo e dell’agricoltura: un regime policolturale1.4 Viabilità: ai margini di un’area di strada1.5 I primi signori e la comunità: i conti di Ventimiglia e i luoghi delpotere e dell’identità nel villaggio1.6 I nuovi signori: i marchesi di Clavesana e i rapporti con i villag-gi vicini nella fase più alta1.7 Profilo del territorio e villaggi confinanti1.8 Scelte tematiche e qualche anticipazione
Indice
7
15182835
414347
5557636980
899091929497
98
101106110
-
2. Assetto insediativo e presenze religiose: compattezza che suggeriscecoesione2.1 Quartieri: i condizionamenti sulle forme della rappresentanza2.2 La chiesa di S. Martino e le sue competenze nel villaggio e nella valle2.3 Le cappellanie in S. Martino: l’articolazione devozionale e sociale2.4 Ulteriori articolazioni del quadro religioso: un rafforzamento del-l’identità comunitaria
3. Gestione di beni collettivi e relazioni con i villaggi confinanti: àmbitidi autonomia della comunità3.1 Distribuzione della proprietà fondiaria e rapporti di vicinato: lamolteplicità degli intrecci3.2 Terre della comunità: un complesso sistema di integrazioni3.3 Terre per il pascolo3.4 Rapporti con i villaggi vicini: documentazione e deformazioneprospettica3.5 Rapporti con i villaggi di Cenova e Lavina: l’elaborazione di unanozione di confine “zonale”
4. Comunità e signori: la definizione delle competenze4.1 Una comunità forte con rappresentanza istituzionale debole4.2 La spartizione di Rezzo: concorrenza intersignorile e affermazio-ne di una fiscalità legata ai redditi4.3 Forme di autogoverno dei Rezzaschi
AbbreviazioniFonti e bibliografiaCarteIndice dei nomi
112112115118
124
128
129133138
140
143
149150
152162
167169191195
-
Introduzione
I quattro saggi raccolti in questo volume testimoniano di un campionariodi problemi relativi all’organizzazione del territorio ligure, disponendosi insuccessione cronologica dal secolo X fino alla primissima età moderna e ana-lizzando situazioni differenti, tutte in relazione a luoghi compresi nell’attua-le regione Liguria: una striscia arcuata di terra, stretta tra i monti e il mare,ricca di passaggi alle regioni retrostanti e priva di pianure significative. Nonsi ha la pretesa che queste situazioni siano le più rappresentative dei secoliqui in esame1, soprattutto in base alla convinzione che quanti praticano l’op-zione tematica della storia del territorio non dovrebbero fissare una gerarchiadi rilevanze e perciò di scale e di campi di osservazione, riconoscendo a tuttiquesti pari dignità.
I primi tre contributi aprono una finestra su un segmento temporaleintenzionalmente ben ritagliato. E’ stato studiato il territorio variamente gra-vitante su Genova nei secoli X e XI, con speciale attenzione per le denomina-zioni usate (cap. I); è stata presa in considerazione, limitatamente al secoloXII, la creazione di nuovi punti di forza nella Riviera di levante da parte dellamaggiore città ligure nella sua iniziale politica di espansione territoriale e diparallelo contenimento delle grandi dominazioni signorili (cap. II); si è piùdecisamente spostata l’attenzione su attori non cittadini, guardando alle ini-ziative di fondazione di nuovi villaggi da parte dei maggiori signori operantinelle due Riviere nel corso del solo Duecento (cap. III). Nell’ultimo saggio siè osservata in modo ravvicinato la dinamica rustici-domini seguendo, invece,la cronologia – dal secolo XIII ai primi decenni del XVI – proposta da unLiber iurium di un villaggio della Riviera di ponente, in maniera utile a dimo-strare anche quanto sia lenta l’espansione del controllo della Repubblicagenovese in alcune sacche di resistenza signorile (cap. IV). Questa coperturacronologica di tutti i secoli centrali e bassi del medioevo può suggerire un usodidattico del volume.
La scelta di condurre un’analisi per situazioni muove anche dalla persua-sione che la storia di una regione non è ricostruibile per puro accumulo dei
7
1 Seguo un’ispirazione simile a quella che ha guidato, su uno spettro tematico più ampio, una rac-colta di saggi di ambito subalpino: Piemonte medievale. Forme del potere e della società. Studiper Giovanni Tabacco, Torino 1985.
-
dati raccolti in singole ricerche o affidandosi a un unico filo conduttore; sullediverse interpretazioni di Liguria nel tempo disponiamo del resto di un con-tributo di una dozzina di anni fa2. Nelle fonti documentarie medievali siricorre malvolentieri a espressioni generiche relative al territorio (e in questocaso si usa si spesso terra)3. Con “territorio” nel linguaggio storiograficoormai si intende concordemente il quadro entro cui compiere analisi coordi-nate di una molteplicità di sviluppi4, anzi sempre più proprio il risultato diquegli sviluppi5; ma è giusto sottolineare come la parola abbia conosciutonegli ultimi anni un logoramento, quasi per eccesso d’uso6. Occorre piuttostolasciarsi inizialmente guidare dalle espressioni usate nel latino medievale –comitatus, territorium, finis, districtus7 e altre ancora – applicate ad aree ditaglia e qualità sempre da accertare. In questo modo ci si è mossi in partico-lare nel cap. I per il largo contesto periurbano genovese: a tutta prima carat-terizzato da un’identità sfuggente, ma in realtà già con una tendenza all’indi-viduazione di una zona che è contraddistinta da un equilibrio peculiare e chein definitiva è ancora senza un termine unico adatto a descriverla.
Tutti gli esiti vanno considerati costruzioni complesse, che avanzano e siassestano con ritmi e soluzioni non sempre lineari e riconducibili a schemiacquisiti definitivamente: vi partecipano infatti una pluralità di protagonisti,con capacità di incidere variabili nel tempo. Non si tratta necessariamente diprotagonisti molto visibili nelle nostre fonti o di territoria dalla sagoma chia-ra, come si è riscontrato nei due contributi che prendono in esame delle vil-lenuove: un tema molto frequentato negli ultimi vent’anni, benché forse conminor fortuna nella divulgazione rispetto a quello dell’incastellamento. Moltoin ombra restano infatti gli abitanti della Riviera di levante che possonodecretare il successo o l’insuccesso insediativo di castelli e villaggi di nuovafondazione e del territorio dal loro organizzato passati in rassegna nel cap. II;oppure i rustici che hanno preferito un insediamento disperso, prima di esse-re indotti da più energiche imprese signorili di riorganizzazione dell’habitat a
8
Ricerche sull'organizzazione del territorio nella Liguria medievale
2 R. Pavoni, Liguria medievale. Da provincia romana a stato regionale, Genova 1992.3 Quando il termine non è usato a indicare un campo: un esempio in P. Guglielmotti, Comunitàe territorio. Villaggi del Piemonte medievale, Roma 2001, pp. 112 sgg.4 G. Sergi, Potere e territorio lungo la strada di Francia. Da Chambéry a Torino fra X e XIIIsecolo, Napoli 1981, p. 14. 5 Mutuando da A. Torre, La produzione storica dei luoghi, in “Quaderni storici”, 37 (2002), 110,pp. 443-476.6 Ma casomai ciò sottolinea il successo di una felice stagione di studi, di cui vanno consideratirappresentativi R. Bordone, Città e territorio nell’alto medioevo. La società astigiana dal domi-nio dei Franchi all’affermazione comunale, Torino 1980 (BSS, 200), e Sergi, Potere e territoriocit.7 Sul districtus genovese va segnalata l’acuta analisi di R. Savelli, Scrivere lo statuto, ammini-strare la giustizia, organizzare il territorio, in Repertorio degli statuti della Liguria (secc. XI-XVIII), a cura di Id., Genova 2003 (FSL, 19), pp. 65 sgg.
-
congregarsi nelle villenuove, come si è constatato nel cap. III. Ma sono tuttisoggetti sociali e politici non ignorabili nel nostro sfondo. Per quanto copio-samente testimoniati, altri attori possono limitarsi a intendere il territoriumdi un villaggio, dal contorno tutto sommato chiaro, alla stregua di un grossorecipiente cui attingere redditi, in denaro e in parte ancora in natura: sul fini-re del medioevo è il caso dei marchesi di Clavesana a Rezzo, ormai senza inte-resse e capacità di agire sui meccanismi della distribuzione delle proprietàfondiaria, della manutenzione del suolo e delle sue strutture, dell’accesso allerisorse collettive e della tutela di una piccola fascia confinaria di quel territo-rium, come è emerso nel cap. IV.
Accade di frequente che nel condurre ricerche di storia del territorio nonsi esplicitino o non si rendano riconoscibili a sufficienza, sotto il profilo meto-dologico, gli approcci adottati, mentre una simile esplicitazione appareopportuna quanto meno per la didattica universitaria, che rischia di subiresempre maggiori semplificazioni. Si tende infatti a ragionare all’interno diquei solidi “contenitori” – al tempo stesso geografici, cronologici e di riferi-menti storiografici – offerti ad esempio dal distretto plebano, dalla signoriaterritoriale, dal contado di una città o dallo stato regionale8, che possonoessere avvertiti non solo come utili orientamenti ma anche come gabbieinterpretative, perché non sempre pienamente adatti a mostrare l’integrazio-ne di tutti i piani del processo storico. Correttivi anche recenti indubbiamen-te non mancano, come ad esempio sembra dimostrare fin dal titolo il semi-nario milanese del 2003 su Signorie rurali e feudi in alcune aree dell’Italiacentro-settentrionale fra XIV e XV secolo, dove l’interesse va appuntatosoprattutto sul primo termine dell’endiadi in età così tarda, perché spessoancora sopraffatto dal secondo nella divulgazione medievistica9. Tra i saggi
9
Introduzione
8 Per cui si possono vedere rispettivamente come primo orientamento Curtis e signoria rurale.Interferenze fra due strutture medievali, a cura di G. Sergi, Torino 1993; P. Toubert, “Città” et“contado” dans l’Italie médiévale. L’émergence d’un thème historiographique entreRenaissance et Romantisme, in “La Cultura”, 22 (1984), pp. 219-248; e G. Chittolini, Cittàcomunità e feudi negli stati del’Italia centro-settentrionale (secoli XIV-XVI), Milano 1996. Siriprende qui quanto già rilevato in Guglielmotti, Comunità e trritorio cit., pp. 15-16.9 Con evidente richiamo al lavoro di G. Chittolini, Signorie rurali e feudi alla fine del medioevo,in Comuni e Signorie: istituzioni, società e lotte per l’egemonia, Torino 1981 (Storia d’Italiadiretta da G. Galasso), pp. 589-676; si veda adesso Poteri signorili feudali nelle campagnedell’Italia settentrionale fra Tre e Quattrocento: fondamenti di legittimità e forme di esercizio.Atti del convegno di studi (Milano, 11-12 aprile 2003), a cura di F. Cengarle, G. Chittolini e G.M.Varanini, in “Reti Medievali - Rivista”, 5 (2004) 1, url: . Presentano interesse di recente anche lavori, come quello di G.Serrazanetti, Dalla domus filiorum Manfredi ai Passaponti: un caso di signoria mancata?, inPer Vito Fumagalli. Terra, uomini, istituzioni medievali, a cura di M. Montanari e A. Vasina,Bologna 2000, pp. 281- 338, che affronta con la necessaria cautela, fin dal titolo, un ambito poli-ticamente “grigio” di notevole interesse. Un orientamento prezioso è adesso in G. Albertoni e L.Provero, Il feudalesimo in Italia, Roma 2003.
-
che qui si propongono, quello dedicato al villaggio del Ponente intendeappunto mostrare i marchesi di Clavesana e del Carretto in specie nella loroveste di signori locali, perché il fatto di essere feudatari di Genova dalla finedel secolo XIV rafforza la loro lealtà verso la città e può consentire loro unmigliore inserimento, ma non muta la qualità dei poteri esercitati a Rezzo, dacui anzi risultano spesso assenti.
Per ovviare al pericolo di stare per sola inerzia in quel tipo di sperimenta-te e rassicuranti cornici, in questa sede si è scelto per i primi tre contributiquale piccolo antidoto un altro tipo di ritaglio cronologico: quello per secoli,che presenta differenti rischi, innanzitutto di eccessiva entificazione di queimedesimi secoli. E’ un escamotage non nuovo10 di cui – pur nella sua dichia-rata arbitrarietà – merita sondare ancora la tenuta perché induce a evitareogni punto di arrivo troppo condizionante e suggerisce di considerare siste-maticamente e in parallelo tutti gli attori e tutti gli sviluppi di un “territorio”creato e via via ridefinito e riqualificato con iniziative, pratiche e contratta-zioni. Nei casi che qui si presentano la disponibilità di fonti che assumonoconsistenza solo nel secolo XI, tuttavia, fa sì che nel cap. I si ricalchi unaperiodizzazione tradizionale che enfatizza la fase “precomunale” in relazionea Genova (dove oltretutto si ha notizia dei consoli cittadini proprio sul finiredel secolo); al contrario, nel cap. IV, la griglia cronologica suggerita dal Liberiurium di un villaggio ha consentito di proseguire l’osservazione sui compor-tamenti dei signori locali addirittura superando i tradizionali limiti delmedioevo.
Ovunque le fonti lo abbiano consentito, anche assumendo la prospettivadella città, cioè di Genova, si è poi scelto di scendere fino a una scala moltogrande di osservazione, fino al microtoponimo, che ha indotto a valorizzare ilcontesto di produzione e di conservazione dei singoli atti che ne recano testi-monianza: documentare il territorio è infatti processo che avviene attraversouna molteplicità di atti, di più o meno intensa consapevolezza da parte diautori ed estensori dei documenti. Contestualizzazione e decodificazionesono pratica comune e direi ovvia del medievista, ma appunto quasi mai pro-posta in maniera formalizzata e ben percepibile soprattutto per gli studenti,che tendono oltretutto a credere che esistano specialisti di luoghi anche mini-mi e apparentemente di nessuna importanza, se non per chi vi è nato o perqualche bizzarro affezionato. Perché, ad esempio, studiare analiticamenteRezzo, che ha contato al massimo 250 nuclei familiari nel basso medioevo econta circa 700 abitanti ai giorni nostri, e soffermarsi anche sulla località
10
Ricerche sull'organizzazione del territorio nella Liguria medievale
10 Cito, quasi a caso, I problemi dell’Occidente nel secolo VIII, Spoleto 1973 (Settimane di studiodel centro italiano di studi sull’alto medioevo, 20), e L’evoluzione delle città italiane nell’XI seco-lo, a cura di R. Bordone e J. Jarnut, Bologna 1988 (Annali dell’Istituto storico italo germanico,Quaderno 25).
-
Pozzette nel suo territorio? Non si tratta solo di una preferenza, forse un po’ datata, per una storia
“dal basso”, che si occupi degli “strati inferiori” della popolazione e perciòdella volontà di proporre una storia più “democratica”, o dell’attrattiva (tuttasoggettiva) esercitata da un contesto documentario più benevolo che per altrecoeve situazioni. Lo studio condotto alla scala topografica – così come stan-no proponendo ormai da anni proprio gli storici e i geografi dell’età modernache hanno operato in ambito ligure11 – consente di cogliere l’elaborazionecomplessa e mutevole di un sistema di interazioni12 tra la società locale e ipoteri presenti in loco, perciò anche le emanazioni di quelli “centrali”: tuttiquanti e in varia misura produttori di giurisdizioni, dalla prima, nelle suediverse componenti, ai secondi, civili o religiosi che siano. Dunque indagareanche sulla località Pozzette significa verificare chi effettivamente riesca –attraverso pratiche di uso, possessi, negoziazioni, atti autoritativi, usurpazio-ni, accordi, riscossioni di decime – a esercitarvi una giurisdizione: un’acqui-sizione che non va mai data per scontata, oggetto di contrattazioni che lascia-no tracce da saper riconoscere, anche per il semplice mantenimento dellostatus quo. Si possono così seguire le onde brevi e lunghe della politica e sipossono non solo riconoscere articolazioni e snodi del rapporto centro-peri-feria (e il centro può essere la sede dell’amministrazione di una grande azien-da agricola o la città a capo di uno stato), ma forse anche rimeditare e relati-vizzare queste medesime nozioni di centro e di periferia: avviene spesso infat-ti che si tenda a riconoscere vera e rilevante capacità di iniziativa solo alprimo termine del binomio.
Al giusto e necessario riconoscimento delle specificità locali, di una ric-chezza di combinazioni non comprimibile, occorre ovviamente in prospettivaabbinare una sintesi condotta con efficaci formulazioni, che tengano conto dibacini territoriali di un certo respiro, in senso giurisdizionale, economico eanche latamente culturale: se con l’indagine su Rezzo si sono voluti propor-re, anzi riproporre, gli schemi per una comparazione intercomunitaria e peruna rigorosa contestualizzazione13 è anche perché la medievistica accademi-
11
Introduzione
11 Vere e proprie perorazioni in questo senso in A. Torre, Premessa a Pratiche del territorio, acura di Id., “Quaderni storici”, 35 (2000), 103, pp. 3-10, e Id., La produzione storica dei luoghicit., con tutti i necessari rimandi a precedenti lavori E. Grendi, D. Moreno e O. Raggio.12 Richiamo quanto ha formulato (in una prospettiva più urbanocentrica) da G. Rossetti, Civiltàurbana e sistema dei rapporti nell’Europa del Medioevo e della prima età moderna: una pro-posta di ricerca, in Spazio, società e potere nell’Italia dei comuni, a cura di Ead., Napoli 1986(Europa mediterranea, Quaderni, 1), pp. 309-311.13 Ho provato ad applicare al contesto regionale ligure quanto già sperimentato in P.Guglielmotti, Comunità e territorio. Villaggi del Piemonte meridionale, Roma 2001 e metodo-logicamente formulato nell’Introduzione; e si veda comunque E. Grendi, Il Cervo e laRepubblica. Il modello ligure di antico regime, Torino 1993, p. IX.
-
ca ligure non si è di recente cimentata sul tema delle comunità14. Più com-plessivamente, i secoli XIV e XV sono ancora in sofferenza di storia locale,perché risultano pochi gli interventi e le monografie degli ultimi anni chesuperino il secolo XIII15. E questo è in parte il motivo, oltre all’indubbialunga diacronia adottata, per cui per trattare di un “normale” villaggio comeRezzo è occorso, come si vedrà, tanto spazio, essendo difficile richiamare perdifferenza o analogia qualche dinamica già esplorata.
Non è sempre facile presentare in maniera gratificante e appetibile, esenza brutali semplificazioni, processi complessi. Ma forse c’è da impararequalcosa dal buon successo a livello di larga divulgazione e dei manuali sco-lastici della formula dell’incastellamento a trent’anni dalla sua elaborazio-ne16 rispetto ad esempio a “processo di localizzazione dei poteri”: l’incastel-lamento è ormai spesso inteso come il motore unico, lo strumento ubiquita-rio della trasformazione delle forme del potere e dell’habitat successiva aquelle di età carolingia, senza aver ancora del tutto eroso l’onnipresenza delfeudo. Resta dunque aperto un problema di comunicazione storiografica e didivulgazione. Si può tuttavia senz’altro sottolineare che, se un tratto unifi-cante si vuole trovare alle ricerche qui presentate, è proprio la constatazio-ne di bassa visibilità e di scarsa efficacia dell’incastellamento, in specie per icondizionamenti esercitati dalle fortificazioni sul territorio vicino. Così è in
12
Ricerche sull'organizzazione del territorio nella Liguria medievale
14 La storiografia di lingua francese ha però prodotto la tesi di dottorato di F. Robin, SestriLevante: un bourg de la Ligurie génoise au XVe siècle (1450-1500), Genova 1976 (Collana sto-rica di fonti e studi, 21): un caso con caratteristiche opposte a quelle del villaggio di Rezzo, a par-tire dal fatto che si trova sul mare e dipende direttamente da Genova.15 Nonostante l’energico e circostanziato scrollone dato ormai più di dieci anni fa da E. Grendi,Storia di una storia locale: perché in Liguria (e in Italia) non abbiamo avuto una local history?,in “Quaderni storici”, 28 (1993), 82, p. 189: “due secoli importanti come il Trecento e ilQuattrocento rimangono ancora vistosamente scoperti”, segnalando tuttavia l’eccezione costi-tuita da G. Petti Balbi, Simon Boccanegra e la Genova del ‘300, Milano 1995. Adesso si possonoaggiungere, senza alcuna pretesa di condurre una rassegna sistematica, i contributi di V. Polonioripresi nel suo volume Istituzioni ecclesiastiche della Liguria medievale, Roma 2002 (Italiasacra, Studi e documenti di storia ecclesiastica, 67) e S. Macchiavello, Sintomi di crisi e annun-ci di riforma (1321-1520), in Il cammino della Chiesa genovese dalle origini a i giorni nostri, acura di D. Puncuh, Genova 1999 (“ASLI”, n. s., 34 [113], 2), pp. 211-264, e G. Petti Balbi, Tradogato e principato: il Tre e Quattrocento, in Storia di Genova. Mediterraneo, Europa,Atlantico, a cura di D. Puncuh, Genova 2003, pp. 233-324. Trattano di una fase precedente irecentissimi R. Ricci, Poteri e territorio in Lunigiana storica (VII-XI secolo). Uomini, terra epoteri in una regione di confine, Spoleto 2002 (Istituzioni e società, 2); e P. G. Embriaco,Vescovi e signori. La chiesa albenganese dal declino dell’autorità regia all’egemonia genovese(secoli XI-XIII), Bordighera-Albenga 2004 (CSOL, 30). Si dispone da breve anche della Storia diGenova. Mediterraneo, Europa, Atlantico, a cura di D. Puncuh, Genova 2003, di cui vannoricordati in particolare i saggi di V. Polonio, Da provincia a signora del mare. secoli VI-XIII, pp.111-231, e G. Petti Balbi, Tra dogato e principato: il Tre e Quattrocento, pp. 233-324.16 P. Toubert, Les structures du Latium médiéval, Rome 1973, 2 voll., che ha fornito argomentie termini di confronto per una letteratura veramente cospicua di cui non si può ovviamente darconto in questa sede.
-
particolare per il territorio circostante Genova, quasi sgombro da castelli:ebbene, nella val Bisagno in avanzato secolo XI si rinuncia consapevolmen-te a esercitare pieni poteri dal castello vescovile. Così in parte appare nelcorso del secolo XII per le fortificazioni nella Riviera di levante, vuoi fonda-te da Genova, con qualche fallimento, vuoi precocemente inquadrate dallacittà, in quanto strutture che non hanno dato adeguata sostanza a poteriautonomi. E’ quanto si constata con agio – ma quasi non potrebbe esserealtrimenti – per le zone dove sono fondate villenuove per iniziativa signori-le nel secolo XIII e dove i castelli preesistenti hanno forse avuto la funzionedi controllo e orientamento dei transiti, di protezione alla vicina pieve, didare volto al tempo stesso concreto e simbolico al potere locale17, ma nonhanno saputo o voluto attrarre popolazione. Anche il villaggio di Rezzo, infi-ne, è teatro di relazioni tra contadini e signori che sfuggono agli schemi piùpropagandati: qui fallisce il tentativo tardissimo (fine secolo XV) di riorga-nizzare le relazioni locali facendo perno su un castello, che pare il primocostruito in loco e che è presto smantellato.
Le ricerche qui raccolte concordano dunque con un’esigenza sempre piùavvertita: quella di rivisitare e rimodulare il tema dell’incastellamento, rivol-gendosi alle fortificazioni come strutture di cui occorre ricostruire, singolar-mente e collettivamente, una più minuta cronologia delle fasi costruttive,delle finalità specifiche e delle effettive proiezioni all’intorno. Il contesto ligu-re è idoneo per una simile prospettiva di ricerca, perché sotto il profiloarcheologico si sta procedendo a una ricognizione sistematica dei luoghi inca-stellati in età medievale, a partire dall’attuale Provincia di Genova18.
Sono qui riproposti come Capitoli I, II e III, con minime correzioni e integrazioni,
lavori già pubblicati in altra sede, mentre il capitolo IV è inedito.
- Definizioni di territorio e protagonisti politici e sociali a Genova nei secoli X-XI, in
Comuni e memoria storica. Alle origini del comune di Genova, Atti del convegno di
studi, Genova 24-26 settembre 2001, Genova 2002 (= “Atti della Società Ligure di
Storia Patria”, n. s., 42 [116], 1), pp. 299-327.
- Genova e i luoghi di nuova fondazione nella Liguria di Levante del secolo XII, in
Borghi nuovi e borghi franchi nel processo di costruzione dei distretti comunali
13
Introduzione
17 C. Wickham, La montagna e la città. L’appennino toscano nell’alto medioevo, Torino 1997(ed. or. Oxford, 1988), pp. 323-324.18 Nell’ambito delle iniziative coordinate dalla cattedra di Archeologia Medievale dell’Universitàdi Genova; aperture metodologiche in L’incastellamento in Liguria. X-XII secolo. Bilancio edestini di un tema storiografico, a cura di F. Benente, Bordighera 2000, in specie in Id.,L’incastellamento in Liguria. Bilancio e destini di un tema storiografico, pp. 17-69. A breve lapubblicazione degli atti del convegno Castelli e insediamento rurale fra conoscenza e valoriz-zazione. Cherasco, 27-28 settembre 2003, a cura del Centro internazionale di studi sugli inse-diamenti medievali.
-
nell’Italia centro-settentrionale (secoli XII-XIV), a cura di R. Comba, F. Panero e G.
Pinto, Cherasco-Cuneo 2002 (Insediamenti e cultura materiale, 1), pp. 257-269.
- Nuove fondazioni signorili nella Liguria duecentesca, in Semifonte in Val d’Elsa e i
centri di nuova fondazione dell’Italia medievale. Atti del Convegno nazionale di
Barberino Val d’Elsa, 12-13 ottobre 2002, Firenze 2003, a cura di P. Pirillo, pp. 65-100.
Si ringraziano curatori ed editori per aver consentito la pubblicazione.
Le carte costituiscono una rielaborazione, ad opera di Fabrizio Benente, che ringrazio,
dei tipi cartografici della Regione Liguria.
-
I. Definizioni di territorio e protagonisti politici e sociali a Genova nei secoli X-XI
Secondo quanto è stato ripetutamente chiarito negli ultimi decenni, nonpiù di undici vescovi dell’Italia centro settentrionale, nell’ampio arco di tempocompreso tra il 962 e il 1159, risulterebbero destinatari di diplomi imperialicon cui sia loro riconosciuto, con tutta la solennità di rito, il districtus nellaloro città e nell’area extraurbana compresa nel circuito di un certo numero dimiglia dalle mura. In quanto titolari della chiesa matrice e in quanto capaci diesercitare un’egemonia politica nella loro città e all’intorno, tali vescovi si tro-vano così a svolgere con pieno riconoscimento prerogative di qualità comitale,contribuendo in maniera decisiva alla disgregazione dell’assetto circoscrizio-nale di origine carolingia1. Gli undici diplomi permettono di constatare inquale modo fosse quasi geometricamente individuato un preciso territorio enon è forse superfluo ricordare subito che questa documentazione, di notevo-lissimo interesse per il destinatario, deve lasciare traccia di sé, quantomeno incopia2. Alla misurata emanazione di simili diplomi concorrono sia una com-plessa valutazione di opportunità da parte imperiale, sia la capacità di solleci-tazione da parte dei vescovi e degli ambienti sociali che essi rappresentano;non di rado la concessione avviene, come è stato ipotizzato ad esempio daAlfred Haverkamp e da Vito Fumagalli, per controbilanciare una persistenzadel potere comitale3. Ciò non esclude naturalmente il fatto che altri vescovi sisostituiscano senza prese d’atto formalizzate ai conti e ai loro epigoni nel con-trollo cittadino o che ricevano concessioni di altro genere.
15
1 Si veda, ad esempio, E. Dupré Theseider, Vescovi e città nell’Italia precomunale, in Vescovi ediocesi in Italia nel Medioevo (sec. IX-XIII). Atti del II Convegno di storia della Chiesa in Italia,Roma, 5-9 settembre 1961, Padova 1964, pp. 55-109; A. Haverkamp, Die Städte im Herrschafts-und Sozialgefüge Reichsitaliens, in “Historische Zeitschrift”, n. F., 7 (1982), in particolare pp.166 sgg.; V. Fumagalli, Il regno italico, Torino 1986, pp. 292 sgg.; P. Racine, Città e contado inEmilia e Lombardia nel secolo XI, in L’evoluzione delle città italiane nell’XI secolo, a cura di R.Bordone e J. Jarnut, Bologna 1988 (Annali dell’Istituto storico italo germanico, Quaderno 25),pp. 99-136.2 Si veda anche P. Cammarosano, Italia medievale. Struttura e geografia delle fonti scritte,Roma 1991, p. 65.3 Haverkamp, Die Städte cit., pp 178 sgg.; Fumagalli, Il regno italico cit., pp. 292-295, ma ancheDupré Theseider, Vescovi e città cit., pp. 76 sgg.
-
Nessuna città ligure e perciò nemmeno Genova, come è noto, rientra traquesta dozzina di casi accertati, peraltro concentrata in Lombardia, in Emiliae nell’area subalpina. Sotto questo punto di vista la “normale” situazionegenovese è dunque condivisa da un buon numero di città, anche di grandetaglia: basti pensare al caso illustre e ben studiato di Milano e dei suoi poten-ti vescovi4. Per quanto riguarda Genova occorre ulteriormente ricordare chegli interventi del regno risultano del tutto eccezionali e che in particolare nonpossiamo fare affidamento su conferme patrimoniali e concessioni di immu-nità a enti ecclesiastici. Assimilabili a dettagliati inventari, simili diplomi sirivelano essenziali per leggere in quale modo fosse interpretato il territorio5.Come nell’età precedente, anche i destinatari di queste concessioni nei seco-li X e XI sono spesso monasteri, ma quando i privilegi sono rilasciati a van-taggio proprio della chiesa vescovile costituiscono di solito preludio alla con-cessione del districtus, di quel potere che poi dà nome al territorio stesso sucui può essere esercitato: è il caso ad esempio della non lontana Asti6.
Per osservare come, tra il secolo X e l’XI, Genova nelle sue diverse com-ponenti sociali e politiche e pochi altri soggetti esterni, per lo più con lamediazione di chi redige gli atti, concretamente avvertano il territorio circo-stante e intendano intervenirvi, disponiamo di un complesso documentariodi circa duecentocinquanta atti, che non offre quel tipo di punti di riferimen-
16
Ricerche sull'organizzazione del territorio nella Liguria medievale
4 Mi limito a rimandare a C. Violante, La società milanese nell’età precomunale, Roma 1953,Parte seconda. Accenno solo al fatto che da ultimo anche G. Ortalli, Venezia-Genova: percorsiparalleli, conflitti, incontri, e G. Zordan, La nascita dei due comuni: proposte metodologicheper un confronto, in Genova, Venezia, il Levante nei secoli XII-XIV. Atti del convegno interna-zionale di studi (Genova-Venezia, 10-14 marzo 2000), a cura di G. Ortalli e D. Puncuh, Genova2001 (= “ASLI”, n. s., 41 [115], 1), rispettivamente alle pp. 9-27 e 29-57, hanno ammonito a nonconsiderare come separate ed esclusive le storie di Genova e Venezia. Cfr. più in generale DieFrügeschichte der europäischen Stadt in 11. Jahrhundert, a cura di J. Jarnut e P. Johanek, Köln-Weimar-Wien 1998 (Städteforschung. Veröffentlichungen des Instituts für vergleichendeStädtegeschichte in Münster). Almeno due presuli genovesi, comunque, in teoria avrebberomodo di ottenere direttamente un privilegio imperiale. Giovanni II nel 1001 è presente a Pavia aun placito presieduto da Ottone III, mentre Landolfo, forse nel 1019, partecipa a Strasburgo aun’assemblea presieduta da Enrico II: V. Polonio, Tra universalismo e localismo: costruzione diun sistema (569-1321), in Il cammino della Chiesa genovese dalle origini a i giorni nostri, a curadi D. Puncuh, Genova 1999 (“ASLI”, n. s., 34 [113], 2), p. 89.5 Si ha tuttavia asciutta ma solenne notizia di “privilegia” di Ottone (senza ulteriore specificazio-ne) e di Berengario di semplice conferma relativi a “possessiones et curtes” della Chiesa diGenova che sarebbero stati letti pubblicamente nel 1189, in occasione della ricollocazione delcorpo del patrono cittadino, il beato Siro, in prossimità dell’altare della chiesa di S. Lorenzo dopol’esecuzione di alcuni restauri pavimentali: Il Registro della Curia arcivescovile di Genova, acura di L. T. Belgrano, Genova 1862 (“ASLI”, 2/2), doc. 18 dei documenti riguardanti le proprie-tà e i diritti della Curia arcivescovile, pp. 411-412. Sulla qualità dell’informazione pesa non poco,come è ovvio, il clima celebrativo del momento.6 Si veda la bibliografia citata alle note precedenti e R. Bordone, Città e territorio nell’altomedioevo. La società astigiana dal dominio dei Franchi all’affermazione comunale, Torino1980 (BSS, 200).
-
to ed è prevedibilmente molto omogeneo, data la selettiva tradizione archivi-stica delle chiese: così, in una documentazione in larga parte privata occorre-rà reperire tracce anche dell’ordinamento pubblico e delle sue trasformazio-ni. Ne emerge una variegata definizione del territorio: nel senso sia della ter-minologia impiegata, sia delle funzioni con cui si intende caratterizzare unadeterminata zona, sia infine, ma in modo più sfumato, dell’individuazione edel ritaglio. Su questo insieme che ci appare composito e segmentato il nuovoorganismo politico, il cui lento assestamento tra fine del secolo XI e il quartodecennio del successivo è stato illustrato da Renato Bordone7, interverrà ispi-rando la propria gestione, laddove possibile, a criteri più unitari.
Dell’eredità che quegli eterogenei protagonisti raccolgono dai secoli pre-cedenti non molto possiamo ricavare: è stato un campo sondato in annirecenti soprattutto da Romeo Pavoni, nel giusto sforzo di fissare tappe edirettrici dello sviluppo del potere cittadino in senso territoriale, e da ValeriaPolonio, con particolare attenzione per le presenze ecclesiastiche8. Mentrecercherò di individuare attraverso le fonti dell’età precomunale che cosa siapervenuto dalle fasi precedenti, rinuncerò intenzionalmente, il più possibile,a leggere in senso regressivo la documentazione del secolo XII: sia per nonreplicare quanto è già stato proposto, sia per accertare, anche semplicemen-te constatando, quali risultati concreti, inseriti nel loro immediato contesto, isecoli qui in esame effettivamente consegnino all’età successiva. Leggere conuna certa sistematicità il territorio significa fare emergere quali siano i sog-getti davvero interessati a incidervi. È un dato che – pur con tutti i limiti deri-vanti dalle nostre fonti – può rivestire notevole interesse per un periodo incui altri protagonisti della vita cittadina (e forse in parte i medesimi) scelgo-no di investire già almeno dai primi decenni del secolo X le proprie fortunenei commerci, sul duplice fronte occidentale e orientale9: questa di certo èuna notevole differenza rispetto alla gran parte delle città italiane.
17
I. Definizioni di territorio e protagonisti politici e sociali a Genova nei secoli X-XI
7 R. Bordone, Le origini del comune di Genova, in Comuni e memoria storica. Alle origini delcomune di Genova. Atti del convegno di studi, Genova 24-26 settembre 2001, Genova 2002 (=“ASLI ”, n. s. 42 [116], 1), pp. 237-259.8 Di Pavoni, oltre a Liguria medievale. Da provincia romana a stato regionale, Genova 1992, sivedano i saggi citati alle note successive; di Polonio, oltre a Tra universalismo e localismo cit.,dove si rinvia a studi precedenti dell’Autrice, segnalo anche – per attenzione ai problemi ogget-to della presente ricerca – Le circoscrizioni territoriali nella Liguria medievale: modulo eccle-siastico o civile?, in “Rivista di studi liguri”, 50 (1964), pp. 177-181. Spunti interessanti per i pro-blemi oggetto della presente indagine in A. Mailloux, Perception de l’espace chez les notaires deLucques (VIIIe-IX siècle), in “Mélanges de l’École française de Rome, Moyen Âge”, 109 (1997),1, pp. 21-57, anche se l’attenzione è qui rivolta, come già il titolo denuncia, più al dato topografi-co che a quello politico. Valga in generale anche il riferimento a P. Vaccari, La territorialità delpotere come base dell’ordinamento giuridico del contado nell’Italia medievale, Milano 1963.9 Sono tendenze note, perciò mi limito a rinviare, per quanto riguarda le precoci aperture versol’Oriente, a recenti lavori di B. Z. Kedar, Mercanti genovesi in Alessandria d’Egitto negli anni
-
1. Il comitatus Ianuensis
Percorreremo innanzitutto la strada, obbligata, di seguire quali siano leoccorrenze delle espressioni e dei termini usati per la localizzazione dei beniimmobili. Paolo Cammarosano ha scritto recentemente che la definizionegeografica, molto schematizzando, può articolarsi per l’età altomedievale suquattro diversi livelli, indicati per praticità come “ ‘territoriale’, ‘circoscrizio-nale’, ‘insediativo’, ‘agrario’ ”, senza che comunque si possa parlare – di que-sto è necessario tenere ben conto – di una terminologia consolidata10. Nellefonti liguri l’ubicazione dei beni fondiari non è mai data ricorrendo simulta-neamente a tutti questi livelli, che credo rara anche in altre regioni italiane.Occorre riconoscere preliminarmente che le molte puntuali ricognizioni diRomeo Pavoni esimono da un’individuazione di genere topografico.Cominciamo perciò a fermare l’attenzione sull’occorrenza di termini cheesprimono il maggior impianto circoscrizionale maturato nell’età precedente,quello centrato sulla città, il cui territorio può essere in linea di massima indi-cato con riferimento al comitato o alla diocesi.
Risulta del tutto sporadico nei secoli X e XI il riferimento al comitatus diGenova, la circoscrizione che Pavoni ha dimostrato (anche utilizzando fontidel secolo XII) ricalcare nelle grandi linee, come è frequente, il disegno delladiocesi11. Sono otto occasioni in tutto, fatto di per sé già abbastanza eloquen-te. Le attestazioni di età carolingia relative a Genova segnalano l’indiscussavitalità cittadina ma non lasciano certo intuire come si articoli il legame delcentro urbano con il territorio. In breve, i futuri docenti genovesi rientrano
18
Ricerche sull'organizzazione del territorio nella Liguria medievale
Sessanta del secolo XI, in Miscellanea di studi storici, II, Genova 1983 (Collana storica di Fontie Studi diretta da Geo Pistarino, 38), pp. 21-29, e Una nuova fonte per l’incursione musulmanadel 934-935 e le sue implicazioni per la storia genovese, in Oriente e Occidente tra Medioevo edetà moderna. Studi in onore di Geo Pistarino, a cura di L. Balletto, Genova 1997, II (Universitàdegli studi di Genova - Sede di Acqui Terme, Collana di Fonti e Studi, 1.2), pp. 605-616.10 Cammarosano, Italia medievale cit., pp. 74-75.11 La circoscrizione sarebbe stata “evidentemente… uno dei primi comitati istituiti dai Carolingiin Italia, erede di una circoscrizione longobarda di cui purtroppo non si conosce praticamentenulla”: R. Pavoni, Dal Comitato di Genova al comune, in La storia dei Genovesi. Atti delConvegno di Studi sui Ceti Dirigenti nelle Istituzioni della Repubblica di Genova, Genova 12-14aprile 1984, V, Genova 1985, pp. 151-175 (la citazione è a p. 151), con l’integrazione fornita in Id.,Organizzazione del territorio genovese nei secoli X-XIII, in “RII”, n. s., 40 (1985), fascc. 1-3, pp.5-12, in specie p. 5 n. Ha parlato di “una rivalutazione della terminologia circoscrizionale” neldiploma di Federico II del 1162 relativo alla vicina Savona, ma sottolineando come “la memoriadella circoscrizione … non è accompagnata da un riferimento ai confini”, L. Provero, Dai mar-chesi del Vasto ai primi marchesi di Saluzzo. Sviluppi signorili entro quadri pubblici (secoli XI-XII), Torino 1992 (BSS, 209), p. 159. Per un esempio di rinuncia a valutare anche sotto l’aspettostrettamente circoscrizionale una fase ben precedente a quella adesso in esame, si veda A.Schwarcz, Die Liguria zwischen Goten, Bizantinern, Langobarden und Franken im 6.Jahrhundert, in Oriente e Occidente tra Medioevo ed età moderna cit., II, pp. 1109-1131.
-
fra quanti sono tenuti a gravitare su Pavia per apprendere la giusta dottrina,come prescrive il capitolare emanato da Corteolona dell’82512. Oltre che inLiguria, il vescovo Sabatino, personaggio di notevole intraprendenza, neglianni Settanta del secolo IX partecipa a un sinodo e soprattutto è presente,forse in quanto suffraganeo dell’arcivescovo di Milano, ma comunque in qua-lità di unico rappresentante della città, all’assemblea in cui si elegge Carlo ilCalvo a re d’Italia13.
Guardiamo allora piuttosto ad Ademaro, identificato quale “comes civita-tis Genuae”, che nell’806 perde la vita nella spedizione organizzata da rePipino contro i Saraceni che devastano la Corsica. Quest’enfasi sulla civitas èeccezionale negli Annales regni Francorum, dove in tutti gli altri casi – pro-prio come tramandano i coevi diplomi – al titolo di conte è apposto sempli-cemente l’aggettivo derivante dal nome della città cui l’ufficiale è preposto;oppure si indica solo che un tal personaggio è un conte, così chiarendone ilrango e caratterizzandolo come ufficiale a disposizione dei sovrani14. Il rilie-vo che pare attribuito alla sola civitas, quasi disgiunta dal territorio, nonandrebbe tuttavia caricato di eccessivo significato, ricavato com’è da un testoche non sappiamo a quali fonti attinga.
Non occorre nemmeno dare per scontate, peraltro, realtà simili attorno aciascuna città dell’Italia settentrionale, che rientri o meno nel regno italico,per una sorta di tradizione non scalfibile di rapporti tra il centro e una suaideale circoscrizione: il caso di Bologna, probabilmente di minor peso rispet-to a Genova e ben indagato da poco anche per l’età carolingia, mostra unacittà – mai sede di comitato perché nell’ambito dell’autorità della Chiesaravennate – che non va oltre un legame assai lasco con il territorio subito cir-costante15. Che da metà secolo X, dal 955, il comitato di Genova rientri tra lemolte circoscrizioni dell’Italia settentrionale attribuite al marchese Oberto èvicenda ripetutamente ripercorsa dagli studiosi, anche in anni recenti16.
19
I. Definizioni di territorio e protagonisti politici e sociali a Genova nei secoli X-XI
12 I capitolari italici. Storia e diritto della dominazione carolingia in Italia, a cura di C. Azzarae P. Moro, Roma 1998, doc. 26, p. 127.13 Un profilo del prelato e un’analisi della sua attività in Polonio, Tra universalismo e localismo cit.,pp. 84-86, cui rimando anche per la notizia che nella primavera dell’878 Giovanni VIII, diretto inFrancia, transita da Genova dopo aver lasciata Roma per le violenze provocate da Lamberto diSpoleto. Si veda anche S. Origone, Bisanzio e Genova, Genova 1997, p. 27.14 MGH, Scriptores, Annales regni Francorum et annales q. d. Einhardi, a cura di G. H. Pertz e F.Kurze, Hannoverae 1895, ad annum, p. 122; sul fatto che quanti sono qualificati come conti nonsiano sempre necessariamente preposti al governo di un comitato si è pronunciato P. Cammarosano,Nobili e re. L’Italia politica dell’alto medioevo, Roma-Bari 1998, pp. 180-181 (un accenno per l’etàprecedente anche in F. Prinz, Clero e guerra nell’alto medioevo, Torino 1994, p. 67).15 T. Lazzari, “Comitato” senza città. Bologna e l’aristocrazia del territorio nei secoli IX-XI,Torino 1998; si veda anche G. Sergi, Le città come luoghi di nozioni pubbliche del potere. Le areedelle marche di Ivrea e di Torino, in Piemonte medievale. Forme del potere e della società. Studiper Giovanni Tabacco, Torino 1985, pp. 5-27.16 Rimando perciò, rinunciando a proporre una completa rassegna storiografica, a Pavoni,
-
Per quanto raro, il riferimento a comitatus avviene per località vuoi vici-ne alla città vuoi ben più distanti: converrà piuttosto distinguere tra le ottomenzioni, che cadono tra il 999 e il 1059 – e si esauriscono quando ci si avvi-cina alla fase di governo cittadino che poi matura nella forma comunale –quelle che si devono a protagonisti della vita ligure da quelle fatte da attoriesterni, che sono inclini, forse per un banale motivo di praticità e di inerzianelle formulazioni, a dare evidenza al dato istituzionale più “tradizionale”,anche se certo non sono ignari dell’evoluzione degli assetti politici e territo-riali. Proprio la più antica citazione, che stentiamo a interpretare quale rico-noscimento di una realtà circoscrizionale ancora pienamente operante, è leg-gibile grazie all’intervento di un protagonista non solo esterno ma di assolu-ta autorità. Nel 999 l’imperatrice Adelaide dona a S. Fruttuoso diCapodimonte, a una ventina di chilometri a est dalla città in linea d’aria, unaterra, forse nei pressi di Brugnato. Il notaio imperiale che redige il diplomasceglie per indicare esclusivamente la dislocazione del monastero di specifi-care che è “constructum in comitatu Genuensi, prope litus maris”17, maaccentuando così l’aspetto più geografico e meno politico della circoscrizione.Nel 1045 è il vescovo di Pavia che nel confermare alla basilica di S. GiovanniDominarum, della sua città, gli sparsi beni che possiede cita anche “in SanctoCipriano capellam unam”, con riferimento al “comitatus Ianuae”, che in que-sto contesto non può che apparirci come un mero contenitore18.
Un’altra menzione in realtà ha quasi carattere ibrido se consideriamo nonle presenze in Liguria, bensì in città: si deve infatti a un marchese della dina-stia obertenga, che nel suo complesso vi pare ben poco presente, se ci fondia-mo sul fatto che un solo suo esponente – stando alle nostre fonti – è attesta-to in un’unica occasione a Genova, dove nel 1039 amministra la giustizia tral’altro non in un suo palazzo, bensì “in via publica ipsius civitatis”, confer-
20
Ricerche sull'organizzazione del territorio nella Liguria medievale
Liguria medievale cit., pp. 176 sgg. Per una sintesi della storia familiare si veda, oltre ai saggi diM. Nobili citati alle note successive, anche Id., Formarsi e definirsi dei nomi di famiglia nellestirpi marchionali dell’Italia centro-settentrionale: il caso degli Obertenghi, in Nobiltà e chiesenel Medioevo e altri saggi. Scritti in onore di Gerd G. Tellenbach, a cura di C. Violante, Roma1993, pp. 77-97.17 Cartario genovese ed illustrazione del Registro arcivescovile, a cura di L. T. Belgrano, in“ASLI”, 2 (1870-1873), 1-3, doc. 27, pp. 44-50 (qui e nei casi successivi ho tenuto conto, quandonecessario, delle correzioni alle date indicate dagli editori dei documenti di origine sicuramentegenovese proposte da M. Calleri, Gli usi cronologici genovesi nei secoli X-XII, in “Atti dellaSocietà Ligure di Storia Patria”, n. s., 39/1, 1999, pp. 25-100).18 Cartario genovese cit., doc. 118, p. 158. Questa cappella è attestata quale donazione regia giànel 909 e proprio la sua antica inclusione nel patrimonio dell’ente può aver confermato l’oppor-tunità di richiamarsi alla distrettuazione di origine carolingia, di cui tuttavia non si fa menzione,nonostante il riferimento alla città, proprio nell’atto del 909: “in loco qui dicitur Sancti Ciprianicapellam unam cum domo coltili et mansos quatuor et cum omni sua pertinentia, in Segestriquandam absentem terram, similiter in Levarnia et in Caurani ac infra civitatem Genuensem” (Idiplomi di Berengario, a cura di L. Schiaparelli, Roma 1903, FSI, doc. 69, pp. 185-188).
-
mando una donazione effettuata sedici anni prima dai coniugi Lamberto eOza al monastero di S. Siro19. Del resto da parte della dinastia non è nemme-no stretto, a quanto pare, alcun legame significativo con gli enti ecclesiasticicittadini, perché per valutare questo rapporto possiamo far conto esclusiva-mente su due donazioni di modesta entità, che segnalano un rapporto diequidistanza dai due monasteri più importanti. La prima si deve al marcheseOberto, figlio del fu Oberto, a favore ancora del cenobio di S. Siro, che nel1014 ha per oggetto una vigna situata fuori dalle mura cittadine20. La secon-da donazione, attuata dal marchese Alberto, figlio del fu Alberto, a favore del-l’altro importante monastero, S. Stefano, nel gennaio 1033 riguarda una terrae un prato non nell’immediato circondario urbano, bensì a Carasco, nelLevante21. Nel giugno 1033 Adalberto e sua moglie fondano dunque il mona-stero di Castiglione, nei pressi dell’attuale Fidenza in diocesi di Parma,lasciando enumerare al notaio Anno, la cui sottoscrizione è seguita da quelladi altri due notai, anche una quota dei beni che hanno “infra civitatem…Ianuensis” (così come leggiamo nella trascrizione muratoriana) e decimesulle loro proprietà tutte nel Levante, cioè a Quinto, Rapallo, Lavagna, Sestri,Moneglia, Carrodano, “infra comitatus Ianuensis”: due espressioni che ricor-rono tuttavia simili per altre quattro città e per altri tredici comitati dell’Italiasettentrionale, in cui la presenza familiare è quanto meno diseguale. In que-sto “impressionante inventario” dei beni obertenghi le realtà dei diversicomitati appaiono così indifferenziate ma comunque accomunate – agli occhidegli autori del documento – da una distinzione se non da una separazionetra città e territorio22.
Sospendiamo questa analisi per assumere una diversa prospettiva.Grazie al citatissimo diploma pavese, che data 958, vediamo infatti un’altra
21
I. Definizioni di territorio e protagonisti politici e sociali a Genova nei secoli X-XI
19 Le carte del monastero di San Siro di Genova (952-1224), I, a cura di M. Calleri, Genova 1997(FSL, 5), doc. 38, pp. 66-67. Per un confronto con le dinastie marchionali subalpine che svilup-pano un differenziato rapporto con le città da loro governate si veda G. Sergi, I confini del pote-re. Marche e signorie fra due regni medievali, Torino 1995, pp. 39-55.20 Le carte del monastero di San Siro cit., doc. 21, pp. 37-38.21 HPM, Chartarum, I, Torino 1836, doc. 291, col. 501, su cui anche E. Basso, Un’abbazia e lasua città. Santo Stefano di Genova (sec. X-XV), Torino 1997, p. 18. Al contrario, il coinvolgi-mento con un ente dell’estremo Levante ligure, il monastero di S. Venerio del Tino, pare più con-sistente, se lo misuriamo, ad esempio, anche solo sulla base della più corposa donazione del mar-chese Oberto, figlio del fu Alberto, che data 1056 e che ha per oggetto beni immobili situati in tredistinte località verosimilmente non distanti dalla sua sede (Le carte del monastero di SanVenerio del Tino, a cura di G. Falco, Torino 1920, BSSS, 91, doc. 11, pp. 14-16).22 L. A. Muratori, Delle antichità estensi, Modena 1717, I, p. 98 (da cui riprendono tutte le edi-zioni a me note, come Cartario genovese cit., doc. 107, p. 150, e Documenti genovesi di Novi eValle Scrivia, a cura di A. Ferretto, Pinerolo 1909, BSSS, 51, doc. 11. pp. 10-12); M. Nobili, Alcuneconsiderazioni circa l’estensione, la distribuzione territoriale e il significato del patrimoniodegli Obertenghi (metà secolo X - inizio secolo XII), in Formazione e strutture dei ceti domi-nanti nel Medioevo: marchesi conti e visconti nel Regno italico (secc. IX-XII). Atti del primoconvegno di Pisa, 10-11 maggio 1983, Roma 1988 (Nuovi studi storici, 1), pp. 72 sgg.
-
più precoce interpretazione del territorio prossimo a Genova che ignora lanozione di comitatus e che ci avverte di come questo termine non possa piùessere usato nella pienezza del suo contenuto, di territorio di applicazione diuna giurisdizione tendenzialmente uniforme. Il punto di vista è quello allostesso tempo dei re Berengario e Adalberto e degli abitanti di Genova: que-sti ultimi superano così la rappresentanza che può essere offerta dal vesco-vo, che adesso è Teodolfo, assai energico almeno sul piano ecclesiastico23.Gli “habitatores in civitate Ianuensi” nel 958, cioè solo tre anni dopo l’attri-buzione anche del comitato genovese al marchese Oberto, ottengono daisovrani conferma di tutti i beni detenuti, a qualsiasi titolo, “infra et – quelche qui conta – extra civitatem”24. Nell’adottare una simile locuzione, cosìgenerica da non denunciare alcuna strutturazione forte dell’area periurba-na, i due re e il cancelliere Ulberto tengono infatti probabilmente conto dellaformulazione suggerita da “Hebo”, scelto dai Genovesi per sollecitare la con-cessione e che ai nostri occhi può essere identificato solo dal fatto di essereun “dilectus fidelis” dei sovrani.
Se osserviamo più nel dettaglio, da un lato il diploma mostra un territoriodai contorni imprecisi punteggiato dai beni in piena proprietà, livellari e tenu-ti in precaria, singolarmente, dagli abitanti della città, con tutte le loro perti-nenze citate in un elenco dal sapore omnicomprensivo e di tono prettamenterurale (“cum terris, vineis, pratis, pascuis, silvis…”); dall’altro il diploma pre-senta questo sparso territorio ricompattato e uniformato sul piano giurisdi-zionale sia dall’autorevole riconoscimento regio della consuetudine locale, siadall’inibizione a qualsiasi pubblico ufficiale di intervenire su tali beni, espres-sa nei termini altrimenti usuali delle immunità agli enti ecclesiastici. Questo èdavvero il territorio genovese, anzi dei Genovesi: un insieme composito su cuiil vescovo non ha una netta preponderanza, pur risultando anche le sue pro-prietà, affidate a concessionari, esenti da ogni altrui giurisdizione. Un insiemeche appare ben più concreto e identificabile dell’area che è più artificialmenteritagliata per altre città, con l’attribuzione al titolare della chiesa cattedrale deldistrictus per un certo numero di miglia dalle mura cittadine.
Riprendiamo l’analisi delle occorrenze. Nel 1018 sono gli appartenenti auna famiglia che sappiamo di origine viscontile, i figli del fu Ingo, quando nel1018 cedono a due donne (di cui una figlia di Oberto “Vicecomes”), alcunipossessi, si risolvono a ricordarli come situati “in comitatu Ianuense”,aggiungendo “et in valle Lavania vel in eorum territorio”, senza peraltro chesiano consigliati a descriverli più minutamente dal notaio, Ariberto, di cuinon ci sono noti altri atti. Per apprezzare meglio questa isolata menzione si
22
Ricerche sull'organizzazione del territorio nella Liguria medievale
23 Polonio, Tra universalismo e localismo cit., p. 87.24 I libri iurium della Repubblica di Genova, I/1, a cura di A. Rovere, Genova 1992 (FSL, 2), doc.1, pp. 4-5.
-
tenga conto che per il secondo decennio del secolo XI disponiamo di ben 48documenti che individuano dei possessi25. Simili personaggi, anche se non èben chiaribile l’origine delle loro funzioni pubbliche che vediamo svolgereesclusivamente in ambito urbano, sono di certo i più idonei a far riferimentoal comitatus. Balza tuttavia agli occhi come al termine comitatus seguano unriferimento prettamente geografico alla zona percorsa dal torrente Lavagna(che secondo il citato documento del 1033 rientra nel comitato genovese) epoi una di quelle specificazioni apparentemente ridondanti e tipiche delperiodo (“vel in eorum territorio”) che denunciano fluidità degli usi termino-logici, assetti di non certa definizione e la preoccupazione di fornire indica-zioni inequivocabili26.
In altre tre occasioni la scelta di far riferimento al comitato genovese perlocalizzare un frazionatissimo insieme di beni immobili è ascrivibile al mede-simo proprietario, Martino del fu Buonfiglio, che nel 1040 prima lo dà inpegno e poi promette di non venderlo ad altri che ad Alberto del fu Bruningo,che entra finalmente in possesso della sua metà sette anni dopo: le locuzioni“in comitatum Ianuensis” e “infra comitato Ianuensis”, per indicare terre dis-perse in una ventina di località ma tutte situate nella val Polcevera, a ovestdella città, si debbono infatti alla penna di due notai, roganti il primo a Cesinoe il secondo a Genova27. In val Polcevera, che pure offre un ventaglio di attra-versamenti appennici in direzione dell’area subalpina, non sono mai attesta-te presenze patrimoniali obertenghe e non è escluso che in questo contestocomitatus significhi ormai anche territorio nettamente extraurbano, quel ter-ritorio cioè che la storiografia definisce usualmente “contado”, in sostanza la“campagna” genovese. In questa come in altre cessioni, anche se si parla diterre tenute a livello, il quadro giurisdizionale di riferimento è per noi asso-lutamente opaco.
Infine, in un libello petitorio sottoscritto dal vescovo Oberto nel 1059 leg-giamo che la Chiesa genovese affida ad alcuni uomini un complesso di beni“infra comitatu Ianuensis”, in Lamanigra, presso Uscio, a meno di quindicichilometri in linea d’aria a est della città28. Quale che sia l’intenzione dei con-traenti, ammesso che scrivere comitatus in un documento che non ha gran-
23
I. Definizioni di territorio e protagonisti politici e sociali a Genova nei secoli X-XI
25 Cartario genovese cit., doc. 70, p. 101: si tratta di Rainfredo, Oberto suddiacono e Ido, figlidel fu Ingo, che cedono ad Anna, figlia del fu Oberto Vicecomes, e Teuza la metà dei beni diOberto. A costoro ha di recente rivolto attenzione G. Petti Balbi, I Visconti di Genova: identità efunzioni dei Carmadino (secoli XI-XII), in “Archivio storico italiano”, 158 (2000), pp. 684-685.26 Pavoni, Dal comitato di Genova al comune, p. 155, scrive che la valle di Lavagna è un distret-to minore del comitato di Genova.27 Hpm, Chartarum, I, doc. 113 del febbraio 1040, col. 350, e Le carte del monastero di San Sirocit., doc. 39 del febbraio 1040, pp. 68-69; doc. 42 dell’ottobre 1047, pp. 71-72. I notai sonoBonando e Oberto.28 ll Registro della Curia arcivescovile cit., doc. 99, pp. 278-279.
-
de risonanza pubblica rifletta una scelta fortemente meditata, l’uso appareormai residuale e l’ambito giurisdizionale cui è applicabile è sicuramentedecurtato del territorio cittadino. Lo ricorda il fatto che è adottata appena treanni dopo che il marchese Alberto, del ramo poi Malaspina, ha giurato dirispettare le consuetudini “habitantibus infra civitatem Ianue”, confermandoin sostanza le disposizioni regie del 95829. Nel 1056 è ancora previsto un pub-blico ufficiale, vale a dire il marchese, operante all’interno della città essen-zialmente per l’amministrazione della giustizia (ma come potrebbe esserediverso, data la forma della concessione che ha la conferma, attuata oltretut-to delegando tre “boni homines”?) Tuttavia ciò non pare intaccare la nozioneche ci è parsa emergere un secolo prima: è territorio di Genova quello su cuii suoi abitanti, che adesso sembrano piuttosto i grandi proprietari30, e perestensione anche le chiese, detengono possessi fondiari; chi lavora questeterre è esente dal fodro.
Il pieno potere giurisdizionale connesso al comitato nella sua forma piùtipica sembra adesso collegato soprattutto a quelle zone dove i marchesiobertenghi dispongono di una base patrimoniale consistente, come apparenella donazione al monastero di Castiglione del 103331, con una concentra-zione nel Levante, dove infatti si svolgono gli unici placiti di cui abbiamo noti-zia oltre a quello genovese: nel 994 Oberto II presiede a un’assise giudiziaria“in valle Lavanie” davanti alla pieve di S. Stefano, dove delibera a favore delmonastero di S. Fruttuoso per la riserva di caccia nel bosco di Dema32; nel1044 Alberto e Adalberto Azzo tengono giustizia a Rapallo, trattando nuova-mente di questo bosco33. Ciò può spiegare il termine che leggiamo in un’uni-ca e tarda occasione, in un documento rogato dal notaio Giovanni nel 1089,quando Ingo, figlio di Bonafiglia, dona a una nipote alcuni beni che gli sonoappena pervenuti dal prete Guido, descrivendoli come situati innanzitutto“infra marcha Ianuensis” e poi, come meglio vedremo in seguito, con riferi-mento ad altri toponimi nella valle di Lavagna34. Espressione in questo casonon tanto dell’autocoscienza marchionale, bensì di una percezione sicura-
24
Ricerche sull'organizzazione del territorio nella Liguria medievale
29 I Libri Iurium cit., I/1, doc. 2, pp. 6-9; sopra, doc. citato alla nota 24.30 Bordone, Le origini del comune di Genova cit., p. 24431 Sopra, nota 22. Proprio facendo base a Rapallo il marchese Alberto del fu Alberto ha da pocodonato, nel 1033, al monastero genovese di S. Stefano una terra e un prato in prossimità diCarasco (sopra, nota 21).32 I placiti del “Regnum Italiae”, a cura di C. Manaresi, II/1, Roma 1957 (FSL, 96), doc. 219, pp.306-307.33 I placiti del Regnum Italiae, a cura di C. Manaresi, III/1, Roma 1960 (FSL, 97), doc. 361, p.83; per situazioni opposte, in cui dalla città si esplicano funzioni giudiziarie chiaramente atte-state, è sempre valido il rimando a H. Keller, Der Gerichtsort in oberitalienischen und toskani-schen Städten, in “Quellen und Forschungen aus italienischen Archiven und Biblioteken”, IL(1969), pp. 1-72.34 Le carte del monastero di San Siro cit., doc. 64, pp. 104-106.
-
mente locale e non sappiamo quanto diffusa, “marcha” potrebbe significarein questo caso proprio il territorio su cui la presenza patrimoniale obertengapuò essere più concretamente avvertita e il riferimento a Genova quasi obbli-gato: ciò avverrebbe sia in mancanza di altri appigli che non suonino troppocircoscritti, sia in considerazione delle stesse aspirazioni obertenghe, che ren-dono in un certo senso obbligatorio il riferimento a una città, anche se nellafattispecie i marchesi vi hanno ormai rinunciato35. Si consideri inoltre chequesti sono gli anni in cui va organizzandosi il potere di quanti già si dicono,con assoluta certezza almeno dal 1076, conti di Lavagna: Giovanna Petti Balbiha ben chiarito le origini di questo raggruppamento signorile – l’unico chevediamo attivo nel secolo XI – che nell’assunzione del titolo comitale trovalegittimazione delle proprie ambizioni36. Anzi, che adesso si parli di una“marcha Ianuensis” sembra comunicare un mancato riconoscimento, e oltre-tutto proprio da parte di abitanti della zona, dei conti di Lavagna, nuovi pro-tagonisti della vita locale, attivi nel costruire una dominazione autonoma chesfalda il disegno dell’originario comitato genovese ed erode proprio il potereobertengo.
La documentazione genovese non reca traccia, nemmeno per il tardosecolo XI, di un altro uso di comitatus, quello più degradato che si ritrova disolito nella locuzione “cum omni contitu et iurisdictione” e che in altri conte-sti, talvolta cronologicamente più avanzati, qualifica una transazione in cui siottengano beni allodiali o liberi da gravami. È vero che le transazioni regi-strate nelle fonti non comportano concessioni giurisdizionali, ma la sensa-zione è anche quella di una scarsa ricezione della terminolgia che usualmen-te più evoca il sistema di potere di origine carolingia. Occorre però notare aquesto proposito che nel 1036 leggiamo come un appezzamento “in valleLavania”, tra i molti dati in affitto dalla Chiesa genovese, confini per due lati,se ci possiamo fidare della trascrizione, con “terra comitalis”37, posta perciòanche nella parte orientale di quello che si ritiene l’originario comitato: sonobeni fondiari – la cui qualità originaria è ancora ben presente a chi scrivesenza posporre nomi propri a quel “comitalis” – che dovevano costituire ladotazione dalla quale chi era a capo della circoscrizione traeva parte della
25
I. Definizioni di territorio e protagonisti politici e sociali a Genova nei secoli X-XI
35 È perciò da correggere, senza tuttavia che risulti sostanzialmente inficiato il discorso com-plessivo, quanto afferma Nobili, Alcune considerazioni cit., p. 72, secondo cui la prima menzio-ne di una marca Ianuensis cade solo nel 1164 (è trattato qui più distesamente quanto già espres-so in M. Nobili, L’evoluzione delle dominazioni marchionali in relazione alla dissoluzione dellecircoscrizioni marchionali e comitali e allo sviluppo della politica territoriale dei comuni citta-dini nell’Italia centro-settentrionale (secoli XI e XII), in La cristianità dei secoli XI e XII inOccidente: coscienza a strutture di una società. Atti della ottava Settimana internazionale di stu-dio, Mendola 30 giugno-5 luglio 1980, Milano 1983, Miscellanea del Centro di studi medioevali,10, p. 244).36 G. Petti Balbi, I conti di Lavagna, in Formazione e strutture dei ceti dominanti cit., p. 95.37 Il Registro della Curia arcivescovile cit., doc. 84, pp. 305-307.
-
propria remunerazione e che probabilmente sono ancora a disposizione deipubblici ufficiali, in questo caso i marchesi, che stanno dinastizzando le pro-prie prerogative38.
Resta unica e data 1060 la menzione della diocesi genovese con significa-to strettamente territoriale. La dobbiamo proprio al marchese Oberto Opizzo(figlio del fu Oberto) – da cui potremmo aspettarci piuttosto una valorizza-zione dei termini marca e comitatus – quando pone per iscritto le propriedisposizioni testamentarie relative a beni situati in diverse diocesi tra cuianche “in… episcopatu… Genuense”39: senza distinguere dagli altri il casoligure e senza rimandare alle circoscrizioni civili. Si apprezza meglio questaisolata menzione se si tiene conto che per il periodo qui in esame si disponedi circa un centinaio di documenti tra quelli raccolti proprio nel cosiddettoprimo registro della Chiesa genovese – che come è noto acquista rango arci-vescovile in fase successiva ai secoli qui in esame, nel 113340 – e quelli di S.Siro, la chiesa che mantiene almeno per tutto il secolo X prerogative di con-cattedralità, prima di essere costituita in monastero benedettino nel 100741.Occorre aggiungere – ed è la nostra unica possibilità di riscontro – come sisia restii a concepire il territorio organizzato per diocesi quando si trattinoquestioni patrimoniali anche per un’operazione pensata dalla Chiesa genove-se stessa a maggiore distanza. Quando tra il 979 e il 980 il vescovo Teodolfo,in un atto di notevole solennità sottoscritto da un nutrito consesso di religio-si, concede in usufrutto al capitolo di S. Lorenzo alcuni beni fondiari pressoSanremo, nella diocesi di Ventimiglia, fa scrivere al prete Bruningo semplice-mente che si trovano “in Tabiensibus et Matutianensibus finibus” (cioè pres-so le attuali Taggia e Sanremo): l’autorità dei contraenti rende del restosuperflua una più strutturata, verso l’alto, individuazione geografica42 in
26
Ricerche sull'organizzazione del territorio nella Liguria medievale
38 Per un caso della vicina regione subalpina in cui per la metà del secolo precedente sono inveceattestati beni che paiono nella piena disponibilità di un ufficiale chiaramente identificato, cfr. Lepiù antiche carte dell’archivio capitolare di Asti, a cura di F. Gabotto, Pinerolo 1904 (BSSS, 27),doc. 66 del 950-951, pp. 122-126, dove è menzionata tra le confinanze di un appezzamentonell’Astigiano anche la terra Arduini comes, su cui Sergi, I confini del potere cit., p. 75.39 Cartario genovese cit., doc. 130, p. 167; vedi Muratori, Delle antichità estensi cit., I, p. 245.40 Polonio, Tra universalismo e localismo cit., pp. 96 sgg.41 Sulla questione della “cattedrale originaria” si è di recente pronunciata in maniera del tuttopersuasiva, con ampio rimando alla letteratura sull’argomento, S. Macchiavello, Per una storiadella cattedrale di Genova: percorsi archeologici e documentari, in “ASLI”, n. s., 37 (111) (1997),2, pp. 21-36, che parla piuttosto di “una “chiesa vescovile” articolata in più sedi cultuali [S. Siroe S. Lorenzo], distinte per le loro differenti funzioni” (p. 35); ma si veda almeno anche V. Polonio,La cattedrale e la città nel Medioevo a Genova. Aspetti storico-urbanistici, in Amalfi, Genova,Pisa, Venezia. La cattedrale e la città nel Medioevo. Aspetti religiosi, istituzionali e urbanistici.Atti della Giornata di Studio, Pisa, 1 giugno 1991, a cura di O. Banti, Pisa 1993, pp. 59-69.42 Liber Privilegiorum Ecclesie Ianuensis, a cura di D. Puncuh, Genova 1962, doc. 8, pp. 22-23, sucui, ad esempio, Pavoni, Liguria medievale cit., pp. 166-167, Polonio, Tra universalismo e locali-smo cit., p. 87, e S. Bertini, Potere e propaganda a Genova nel Duecento, Genova 1998, pp. 33-34.
-
grado tra l'altro di irritare il titolare della diocesi del Ponente, che deve su-bire questa ingombrante presenza patrimoniale genovese. Tale accertamentoconsente tra l’altro di ben apprezzare l’inventiva con cui nel secolo XII, alme-no dal 1130, si ricorre a episcopatus per designare il territorio su cui il comu-ne intende estendere la propria giurisdizione, in documento tra l’altro, rela-tivo all’Oltregiogo e in cui si parla del districtus di Gavi, dove operano mar-chesi di stirpe che tradizionalmente si ritiene obertenga43.
Applicato alla città, territorium non è usato per tutto il periodo qui inesame se non nel caso sopra ricordato, con valore sinonimico sia di comita-tus sia di valle, quasi non sia reputato adatto a rappresentare il lento preci-sarsi delle ambizioni genovesi sull’area circostante: è termine, infatti, che tro-viamo talvolta impiegato, a un altro livello, legato a microtoponimi, anche inzone non distanti dalle mura urbane44. Dell’assenza di menzioni di districtuscon significato territoriale dalle nostre fonti si è già data ragione, ma comeper comitatus merita aggiungere che il termine non è mai leggibile nemme-no con un significato molto più limitato, per esprimere un potere collegato auna terra oggetto di transazione. Possiamo così arrivare a una prima conclu-sione: tra il secolo X e l’XI, benché molte zone restino opache al nostro sguar-do, in specie a Ponente, il territorio è solo episodicamente avvertito comeinquadrato in un organismo di respiro subregionale, se anche ammettiamoche il termine comitatus a questa altezza cronologica abbia inesorabilmenteun simile significato45. Non è accertabile come operi il potere marchionaleladdove non si appoggi a proprietà obertenghe: una situazione in fondo “nor-male”, che assimila la situazione genovese a quella di altre regioni vicine.
27
I. Definizioni di territorio e protagonisti politici e sociali a Genova nei secoli X-XI
43 I Libri Iurium cit., I/1, doc. 141, pp. 208-210; su cui ad esempio Pavoni, Organizzazione delterritorio genovese cit., p. 9. Sui marchesi Id., Signorie feudali fra Genova e Tortona nei secoliXII e XIII, in La storia dei Genovesi. Atti del Convegno di studi sui ceti dirigenti nelle istituzio-ni della Repubblica di Genova, Genova 28-30 aprile 1983, IV, Genova 1984, pp. 278 sgg.44 Mi limito a tre esempi. Il primo è di età alta rispetto al panorama documentario genovese, per-ché nel 965 i figli del fu Alberto giudice donano, con atto rogato dal notaio Fulcoino, al mona-stero di S. Stefano la loro quota di beni situati non lontano dalla città “in locos et fundos Albariocum ecclesia Sancti Nazarii cum decimis et primiciis, in Carsaneto et Zinestedo et Bauali, campolongo, in eorum territoriis” (Cartario genovese cit., doc. 6, pp. 14-15). Il secondo è interessanteperché identifica un’area di esclusiva pertinenza ecclesiastica, anche se non è chiaro se si trattidella chiesa che poi viene volta in monastero nel 1007 o della Chiesa genovese nel suo insieme:nel 987 il vescovo Giovanni conferma a S. Stefano, con atto scritto dal prete Bruningo, le “libel-larias quas in territoriis Sancti Silii”, con successiva precisazione “scilicet in Alpibus”, la devotaSarra aveva a lungo posseduto (Cartario genovese cit., doc. 13, pp. 25-26). Infine, l’ultima chia-risce come il termine abbia spesso valore sinonimico: nel 1053 Oberto, figlio di Leda, dona almonastero di S. Siro beni situati “in loco et fundo Pelio [Pegli] vel in territoriis et pertinenciis”,così come scrive il notaio Oberto (Le carte del monastero di S. Siro cit., doc. 46, pp. 79-80).45 Rende conto del dibattito sulla qualità della distrettuazione di matrice pubblica, fornendoconcreti esempi relativi al secolo X, Sergi, I confini del potere cit., pp. 299 sgg.
-
2. Attorno ai villaggi
Veniamo perciò a un livello diverso, quello del villaggio, lo si voglia omeno – con Cammarosano – definire circoscrizionale o insediativo, permisurare quali altri spunti organizzativi siano percepibili sul territorio.Cominceremo a farlo seguendo un termine che non ha un solo significato,assumendo – spessissimo – quello di confine, cioè finis, di cui occorre oltre-tutto evitare interpretazioni anacronistiche: si può certamente parlare di con-fini di un prato o di una vigna, ma quale nozione tra il secolo X e l’XI i con-temporanei ne avessero su una scala maggiore è difficilmente sondabile,soprattutto perché non doveva essere sempre facile chiarire le competenze incampo giurisdizionale e nella fattispecie fiscale su un determinato tratto diterra. Limitiamoci ad accennare soltanto a un complesso di fattori che posso-no avere incidenza nel processo di definizione territoriale: i distretti pievani,che sono poco rappresentati nelle fonti ma che nella regione potrebbero esse-re ancora in via di assestamento; l’incastellamento, che come meglio vedre-mo non appare né così diffuso, né pienamente realizzato; la diffusione del-l’incolto, che stando alle indicazioni confinarie degli appezzamenti oggettodelle registrazioni è ancora spesso inframmezzato ai coltivi; e infine il fattoche non sempre in questione vi sono solo elementi facilmente identificabiliquali i fiumi o gli spartiacque alpini, ammesso che si accetti una loro inter-pretazione in chiave di confini “naturali”. A maggior ragione che per i termi-ni finora passati in rassegna, la polisemia di finis deve perciò suggerire unaforte contestualizzazione, per quanto possibile, di ogni singola menzione.
La prima volta che leggiamo il termine finis è assai precoce, nel 916, perun luogo, Bargagli, a una ventina di chilometri ad est di Genova nell’alta valledel Bisagno e poco a sud di un buon passo appenninico, quello della Scoffera.Bargagli vede una concentrazione di interessi economici della Chiesa genove-se, che è quanto ci consente di seguire le ulteriori citazioni fino agli anniSessanta del secolo XI. In tre contratti di livello stipulati con abitanti dellazona entro l’anno 1000 leggiamo che i beni in questione sono localizzati “infine” o “in finibus Bargalina”, mentre la più precisa dislocazione è come diconsueto data con espressioni che cominciano con “locus ubi dicitur”46. Nel1006 si sceglie la formula “in loco Bargali” o semplicemente “in Bergalli”,come avviene anche nel 1065 (o 1075)47, mentre nel 1060 si fa riferimento aterre in Taciolello, una località che in atti precedenti risulta in un certo senso
28
Ricerche sull'organizzazione del territorio nella Liguria medievale
46 Il Registro della Curia arcivescovile cit., doc. 7 del 916, pp. 159-160 (in finibus Bargalina);doc. 43 del 995, p. 273 (in finibus Bergalina); doc. 51 del 1000, pp. 247-248 (in fine Bargallina).47 Il Registro della Curia arcivescovile cit., doc. 52 del 1006, pp. 287-289; doc. 110 del 1065 (o1075), pp. 145-147.
-
subordinata a Bargagli, adesso non nominata48. Si badi inoltre al fatto chenella appena citata registrazione del 1006 si rinnova il livello per “rebus iurisecclesie plebis Sancte Marie sito in Bergali” e che in questo specifico caso nonsi fa nemmeno riferimento alla circoscrizione plebana.
Per la redazione di quei contratti livellari che conosciamo come libellipetitori, concessionari e rappresentanti della Chiesa genovese (amministra-tori e scriptores, di buone capacità grafiche)49 non si rivolgano a notai: lascelta delle varie espressioni ubicatorie ricade perciò sui soli contraenti e,trattandosi spesso di rinnovo delle concessioni, avviene probabilmente perinerzia. Se fossimo persuasi che a questa altezza cronologica finis corrispon-de necessariamente a un’organizzazione locale che distingua quello diBargagli da altri territori, verrebbe da pensare che l’uso di “locus” (tanto piùperché non seguito da “et fundus”50) corrisponda a un declino delle funzionidi centralità del villaggio. Ma una simile valutazione appare contraddettadalla presenza, accertabile dopo la metà del secolo XI, di almeno tre chiesenell’insediamento (di cui la pieve è appunto attestata dal 1006)51, che quan-tomeno contribuiscono a disegnare delle gravitazioni fiscali riscuotendo deci-me, e dal fatto che casomai la prossimità al passo della Scoffera suggerisce unmiglior apprezzamento del luogo nel tempo, in una prospettiva non sola-mente agricola: l’analisi di questo primo caso consiglia di inclinare per un’in-terpretazione poco letterale della terminologia e per un’organizzazione terri-toriale ancora fluida.
Con un numero di occorrenze minore del caso di Bargagli, finis è usatoanche per due località costiere, sbocco di numerose vallate adducenti a passiappenninici: Lavagna (dal 979)52 e la vicina Sestri (nel 1031 e nel 1054)53,che, in misura ben maggiore di Bargagli, avranno un futuro importante. Lascelta terminologica attuata in questi pochi documenti ha suggerito l’esisten-za di due distretti, con radici antiche, perché i luoghi avrebbero ospitato for-tificazioni bizantine, capaci di esplicare funzioni non solo difensive54.L’ipotesi della preesistenza di castra non è da escludere, ma resta poco veri-ficabile l’effettivo contenuto territoriale e giurisdizionale da connettere al ter-
29
I. Definizioni di territorio e protagonisti politici e sociali a Genova nei secoli X-XI
48 Il Registro della Curia arcivescovile cit., doc. 103, pp. 274-275; tra le molte confinanze deibeni locati la “terra Sancti Ambrosii e la terra Sancte Marie” (la pieve).49 Devo questa valutazione a Sandra Macchiavello, che ringrazio.50 Pavoni, Organizzazione del territorio cit., pp. 7-8.51 Due sono quelle citate alla nota 47, mentre nel 1027 un atto è rogato “in loco Bergalli, ubiSancto Laurencio dicitur”: Cartario genovese cit., doc. 95, pp. 134-135.52 Le carte del monastero di San Siro cit., doc. 5, pp. 10-11: “in finibus Lavaniensis”.53 Il Registro della Curia arcivescovile cit., doc. 81, pp. 290-293, di cui merita citare per interoil contesto in cui il termine si trova: “in finiza Sigestrina, in Mazasco vel in valle Lavaniensis,locus ubi dicitur…”; doc. 95, pp. 295-296: in “fine Sigestrina”.54 Pavoni, Dal comitato di Genova cit., pp. 154-155.
-
mine. Prendiamo il caso di Lavagna, più “parlante”. All’interno di un medesi-mo documento del 980 si legge prima che una “sorticella” è situata “in fini-bus Lavaniensis, locus ubi dicitur Macinola”, poi che altri beni si trovanosemplicemente “in Clavari”: si paleserebbe così, grazie all’intervento diAmelio, accolito della Chiesa genovese che sta cedendo in fitto queste pro-prietà, una differenza nella percezione dei territori circostanti i due insedia-menti55. Si è rilevato in precedenza, tuttavia, come nel 1018 alcuni possessisiano localizzati oltre che “in comitatu Ianuense”, anche “in valle Lavania velin eorum territorio”. Per la zona ha perciò efficacia anche un sistema ubica-torio che privilegia l’aspetto geografico: questo peraltro avviene anche in altreregioni, ad esempio nel vicino appennino piacentino dove, secondo VitoFumagalli, il termine vallis ha anche significato distrettuale56. Quando peròleggiamo, per il 1031, che le “res” date in livello a Tedisio, della famiglia dicoloro che si diranno conti di Lavagna, sono disperse tra un gran numero dimicrolocalità, ma sono innanzitutto “posite… in finiza Sigestrina, in Mazascovel in valle Lavaniensis”, oppure, per il 1089, che altri beni descritti in unadonazione tra laici sono ubicati, in un elenco che evita di disegnare precisegerarchie, “per locas qui nominatur et in fundo Rapallo et in Montexello seuin Caneza atque in Cavalixi et in Perogallo seu in finibus Lavaniensis et incastagneto maiore et in via Rapalina” siamo ben ammoniti di non attribuireeccessivo significato a tali denominazioni: per il secolo XI non disponiamo dipositivi elementi di riscontro di una nitida distinzione territoriale, come ciconferma anche il fatto che altre terre sono ubicate semplicemente “inLavania”57. Lasciamo tuttavia aperta l’ipotesi che una più intensa presenzaobertenga attorno ad alcune località, come potrebbe trattarsi per Lavagna eSestri rispetto a Rapallo – un elemento condizionante ben più recente dellefortificazioni di età bizantina – abbia potuto riverberarsi sulla terminologiaimpiegata e che un contributo sia dato anche dalla nascente signoria dei conti
30
Ricerche sull'organizzazione del territorio nella Liguria medievale
55 Le carte del monastero di San Siro cit., doc. 6, pp. 11-12. Anche nel 977 altri beni dati in fittodalla chiesa vescovile sono situati “in valle Lavania”: Le carte del monastero di San Siro cit., doc.4, pp. 9-10.56 Sopra, nota 25. Pavoni, Dal comitato di Genova cit., p. 155 (che appunto rimanda a V.Fumagalli, L’amministrazione periferica dello Stato nell’Emilia occidentale in età carolingia, in“Rivista storica italiana”, 83, 1971, pp. 911-920). Per un’analisi dedicata anche al termine vallis,in tutt’altro contesto, si veda A. Degrandi, Le parole della politica nella coscienza delle comuni-tà valsesiane, in I tempi lunghi del territorio medievale di Borgosesia. Atti del Convegno del 7e 8 novembre 1997, a cura di G. Gandino, G. Sergi e F. Tonella Regis, Torino 1999, pp. 54-55.Tuttavia appena due anni prima, nel 1016, alcuni uomini si impegnano con un rappresentantedella chiesa genovese a non avanzare pretese su un appezzamento descritto come semplicemen-te situato “in loco et fundo Macino” (Le carte del monastero di San Siro cit., doc. 23, pp. 41-42),località che negli altri documenti relativi a Lavagna appare come subordinata a questo villaggio,come ad esempio nel 1037: “in Lavania, ubi dicitur Mayxeone” (doc. 37, pp. 64-66).57 Rispettivamente Il Registro della Curia arcivescovile cit., doc. 81, pp. 290-293, e Le carte delmonastero di San Siro cit., doc. 64, pp. 104-106. Si veda anche alle note precedenti.
-
di Lavagna, che a parte gli Obertenghi sono gli unici signori che vediamo ope-rare nel secolo XI in tutto il Levante. Rilevare una contraddizione con quan-to si è detto sopra, a proposito di una “marca Ianuensis” citata nel 1089 chesmentirebbe le ambizioni dei conti di Lavagna (quando non costituisse il ten-tativo di dare una lettura gerarchica del ceto dominante)58, sarebbe però unerrore di prospettiva: siamo in realtà di fronte a usi terminologici che cerca-no di tradurre percezioni soggettive di poteri che devono oltretutto trovare unassestamento.
Avviciniamoci adesso alla città e abbandoniamo la strada di farci guidaredal singolo termine per rivolgerci invece concretamente a una singola locali-tà, buono spunto per cogliere una situazione diffusa. A una decina di chilo-metri da Genova nella adiacente val Bisagno, che fornisce alla città essenzia-li risorse agricole, anche Molassana è situata in eccellente posizione stradale.In trentaquattro atti dedicati alla gestione di beni della Chiesa genovese la cuiubicazione è data con riferimento a questo luogo leggiamo ogni sorta di locu-zione. Cito, quasi a caso, un mulino “in Molaciana” nel 95659, una terra “queposita est in valle Molaciana” nel 98660, un appezzamento situato “in valleBesanio, locus ubi dicitur Molaciana” nel 98861, “res… in valle Vesano, propecurte Molaciana” nel 101162, altri beni “in locis et fundis Molazana” nel103863, senza che si affermi una formula unica, esattamente come avvieneper altri insediamenti suburbani che sembrano di minor taglia64. E ciò si con-stata nonostante che la Chiesa genovese risulti indiscutibilmente il soggettocon i maggiori interessi della zona e nonostante che almeno dal 990 un suoapprestamento fortificato – come è noto l’unico ben individuabile in questafase nel raggio di molti chilometri da Genova – possa contribuire a rafforza-re un’interpretazione unitaria del territorio anche in senso giurisdizionale,con emanazione di un potere non solo economico: in posizione arroccata,questo castello pare tuttavia avere funzioni essenzialmente difensive, non èatto a ospitare popolazione65 e non sembra dare una fisionomia più compat-ta all’insediamento, il cui assetto, al pari di altre località nella valle, risulta
31
I. Definizioni di territorio e protagonisti politici e sociali a Genova nei secoli X-XI
58 Sopra, testo corrispondente alla nota 34.59 Per questo documento l’editore propone in alternativa anche la data 971: Il Registro dellaCuria arcivescovile cit., doc. 21, pp. 209-210.60 Il Registro della Curia arcivescovile cit., doc. 34, pp. 173-17461 Il Registro della Curia arcivescovile cit., doc. 37, pp. 275-276.62 Il Registro della Curia arcivescovile cit., doc. 62, pp. 211-212.63 Il secondo Registro della curia arcivescovile di Genova trascritto dal socio Luigi Beretta epubblicato dal socio L. T. Belgrano, in “ASLI”, 18 (1887), doc. 270, pp. 299-301.64 Pavoni, Organizzazione del territorio cit., e V. Polonio, Monasteri e paesaggio nel suburbiogenovese. La val Bisagno tra X e XIII seecolo, in “ASLI ”, n. s., 37 (111) (1997), 2, pp. 49 sgg.65 Il Registro della Curia arcivescovile cit., doc. 38, pp. 248-250; T. Mannoni, Il castello diMolassana e l’archeologia medievale in Liguria, e S. Bazzurro, D. Cabona, G. Conti, S.Fossati, O. Pizzolo, Lo scavo del castello di Molassana, in “Archeologia medievale”, I (1974),rispettivamente alle pp. 11-18 e 19-54.
-
comunque poco decifrabile66.Ma proprio l’individuazione territoriale non sembra obiettivo perseguito
dagli amministratori della Chiesa genovese attorno a Molassana, come rica-viamo innanzitutto dal disinteresse a condurre in regime monopolistico l’at-tività molitoria, che potrebbe contribuire a precisare la loro identità qualiorganizzatori di altre funzioni essenziali dell’insediamento, oltre a quelledifensive: in almeno sette casi ben distribuiti lungo il periodo in esame sonoceduti in locazione mulini o è data l’autorizzazione a edificarli a differentidestinatari, anche consorzi, capaci di far fruttare queste costose strutture67. Irappresentanti della Chiesa genovese non paiono orientarsi per una gestionepienamente signorile del proprio patrimonio nella valle, tramutando secondoun processo notissimo il possesso in potere68 (a meno che con queste cessio-ni non segnalino un arretramento rispetto a poteri già esercitati in preceden-za): tuttavia non sembrano nemmeno intenzionati a delegare tale gestione adaltri. Nel coordinamento di quella che latamente possiamo considerare unaclientela, non lasciano che alcun raggruppamento familiare ottenga una pre-ponderanza locale: ad esempio i fratelli Bellando (un sacerdote) e Bruningonel 1073 risultano concessionari sì di sostanziosi beni a Molassa