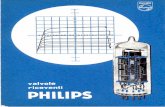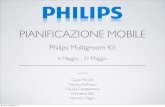Metodo Philips
Click here to load reader
-
Upload
steraniero -
Category
Documents
-
view
394 -
download
6
description
Transcript of Metodo Philips

Tratto da: Pg.Branca-F.Colombo, Verso una pedagogia di comunità Par. 4.3.6.2 -pag. 145-154 – in : AA.VV.- Territorio e lavoro di Comunità - CLEUP Editrice - Padova - 2001 –
Il metodo Philips
¶ I processi di partecipazione nella dimensione collettiva
¶ Il metodo Philips - le premesse - ¶ Aspetti metodologici ¶ L’incrocio

2
I processi di partecipazione nella dimensione collettiva Tutti abbiamo sperimentato come sia difficile decidere in un contesto collettivo. Quando pensiamo al funzionamento di alcune assemblee, nell’ambito delle Cooperative, Associazioni , Istituzioni, ecc., siamo presi dallo sconforto. Nonostante le lodevoli intenzioni si sentono sulla propria pelle gli effetti del blocco della partecipazione. Il dibattito, a volte, è un ping-pong senza sbocco. In altre occasioni si ha l’impressione di avere a che fare con un muro di gomma. Nei corridoi si ascoltano profezie paralizzanti... “è inutile partecipare, esprimere le proprie opinioni, soliti noti hanno già deciso” Una contraddizione spesso presente risiede nella relazione fra i processi di partecipazione, i contenuti e gli effetti delle decisioni. A fronte di scarsi ed insufficienti processi di partecipazione si richiedono decisioni che impegnano il collettivo su contenuti determinanti per il futuro prossimo. Per esempio: le linee politiche di una Cooperativa, le soluzioni a un problema, azioni collettive verso..., ecc. Oppure si richiede la partecipazione come “pura presenza” per ascoltare, accettare o “essere sensibilizzati” dagli effetti di decisioni prese da altri e che comunque interessano i comportamenti e le azioni di tutto il collettivo. Dall’analisi dei comportamenti organizzativi è rilevabile come, nella maggioranza dei casi, la partecipazione non sia un processo premiato dagli stessi soggetti che, per ruolo Istituzionale e/o organizzativo, la richiedono. Così nelle assemblee si assiste ai fenomeni della “desertificazione” - scarsa affluenza - o della fuga durante lo svolgimento o dopo le prime battute. Per difendersi da tali fenomeni è possibile cadere nella tentazione di costruire una forte attribuzione, che rapidamente si trasforma in stereotipo dominante: “ la gente non ha voglia di partecipare, non desidera assumersi responsabilità, fugge dagli impegni, non è interessata...”. Se spostiamo l’attenzione verso le interazioni far i partecipanti potremmo domandarci: quanto i processi di partecipazione, richiesti e mobilitati permettono l’influenzamento reciproco dei soggetti, nella dimensione collettiva ? In una assemblea assumono particolare rilevanza quegli elementi che svolgono la funzione di dati strutturali definendone i confini, fra questi: ◊ il numero delle persone - nelle assemblee siamo di fronte a una elevata pluralità -; ◊ i ruoli istituzionali ed organizzativi che rivestono le persone presenti, con i gruppi di
appartenenza formali ed informali; ◊ gli scopi ed i contenuti da affrontare - per es.: se siamo in un’assemblea decisionale, i contenuti
della decisione da prendere, le finalità e gli effetti sul sistema -; ◊ le risorse strutturali a disposizione: tempi, informazioni, materiali, luoghi, ecc. D’altro lato per garantire l’effettiva partecipazione dei diversi soggetti è necessario promuove ed attivare i processi che direttamente la investono, quali:

3
• l’espressione delle differenti istanze ( opinioni, bisogni, problemi, ecc.) e il loro riconoscimento; • la discussione e il confronto fra i diversi soggetti ( persone, ruoli, gruppi, ecc.); • l’influenzamento reciproco nella presa di decisione collettiva. L’interazione fra dati strutturali e processi di partecipazione gioca un ruolo determinate nella formazione del clima organizzativo - l’atmosfera che si respira nell’assemblea - e non ultimo nella definizione della qualità di vita possibile e desiderabile del conteso collettivo. Ci troviamo così di fronte alla necessità di trovare metodologie che ottimizzino l’integrazione fra aspetti che interessano l’efficienza - in particolare l’utilizzo dei dati strutturali - con altri relativi all’efficacia dei processi e dei risultati. Il Metodo Philips - le premesse - Il metodo Philipsi si occupa di facilitare i processi di decisione all’interno di un contesto collettivo, attraverso un percorso di lavoro che consente l’interazione e l’influenzamento reciproco dei componenti. Le persone sono facilitate ad esprimere e confrontare le proprie istanze in un contesto che riconoscono come appartenente e quindi poco minacciante. A questo scopo, all’interno del contesto collettivo, sono esplorate e riconosciute le differenti aggregazioni possibili fra i partecipanti, per es.: gruppi per scelta affettiva, per ruoli omogenei, per compiti e funzioni, per atteggiamenti, per sentimenti, ecc. La metodologia del Philips si basa sulla esplorazione ed estensione progressiva del processo decisorio nelle differenti dimensioni sociali - persona, gruppi omogenei, gruppi eterogenei, leaders, assemblea plenaria - e sulla interazione reciproca fra le stesse dimensioni. Per essere efficace il metodo richiede: ¶ il riferimento a un collettivo omogeneo per contesto di appartenenza o per ruoli; per es.:
l’assemblea di una cooperativa o di una associazione, gli insegnanti di un Istituto, una classe scolastica, gli operatori sociali appartenenti a un territorio, le casalinghe di un quartiere, ecc.
¶ L’accordo del collettivo sul percorso di lavoro che viene proposto. ¶ L’interesse e il consenso sui contenuti da affrontare. Sul piano dei contenuti il “Philips” è utile quando, in un collettivo è necessario far emergere, esplorare e decidere collettivamente: ¶ le premesse fondanti di un intervento o di un’organizzazione, ovvero i modelli di pensiero, le
logiche, le strategie di azione - per es.: per un collettivo di volontari: quali sono i processi prioritari per promuovere lo sviluppo delle proprie organizzazioni ? -

4
¶ I bisogni prioritari da soddisfare all’interno di una sistema organizzativo - per es.: in un CSV quali sono i bisogni prioritari che il sistema organizzativo-partecipativo della cooperativa deve soddisfare nel prossimo anno ? –
¶ I problemi principali su cui investire energie - per es.: all’interno di una associazione di
quartiere: quali problemi affrontare ed intervenire collettivamente nel prossimo anno -. Aspetti metodologici e processi attivati Il percorso proposto mobilita le energie e attiva il processo decisorio attraverso le seguenti fasi ( si veda la Fig 1.) :
1. Presentazione del contenuto oggetto di analisi e decisione collettiva (sintesi dei lavori della giornata precedente)
2. Presentazione delle fasi del processo di lavoro, confronto con l’assemblea per la comprensione del senso, verifica del consenso sulle possibilità di attuarlo.
2. Esplorazione collettiva del contenuto (start-up) Vengono presentate le possibili scelte da realizzare (esito dei lavori di gruppo). E’ utile presentare una scheda che contiene, come possibili scelte, un numero elevato di possibilità - 3. Decisione individuale In relazione allo strumento utilizzato nella fase precedente si chiede alle persone di effettuare la
scelta e di decidere in modo autonomo, senza interazione far partecipanti: si chiede alle persone di scegliere gli item utilizzando il metodo delle scelte multiple ( la scelta di 1/3 delle possibilità totali), senza porre le risposte in ordine di priorità.
Si garantisce l’anonimato e si raccolgono le schede con le scelte individuali. Solo in seguito, nell’ultima fase del processo, verrà restituita l’immagine collettiva delle
scelte, elaborata a partire dalle preferenze individuali. 4. Formazione dei gruppi decisionali In questa fase si costituiscono i gruppi per libera associazione, promuovendo quindi la scelta
preferenziale o affettiva da parte dei membri. Come unica limitazione viene indicato il numero dei gruppi e il numero di partecipanti per gruppo. Normalmente sono costituiti gruppi con un numero di membri non troppo numeroso, per facilitare la discussione e la presa di decisione in tempi brevi - per es.: gruppi di 6-7 persone per tempi di lavoro dell’ordine di ½ ora -.
Ogni gruppo ha il compito di decidere i primi n-fattori relativi all’oggetto in esame e a posizionarli in ordine di priorità secondo un criterio stabilito - per es.: l’importanza rispetto ai bisogni, ecc. -
Il numero delle scelte prioritarie è limitato, di solito, a 5 massimo 6 scelte.

5
5. Assemblea di socializzazione Ogni gruppo presenta la propria decisione in assemblea. Chi conduce o anima l’assemblea ha il
compito di facilitare la comprensione delle scelte e di far emergere i criteri utilizzati dai gruppi. Inoltre viene promosso il dibattito sugli aspetti che hanno influenzato le scelte e sugli effetti delle decisioni sul contenuto, oggetto di lavoro.
L’animatore dell’assemblea cerca di mettere in evidenza le differenze fra i gruppi e quei fattori che nessun gruppo ha priorizzato.
6. Seconda formazione dei gruppi Il compito dei gruppi è identico al precedente: stabilire l’ordine di priorità per un numero n. di
elementi . Per facilitare l’interazione fra i membri del collettivo è opportuno formare gruppi in relazione a variabili che permettano di costituire gruppi omogenei all’interno ed eterogenei fra loro, ad esempio tecnici e politici; o gruppo di governance e operatori; appartenenti a diversi CSV…
7. Leaders in acquario Al termine della fase precedente ogni gruppo elegge un proprio rappresentante che con i
rappresentanti degli altri gruppi, in acquario, dovrà decidere le priorità per tutto il collettivo. Nella situazione dell’acquario i leaders dei gruppi decidono le priorità “circondati” da tutti gli
altri membri dell’assemblea, che non possono intervenire nel processo. Il gruppo in acquario può richiedere la presenza dell’animatore per facilitare e coordinare il
processo decisionale. In questa fase i membri dell’assemblea controllano direttamente la gestione della leadership e dei
processi ad essa correlati.