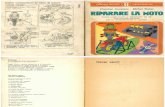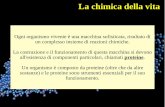Meccanismi Per Riparare Il DNA
-
Upload
leonardo-schrikker -
Category
Documents
-
view
221 -
download
3
description
Transcript of Meccanismi Per Riparare Il DNA

Meccanismi per riparare il DNA
In una cellula, quando esiste un “maleappaiamento”, cioè ad esempio G-T, la cellula deve avere un modo per riconoscere qual’è il filamento di nuova sintesi rispetto a quello parentale perché deve sapere qual’è la base sbagliata delle due. Noi sappiamo che il DNA è metilato, e controlla lo stato di aggregazione della cromatina, e ovviamente il pattern di metilazione del DNA anche viene trasmesso al DNA di nuova sintesi. Soltanto che questo meccanismo è sfalsato rispetto alla duplicazione del DNA, quindi prima avviene la duplicazione del DNA e poi dopo vengono copiate nel nuovo filamento tutte le modificazioni epigenetiche. Quindi c’è un istante in cui il DNA è semimetilato, cioè, in cui è metilato soltanto da una parte. Chiaramente i gruppi metilici stanno ad indicare che quello è il filamento prentale, quindi e c’è un errore viene corretto solo nel filamento di nuova sintesi, che è quello senza gruppi metilici.
Un meccanismo comune di correzione, se c’è una base male appaiata, interviene una endonucleasi,che tagli a monte del “maleappaiamento”, creando così un’intaccatura, a questo punto interviene la DNA polimerasi I, che fa sempre la stessa cosa. Quando vede un’intaccatura sul DNA, ci si siede sopra, prende come primer il DNA che sta prima diggerendo quello che sta davanti sostituendo il DNA correggendo la base maleappaiata. Le basi azotate possono subire una reazione di deamminazione ossidativa. Esiste un apparato enzimatico apposta per rimuovere queste basi anomale. Interviene una DNA glicosidasi, che taglia il legame glicosidico, che unisce cioè il ribosio alla base azotata, quindi esiste una DNA glicosidasi specifica per ogni base, creando così un sito dove manca la base. Ancora lo scheletro zuccherofosfato è intatto, dopo che si è creato questo sito detto apurnico perché manca una purina interviene una endonucleasi, che taglia in corrispondenza del sito apurinico lo scheletro zucherofosfatoe così facendo crea un’intaccatura. A questo punto interviene sempre la DNA polimerasi I, che fa sempre la stessa cosa, usa il DNA precedente come primer
e sostituisce il DNA che gli sta davanti. Questo è il motivo per cui la DNA plimerasi è è un enzima poco veloce e poco processivo, proprio perché non deve copiare tutto il genoma, serve soltanto per sostituire 10, 20 nucleotidi che gli stanno davanti, siano essi primer di RNA che devono essere sostituiti durante la duplicazione oppure errori che devono essere corretti. Il folato è una vitamina che serve per trasportare gruppi monocarboniosi, gruppi CH3, o al massimo bicarboniosi, CH3-CH2. Questi gruppi monocarboniosi servono per la sintesi delle purine, oppure servono per la metilazione (da desossi UTP al desossi TTP) e quindi si tratto di una vitamina molto importante per il metabolismo del DNA, tra l’altro questo è il motivo per il quale, alle donne in gravidanza, si da sempre un’integrazione di acido folico, perché nel bambino che si sta formando, si passa in nove mesi da una cellula a una cosa che pesa più o meno tre chili, quindi c’è una sintesi del DNA molto veloce e quindi serve un sacco di acido folico per la sintesi della timina, delle purine e per tutte le modificazioni epigenetiche, per la

metilazione corretta del DNA, che è una cosa importante. Se c’è qualche gene che controlla il ciclo cellulare che dovrebbe essere spento e invece è acceso, allora ci possono essere dei problemi come losviluppo di tumori. Se non ci sono abbastana gruppi metilici per la formazione di Timina, allora viene incorporato l’uracile nel DNA, che viene riconosciuto come estraneo da quel sistema di riparo di cui si parlava prima. Se non c’è la timina normale, per sostituire quella base, rimane un sito a purinico, un sito senza nessun nucleotide. E quindi nella divisione successiva in quel sito verrà incorporato un nucleotide a caso e quindi c’è lo sviluppo di tumore. Un altro meccanismo che interviene per la rimozione dei dimeri di timina, che abbiamo visto ieri, quando
abbiamo parlato della chimica degli acidi nucleici, l’irraggiamento con luce UV può portare alla formazione di un anello di ciclobutano che porta una distorsione localizzata della doppiaelica. Un meccansimo per rimuovere questo tipo di danno è l’intervento di una endonucleasi e successivamente di una elicasi, che svolge il DNA contenente il dimero di timina. Poi ovviemnte c’è il
solito intervento della DNA polimerasi I.Un’altra mutazione che può avvenire, è quella ad opera di agenti alchilanti che sono delle sostanza chimiche che ossono introdurre i gruppi metilici ad esempio nella guanina. Questo composto che si forma si appaia perfettamente con la timina, con la stessa geometria di un appaiamento secondo la gemotria di Watson e Crick. Chiaramente se questa cosa non viene corretta, va incontro a mutazione, perché nella
divisione successiva, verrà introdotta una base che non era presente. Questo riparo viene riparato da un enzima che è una metil transferasi, cioè un enzima che prende questi gruppi metilici che stanno dove non dovrebbero stare, quindi se c’è una citosina metilata in posizine 5’, quella è una metilazione corretta, e fa parte del bagaglio epigenetico della cellula, mentre questo tipo di metilazione non deve essere presente normalmente e quindi questa metil transferasi la riconosce e toglie il gruppo metilico.
Adesso che abbiamo parlazo della duplicazione del DNA, vediamo un metodo per determinare la sequenza del DNA che

si basa proprio sulle conoscenze acquisite da questi studi sulla duplicazione del DNA. Il metodo si chiama metodo Sanger, ed è stato praticamente usato con qualche modifica che dopo vedremo per il completamento del progetto genoma umano. Ovviamente, per queso metodo c’è bisogno di uno stampo a singola elica, rappresentato dal DNA di cui si vuole determinare la sequenza, poi serve un primer per le DNA polimerasi, serve un pezzettino di doppio filamento per poter funzionare. La presenza dei 4 nucleotidi trifosfato dei quali uno è marcato, così ci permette di poter vedere soltanto il DNA di nuova intesi. Oltre a
questo c’è il didesossinucleotide , la cui formula è questa qua, che manca oltre all’ossidrile in 2’ anche dell’ossidrile in 3’. Chiaramente, quando questo nucleotide viene incorporato nel DNA nascente, la reazione di
sintesi del DNA si blocca, perché la DNA polimerasi che cosa fa, utilizza praticamente il gruppo fosfato per attaccarlo all’ossidrile in 3’ del DNA nascente, qui siccome non c’è nessun ossidrile, ma c’è l’idrogeno la sintesi si blocca. Vediamo un esempio, un pezzetto di DNA lungo 6 nucleotidi, in realtà si usano pezzi di DNA lunghi qualche centinaio di nucleotidi. C’è uno stamp a singola elica, c’è la sequenza che noi vogliamo determinare, e noi conosciamo un pezzo della sequenza di quel DNA che sta attaccato alla sequenza che noi vogliamo determinare. La conosciamo perché possiamo sintetizzare un oligonucleotide lungo una ventina di nucleotidi da usare come primer e, a questo punto, una volta che si ha quella roba li, si divide in 4 provette, che contengono tutte quante i quattro nucleotidi, una DNA polmerasi, e in una provetta ci mettiamo la didesossiadenina, in un’altra la didesossicitosina, e così via per i quattro nucleotidi e facciamo avvenire la sintesi. Che cosa succede, prendiamo ad esempio la reazione con la didesossiadenina, se io ci metto tanta didesossiadenina, ogni frammento di nuova sintesi incorporerà subito il didesossinucleotide, e quindi la sintesi si blocca subito, se ce ne metto troppo poca, al contrario, la sintesi viene completata perché la didesossi è raro che ci vada a finire, quindi se uso una quantità tale che in media viene incorporata una sola molecola di desossiadenina per molecole di DNA di nuova sintesi, avrò una miscela di fammenti a tutte le adenine presenti nel DNA stampo. La stessa cosa vale per gli altri tre nucleotidi, a questo punto si prende la reazione, si mette su un gel e si sottopone a un campo elettrico (elettroforesi) in quattro campioni diversi
(le quattro lane), il che consente di separare le molecole cariche secondo la loro dimensione. Quelli più piccoli sono più veloci, saranno più in basso. A questo punto, una volta avvenuta la separazione, si legge direttamente la sequenza partendo dal basso andando verso l’alto. Questo metodo viene
chiamato sequenziamento di Sanger. Ora questo metodo, era poco adatto per un progetto così ambizioso come il progetto genoma umano, visto che il nostro genoma è lungo tre miliadi di nucleotidi. Per determinare quali sono i polimorfismi degli individui bisogna ovviamente sequenziare non uno, ma centinaia di individui diversi. Questo significa sequenziare centinaia di miliardi di nucleotidi. Ovviamente questo metodo non andava bene perché, innanzi tutto, per ogni singola sequenza c’è bisogno dello spazio di quattro lane sul gel di sequenza, inoltre, siccome è un metodo che si basa sulla separazione delle varie

bande che differiscono in lunghezza di un solo nucleotide, chiaramente la differenza di mobilità di queste due bande, se una è lunga 100 e l’altra 101, sarà una certa distanza, ma se è 600 e 601, la distanza sarà talmente piccola da essere invisibile all’occhio umano. Ed è per questo che i ricercatori hanno sviluppato un’altro metodo, che non fa più uso del radioattivo, per visualizzare il DNA di nuova sintesi, ma fa uso di questi didesossinucleotidi ai quali è stata attaccata una sonda fluorescente, una cosa che quando viene illuminata dalla luce ultravioletta emette luce di un certo colore. Ovviamente si utilizzano colori diversi per i quattro nucleotidi e questo ci permette di caricare le quattro lane che abbiamo visto prima, in una singola miscelaperché le quattro bande, a questo punto, siccome i nucleotidi hanno 4 colori diversi, si possono facilmente distinguere. Inoltre, siccome tutto quanto avviene automatizzato, non èpiù lo sperimentatore che con l’occhio deve guardare una lastra fotografica, e quindi a un certo punto diventa difficile distinguere due bande quando sono quasi sovrapposte, qui è invece un computer che raccoglie le informazioni e di coneguenza è molto più preciso. Questo è quello che esce fuori chiaramente, il computer interpreta se il segnale che gli arriva ha una certa lunghezza d’onda e lui sa quale base è.
Questo è praticamente il metodo che è stato usato per il progetto genoma umano, che altrimenti sarebbe stato impossibile realizzare. Si formano tutti i frammenti possibili, ognuno è marcato da un colore diverso, dipende dal nucleotide. Poi con l’elettroforesi si separano tutti i frammenti in base alle loro dimensioni e a questo punto si puù leggere la sequenza. C’è un illuminatore di luce ultravioletta, un detector che capta la
luce emessa, il tutto viene dato ad un computer che elabora il tutto. Quando si andava ad analizzare quello che è venuto fuori dal progetto genoma umano, si è scoperto che ben il 40% del nostro DNA è fatto da sequenze ripetute, cioè sequenze più o meno lunghe e che vengono ripetute decine o anche centinaia di volte. Il numero di ripetizioni è tale che se io analizzassi 5 di
queste regioni ripetute, la probabilità di trovare due individui con lo stesso numero di ripetizioni è uno si 20 miliardi. Un DNA quando ha la stessa sequenza ripetuta tutte queste volte, quando c’è il crossing over è possibile che i due cromatidi facciano il crossing over mettendosi non appaiati correttamente, quando questo accado, ovviamente viene cambiato il numero delle ripetizioni, da una parte dimiuisce e dall’altra aumenta. Questo fatto, ripetuto per milioni di generazioni, ha generato la situazione in cui abbiamo questo

DNA ripetuto, ma il numero di ripetizioni è diverso da individuo a individuo. Quindi l’analisi di questo particolare DNA, che non si sa a che serve tra l’altro, permette di individuare una persona. Quando si dice che sulla scena del delitto di fa l’analisi del DNA, o per l’analisi della paternità, significa che si va ad analizzare proprio queste regioni ripetute, e siccome la probabilità che due persone hanno lo stesso numero di 5 regioni ripetute è di uno su 20 miliardi, chiaramente è molto difficile, pressoché impossibile, visto che siamo solo 7 miliardi, che si possa sbagliare persona.
PCR

Adesso vediamo un’altra tecnica che sfrutta la presenza di una DNA polimerasi, Questa tecnica è la PCR, reazione a catena della polimerasi (polimerase chain reaction). Serve ad amplificare un tratto di DNA, quando si fa l’analisi del DNA sulla scena del delitto, per analizzare quelle 5 regioni ripetute di cui di diceva prima, ovviamente serve una quantità discreta di DNA, solo che sulla scena di un delitto, spesso la polizia trova un capello al quale sono attaccate poche cellule del bulbo pilifero. Questa tecnica serve ad amplificare queste regioni di DNA che si vogliono amplificare, quindi bastano delle quantità minime di DNA per poter essere amplificate. Questa tecnica è stata ideata molto tempo fa, e si basa sul riscaldamento ciclico di una soluzione che contiene DNA polimerasi e i quattri nucleotidi. La soluzione viene ciclicamente riscaldata, per separare il DNA e poi viene abbassata la temperatura per far avvenire la sintesi. Solo che la DNA polimerasi che si usava allora era la DNA polimerasi estratta da E.coli, la quale come la maggior parte delle polimerasi degli organismi che vivono a temperatura ambiente viene denaturata con il calore. C’era questo grosso impedimento che ad ogni ciclo bisognava aggiungere una nuova quantità di DNA polimerasi. Questo ha impedito lo sviluppo di questa tecnica finché a qualcuno non è venuto in mente che esistono sulla terra degli organismi che sono dei procarioti che vivono anche a temperature superiori a 100 gradi, nelle pozze solforiche. I loro enzimi devono resistere ad alte temperature al contrario di quella di E.coli. DA quel punto in poi la tecnica si è molto sviluppata e ora, in biologia molecolare non ci sono esperimenti che non la richiedano. Ora, quello che bisogna avere per poterla utilizzare, bisogna conoscere la squenza di DNA che fiancheggia la sequenza che vogliamo amplificare. Questo poteva essere un problema qualche anno fa, ma adesso non o è più visto che la sequenza del genoma umano è stata completamente determinata. C’è un sottosito sul sito del NIH dove c’è tutta la sequenza del DNA e si può vedere tutto il cromosoma, perciò se si conosce la sequenza da amplificare si va a vedere la sequenza di ciò che fiancheggia la regione che bisogna
amplificare. Serve il DNA stampo che si vuole amplificare, due oligonucleotidi che fiancheggiano la regione che si vuole amplificare, perché quasta tecnica fa uso della DNA polimerasi che fa uso di un ossidrile in 3’ da poter allungare. Poi una
DNA polimerasi termostabile e i quattro desossinucleotidi trifosfato. Il processo prevede diversi cicli che si ripetono con questa modalità, prima c’è la denaturazione del DNA stampo, quindi si porta la soluzione a 95°C per separare le due eliche, poi la temperatura si abbassa a circa 55°C per permettere l’appaiamento con i due primer. Poi si rialza di nuovo, siccome la DNA polimerasi è la polimerasi di un organismo che vive ad alte temperature, funziona bene ad alte temperature, circa a 72 gradi, e quindi si porta la temperatura a 72 gradi e inizia la sintesi. Dopo questo ciclo si ripete di nuovo. All’inizio, quando ancora non avevano pensato alla DNA polimerasi termostabile, la tecnica veniva poco usata perché, oltre al fatto di aggiungere l’enzima nuovamente nella miscela di reazione si dovevano avere tre termstati e lo doveva passare a mano queste provette da un termostato all’altro, adesso ovviamente tutto è automatizzato, quindi è lo stesso termostato che automaticamente cambia la temperatura della provetta. Vediamo che cosa accade all’interno della provetta quando si verificano questi cambiamenti di temperatura. All’inizio abbiamo il DNA che vogliamo amplificare, c’è il segmento a 95 gradi, poi c’è l’appaiamento. È da notare che la reazione è termodinamicamente favorita rispetto al riappaiamento del DNA che vogliamo amplificare, perché abbiamo