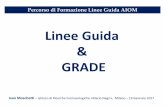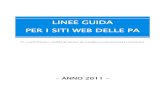Linee guida potassio
-
Upload
cosimo-maglie -
Category
Documents
-
view
215 -
download
0
description
Transcript of Linee guida potassio

Direzione Sanitaria
PSG_LG_01
Ed 1 Rev. 0 del
Maggio 2009
Ed. 1 Rev. 0 Maggio 2009 Linee Guida per il trattamento della ipopotassemia Pagina 1 di 8
Linee guida per il trattamento
della ipopotassiemia
REVISIONI
Numero 0 1 2 3 4 5
Data Maggio 2009
Redazione/
Aggiornamento
dott. M. Battistin, dott. F
Marchesini, dott. S. Basso,
dr. A. Bravin, dott. P.
Casarin, dott. M. Cassin,
dott.ssa E. Milan, dott.ssa C.
Muran, dott. D. Tomasello
Verifica Direzione Sanitaria
Approvazione Direzione Sanitaria

Direzione Sanitaria
PSG_LG_01
Ed 1 Rev. 0 del
Maggio 2009
Ed. 1 Rev. 0 Maggio 2009 Linee Guida per il trattamento della ipopotassemia Pagina 2 di 8
SOMMARIO
1 LEGENDA................................................................................................................................. 3
2 INTRODUZIONE ......................................................................................................................... 3
3 EZIOLOGIA............................................................................................................................... 3
4 SEGNI E SINTOMI....................................................................................................................... 4
5 ANORMALITÀ ELETTROCARDIOGRAFICHE.................................................................................... 4
6 TRATTAMENTO DELL’IPOKALIEMIA............................................................................................... 5
7 PREVENZIONE DELL’IPOKALIEMIA................................................................................................ 5
8 FLUSSO DIAGNOSTICO TERAPEUTICO DELLA IPOPOTASSIEMIA
9 FARMACI PRESENTI IN PTAV PER IL TRATTAMENTO DELLA IPOPOTASSIEMIA
9.1 TRATTAMENTO ORALE ........................................................................................................ 6
9.2 TRATTAMENTO PARENTERALE CON SOLUZIONI PRE-DILUITE ..................................................... 6
9.3 TRATTAMENTO PARENTERALE CON SOLUZIONI PREPARATE ESTEMPORANEAMENTE .................... 7
10 STORIA DELLA LINEA GUIDA
11. BIBLIOGRAFIA ......................................................................................................................... 7

Direzione Sanitaria
PSG_LG_01
Ed 1 Rev. 0 del
Maggio 2009
Ed. 1 Rev. 0 Maggio 2009 Linee Guida per il trattamento della ipopotassemia Pagina 3 di 8
1. Legenda
⇒ 1 mMol di Potassio = 1 mEq di Potassio
� 1 fiala di Potassio aspartato 1 mEq/ml 10 ml contiene:
− 1 mEq di K+
in 1 ml
� 1 fiala di Potassio aspartato 3 mEq/ml 10 ml contiene:
− 3 mEq di K+
in 1 ml
� 1 fiala di Potassio cloruro 2 mEq/ml 10 ml contiene:
− 2 mEq di K+
in 1 ml
⇒ 1 mMol di Magnesio = 2 mEq di Magnesio
� 1 fiala di Magnesio solfato 10% 10 ml contiene:
− 1 g di Magnesio solfato
− 8 mEq di Magnesio
− 4 mMol di Magnesio
2. Introduzione
L’ipopotassiemia è una anormalità elettrolitica di comune riscontro nella pratica clinica ed è definita
come un valore di concentrazione plasmatica di potassio < 3.5 mMol/l.
L’ipopotassiemia è generalmente ben tollerata nei pazienti per altro sani, ma può essere pericolosa per
la vita quando severa. Inoltre nei pazienti con patologie cardiovascolari, anche una lieve o moderata
ipopotassiemia aumenta il rischio di morbilità e mortalità, dato che il potassio è uno ione intracellulare
e la sua concentrazione serica non sempre corrisponde a quella intracellulare.
Classificazione della ipopotassiemia
� lieve tra 3,0 e 3,5 mMol/l,
� moderata tra 2,5 e 3,0 mMol/l,
� severa inferiore a 2,5 mMol/l.
3. Eziologia
a) Ridotto apporto:
• Inedia
• Ingestione di creta
b) Ridistribuzione intracellulare
• Alterazioni dell’’Equilibrio acido-base (alcalosi metabolica )
• Cause ormonali (Insulina, agonisti β2-Adrenergici , antagonisti α-Adrenergici,
ipertiroidismo)
• Stato anabolico
− Somministrazione di Vit. B12 o acido folico (produzione di globuli rossi).
− Fattori di crescita per granulociti e macrofagi (produzione di globuli bianchi)
− Nutrizione parenterale totale
c) Altre cause

Direzione Sanitaria
PSG_LG_01
Ed 1 Rev. 0 del
Maggio 2009
Ed. 1 Rev. 0 Maggio 2009 Linee Guida per il trattamento della ipopotassemia Pagina 4 di 8
• Pseudoipokaliemia
- Ipotermia
• Paralisi periodica ipokaliemica
• Tossicità da bario
d) Aumentate perdite
• Non renali
− Perdite gastrointestinali (diarrea, tumori intestinali),
− Perdite dai tegumenti (sudore)
e) Renali
• Aumentato flusso distale: diuretici, diuretici osmotici, nefropatie con perdita di Sali
• Aumentata secrezione di potassio
� Eccesso di mineralcorticoidi: Iperaldosteronismo primario, iperaldosteronismo secondario
(ipertensione maligna, ipertensione nefrovascolare, tumori secernenti renina, cirrosi
epatica, ipovolemia), abuso di liquirizia, carbenoxolone, iperplasia surrenalica congenita,
sindrome di Cushing, sindrome di Bartter
� Perdita distale di anioni non riassorbiti: vomito , drenaggio con sng, acidosi tubulare renale
(tipo II), chetoacidosi diabetica, abuso di toluene, derivati della penicillina
� Altre: amfotericina B, sindrome di Liddle, ipomagnesiemia
4. Segni e Sintomi
I pazienti con ipopotassiemia spesso sono asintomatici, particolarmente quando il disordine è lieve.
Se l’ipopotassiemia è più severa si possono presentare con una sintomatologia aspecifica come
stanchezza generalizzata, apatia, stipsi.
Con ipokaliemie sotto le 2,5 mMol/l, si può verificare necrosi muscolare con rabdomiolisi o svilupparsi
una paralisi ascendente con compromissione della funzione respiratoria al di sotto delle 2 mMol/l.
In pazienti senza sottostanti patologie cardiache, anormalità nella conduzione cardiaca sono
estremamente insolite anche quando la potassiemia è inferiore alle 3,0 mMol/l. In quelli invece affetti
da cardiopatia ischemica, insufficienza cardiaca o ipertrofia ventricolare sinistra, anche le ipokaliemie
lievi-moderate aumentano la probabilità di aritmie cardiache.
L’ipopotassiemia inoltre aumenta la potenziale attività aritmogena della digossina.
5. Anormalità elettrocardiografiche
Non ci sono in genere anormalità elettrocardiografiche in pazienti con lieve ipopotassiemia, ma queste
possono divenire evidenti nell’ipopotassiemia da moderata a severa manifestandosi con comparsa di
onde U, appiattimento o inversione delle onde T o cambiamenti del segmento ST.
L’ipopotassiemia severa predispone alle aritmie e all’arresto cardiaco, fatto oltre modo vero quando i
pazienti sono trattati con digossina o sono intossicati da digossina.
Le principali aritmie associate all’ipopotassiemia sono la tachicardia ventricolare (TV) e la fibrillazione
ventricolare (FV) che possono non rispondere alla terapia elettrica o farmacologica fino a quando non
viene corretta la concentrazione serica del potassio.
La sindrome del QT lungo, ereditaria o acquisita, è dovuta a malfunzionamento dei canali ionici
responsabili della ripolarizzazione ventricolare. La deplezione di potassio e/o magnesio è il principale
disturbo metabolico associato con il malfunzionamento dei canali che predispone all’aritmia e in
particolare alla torsione di punta, un’aritmia ventricolare riconosciuta come variante della TV il cui
trattamento principale è la correzione dell’ipopotassiemia associata alla somministrazione di magnesio
solfato.

Direzione Sanitaria
PSG_LG_01
Ed 1 Rev. 0 del
Maggio 2009
Ed. 1 Rev. 0 Maggio 2009 Linee Guida per il trattamento della ipopotassemia Pagina 5 di 8
Infine l’ipopotassiemia può interferire con i benefici effetti dei farmaci antiaritmici rendendo i pazienti
più suscettibili al ripresentarsi della sottostante aritmia.
6. Trattamento dell’Ipokaliemia
Nei pazienti stabili con ipopotassiemia lieve,quando il tratto gastroenterico è utilizzabile, è più sicuro
correggere l’ipopotassiemia utilizzando la somministrazione orale che permette di impiegare dosaggi
variabili da 75-100 mMol/die con la necessità di circa una settimana per la correzione.
Criteri per l’infusione di soluzioni contenenti Potassio:
Infusione in vena periferica di soluzioni di potassio:
� massima concentrazione 80 mEq/l
� velocità d’infusione
- in condizioni normali 10 mEq/ora
- in casi particolari 20 mEq/ora
- in emergenza: 2 mEq/min per 10 m’ poi 10 mEq in 10 m’.
� le infusione di soluzioni con concentrazione >30 mEq/l devono essere infuse con pompa.
Infusione in vena centrale (raccomandata l’utilizzo della pompa)
� massima concentrazione >80 mEq/l
� velocità d’infusione >20 mEq/ora
Impiego in età pediatrica
� velocità massima d’infusione per via venosa periferica non superiore a 0.3 mEq/kg/ora.
Nei pazienti con ipopotassiemia moderata o severa bisogna distinguere i pazienti in asintomatici, con
aritmie potenzialmente fatali, in arresto cardiaco.
In assenza di sintomi compresa la tossicità da digossina e comunque in assenza di patologie cardiache
severe, il potassio dovrebbe essere somministrato alla posologia di 10 mMol/ora e.v. anche in una
vena periferica. In questa condizione la somministrazione di magnesio è richiesta solo se ne è stata
accertata la carenza.
L’insorgenza di aritmie richiede la somministrazione endovenosa di potassio la cui dose massima
raccomandata è di 20 mMol/ora con la possibilità di una più rapida somministrazione quando si
sospetti un arresto cardiaco imminente ( infusione iniziale di 2 mMol/min per 10 min seguito da 10
mMol in 5-10 min).
Un’iniezione in bolo rapido di potassio deve essere, comunque evitata perché può determinare
l’arresto cardiaco.
La somministrazione di magnesio dovrebbe essere iniziata precocemente dopo quella di potassio
anche prima di conoscere i livelli di magnesiemia.
Nell’arresto cardiaco l’ipopotassiemia può essere nota o essere scoperta dopo che la rianimazione è già
stata avviata. Sebbene lo stato metabolico del paziente in arresto cardiaco (acidosi metabolica)
favorisca un incremento del potassio sierico, il potassio intracellulare rimane basso.
7. Prevenzione dell’ipokaliemia
L’ipopotassiemia è frequentemente iatrogena e quindi evitabile.
Per effettuare una prevenzione primaria gli elettroliti dovrebbero essere monitorati nei pazienti a
rischio come quelli trattati con diuretici e quelli con alte perdite gastrointestinali.
E’ importante, inoltre, monitorare il potassio sierico dopo il trattamento iniziale e prevenire il
manifestarsi dell’ipopotassiemia mediante la rimozione di ogni fattore precipitante.
L’ipopotassiemia può anche verificarsi in pazienti con insufficienza renale che richiedono terapia
dialitica. I medici non nefrologi possono disconoscere il flusso di potassio che si realizza con le

Direzione Sanitaria
PSG_LG_01
Ed 1 Rev. 0 del
Maggio 2009
Ed. 1 Rev. 0 Maggio 2009 Linee Guida per il trattamento della ipopotassemia Pagina 6 di 8
differenti metodiche dialitiche. Nei pazienti che ricevono dialisi peritoneale, l'ipopotassiemia è un
evento che si determina frequentemente. In quelli che ricevono l’emodialisi, l’ipopotassiemia si verifica
verso la fine o subito dopo la fine della seduta dialitica. I pazienti a maggior rischio sono quelli con una
bassa potassiemia già all’inizio della procedura.
8. Flusso diagnostico terapeutico della ipopotassemia
9. Farmaci presenti in Prontuario Terapeutico di Area Vasta per il trattamento della ipopotassiemia
Per il trattamento dell’ipopotassiemia sono previste tre possibilità per la somministrazione di potassio
1. orale
2. parenterale con l’impiego di soluzioni prediluite
3. parenterale con soluzione preparate estemporaneamente diluendo soluzioni concentrate di
potassio.
9.1 TRATTAMENTO ORALE
Quando si verifichi la necessità di correggere una carenza di potassio si dovrà ricorrere in via prioritaria
prescrizione e somministrazione di potassio per via enterale (orale, SNG, PEG).
Per il trattamento orale/enterale è disponibile e richiedibile alla farmacia una preparazione galenica
contenente 20 mEq di K+ (cartine di potassio cloruro 1,5 g)
La loro diluizione in acqua e la successiva somministrazione consente una correzione “rapida” della
carenza di potassio (dose da 2-6 cartine al dì),
9.2 TRATTAMENTO PARENTERALE CON SOLUZIONI PRE-DILUITE
Quando si verifiche la necessità di somministrazione endovenosa di soluzioni concentrate di potassio
cloruro, le formulazioni di prima scelta sono quelle rappresentate da soluzioni già diluite contenenti
potassio disponibili in PTAV. Sono disponibili soluzioni diverse per solvente e concentrazione di
potassio.
KCl mEq/litro K mEq Volume Composizione
40 20 500 Potassio Cloruro 0,3 % +
Glucosio 5%
80 40 500 Potassio Cloruro 0,6 % +
Glucosio 5%
40 20 500 Potassio Cloruro 0,3 % + NaCl
0,9%
80 20 250 Potassio Cloruro 0,6 % + NaCl
0,9%
80 40 500 Potassio Cloruro 0,6 % + NaCl
0,9%

Direzione Sanitaria
PSG_LG_01
Ed 1 Rev. 0 del
Maggio 2009
Ed. 1 Rev. 0 Maggio 2009 Linee Guida per il trattamento della ipopotassemia Pagina 7 di 8
9.3 TRATTAMENTO PARENTERALE CON SOLUZIONI PREPARATE ESTEMPORANEAMENTE
Per l’impiego di soluzioni con concentrazione di potassio differenti da quelle previste al punto
precedente, si dovrà ricorrere a soluzioni preparate estemporaneamente partendo da soluzioni
concentrate. In PTAV sono presenti le seguenti preparazioni farmaceutiche:
� potassio aspartato 1 mEq/mL, fiale da 10 mL (10 mEq di K+/fiala)
� potassio aspartato 3 mEq/mL, fiale da 10 mL (30 mEq di K+/fiala)
� potassio cloruro 2 mEq/mL, fiale da 10 mL (20 mEq di KCl/fiala)
L’impiego di soluzioni concentrate di potassio è riservata alle S.O. autorizzate secondo la procedura
prevista.
10. Storia della linea guida
Revisione Data Motivo
0 Maggio 2009 Creazione della Linea Guida
11. Bibliografia − Guidon-Attali C, Colavolpe JC, Francois G. Alterazioni della Kaliemia nell’adulto. Encycl Méd Chir (Elsevier, Parigi),
Anestesia-Rianimazione, 36-860-A-15 1998, 14 p.
− Alfonzo AVM, Isles C, Geddes c, Deighan C. Potassium disorders-clinical spectrum and emergency management.
Resuscitation (2006) 70, 10-25.
− Gennari FJ. Hypokalaemia. New Eng J Med 1998;339: 451-8.
− Venkataraman R, Kellum J, Pinsky M. Skills and technique. Homeostasis. In Patient- Centred Acute Care Training.
European Society of Intensive Care Medicine 1-34.
− Singer GG, Brenner BM. Fluid and Electrolyte Disturbance. Harrison’s Principles of Internal Medicine 16Th Edition.
McGraw Hill Companies 252-263.
− Soar J, Deakin CD, Nolan JP, Abbas G ,Alfonzo A, Handley AJ, Lockey D, Perkins GD, Thies K. European Resuscitation
Council Guidelines for Resuscitation 2005. Section 7. Cardiac arrest in special circumstances. Resuscitation (2005) 67S1,
S135—S170
− Ospedale Giovanni Bosco di Torino Azienda Regionale USL 4 Della Regione Piemonte. Linee Guida nella Diagnosi e nel Trattamento dei
Pazienti con Disturbi Idroelettrolitici e dell’ Equilibrio Acido Base in Pronto Soccorso. Ipokaliemie 11-12.






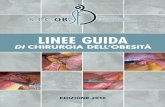
![Linee guida contabilizzazione - ordineingegneri.genova.it · Linee guida contabilizzazione - ordineingegneri.genova.it ... ] ] o ¦ ¦ ¦](https://static.fdocumenti.com/doc/165x107/5b2c7ad17f8b9abe2a8c0c21/linee-guida-contabilizzazione-linee-guida-contabilizzazione-o-.jpg)