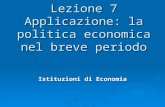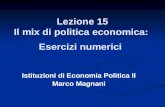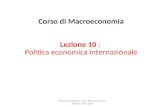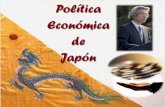Lezione 5 Politica Economica
-
Upload
claudiomodolo -
Category
Documents
-
view
213 -
download
0
description
Transcript of Lezione 5 Politica Economica
Lezione 513 marzo 2015
Il fallimento di mercato legato ai beni pubblici prende il nome di sottoproduzione rispetto a quanto socialmente ottimale. Sovrapproduzione e sottoproduzione si riferiscono appunto al livello che mi aspetto, che dal punto di vista socialmente ottimale ci genera efficienza paretiana.Dunque per sottoproduzione intendiamo ad esempio il caso in cui si riuscisse a raccogliere la disponibilit a pagare di tutti i cittadini per finanziare quel bene pubblico e si troverebbero una o pi imprese disposte a offrire il bene, in tal caso effettuando lo scambio (bene-denaro) il benessere sociale aumenterebbe. Si parla di inefficienza se di fatto ci non accade, per un mancato coordinamento non si riesce a ottenere una soluzione che farebbe star meglio tutti. L'esistenza sui mercati dei beni pubblici non garantita, perch i produttori non li trovano vantaggiosi non potendo escludere alcuni consumatori. Tali consumatori al massimo domandano il bene in quantit troppo piccole. Esempio: per un diportista un faro ha la sua utilit, ma non tale da condizionare il diportista a costruire il faro. Inoltre i consumatori possono non domandare un bene esplicitamente per avere dei vantaggi, magari in modo tale da evitare un pagamento e sfruttando comunque il servizio. Ci dato dal fatto che gli agenti economici sono definiti assolutamente opportunisti. I beni pubblici dunque non hanno la definizione per i singoli, quindi la funzione di produzione non derivabile. Tutti questi elementi portano a evidenziare che dunque nessun singolo potrebbe farsi carico dell'erogazione del bene/servizio.Se anche ci fosse escludibilit per il dato bene, non ci sarebbe comunque efficienza. Esempio: la 131 potrebbe diventare un'autostrada, con dunque caselli che escluderebbero gli accessi gratuiti. In questo caso per il pedaggio sarebbe un guadagno per i costruttori ma data la mole di persone e di autoveicoli che transitano ogni giorno, non sarebbe una soluzione di ottimo marginale, poich (in questo esempio) il costo marginale di un auto in pi non disturberebbe granch, sarebbe cio vicino allo zero e un pedaggio sarebbe troppo elevato quindi prezzo > costo marginale non c' condizione di ottimo si accetter in questi casi una condizione sub-ottimale.La non rivalit legata al fatto che il bene pubblico grande, rendendo facile per il consumo a pi soggetti senza che uno levi utilit all'altro ; il fatto che la disponibilit a pagare dei cittadini sia pi piccola dell'unit piccola con cui il bene viene prodotto, ci fa si che le curve di domanda dei beni pubblici siano costruite in maniera diversa rispetto ai beni privati (dove la domanda si somma orizzontalmente); per i beni pubblici la somma verticale. Nell'articolo di Samuelson viene definito un concetto importante: per i beni pubblici il saggio marginale di trasformazione (SMT) per due beni deve essere totale alla sommatoria dei saggi marginali di sostituzione (SMS) individuali, quindi con n individui avr SMT = n SMS .Il primo teorema dava un'efficienza paretiana con una formula diversa, e qui sta la differenza: il mercato privato eguaglia i saggi marginali di ciascun individuo e poi attraverso i prezzi va ad agire dal lato dell'offerta, sui saggi di trasformazione. Ecco anche perch non si pu risolvere con il mercato il problema del bene pubblico.Dato un saggio marginale di ogni soggetto, esso definisce le scelte, e dunque la domanda individuale di un dato bene piuttosto che di un altro; quindi la totalit dei saggi marginali presuppone appunto la somma delle domande individuali, da eseguire verticalmente(vedi grafico 4.3 Rosen Gayer, spiega come eseguire la domanda verticale muovendo i segmenti in verticale. Domanda di Adamo e domanda di Eva, sommate verticalmente trasponendo un pezzetto di domanda di A e portandolo su, in modo che una volta individuato il punto, la curva che ne risulta sia per forza pi inclinata. {preferisce il grafico delle slides}) tale grafico sta rappresentando in modo esemplificato la regola dei saggi marginali di sostituzione. La curva di offerta risulta tratteggiata (prima del punto in rosso) per indicare che per una quantit cos piccola, nessun produttore in grado di vendere una unit piccola del bene pubblico. Concettualmente chiaro che un utente da solo non avr convenienza economica a produrre il bene, mentre diventa diverso se sommiamo tutte le curve di domanda (ad esempio l'illuminazione pubblica: un soggetto ne usufruisce in misura minima per poterla produrre).[Fig 4.4 del testo rappresenta l'equilibrio raggiunto appena scritto ma non evidenza il fatto di tratteggiare la curva di offerta prima del punto in cui si sommano le domande individuali.]la somma verticale non un effetto naturale, infatti poi c' bisogno di un intervento forzoso dello stato, che deve chiedere ad ogni soggetto quanto disposto a pagare per ottenere il bene. Il mercato lasciato da solo non pu generare in automatico tale somma verticale, ma uguaglierebbe i saggi marginali di sostituzione (ci che appunto avviene per i beni privati)il problema della non escludibilit accomuna sia i beni pubblici che le esternalit. Inoltre i cittadini tendono a non rivelare le proprie domande individuali. (es comitato del comune di Cagliari che raccoglie fondi porta a porta per il servizio di nettezza urbana: ovvio che sarebbe impossibile finanziarlo in tal modo poich tale meccanismo porta tendenzialmente i singoli a non dichiarare la loro disponibilit a quanto pagare, sperando che qualcun altro lo faccia al posto loro).Free Riding (leggi: opportunismo) : fare una corsa gratis. Dunque usufruire di un bene pubblico senza contribuire alla sua produzione; ci razionale quando siamo in presenza di beni non escludibili pubblici. Altro esempio: comuni turistici che spendono molti soldi per finanziare eventi pubblici e fare pubblicit; i vari imprenditori non pagheranno, non tutti quanti, dato che potrebbero pagare gli altri. Ovviamente se il livello di escludibilit abbastanza elevato (beni Club) l'effetto del free riding meno evidente, o meno presente.Acocella ripropone l'esempio di teoria dei giochi delle due imprese che potrebbero costruire un ponte per ridurre il tempo di percorrenza tra due punti.: la costruzione darebbe all'impresa un utilit di 5, ma il costo minimo del ponte 6. dunque le domande individuali non potrebbero incontrare l'offerta individuale (non conviene costruire per le singole); se le imprese cooperassero, l'utilit totale diverrebbe 10 e allora il ponte si potrebbe fare. In questo modo le imprese potrebbero suddividere i lavori al 50% e pagare 3 di utilit ciascuno. Di conseguenza avrebbero un vantaggio di +2. si costruisce la matrice dei payoff e si analizzano i casi delle varie mosse delle imprese. Ad esempio se una non costruisce e l'altra si, ovviamente la prima avr un utilit di 11 (dato il +6 del servizio che pu sfruttare senza averlo finanziato), mentre la seconda avr una utilit netta di -1 (5 -6) e in totale starebbe a 5.come in altri tipi di gioco, anche in questo esiste una strategia dominante, cio il soggetto sa sempre cosa fare a prescindere da cosa fa l'altro, cio la strategia che viene sempre giocata perch conveniente. In questo caso, in presenza di free riding, la strategia dominante sar non costruire: per paura di risultare da soli nella costruzione, entrambe le imprese decideranno di non cooperare, per non rischiare un calo di utilit inferiore a quella di partenza.Si parla di equilibrio di Nash: a prescindere da cosa fa B, l'impresa A sta comunque pi sicura nella strategia di non costruire. E viceversa, data la simmetria del gioco.
Un monopolista sommer i vari saggi marginali e avr la disponibilit e la convenienza a costruire qualche tipo di bene (esempio un grossissimo armatore potr costruire un faro), in tal caso per non sar una soluzione ottimale ma una soluzione di second besti brevetti funzionano in maniera simile, creando un monopolio forzato per chi scopre/inventa un dato bene.Altra grande categoria dei fallimenti microeconomici di mercato: esternalit.Esternalit: danno o beneficio associato all'attivit di produzione e consumo il cui valore non internalizzato nel prezzo di mercato. L'esternalit NON viene contabilizzata nel prezzo di mercato. In presenza di esternalit l'impresa fornisce un segnale incoerente; un agente economico guarder i prezzi, terr conti dei suoi danni / benefici , senza curarsi degli altri.Esempi di esternalit negative da produzione a produzione: impresa che scarica a fiume o a mare rifiuti di produzione, e a valle ci sia una impresa ittica, che ne viene danneggiata.Esternalit da produzione a consumo se magari l'atto di scaricare rifiuti impedisce di usufruire del mare/fiume per fini turistici.Altro classico esmpio quello del frutteto e delle arnie: esternalit positive da produzione a produzione. Esternalit negativa da consumo a produzione: *fare esempio*