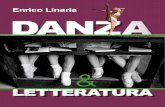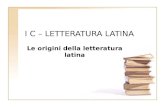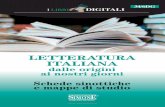Letteratura
-
Upload
carmine-mario-muliere -
Category
Documents
-
view
213 -
download
1
description
Transcript of Letteratura
EQUIPèCOCarmine Mario Muliere Editore
WALTER CLEMENTELLIMAURO - ELENA
AlbertiNeruda
BaldwinVassilikos
SartreMontale
MauriacAsturiasEhrenburgGoytisolo
ScorzaFuentes
Gombrowicz
Alberti
MarquezMoravia
BöllLevi
Vargas LlosaRoth Sabato
McCarthy
© 2010 by EQUIPèCO CARMINE MARIO MULIERE EDITORE
Tutti i diritti riservatiE-book 4ISBN 978 - 88 - 904667 - 2 - 4
Via Donnicciola 25 - 00030 San Cesareo - RMTelefono: 06 9570723
www.equipeco.it
Ideazione grafica - elaborazione foto - impaginazionemcm art©
In copertina Muliere, opera digitale, 2006
WALTER MAURO - ELENA CLEMENTELLI
LA TRAPPOLA E LA NUDITÀIntellettuale e Potere
EQUIPèCOCARMINE MARIO MULIERE EDITORE
INDICE
pagina9558293105116133144154167177189199213234254281293307335356372390
Introduzione............................................................................................................................Rafael Alberti..........................................................................................................................Pablo Neruda..........................................................................................................................James Baldwin.........................................................................................................................Vassilis Vassilikos....................................................................................................................Juan Goytisolo.........................................................................................................................Witold Gombrowicz.............................................................................................................Heinrich Böll............................................................................................................................Ilja Ehrenburg..........................................................................................................................François Mauriac....................................................................................................................Jean-Paul Sartre…………...................................................................................................Eugenio Montale…………................................................................................................Miguel Angel Asturias..........................................................................................................Carlos Fuentes.........................................................................................................................Gabriel Garcìa Marquez......................................................................................................Ernesto Sabato........................................................................................................................Mario Vargas Llosa.................................................................................................................Manuel Scorza........................................................................................................................Carlo Levi.................................................................................................................................Alberto Moravia.....................................................................................................................Mary McCarty.........................................................................................................................Philip Roth................................................................................................................................Ringraziamenti........................................................................................................................
LA TRAPPOLA E LA NUDITÀ - Intellettuale e Potere
8
Walter Mauro_Elena Clementelli
Raul, ti ricordi?Ti ricordi, Rafael?
Federico, ti ricordisotto terra...Pablo Neruda
Prima di affrontare il problema del rapporto fra lo scrit-tore e il potere, che costituisce l’epicentro dal quale si dipartela struttura di questo libro di incontri e di confessioni di alcunifra i maggiori scrittori del nostro tempo, sarà opportuno chia-rire il senso e il significato che il termine potere è andato as-sumendo sotto vari aspetti, ma soprattutto attraverso latriplice distinzione di Max Weber fra potere razionale, tradi-zionale e carismatico. Di fronte a tale problema, può risultareimportante il recupero del concetto di interconnessione delsociale che ha improntato tutta l’opera weberiana, anchecome sforzo di intendere il potere sia quale «rapporto in-terpersonale sia come attributo di una collocazione o posi-zione oggettiva giuridicamente o informalmente codificata».1
E tale puntualizzazione può riuscire ancora piú utile se si ri-flette intorno all’incertezza terminologica che ha accompa-gnato il vocabolo potere fin dai tempi piú antichi, da Platonesi potrebbe dire al punto da giustificare la definizione di Fer-rarotti di concetto-paravento come diretta conseguenza diuna tradizionale ambiguità concettuale e di una utilizzazionepericolosamente acritica.
INTRODUZIONE
1- Franco FerrarottiIntroduzione a
La sociologiadel potere
Laterza editoriBari 1972
9
LA TRAPPOLA E LA NUDITÀ - Intellettuale e Potere
Bastava la Tua corposità a opprimermi...Acquistasti ai miei occhi un alonemisterioso, come tutti i tiranni,il cui diritto si fonda sulla loro persona,non sul pensiero.
Dalla Lettera al padredi Franz Kafka
Nella triplice distinzione weberiana dunque, se da un cantopuò individuarsi l’esigenza di una lettura correttamente sto-rica, localizzabile cioè al momento della crisi della Germaniaguglielmina, come sostiene legittimamente il Ferrarotti, d’al-tro lato può riconoscersi un indice di lettura in grado di for-nire la chiave per penetrare al vivo degli infi niti, talvoltainsolubili problemi che il rapporto stesso pone, sia sul pianodella vita e della sopravvivenza del cittadino che dell’artistae dell’intellettuale. Quando Max Weber parla dei tre tipipuri del potere legittimo o razionale, tradizionale e carisma-tico, tende evidentemente a realizzare una interconnessione,si diceva, in grado di conglobare e diversificare al contempo,e anche di affrancarla da qualsiasi possibile suggestione psi-cologica, malgrado qualche non corretta interpretazione delsuo pensiero, ma d’altronde c’è da aggiungere, e si avràmodo di chiarire meglio la natura accattivante della sua con-cezione, che nei riguardi dello scrittore, ed è questo il puntofocale della nostra indagine, non si può del tutto escluderel’incidenza che un approccio psicoanalitico del problema fi-nisce per determinare, al di là ovviamente delle intenzioniweberiane.Il potere razionale si definisce come tale, evidentemente,«quando poggia - afferma Weber - sulla credenza nella le-galità di ordinamenti statuiti, e del diritto di comando di co-loro che sono chiamati ad esercitare il potere in base adessi»,2 laddove invece si può parlare - prosegue Weber - dipotere tradizionale «quando poggia sulla credenza quoti-
2- Max WeberEconomia e SocietàEdizionidi ComunitàMilano 1961ed. or. 1922
10
Walter Mauro_Elena Clementelli
diana nel carattere sacro delle tradizioni valide da sempre,e nella legittimità di coloro che sono chiamati a rivestire unaautorità»3 e infine di carattere carismatico «quando poggiasulla dedi zione straordinaria al carattere sacro o alla forzaeroica o al valore esemplare di una persona, e degli ordina-menti rivelati o creati da essa».4
È chiaro che nel primo caso la forma di obbedienza si in-staura sulla base di una legalità formale delle prescrizioni,mentre nel secondo la forma del rapporto risulta piú amonte dell’altra, lungo l’arco cioè di una obbedienza fondatasulla persona del signore in virtú di una designazione affidataalla tradizione e da questa consegnata alla realtà di una esi-stenza, e nel terzo caso infi ne, il senso della mediazione fini-sce per assumere il carisma, appunto, della fiducia personaleconsegnata dalla rivelazione, dall’eroismo, dall’esemplarità.Ha ragione Weber ovviamente quando sottolinea che il po-tere carismatico, in quanto straordinario, finisce per contrap-porsi frontalmente sia al potere razionale soprattutto di tipoburocratico, sia a quello tradizionale, soprattutto quandoquest’ultimo assume le connotazioni della patriarcalità edella patrimonialità: è come contrapporre razionalità ad ir-razionalità. Ma il carattere coercitivo, e repressivo in sensolato, assume via via configurazioni sempre piú coinvolgenti,fino ad una totale inglobazione dei tre momenti, nella vitadell’individuo.Per tornare al concetto di potere legale, è evidente che ilproblema si pone in termini di razionalità, secondo l’intui-
3-ibidem4-ibidem
11
LA TRAPPOLA E LA NUDITÀ - Intellettuale e Potere
zione di Weber, e ciò consente di liberare immediatamenteil terreno della discussione da tutte quelle forme di potere,fascismo e nazismo soprattutto, che fondano la propria dot-trina sull’irrazionale, su quella degenerazione vale a dire del-l’idealismo romantico che conduce diritto al dramma,dell’annientamento della ragione. Il problema invece diventaimportante, e come sappiamo angoscioso, quando si af-fronta sul versante di una concezione liberatoria, e quindirazionale, come il socialismo.Nella disamina che fa Lenin intorno alla società classista neirapporti con lo Stato, egli ricorda certe affermazioni di En-gels oltremodo interessanti, poiché centrano il pro blemadell’idea fondamentale del marxismo sulla funzione storica esul significato dello Stato in quanto prodotto e manifesta-zione degli antagonismi inconciliabili tra le classi. SecondoEngels dunque - il brano, nella traduzione di Lenin, è trattodall’opera del 1894 L’origine della famiglia, della proprietàprivata e dello Stato - «lo stato non è affatto una potenzaimposta alla società dall’esterno e nemmeno la realtà del-l’idea etica, l’immagine e la realtà della ragione, come affermaHegel. Esso è piuttosto un prodotto della società giunta a undeterminato stadio di sviluppo, è la confessione che questasocietà si è avvolta in una contraddizione insolubile con sestessa, che si è scissa in antagonismi inconciliabili che è im-potente a eliminare.Perché questi antagonismi queste classi con interessi econo-mici in conflitto, non distruggano se stessi e la società in una
12
Walter Mauro_Elena Clementelli
sterile lotta, sorge la necessità di una potenza che sia in ap-parenza al di sopra della società, che attenui il conflitto, lomantenga nei limiti dell’ordine; e questa potenza che emanadalla società, ma che si pone al di sopra di essa e che si estra-nea sempre piú da essa, è lo Stato».5 Lo Stato quindi comemomento liberatorio, e non come fenomeno di estinzione:a tale proposito, è nell’ambito di questa dicotomia, il di-scorso di Lenin si fa polemico nei confronti di coloro che ri-ducono il pensiero di Engels e di Marx ad una formulasecondo la quale lo Stato si estingue in contrapposizione alladottrina anarchica dell’«abolizione dello Stato»: il che signi-fica ridurre la concezione stessa dello Stato marxista entro iconfini di un opportunismo «utile solo alla borghesia», so-stiene Lenin.Una chiarificazione del problema, in un senso piú modernoed anche per le ricche e numerose implicazioni che com-porta nel rapporto che piú ci compete al momento fra intel-lettuale e potere, ci viene da Gramsci, quando affronta ilproblema di fondo della relazione stato-cittadino alla lucedi una lucida interpretazione del pensiero di Machiavelli, nonrivisitato grossolanamente come teorico di una tirannide ir-razionale, ma come fruizione di un pensiero critico che finisceper porre il problema essenziale del moderno principe. Esi-ste infatti un cesarismo progressivo e uno regressivo, e men-tre il prima si verifica quando il suo intervento aiuta la forzaprogressiva a trianfare sia pure con certi compromessi e tem-peramenti limitativi della vittoria, il secondo si realizza
5- Vladimir IlijcUlianov (Lenin)
Stato e RivoluzioneEditori Riuniti
Roma 1970ed. or. 1917
13
LA TRAPPOLA E LA NUDITÀ - Intellettuale e Potere
«quando il suo intervento aiuta a trionfare la forza regres-siva, anche in questo caso con certi campromessi e limitazioniche però hanno un valore, una portata e un significato diversiche non neI caso precedente».6 E Gramsci prosegue citandogli esempi di Cesare e di Napoleone I come momenti di uncesarismo progressivo, Napaleone III e Bismarck come feno-meni di cesarismo regressivo. Ma laddove il filosofo marxistariesce ancor meglio a chiarire il suo pensiero, anche nei con-fronti della distinzione di Engels, è nella polemica con CurzioMalaparte, quando a proposito della pubblicazione del vo-lumetto malapartiano sulla Tecnica del colpo di stato, al con-cetto dello scrittore toscano: «Tutto nello stato, nulla fuoridello stato, nulla contro lo stato» (in simbiosi coI concetto«dove c’è la libertà non c’è lo stato», egli contrappone la di-stinzione del termine di libertà non come necessità ma nellasua accezione comune di libertà politica, ossia di stampaecce tera: per cui appare chiara la consequenzialità dalla pro-posizione di Engels sul passaggio dal regno della necessità alregno della libertà. Di qui la definizione gramsciana di Stato-veilleur de nuit o Stato-carabiniere, occupato soltanto a man-tenere l’Ordine e a garantire il rispetto delle leggi, secondouna definizione di Lassalle.Un concetto questo, che finisce talvalta per coincidere conil concetto dello Stato etico, e che costringe l’in tellettuale aporsi l’interrogativo gramsciano: «La concezione dello Statogendarme-guardiano notturno non è poi la concezione dellostato che solo superi le estreme fasi corporativo-economi-
6- Antonio GramsciNote sul Machiavellisulla politica esullo Stato modernoEinaudiTorino1966
7-ibidem.
14
Walter Mauro_Elena Clementelli
che?».7
A questo punto subentra l’altro problema della necessitàstorica che coinvolge per intero la figura dell’artista e del suorapporto con il potere, sul quale si ritornerà fra poco, ancoracon il sussidio di Gramsci, che ha posto il tema in modo estre-mamente moderno e attuale.Si deve ancora sottolineare, a proposito del concetto di tran-siziane dalla democrazia formale a quello della democraziasostanziale, la dicotomia metodologica fra Lenin e Gramsciche ha fornito al Ferrarotti Io spunto per interessanti consi-derazioni. Anzitutto iI sociologo contesta la tesi di Salvadori,secondo il quale «sia Gramsci che Lenin che Trotsky affer-marono, contemporaneamente alla libertà di pensiero dellemasse e degli intellettuali, il compito del partito rivoluziona-rio di tenere a bada, per mezzo di un’azione di lotta e di di-reziane ideologica, le espressioni dell’arte e della scienza chenelle loro implicazioni dessero luogo a tendenze conserva-trici e reazionarie»;8 e poi, muovendosi dalla convergenzadei due intorno alla fiducia che nutrono nella via e nel me-todo rivoluzionario della lotta di classe, marca i toni e le sfu-mature del loro volontarismo e della loro convinzione dellarivoluzione come compito storico, finisce per connotare chia-ramente le profonde divergenze lungo gli stadi intermediche a quelle comuni conclusioni debbano portare, sottoline-ando lo strumentalismo del partito di fronte alla rivoluzionenella concezione leninista, laddove invece Gramsci central’intero suo discorso sul partito politico rivoluzionario inteso
8- Massimo L.Salvadori
Politica,potere e cultura
nel pensiero diGramsci
in Rivista di storiacontemporanea
N.1, gennaio 1972
15
LA TRAPPOLA E LA NUDITÀ - Intellettuale e Potere
come novello principe nel significato che Machiavelli si sfor-zava di dare al tema centrale dell’ascesa al potere, e con-clude: «Mentre in Lenin la questione fondamentale è inprimo luogo la presa del potere politico centrale, per Gram-sci la questione fondamentale consiste nel garantire il farsidel processo rivoluzionario come lotta quotidiana che tendealla conquista del potere, ma nel contempo socializza allabase il potere stesso, spostando i termini di forze reali a pocoa poco, nelle lotte su scala aziendale e comunitaria, a favoredelle grandi maggioranze oppresse».9 Di qui il rifiuto gram-sciano di ogni atteggiamento dogmatico o fideistico che con-duce diritto a formulazioni irrazionali e prevaricanti, el’assunziane invece, come fa giustamente notare ancora il Fer-rarotti, della forte richiesta gramsciana di una nuova cultura,richiesta che ha subìto le piú singolari deformazioni e altera-zioni nel giudizio critico intorno al pensiero del filosofo co-munista.Per tornare al discorso piú generale, e indirettamente allatriplicità weberiana, sarà interessante introdurre il concettodi arena del potere cui allude Harold Lasswell, il quale defi-nendola come «la situazione composta da coloro che do-mandano il potere o che fanno parte del campo delpotere»10 finisce per allargare l’area di giudizio e di defini-zione ad una sfera d’azione piú vasta di quanto non comportiil solo problema del potere politico, o almeno la presenzaindispensabile di uomini politici, in ciò convalidato e dal con-cetto di preminenza come formulazione del cosiddetto go-
9- Franco FerrarottiIntroduzione aLa sociologia delpotereop. cit.
10- Harold LasswellA. KaplanPotere e societàEtas KompassMilano 1969
16
Walter Mauro_Elena Clementelli
dimento del potere e da talune sollecitazioni di Tawneyquando osserva come la discussione dei problemi che il po-tere determina e provoca è risultata il piú delle volte condi-zionata, e pregiudicata, «dal fatto che si è concentratal’attenziane su alcune delle sue manifestazioni ad esclusionedi altre».11
Il Tawney infatti, lungo l’arco di un tracciato speculativo for-temente decentrato, arriva a concludere: «I fondamenti delpotere variano da età a età, col variare degli interessi chemotivano gli uomini, e col variare degli aspetti della vita aiquali essi attribuiscono un’importanza preponderante. Fontedel potere è stata la religione, il valore e il prestigio militare,la forza dell’organizzazione professionale, il controllo esclu-sivo di certe forme di conoscenza e di abilità, come quelledel mago, dello stregone, del giurista».12 Quando MaxWeber parla di potere tradizionale come legittimità che sifonda sulla base di antichi ordinamenti e poteri di signoria,accanto ad altre forme di compressione che interessano inmisura minore il nostro discorso, introduce i concetti di ge-rontocrazia, di patriarcalismo e di patrimonialismo, laddovesoprattutto i primi due finiscono per fondersi all’interno delnucleo domestico assommandosi nella figura prevaricante,in senso tradizionale, del padre cui si deve rispetto e reve-renza, al punto da condividerne le idee e cedere passiva-mente alla sua volontà. Fa notare giustamente Weber come«non disponendo di un apparato, egli è ancor piú dipen-dente dalla volontà di obbedienza dei membri del
11- R. H. TawneyEquality
London 1931
12-ibidem
13. Max WeberEconomia e Società
op. cit.
17
LA TRAPPOLA E LA NUDITÀ - Intellettuale e Potere
gruppo»,13 e quindi si deve parlare di consociati piú che disudditi. E d’altro canto, proprio in virtú di queste connota-zioni, tale tipo di potere è l’unico a non possedere in sé quelcarattere liberatorio insito invece nel potere politico di tiposocialistico o in quello religioso di tipo cristiano, nella prei-storia evidentemente del loro progressivo degenerare.«Padre e figlio si incontrano sulla stessa strada troppo strettaper due uomini. Bisogna che uno ceda il posto all’altro»14: datale considerazione si è mosso l’intervento di René Girardnel corso del Convegno organizzato nel 1965 a Royaumontdall’Istituto di Sociologia della Université Libre di Bruxellese dall’Ecole Pratique des Hautes Etudes di Parigi, durante ilquale il momento di interdisciplinarità fra Marx e Freud, at-traverso la spirale hegeliana, è venuto fuori lungo l’arco diun concreto raffronto problematico.Sul filo dell’incontro e della verifica fra l’individuale e il so-ciale, le strutture antropologiche dell’immaginario hanno rin-tracciato un fertile terreno d’incontro e di comunicazionecon la concretezza e il realismo su cui si muove la concezionemarxistica della vita e dell’arte. Di qui la legittimazione di ta-lune facoltà di individuazione delle caratteristiche repressivedel patriarcalismo come capacità di proiezione su un ver-sante molto piú vasto e pregnante del paleomarxismo sche-matico e pregiudiziale.Ma torniamo a René Girard: per le sue affermazioni riguar-danti il rapporto padre-figlio, egli si muove dal mito di EdipoRe, e precisamente dal momento in cui, ispirato dall’oracolo,
18
Walter Mauro_Elena Clementelli
Laio allontana con la forza Edipo per paura che questiprenda il suo posto sul trono di Tebe e nel letto di Giocasta;e di conseguenza, ancora su ispirazione dell’oracolo, Edipoallontana altrettanto violentemente Laio e prende il suoposto sul trono di Tebe e nel letto di Giocasta.Tale parabola conduce Girard alla considerazione primariache «desiderando ciò che desidera il padre, e possedendopoi ciò che egli possiede, per sempre e dovunque, il figliovuole impadronirsi dell’essere del padre»: il rapporto fra ilsé e l’Altro appare evidente e va collocato alle radici stessedel dissidio: il che significa che il momento della pietà filialee quello della rivolta finiscono per legarsi ad una stessa ori-gine. Il clima sotteso di angoscia che circola all’interno dellaLettera al padre di Kafka si deve identificare anche in talecondizione della psiche del soggetto nei confronti del pa-triarca: «Avrei avuto bisogno di qualche incoraggiamento,di un pó di gentilezza, che mi si aprisse un poco il cammino,invece tu me lo nascondevi, sia pure con la buona intenzionedi farmene imboccare un altro». E Montale dirà, nel corsodel nostro colloquio: «La mia famiglia non è stata tirannica,anzi potrei fare un appunto che lo è stata poco, troppopoco, perché si sono completamente disinteressati dime...».14
Il padre quindi finisce per muoversi entro un’area mediatadi felicità e di infelicità nei confronti del figlio, i due si ritro-vano in luoghi differenti, e soprattutto agiscono in due re-gioni asso lutamente distinte o separate dell’esistenza. La loro
14- René GirardUna analisidi Edipo re
in La critica traMarx e FreudGuaraldi ed.
Firenze 1973
19
LA TRAPPOLA E LA NUDITÀ - Intellettuale e Potere
divergenza può anche assumere il carattere di provvisorietà,soprattutto laddove va a collocarsi la circolarità del mito, af-ferma ancora Girard, per cui all’inizio c’è un padre della vitaquotidiana, ed è Polidio, e un padre del desiderio e del di-vieto, ed è Laio: una struttura questa che finisce per rove-sciarsi al momento della fuga, convalidando cosí il concettodella continua inversione sulla quale si fonda, appunto, la cir-colarità del mito.Non solo: l’insistenza con cui Sofocle sottolinea i difetti diEdipo, un carattere aggressivo e collerico, serve a configu-rare il rapporto lungo un arco di mediazione fra mecca nicitàe dialettica che non è in grado di compiere una precisascelta, e deve perciò muoversi entro quella sfera di ambi-guità per cui «il figlio non sa mai di essere per suo figlio esat-tamente ciò che suo padre fu per lui». Il momento dimaggior frizione, e quindi di piú arduo rapporto, sta nelmezzo, nella facoltà cioè di possedere il dominio del passag-gio oppositivo dal meccanico al dialettico, in questo fran-gente, il pericolo prospettato da Girard risulta chiaro eindubitabile: «Instaurare l’ordine dialettico, vedere in taleordine se non una realtà per lo meno una esigenza fonda-mentale nell’ordine culturale, porre il principio di una reci-procità senza limiti è come destinare gli uomini ai piúspaventosi conflitti».15
È abbastanza facile, a questo punto, concludere che «amareil figlio in quanto figlio significa vedere in lui un possibile ri-vale, venerare il padre in quanto padre è già meditare sulla15-ibidem
20
Walter Mauro_Elena Clementelli
sua scomparsa».È a questo punto, a tale svolta della statuizione, che inter-vengono quelli che Girard definisce possibili palliativi, mache non possono essere ritenuti soltanto come tali, pena loscadimento di tutto il livello di guardia del discorso. È veroinfatti, come sostiene Girard, che «possiamo considerare ilsacrificio di Abramo come momento essenziale della fonda-zione di una cultura patriarcale», per cui Abramo stesso fi-nisce per identificarsi in un altro Laio, ma è altrettanto veroche la matrice stessa del potere carismatico cristiano simuove entro un’area diversa e pertanto possiede in sé ulte-riori ragioni di verifica.Nel momento stesso in cui l’adolescente sfuggito al poteretradizionale, si intrica nelle spire del potere carismatico fini-sce per reperire nuove e diverse ragioni di esistere, e luci-damente è già in grado di individuare la violenta dicotomiafra il Cristianesimo originario e le sue forme degeneranti econtroriformistiche.La testimonianza piú evidente di questo passaggio, il lettorepotrà trovarla nelle parole drammatiche di Mary McCarthy:ma al di là della documentazione di una scrittrice, risulta evi-dente il momento del passaggio da un rapporto diretto edepurato da ogni inquisitoria manifestazione repressiva, aduna stagione, invece, in cui proprio tali componenti prevari-canti finiscono con il prendere il sopravvento. Malgrado ognibuona intenzione di estendere il discorso, è ancora ad unoscrittore che dobbiamo ricorrere: e mentre Mary McCarthy
21
LA TRAPPOLA E LA NUDITÀ - Intellettuale e Potere
ci fornisce i dati di un rapporto che via via traligna nell’inti-midazione, François Mauriac a sua volta rappresenta la testi-monianza di un recupero totale delle origini come matricespirituale in grado di restituire alla fede religiosa tutto il suocarattere liberatorio, socialistico.Il tempo presente, il cattolicesimo dissenziente e le piú avan-zate forme di insegnamento religioso, si configurano comeuna precisa documentazione dello sforzo di liberazione e diaffrancamento da un rituale e da una sacralità che aveva fi-nito con il fuorviare le coscienze, provocando problemi ecrisi drammatiche, comparabili appunto alle degenerazionidel socialismo. Superato il momento del quia dantesco comeinvito dogmatico all’acquiescenza, e il tragico momento in-quisitorio della Controriforma, l’insegnamento religiosotende oggi a liberarsi proprio di quella prevalenza carisma-tica che per secoli lo aveva caratterizzato come riconosci-mento falsamente spontaneo dei dominati, concesso,sottolinea Weber, in base alla prova che nasce dalla fedenella rivelazione, dalla venerazione dell’eroe e dalla fiducianel capo.È quindi il presupposto del dovere ad alterare i termini delrapporto. E se è vero quanto afferma Lasswell che «la costri-zione è l’esercizio di influenza attraverso la minaccia di pri-vazioni, e l’allettamento I’esercizio di influenza attraverso lapromessa di vantaggi», allora il carattere drammatico cheviene ad assumere il rapporto carismatico traspare in tuttala sua violenta prevaricazione, come minaccia di punizione e
22
Walter Mauro_Elena Clementelli
come promessa di premio. Né si deve trascurare, al di là delpuro e semplice rapporto merito-premio, il carattere emo-zionale del rapporto stesso, anche quando l’ordine gerar-chico si individua nella dualità profeta-discepolo, poichéviene a mancare la sequenza, logica nel potere politico, del-l’assunzione e della destituzione, per cui non resta che la resao la fuga. Non pochi saranno i nostri amici che nel corso delleconversazioni parleranno di fuga a proposito del potere re-ligioso, proprio in virtú dell’assenza di regole che possanogovernarlo. Ha ragione perciò Weber ancora, quando sot-tolinea la contrapposizione del potere carismatico, in quantostraordinario e irrazionale, a quello legale-politico, di tiporazionale e ancor di piú a quello tradizionale-patriarcale epatrimoniale o di ceto.C’è da chiedersi, infine, a conclusione del discorso teoricointeso come necessaria premessa al tema che ci siamo pro-posto, per quale ragione la ribellione al potere carismaticoha trovato, nel mondo moderno, una maggiore possibilità disviluppo, un’area piú malleabile di quanto non sia accaduto,tutto sommato, nei confronti del potere politico e patriar-cale: la ragione sta forse nel carattere permanentemente ri-voluzionario che il concetto di carisma ha finito per avere, inobbedienza alla sua stessa origine che si identificava con unvero e proprio rovesciamento del passato: «A differenzadella forza egual mente rivoluzionaria della ratio, il carismapuò rappresentare - sottolinea Weber - una trasformazionedall’interno, può cioè costituire un mutamento, fondato sulla
16- Max WeberEconomia e Società
op. cit.
23
LA TRAPPOLA E LA NUDITÀ - Intellettuale e Potere
necessità o sull’entusiasmo, delle direttrici di pensiero edazione in base ad un orientamento del tutto nuovo delle po-sizioni di fronte a tutte le singole forme di vita e di fronte almondo».16
Al cospetto delle forme di democrazia diretta e di parteci-pazione di base che caratterizzano il nostro tempo, il poterecarismatico ha finito per cedere ad un maggior potenziale discardinamento di quanto sia stato possibile alle manifesta-zioni del potere burocratico, piú soggetto a regole di torna-conto e di strategia politica, o patriarcale, fortemente legatoal potere politico, almeno nelle sue interne strutture.«Qualcuno doveva aver calunniato Joseph K. poiché senzache avesse fatto alcunché di male una mattina venne arre-stato»: dal celebre avvio del racconto forse piú sconvolgentedella letteratura moderna, Il processo di Kafka, ha cominciatoa prendere forma e coscienza il senso di smarrimento, e diincredulità, dell’intellettuale di fronte alla repressione che ilpotere ha esercitato su di lui, in ogni tempo. Al di là di pre-cedenti, e successive forme apparenti di collaborazione,identificabili via via attraverso i mutevoli e problematiciaspetti del mecenatismo o del cortigianesimo, il nodo delproblema ha sempre finito con il riconoscersi nello sdegnodi Alfieri quando alla corte di Vienna assistette alla metasta-siana genuflessioncella d’uso. Mai tuttavia una presa di co-scienza, fondata sulla propria capacità di marcaturadell’attività deformante del rapporto scrittore-potere, avevarintracciato un cosí vasto e incisivo indice di angoscia esisten-
24
Walter Mauro_Elena Clementelli
ziale come nel caso dello scrittore praghese, e nei confrontidel potere familiare e al cospetto dell’ottusità, e del rifiutodella ragione e dell’intelligenza, da parte del potere politico.C’è da aggiungere che certi recenti studi psicocritici hannofornito strumenti di conoscenza e di individuazione della re-altà fenomenica del rapporto quanto mai utili all’indaginestrutturale intorno a tutta la vasta e possibile conglobazionedi elementi adatti all’interpretazione degli stati d’animo e deiriflessi della coscienza dell’artista.Ancora al Convegno di Royaumont del 1965, Charles Mau-ron affrontò il tema della formazione del mito personalenello scrittore, giungendo a conclusioni oltremodo interes-santi che servono anche a penetrare piú profodamente neirisvolti dell’opera d’arte come rispecchiamento freudiano emarxista al contempo in questo caso, di una prevaricante re-altà esterna. Il discorso di Mauron è molto chiaro e vale lapena di riferirlo almeno in quella parte che riguarda la fun-zione deI mito personale nella creazione letteraria: «Esso -afferma il Mauron- rappresenta un campo di forze psichiche,una specie di matrice immaginativa se vogliamo, spogliandoperò l’espressione di tutto ciò che ha di statico».17
La matrice attira, accoglie, ordina tutta una serie di materiali,ricordi od oggetti, provenienti dai contenuti della coscienzae, quindi, dalla esperienza del mondo proprio dell’artista;nel caso dello scrittore essi possono riguardare anche le sueletture e le sue osservazioni. Bisogna inoltre sottolineare cheil fantasma dominante vive nella interiorità dello scrittore e
17- Charles MauronLa formazione
del mito personalenello scrittore
in La critica traMarx e Freud
op. cit.
25
LA TRAPPOLA E LA NUDITÀ - Intellettuale e Potere
si evolve nel tempo, di opera in opera, secondo influenzeesterne o interne». Il che significa, in virtú del rifiuto del con-cetto di staticità nella matrice immaginativa, collocarsi al dilà dell’idea romantica di intellettuale di categoria nietz-schiana, e individuare invece al vivo del rispecchiamentodell’umano il senso drammatico delle cose che l’artista soffree vive fra le pieghe della coscienza. Non soltanto: ma vuoldire anche fornire all’immaginazione, al sogno, quei conno-tati di sovversione che liberano automaticamente la fantasiapoetica da ogni possibile compromissione narcisistica e rea-zionaria, in funzione di una dinamica liberatoria in grado diinserirla di diritto nella facoltà dialettica della storia.Per tornare ancora per un momento a Mauron, resta da sot-tolineare l’importanza che egli attribuise agli scritti giovanilidell’artista, localizzabili proprio alla svolta durante la qualel’adolescente mette in opera meccanismi particolari di difesacontro l’angoscia, in forza dei quali riesce a crearsi una bar-riera, un muro di cinta fondato sull’acquisizione di una auto-nomia materiale e morale (e Carlo Levi insisterà fortementesul termine di autonomia nel nostro incontro), che rappre-senta il primo passo verso la conquista di uno status socialee la fondazione di un focolare privato, prospettive questeangosciose che sottolineano il difficile, tormentoso passaggiodall’ambiente familiare, quasi sempre repressivo, a quello digruppi piú estesi che servono ad ingigantire il concetto direpressione. «L’immaginazione - afferma ancora Mauron -fonte di disegni ideo-affettivi ne viene necessariamente sti-
26
Walter Mauro_Elena Clementelli
molata. I fantasmi formatisi in questo periodo paiono anchepiú pregni di significato e piú durevoli di qualsiasi altro. Nondobbiamo neanche dimenticare, poi, che la spinta puberaleriattiva l’Edipo e con esso tutte le precedenti fissazioni, tuttala serie dei conflitti che portarono all’Edipo»,18 a condizionetuttavia, e lo stesso Mauron convalida questa esigenza, chesi tenga nel debito conto l’ambiente sociale e culturale entrocui si sviluppa tale consapevolezza, con tutto l’universo deisuoi stimoli e dei suoi divieti, dei desideri e delle paure chepopolano di incubi la fase incubatrice dell’artista, ci si per-doni il voluto bisticcio.A tale proposito, e per entrare ancora piú nel vivo della ma-teria di questo libro, ci soccorrono due brani autobiograficiche Peter Weiss scrisse fra il 1961 e il 1962, Abschied vonden Eltern e Fluchtpunkt,19 poiché essi forniscono alcunechiavi interpretative di estre mo interesse per comprenderee individuare ancor meglio le ragioni di una liberazione, diuna sorta di anarchia verbale che nell’attività drammaturgicadi Weiss hanno trovato la loro piú compiuta espressione.Nell’arco di un complesso conflitto privato e familiare, Weissfinisce per andare ancora oltre il dramma del rapporto kaf-kiano tra padre e figlio, poiché accentua i termini del divarioe della rottura lungo le strutture di una diversificazione so-ciopolitica, oltre che umana. In tal senso l’illuminismo e la lu-cidità razionale di Weiss risultano abbastanza consequenzialialla natura stessa della sua condizione di ebreo e di antibor-ghese, vissuto all’indomani della stagione kafkiana, alle ma-
18-ibidem
19- Peter WeissCongedo dai geni-
torie Punto di fuga
EinaudiTorino 1965-67
27
LA TRAPPOLA E LA NUDITÀ - Intellettuale e Potere
trici dolorose della piú cupa notte d’Europa, quella del nazi-smo e delle persecuzioni politiche da esso messe in opera.Ecco quindi che il conflitto privato diventa in lui pubblico eimpegna tutte le componenti del vero e del reale, in un de-terminato distacco dalle ambiguità del monologo e dellacontemplazione interiore. Il senso primordiale deII’educa-zione, con tutti i sobbalzi di coscienza e la durezza sconvol-gente di brutali scoperte sessuali e psicologiche, si confondelungo piú ampie spirali, sí da impegnare a fondo tutti i com-portamenti esterni dell’uomo.La rivolta che lo spingerà fino al punto di fuga nasce e si svi-luppa irrazionalmente, senza quelle componenti filosoficheche ad esempio agiscono sulla ribellione camusiana.In Weiss infatti, il contingente già filtra e si dissolve allo statodell’immaturità infantile, per cui l’assurdo e la ribellione al-l’equivoco balzano fuori da una situazione e da una condi-zione preistorica che non possiede piú àncore di salvezza,dal momento che vive e si muove lungo i paesaggi allucinatidi una terra bruciata e senza orizzonti.La reazione, letteraria senza dubbio ma anche umana e psi-cologica, e perciò piú fredda e decantata pur nelI’onda caldadel sentimento, alla morte del padre, è abbastanza sintoma-tica di un’abdicazione totale, di un rifiuto tenace a misurarei termini della realtà con un metro diverso da quello irrazio-nale dell’adolescenza (e tale condizione ritroveremo nelleparole di Monique Lange, nel nostro incontro con lei e conGoytisolo, a proposito della morte della madre), e di una lu-
28
Walter Mauro_Elena Clementelli
cidità ormai acquisita, poiché ha trova to proprio nell’infanziagli strumenti della consapevolezza. Lungo tale difficile incro-cio, insolubile in termini filosofici, si inserisce la realtà solu-toria della seconda parte dell’au tobiografia, il punto di fugache va subito a confondersi con l’individuazione dell’io na-scosto dietro il muro dell’incomprensione sociale e ideolo-gica. «Arrivai a Stoccolma l’8 novembre 1940», ricordaWeiss ad apertura del secondo tempo della sua educazionesentimentale. Qui, liberatosi della famiglia e apparentementeaffrancato da ogni sorta di tirannide, finisce per ritrovarsi su-bito ingabbiato fra le spire delle contraddizioni e delle piúdifformi sollecitazioni. A chi osservi la sua pittura in queglianni appare chiaro come l’ansia della ricerca sia di continuofrenata e svariata da esigenze evasive che inutilmen-te loscrittore si sforza di comprimere entro i confini della logicae della dialettica: è l’Europa con tutto il grande fardello didolore e di crisi che si sta trascinando dietro.La dialettica del vano e dell’assurdo riesce allora a prendereil sopravvento su ogni possi bile concretezza della vita e de-lI’impegno politico, e la preistoria, nel momento stesso in cuidiventa storia e contemporaneità operante, si traduce inegoismo puro, in una sorta di individualismo che ha ormaisuperato in pieno il superomismo romantico, e va invece ariconoscersi nell’esigenza di fondo di reperire una libertà as-soluta lungo le strutture mitiche del pensiero. Sarà vanol’amore, come sarà vano il ricordo struggente della tragediadel popolo ebraico in cui va a naufragare la propria matrice
29
LA TRAPPOLA E LA NUDITÀ - Intellettuale e Potere
domestica, e a nulla servono le parole deIl’amico Hoderer,una sorta di socratica punta del dilemma e della sillogequest’ultimo, per veder di sradicare l’intellettuale e l’uomodal proprio connaturato egoismo. La liberazione sarà il lin-guaggio, punto di fuga che recupera il punto di partenza: nelmomento in cui Peter Weiss restituisce alla memoria le suefacoltà di rimarginazione, isolandole al contempo da ognideteriore attività contemplativa, anche l’autobiografia vienemeno per cedere il posto alla biografia e alla nascita primor-diale dello scrittore. Alla ricognizione e all’individuazione dellinguaggio, autentica e sola ragione di vita e di sopravvivenza,si chiarisce il passato e si determina il presente e il futuro, at-tra verso una via di recupero e di riscatto che si riconoscenell’acquisizione stessa della libertà: «La libertà era assoluta,io potevo perdermi in essa e in essa potevo ritrovarmi, po-tevo abbandonare tutto, ogni sforzo, ogni solidarietà, e po-tevo cominciare a parlare. E la lingua che ora venivaspontanea era quella che avevo imparato all’inizio della miavita, la lingua naturale che era il mio strumento, che sola an-cora mi apparteneva e che non aveva piú niente a che farecol paese nel quale ero cresciuto.In quel momento la guerra era superata e io avevo ormai allemie spalle gli anni della fuga ai quali ero sopravvissuto. Po-tevo parlare, potevo dire ciò volevo dire e forse qualcunomi ascoltava, forse altri mi avrebbero parlato e io li avrei ca-piti».20 Tale condizione di creatività artistica, collocabile inuna sfera di mediazione fra conscio e inconscio, con la fase20-ibidem
30
Walter Mauro_Elena Clementelli
del linguaggio interpretata come momento liberatorio con-clusivo, ha le sue matrici fondamentali in certa psicologia clas-sica dell’Ottocento tedesco, e massimamente in taluneproposizioni estetiche di SchelIing, proiettate poi, ad esem-pio, nell’opera poetica di Schiller, il cui sforzo creativo, inter-mediato nell’arte come gioco, finiva poi per riconoscersinell’esigenza primaria di rintracciare il filo segreto del cosid-detto istinto sensibile condizionato in modo assoluto dal cer-chio razionale condotto dalle forze dominanti. L’urto frasoggettività e realtà assume connotazioni dialettiche benprecise nel momento in cui si giunge all’intuizione hegelianadella necessità delI’arte come derivazione e conseguenzadella precarietà del reale: un filone questo, che da taluni es-senziali presupposti della Scuola di Francoforte finisce perpenetrare nei congegni del pensiero di Marcuse, soprattuttoin Eros e civiltà, laddove egli considera «l’arte come una li-berazione simbolica in forme sublimate di bisogni repressi».21
Ha ragione Vittorio Saltini quando rivendica appunto alla fi-losofia tedesca classica la paternità22 del concetto di ritornodel represso che invece Francesco Orlando attribuisce glo-balmente a Freud,23 privandola in tal modo di quelle facoltàdi sviluppo di un’estetica scientifica che deve rintracciare ra-gioni di incontro e di derivazione piuttosto che motivi di iso-lamento.D’altro canto, c’è da rilevare il carattere a volte illuminantedel lavorio critico svolto da Orlando già in un saggio prece-dente dedicato ad una pregnante lettura freudiana della
21- Vittorio SaltiniRegressione,
inconscio eletteratura
in L’Espresso23 dicembre 1973
22- ibidem
23- FrancescoOrlando
Per una teoriafreudiana
della letteraturaEinaudi
Torino 1973
31
LA TRAPPOLA E LA NUDITÀ - Intellettuale e Potere
Phédre: e proprio muovendosi da quelle posizioni, il criticosviluppa il concetto del bisogno non soltanto di recuperareil represso da parte della letteratura, ma anche la conse-guente esigenza di trasgredire, attraverso l’individuazione ditaluni punti essenzia li, fra i quali basterà sottolineare da unaparte «il ritorno del represso come presenza di contenuticensurati dalla represssione sociale che grava sul sesso»,dall’altra «il ritorno del represso come presenza di contenuticensurati da una repressione ideologico-politica».24 Il caso diFedra, il cui desiderio di peccato risulta di continuo azionatodalla molla di una repressione sociale che finisce per proiet-tarsi in una forma di repressione ideologica, può ritenersiesemplare ed esemplificante, come d’altronde sostiene Or-lando, e si configura senz’altro come forza propedeutica su-scettibile di ulteriori sviluppi di una direzione nonisolatamente freudiana, ma in grado invece di arricchirsi deicontributi essenziali di altre forze di convergenza.Proprio tale facoltà di irradiazione legittima la necessità diritornare al primitivo rapporto fra scrittore e potere, nellasua triplice accezione, soprattutto all’impatto che l’idea diletteratura ha subìto di fronte al rifiuto della trasgressione,e alla punizione di essa massimamente quando si configuracome privilegio dell’immaginazione. Sgomberato il terrenodalla possibilità di un rapporto scrittore-potere politico inuna società di tipo capitaIistico che slitta verso forme di per-versione come il nazismo e il fascismo (poiché in questi casila repressione dell’intellettuale nasce e si sviluppa come24-ibidem
32
Walter Mauro_Elena Clementelli
struttura connaturata al carattere stesso che il potere è an-dato assumendo), è chiaro che gli sviluppi di piú drammaticointeresse sono reperibili nel rapporto, e nell’urto illogico esorprendente, fra scrittore e potere socialista, cosí come èandato configurandosi nel periodo postrivoluzionario e an-cora oggi nei paesi retti a democrazia popolare.Nel fitto dialogo fra Renato e Bruno, dietro i quali si celanoin realtà i due protagonisti della sinistra hegeliana Max Stir-ner e Bruno Bauer, Marx ed Engels tendono ad individuarele strutturazioni di fondo dell’arte socialista entro marginimolto piú vasti, tutto sommato, di quanto poi certi fedeli eortodossi difensori del realismo non si preoccuperanno difare: «La concentrazione esclusiva del talento artistico in al-cuni individui e il suo soffocamento nella grande massa, chead essa è connessa, è conseguenza della divisione del lavoro.Anche se in certe condizioni sociali ognuno fosse un pittoreeccelIente, ciò non escluderebbe che ognuno fosse un pit-tore originale, cosicché anche qui la distinzione tra lavoroumano e lavoro unico si risolve in una pura assurdità. In unaorganizzazione comunistica della società in ogni caso, cessala sussunzione dell’artista sotto la ristrettezza locale e nazio-nale, che deriva unicamente dalla divisione del lavoro, e lasussunzione dell’individuo sotto questa arte determinata,per cui egli è esclusivamente un pittore, uno scultore: nomiche già esprimono a sufficienza la limitazione del suo svi-luppo professionale e la sua dipendenza dalla divisione dellavoro. In una società comunista non esistono pittori, ma
25- K. Marx eF. Engels
Scritti sull’Artea cura di C. Salinari
LaterzaBari 1967
33
LA TRAPPOLA E LA NUDITÀ - Intellettuale e Potere
tutt’al piú uomini che, tra l’altro, dipingono».25
Quel tipo di possibilismo e di apertura, che nei casi piú dram-matici finirà poi per risolversi in frustrazioni autocensorie, evi-denziato da Marx e da Engels nella prima parte del branoriportato, risulta poi esplicitamente frenato dalle conclusioniche tendono a proporre risoluzioni socialistiche nel campodell’arte che piú direttamente investono il problema di fondodell’autonomia espressiva, vale a dire il rapporto fra quellache Gramsci definisce sintomaticamente arte coatta e l’anar-chia liberatoria che di continuo si insinua al nodo vitale diqualsiasi espressione artistica, senza escludere neppure unaprogettazione di categoria strettamente aderente al vero eal reale.Il problema si pose per la prima volta in tutta la sua tragicaevidenza nel corso del famoso Primo congresso degli scrittorisovietici svoltosi a Mosca nel 1934, quando le singole posi-zioni andarono a convergere intorno ad un’idea centrale chefu esasperata e radicalizzata al massimo grado, fino a diven-tare una sorta di verbo infal libile nella creazione artistica.I due punti di vista estremi potrebbero sintetizzarsi nellestrutture ideologiche espresse da una parte dai seguaci diBlok, difensori della teoria secondo la quale non era possi-bile, né conseguente, imporre alla massa una determinata cul-tura, frutto di cieca acquisizione, e dall’altra degli intellettualicosiddetti zdanoviani, che presero appunto nome e ideolo-gia dal loro capo spirituale, Andrej Zdanov, tipico prodottodella piú ottusa e refrattaria ortodossia. Nel suo sforzo di sta-
34
Walter Mauro_Elena Clementelli
bilire una precisa continuità tra umanesimo tradizionale ecultura delle masse, individuabile d’altronde anche nel pen-siero di Gramsci e nel suo legame con la fase piú avanzatadel pensiero crociano, Blok individuava nelle masse la nuovaforza motrice della storia, e pertanto una entità in grado diereditare appieno la grande cultura umanistica e di farla pro-pria. Di qui il concetto di fondo di Blok: «Noi non siamo i pa-stori, il popolo non è il gregge. Noi siamo soltanto compagnipiú informati», cui Zdanov contrappose la teoria stalinianadello scrittore ingegnere di anime: «Essere ingegnere dianime significa stare con entrambi i piedi sul terreno dellavita reale. E questo a sua volta significa rottura col romanti-cismo di vecchio tipo, col romanticismo che raffigurava unavita inesistente ed eroi inesistenti, portando il lettore dallecontraddizioni e dall’oppressione della vita nel mondo del-l’irrealizzabile, nel mondo delle utopie».26 Né Massimo Gorkijparve meno drastico nell’occasione: «Lo sviluppo sociale eculturale dell’umanità procede in maniera normale soloquando le mani insegnano al cervello, poi il cervello, reso piúscaltro, insegna alle mani, e infine le mani, ormai abilissime,condizionano nuovamente e con intensità ancora maggiorelo sviluppo del cervello...».E ancora Gorkij, in un’affermazione sintomatica, matrice diinfinite e tragiche crisi coscienziali: «La realtà ci fornisce unamateria prima sempre piú ricca su cui operare delle genera-lizzazioni artistiche, eppure né un dramma né un romanzo cihanno offerto ancora una raffigurazione abbastanza convin-
26-Rivoluzione eletteratura,dibattito al
Primo Congressodegli scrittori
sovietici del 1934a cura di V. Strada
LaterzaBari 1967
27- Massimo Gorkijibidem
35
LA TRAPPOLA E LA NUDITÀ - Intellettuale e Potere
cente della donna sovietica che agisce liberamente ed egre-giamente in tutti i campi della edificazione della vita sociali-sta».27
Il dissidio di fondo arte-potere nasce proprio su queste strut-ture, e non è casuale il fatto che proprio da Ilija Ehrenburg, ilquale fornirà una drammatica testimonianza in questo libro,cominciano ad affacciarsi a quel Congresso i primi dubbi in-torno aI problema, all’interno dell’universo socialista, mai ri-fiutato e isolato, ma piuttosto coinvolto in pieno nel dissenso,laddove egli sottolinea, sulla scia dell’intervento dolente diBucharin, che «la creazione di un’opera d’arte è un processoindividuale, anzi un processo intimo», coinvolgendo in talediscorso la difesa della poesia di Pasternak che da quel Con-gresso uscí ovviamente con le ossa rotte, e considera ancora«atteggiamento burocratico nei confronti della letteratura»scrivere «questa determinata cosa in questa determinata ma-niera». Tutto ciò non esclude affatto, a giudizio di Ehrenburg,la validità e la sostanza dell’edificazione di una società socia-lista, anzi ne convalida le strutture e ne definisce i termini:«La nostra società è profondamente democratica. Il pastoredi ieri oggi è ingegnere. Il livello culturale delle grandi massesi sta elevando ogni giorno di piú, ma ci troviamo davanti auna massa tutt’altro che omogenea. Abbiamo i colcosiani, ap-pena usciti dall’analfabetismo, e abbiamo scienziati presso iquali vengono ad imparare americani ed europei. Naturalequindi che da noi anche la letteratura si proponga fini di-versi».28
28- Ilija Ehrenburgibidem
36
Walter Mauro_Elena Clementelli
Se la posizione di Ehrenburg può essere indicativa deldramma di un intellettuale cosmopolita e socialista al con-tempo, la testimonianza che a quel Congresso forní Jurij Kar-lovic Oleša, una confessione che vale la pena di riportare, adintegrazione di tutte le confessioni che compaiono in questolibro, si configura come comprendere i motivi di fondo di uncomplesso di inferiorità di fronte alla realtà rivoluzionaria, esoprattutto del senso di incubo e di sgomento che tale con-dizione comporta in uno spirito educato ad un piú apertotipo di cultura: «Un personaggio può uccidere l’artista. Seianni fa - racconta Oleša - scrissi il romanzo Invidia.29
Il personaggio centrale del racconto era Nokolaj Cavalarov.Mi dissero che in Kavalarov c’era molto di mio, che era unpersonaggio autobiografico, che ero io stesso. Sí, Kavalarovguardava il mondo con i miei occhi. Le tinte, i colori, i perso-naggi, le similitudini, le metafore, le conclusioni di Kavalarovmi appartenevano. E, erano i colori piú puri, piú luminosi,ch’io abbia visto... molti di essi mi son venuti dall’infanzia, sni-dati dall’angolino piú nascosto, dal cassetto delle osserva-zioni che non si ripetono. Come artista ho profuso inKavalarov tutte le mie energie migliori, le energie della primaopera, quella in cui si narrano proprio le prime impressioni.A questo punto mi hanno detto che Kavalarov era banale einsignificante. Sapendo che in Kavalarov c’è molto di mio, hoconsiderato come rivolta a me stesso quest’accusa di bana-lità, di nullità, e me ne sono sentito offeso. Non ci ho credutoe mi sono chiuso in me stesso. Non ho creduto che un uomo
29- Jurij OlešaInvidia e I tre gras-
sonied. it. a cura di V.
StradaEinaudi
Torino 1969
37
LA TRAPPOLA E LA NUDITÀ - Intellettuale e Potere
giovane, attento, capace di vedere il mondo in maniera tuttasua, potesse essere banale e insignificante. Mi sono detto: al-lora, questa tua capacità, queste cose assolutamente tue,tutto ciò che tu stesso consideri come una forza, non sareb-bero altro che insignificante banalità? Com’è possibile?Eppure, volevo credere che i compagni che mi avevano ac-cusato (erano critici comunisti) avessero ragione, e ho cre-duto. Ho cominciato a pensare che ciò che a me sembravaricchezza, realmente è solo miseria. Cosí è nata in me l’ideadella miseria. Ho immaginato di essere io stesso un mendi-cante. La vita di un uomo al quale sia stato tolto tutto me lasono figurata come estremamente difficile, dolorosa. La fan-tasia creatrice mi è venuta in aiuto e sotto il suo soffio vitalela nuda idea dell’inutilità sociale ha comin ciato a trasformarsiin invenzione poetica, e ho deciso di scrivere la storia di unmendicante. Ecco, ero stato giovane, avevo avuto un’infanziae un’adolescenza. Adesso vivo, inutile a tutti, essere insignifi-cante, volgare. Che fare? Divento un mendicante, un auten-tico mendicante. Me ne sto sui gradini davanti alla farmacia,chiedo l’elemosina ed ho un nomignolo: scrittore. È una storiacommovente, per me; compatire se stessi dà un piacere stra-ordinario. Toccato il fondo dell’abiezione, scalzo, con un vec-chio giubbotto imbottito, me ne vado a zonzo per il paese ela notte passo accanto alle fabbriche. Le ciminiere, il fuoco, eio vado scalzo.Una volta, nella fresca purezza di un mattino, passo vicino ilun muro. Capita, ogni tanto, che fra i campi, non lontano da
38
Walter Mauro_Elena Clementelli
un centro abitato, si incontri un muro diroccato. Un prato,qualche albero, un cardo, un pezzo di muro, e l’ombra delmuro sul prato è ancora piú netta, piú geometrica del murostesso. Comincio a camminare partendo da uno degli angoli,e vedo che nel muro c’è un arco, una stretta apertura con laparte superiore arcuata, come se ne vedono nei quadri delRinascimento. Mi avvicino a quest’arco, vedo una soglia e da-vanti ad essa alcuni gradi ni. Do un’occhiata dentro, e vedoun verde straordinario... Forse ci pascolano le capre. Oltre-passo la soglia, entro, guardo me stesso e vedo la giovinezzache è tornata. Improvvisamente, chissà perché, mi è venutoincontro di nuovo la giovinezza. Vedo la pelle fresca dellemie mani, ho la maglietta, sono tornato giovane, ho sedicianni, ho tutta la vita davanti a me».30
Oleša voleva scrivere questa storia, ma dopo lunghe rifles-sioni ha capito che il sogno piú grande era quello di conser-vare il diritto ai colori della giovinezza; a questo puntosubentra il tragico complesso di inferiorità di fronte alla re-altà socialista, si fa strada in lui la spirale della rinuncia. Men-tre medita intorno alla storia del mendicante, mentre cercala giovinezza, il suo paese costruisce fabbriche, al tempo delpiano quinquennale per l’edificazione di un’industria socia-lista: «Non era un tema per me» confessa drammaticamentelo scrittore dinanzi all’assemblea degli scrittori sovietici. «Difronte a un tema del genere, non potevo essere un artistaautentico. Avrei mentito, avrei inventato; mi sarebbe man-cata quella che si suole chiamare ispirazione. Mi è difficile ca-
30- Jurij Olešain Rivoluzione
e letteraturaop. cit
39
LA TRAPPOLA E LA NUDITÀ - Intellettuale e Potere
pire il tipo dell’operaio, il tipo dell’eroe rivoluzionario. Io nonposso essere loro. Sarebbe superiore alle mie forze, supe-riore alIa mia comprensione. Per questo non tratto soggettidel genere. Ho avuto paura e ho cominciato a pensare chenon sono utile a nessuno, che le parti colari capacità artisticheche mi sono proprie non possono trovare sbocco, e per que-sto è nata in me l’immagine tremenda della miseria, un’imma-gine che lentamente mi uccideva». Ecco come il dramma diOleša finisce per localizzarsi al nodo del duro rapporto fral’arte e il potere in una società socialista, nello sforzo brutaledi una ricerca alternativa di identificazione dell’altro, mo-mento cruciale e irrinunciabile per uno scrittore: «La Rivolu-zione d’Ottobre - ricorderà altrettanto tragicamenteMandel’stam - non ha potuto non influire sul mio lavoro per-ché mi ha tolto la biografia, l’importanza personale».Era abbastanza naturale che la critica piú angosciosa a taletipo di rapporto, il piú tormentoso appello alla coerenza so-cialista nascesse e si sviluppasse all’interno del socia lismostesso, fatte le debite eccezioni. Ci soccorre a tal proposito ilpensiero di Gramsci, laddove egli getta il dubbio dell’etero-dossia affermando che «la letteratura non genera letteratura,cioè le ideologie non creano ideologie, le superstrutture nongenerano super-strutture altro che come eredità di inerzia epassività». Se è vero che, sostiene Gramsci, che l’attività rivo-luzionaria genera l’uomo nuovo, allora diventano prevalentie privilegiati il momento e il metodo dialettico come propul-sori e creatori di una piú concreta immagine della realtà e dei
40
Walter Mauro_Elena Clementelli
suoi problemi di fondo. Dialettica, quindi, come matrice dilibertà: di qui, oltre che da certe fruibili matrici crociane, sidipartono le strutture che spingono Gramsci fino al rifiuto difondo, estremamente attuale, dell’arte coatta, di una proget-tazione vale a dire, che nasca e si sviluppi come conseguenzae contraccolpo di una particolare condizione politica preva-ricatrice, e in quanto tale non piú in grado di governare gliintelletti e di stabilire quella novità dei rapporti da cui si ge-nera la nuova cultura. Gramsci aveva già premesso che «lot-tare per una nuova arte significherebbe lottare per crearenuovi artisti individuali», il che è assurdo, aveva aggiunto,«poiché non si possono creare artificiosamente gli artisti»:il rifiuto quindi di un’arte governata dall’alto e orientataverso ben definite ortodossie è condannabile da ogni puntodi vista: «Che l’uomo politico faccia una pressione perchél’arte del suo tempo esprima un determina to mondo cultu-rale è attività politica, non di critica artistica: se il mondo cul-turale per il quale si lotta è un fatto vivente e necessario, lasua espansività sarà irresistibile, esso troverà i suoi artisti. Mase nonostante la pressione, questa irresistibilità non si vedee non opera, significa che si trattava di un mondo fittizio eposticcio, elucubrazione cartacea di mediocri che si lamen-tano che gli uomini di maggior statura non siano d’accordocon loro».31 Di qui la netta e inequivocabile distinzione gram-sciana tra artista e uomo politico, donde nasce la difficile pro-blematica del rapporto fra intellettuale e vita pubblica, fraarte e potere. Nel dichiarare esplicitamente che la diver-
31- Antonio GramsciLetteratura e
vita nazionaleEinaudi
Torino 1950
41
LA TRAPPOLA E LA NUDITÀ - Intellettuale e Potere
genza piú sensibile fra i due poli consiste nell’interpretazionedell’immagine per l’artista e per l’uomo politico, nel sensoche per quest’ultimo «ogni immagine fissata a priori è rea-zionaria», poiché il politico considera tutto il movimento nelsuo divenire, mentre per l’artista la rappresentazione investerealisticamente «ciò che c’è», Gramsci perviene ad una con-clusione che, negli anni successivi, diventerà problema essen-ziale dell’intellettuale nei suoi duri rapporti con il potere,laddove afferma e sottolinea l’inconciliabilità dei due puntidi vista, dal momento che il politico troverà l’artista semprein arretrato con i tempi «sempre anacronistico, sempre su-perato dal movimento reale».Da tale affermazione alla deflagrazione violenta del problemadei rapporti fra intellettuale e potere individuabile nella re-altà politica del proprio tempo, il passo è tanto breve cheGramsci stesso ne avverte l’incalzare quando sottolinea conforza la propria convinzione che «il comunismo non oscureràla bellezza e la grazia», anticipando di parecchi anni, comefa giustamente notare Alberto Giordano,32 talune afferma-zioni venute alla luce durante il memorabile IV Congressodell’Unione Scrittori cecoslovacchi del 1967, soprattutto diMilan Jungmann che riferendo le parole del poeta comunistaNazim Hikmet, ne sottolineava il senso quando questi avevafermamente dichiarato che «lo scrittore può e deve dire alpolitico sul conto della vita qualcosa che ancora non è nata,qualcosa che egli è riuscito a intuire e a cogliere nello scorreredel tempo, e che pertanto il suo compito non deve limitarsi
32- AlbertoGiordanoGramsciAccademiaSansoni editoriMilano 1971
33- GianlorenzoPaciniLa svolta di PragaNuove EdizioniRoma 1968
42
Walter Mauro_Elena Clementelli
ad illustrare delle tesi già note».33
La definizione del concetto di cultura, lungo tali versanti dipensiero, risulta in Gramsci tipicamente leninista, e di conse-guenza si realizza in lui, nel momento stesso in cui si pone ilproblema del rapporto fra intellettuale e società, il rifiutonetto delI’intellettuale arcade e narcisista, tutto impregnatodi formalismi stilistici e di sovrastrutture astratte. Muoven-dosi da tale definizione, e nel solco della progettazione diun intellettuale nuovo e diverso, Gramsci finisce per pole-mizzare duramente contro la pretesa dell’intellettuale di pre-sentarsi come struttura portante di una ipotetica libertà dipensiero fondata sulle definizioni e sulle categorie della fi-losofia idealistica. Stabilito come dato illusorio l’autonomiadegli intellettuali, si pone per lui il problema indilazionabiledell’estensione del concetto di intellettuale, poiché la pole-mica risulta troppo facile nell’acquisizione di una continuitàdel concetto tradizionale: di qui l’esigenza prevalente di pre-venire ad una definizione funzionale degli intellettuali e dellaletteratura stessa, in una sorta di equazione categorica conle altre discipline, l’architettura ad esempio: «Cosa corri-sponde in letteratura al razionalismo architettonico?Certamente la letteratura secondo un piano, cioè la lettera-tura funzionale, secondo un indirizzo sociale prestabilito. Èstrano che in architettura il razionalismo sia acclamato e giu-stificato e non nelle altre arti. Ci deve essere un equivoco.Forse che l’architettura sola ha scopi pratici?Certo, apparentemente cosí pare, perché l’architettura co-
43
LA TRAPPOLA E LA NUDITÀ - Intellettuale e Potere
struisce le case d’abitazione; ma non si tratta di questo; sitratta di necessità. Si dirà che le case sono piú necessarie chenon le altre arti e si vuol dire solo che le case sono necessarieper tutti, mentre le altre arti sono necessarie solo per gli in-tellettuali, per gli uomini di cultura. Si dovrebbe concludereche proprio i pratici si propongono di rendere necessarietutte le arti per tutti gli uomini, di rendere tutti artisti».34
A questo punto Gramsci sta correndo sul filo teso dello zda-novismo, e quindi di un’idea dell’arte asservita alla propriafunzionalità razionale, con l’esclusione pericolosa dell’estro edi una libera incidenza dell’autonomia creativa. Nell’affer-mare che «quando l’arte, specialmente nelle sue forme col-lettive, è diretta a creare un gusto di massa, ad elevare questogusto, non è industriale, ma disinteressata, cioè arte», Gram-sci perviene al momento cruciale del suo esclusivismo, alnodo del problema della coercizione sociale sul quale il di-scorso si chiarifica e in parte si riscatta: «La coercizione, l’in-dirizzo, il piano sono semplicemente un terreno di selezionedegli artisti, nulla piú: e da scegliere per scopi pratici, cioè inun campo in cui la volontà e la coercizione sono perfetta-mente giustificate... La questione non verte quindi sulla co-ercizione ma sul fatto se si tratta di razionalismo autentico, direale funzionalità, o di atto d’arbitrio, ecco tutto». Il discorsoè capzioso, come si vede, e si presta ad una infinità di equi-voci che i tempi si occuperanno di chiarire lungo l’intero arcodel rapporto scrittore-potere: ma resta il fatto che tutte le di-vergenze, le dicotomie, i dibattiti, le ingenue difese e le al-
34- Antonio GramsciLetteratura evita nazionaleop. cit.
44
Walter Mauro_Elena Clementelli
trettanto ingenue accuse che tale rapporto ha provocatohanno avuto origine dalla difficoltà, da parte del marxismo,di giungere ad una identificazione precisa dei confini entroi quali l’arte può e deve muo versi, confini e limiti, d’altronde,che oggi risultano fortemente dilatati e ampliati, proprio sulfilo di una piú corretta lettura dei testi del paleomarxismo.Ci siamo piú a lungo soffermati sull’elaborazione gramsciana,perché sintomatica di un tormento intellettuale che si sforzadi reperire, all’interno del congegno, un’area di respiro au-tonomo per lo scrittore di fronte al potere. Il problema ètutto qui, tragico nella sua semplicità, poiché finisce per co-stringere ad uno scontro frontale la logica dell’arbitrio di cuiparla Solzenitsyn da una parte, e i perseguitati oggetto dellanarrazione letteraria dall’altra, in un impatto violento e an-goscioso fra significante e significato. Nel riferire, in tutte lesue opere, la crudeltà del processo degenerativo che si de-termina in tutti quelli che vanno a far parte degli apparati disicurezza dello Stato, Solzenitsyn pone un duplice problema,storico e assoluto: e se nel primo caso una parvenza di giu-stificazione può sussistere nel concetto di difesa di una so-cietà nuova, e quindi nella gelosa preservazione della legalitàsocialista contro i tentativi di slittamento ideologico (e lostesso scrittore si pone tale problema in termini realistici),nel secondo, il problema si pone da un punto di vista etico-religioso, come fa giustamente osservare Lombardo Radice,e allora il tema del perseguitato finisce per assumere con-torni e sembianze cristiane che spostano i termini del pro-
45
LA TRAPPOLA E LA NUDITÀ - Intellettuale e Potere
blema, e lo riportano alla sua matrice storica. Né meno insi-stente e drammatico risulta il problema del rapporto difronte al dilagante progresso scientifico che caratterizza inquesti anni la vita e la civiltà delle democrazie popolari. È sin-tomatico il fatto che i due poli del dissenso culturale sovieticosiano lo scienziato Sacharov e lo scrittore Solzenitsyn: ciò si-gnifica che la comune lotta per la libertà d’espressione sipone su due piani morali abbastanza diversi, e divergenti,laddove l’uno, lo scienziato combatte per una libertà dellosviluppo scientifico, l’altro, lo scrittore, pone il problema nellasua globale drammaticità, sul piano cioè di una pura libertàdi pensiero.Il motivo di fondo del pensiero gramsciano ancora una voltariemerge nella sua sostanziale struttura, e nella configurazionedi quell’intellettuale organico in rapporto al partito politicoche finisce per diventare una sorta di Capo delle Tempestedell’intero discorso: poiché mentre chiaro ed esplicito risultail discorso leninista intorno al salto quantitativo, lo stridoredella contraddizione risulta bene in evidenza quando si passaal salto qualitativo, fra spontaneità appunto, e coscienza diclasse, il cui momento di raccordo dovrebbe configurarsinella facoltà di persuasione insita nell’intellettuale organico.La primavera praghese aveva posto tali problemi in modoperentorio, risolvendoli, pur fra tante ingenuità e rischi, conla completa acquisizione del concetto di autonomia espres-siva, diritto inalienabile dell’artista: «Il nuovo corso cecoslo-vacco mi riempí di entusiasmo, - afferma Lucio Lombardo
46
Walter Mauro_Elena Clementelli
Radice - vidi, nel suo decorso e nel suo sviluppo, la prova delfatto che forze capaci di compiere il passaggio a una formadi democrazia socialista esistevano non solo nel paese, maanche in un partito comunista che pure era stato tra i piú la-cerati, straziati, deformati da arbìtri, persecuzioni, illegalità.Vidi che quel passaggio, quella trasformazione di fondo delsocialismo si poteva compiere senza tragedie, senza rotturetotali, anche se - certamente - non senza scosse, conflitti,squilibri».35
Le conclusioni del discorso di Lombardo Radice sono pessi-mistiche, anche se un filo di speranza pare sorreggerne l’an-sia: «ll tempo a disposizione per battere ancora la strada,relativamente pacifica e indolore, di un nuovo corso, è poco.È difficile che la storia si ripeta: è difficile perché una situa-zione storica non è mai statica. Si logorano rapidamente leistituzioni, i partiti, le coscienze degli uomini quando un cam-biamento dall’interno avvertito come indispensabile, e sto-ricamente necessario!, fallisce o viene fatto fallire, come èaccaduto nel 1968 in Cecoslovacchia. Poiché quella trasfor-mazione è inevitabile (nei limiti entro i quali tale aggettivoha senso fuori dal mondo naturale), avverrà, ma di anno inanno, di mese in mese, diventa sempre piú probabile che av-venga con una rottura, tanto piú radicale, dolorosa e costosa,quanto piú la situazione è stata prolun gata da una violenzaantistorica».36 La lunga trafila di scrittori che abbiamo incon-trato nei nostri viaggi, è un nugolo di vittime in lista d’attesaper il volo aperto, senza speranza, verso la storia: Carlo Levi
35- LucioLombardo
RadiceGli accusati
Editrice De DonatoBari 1972
36-ibidem
47
LA TRAPPOLA E LA NUDITÀ - Intellettuale e Potere
che chiede notizie di Pablo appena ci vede (e Neruda era giàmorente a Santiago, la sua casa già profanata e devastata daifascisti), e Rafael Alberti che diventa un bersaglio fisso perl’anonimo speaker della radio, inconsapevole nunzio di tra-gedie, e Ilija Ehrenburg che parla della propria vita, tutta vis-suta nell’incubo di sentir picchiare alla porta gli sbirri cheindagano spietatamente, senza sosta, e James Baldwin cheparla di una trappola entro cui sono tutti insieme, e si difen-dono tutti alla stessa maniera, contrapponendo al mostro lapropria nudità, una congenita sprovvedutezza, una amaraprecarietà d’astuzia, rappresentano solo alcuni casi, ai qualise ne potrebbero aggiungere degli altri, e poi altri ancora,per una verifica all’infinito.A seguirli nel racconto della propria vita, e soprattutto nelbrutale passaggio da un potere all’altro, nella maggior partedei casi in una lotta senza respiro, che non trova vuoti népause, ci si accorge come una battaglia secolare, combattutacerto fin dai tempi di Platone, ha subìto nel nostro secolo unadura accentuazione, forse come riflesso di una mutata con-dizione umana nel rapporto fra scrittore e società. C’è da ag-giungere che la dura notte vissuta dall’Europa durante ilnazismo, e l’ansia, la facoltà di abnegazione con cui lo scrittoreeuropeo ha cercato rifugio nell’universo liberatorio del mar-xismo, ottenendone in cambio il veleno dello stalinismo e lescudisciate del XX Congresso, hanno significato per lui la re-altà di ferite difficilmente rimarginabili, che restano a marcarela pelle per sempre, e che finiscono poi per consentire una
48
Walter Mauro_Elena Clementelli
percezione piú dura e impetuosa, piú lucida, nei confrontidella propria adolescenza. Ecco perché per molti di loro, so-prattutto per gli esuli (ma esuli lo sono un pó tutti: non è unesule in patria Baldwin, e non lo è Mary McCarthy, e ancoraLevi o Moravia, e perfino Montale ?), l’universo dell’infanziaassume contorni di assuefazione psicologica talvolta capacidi proiet tare il mondo futuro all’indietro, verso un passatosenza fine, lungo i crinali di una preistoria sulla quale agi-scono come fantasmi il padre o il sacerdote. Molti di loro neparlano con ironia e talvolta con divertimento, come di unincubo da cui ci si è liberati, ma basta che il passato si riversinel presente, perché il recupero della durezza, il rigurgitodel dolore raffiori netto e implacabile, come monito di unacondizione di fuga continua, in cui ogni area di parcheggioè un terreno minato, ogni incrocio apparentemente liberofinisce per tradursi in tranello, in inganno. Neanche tutti gliattentati alla propria dignità di uomini riescono a rendereadulti e guardinghi gli scrittori, i poeti soprattutto: c’è in lorouna condizione di virginale candore che li rende del tutto in-difesi di fronte al potenziale di prevaricazione del potere:per questa ragione l’indice di incredulità, di perplessità, distupore diremmo, finisce per mostrarsi identico di fronte aitre poteri, malgrado le debite differenze di peso specificocon cui si prospettano nella vita di un uomo.C’è un’arma di difesa che essi posseggono e alla quale nonintendono rinunciare a nessun costo; è qualcosa che li rendesorprendentemente duri e inflessibili, ed è la letteratura, la
49
LA TRAPPOLA E LA NUDITÀ - Intellettuale e Potere
fantasia poetica, in una parola il riscatto dell’immaginazione.Il prezzo della parola si erge a difesa della propria precarietàpolitica come alternativa dell’onestà all’inganno, come anti-doto del proprio recupero all’universo dissolto. Quando siparla dello scrittore come forza, capacità contestataria innatae congenitamente unita alla natura stessa dell’artista, si devestare attenti a liberare l’espressIone da quel senso di nietz-schiana superiorità dell’intellettuale creatore, e quindi deifi-cato, che tanti lutti e disgrazie ha recato agli uomini, ma alcontempo è doveroso restituire a colui che ha scelto l’arma,apparentemente innocua, della letteratura, la propria capa-cità di autonomia liberatoria, diremmo di anarchismo inter-pretativo delle strutture della realtà. Il sobbalzo di coscienza,il risveglio dal torpore ideologico che la marcatura fantasticapuò produrre nell’artista è inevitabile quando lo scrittore, ilpoeta si accorge che la propria area di libertà creativa risultaminacciata ed invasa (gli esempi di poeti come Eluard, Ara-gon, Alberti sono probanti al riguardo, insieme a quelli al-trettanto sintomatici e dolorosi di Neruda, di Quasimodo: «Ecome potevamo noi cantare con il piede straniero sopra ilcuore...») non solo, ma offeso violentemente risulta il propriosenso comunitario della vita, di fronte allo spettacolo del-l’universo di distruzione che il tiranno provoca fra gli agglo-merati umani già prima soggetti al gioco della fantasiapoetica. Sono momenti in cui scendere sulle piazze e per lestrade diventa problema di coscienza cui non è possibile ri-nunciare, e l’artista vi si sottopone in continuità, senza ope-
50
Walter Mauro_Elena Clementelli
rare fratture all’interno della propria creazione, in virtú diuna forza motrice che lo spinge automaticamente verso unalotta che diventa una forma di riscatto, e di riconquista delbene perduto, la libertà vale a dire di riprendere il propriodialogo fantastico con il mondo.La fantasia, l’immaginazione dello scrittore d’oggi tuttavia èsovversione, non assuefa zione: è un concetto che era statoaccennato poco fa, ed ora va ripreso alla luce delle tante te-stimonianze che il lettore incontrerà nel corso degli incontrie dei colloqui con gli scrittori del mondo. Il concetto di eva-sione, di disimpegno, e quindi di fuga dalla realtà ha accom-pagnato, diremmo perseguitato l’artista per secoli. Non solo:ma talune perversioni ideologiche, come lo stalinismo adesempio, hanno finito per accentuare il divario fra i due tipidi immaginazione, condannando alla crocifissione tutti coloroche osa vano distrarsi da un concetto inflessibilmente aristo-telico dell’attività creatrice dell’individuo.Una sorta di imposizione pareva aver sbalzato di nuovo l’ar-tista entro i gorghi della triplice unità aristotelica, restituen-dolo sbalordito alla preistoria inquisitoria del Santo Uffizio:ne abbiamo saputo qualcosa anche noi in tempi di neoreali-smo. Il moto liberatorio, il sobbalzo di coscienza dal qualel’immaginazione poetica ha riacquistato le proprie connota-zioni di libertà e di autonomia dell’ingegno, non ha avuto unamatrice letteraria, si deve riconoscere, bensí è stata la con-seguenza del forte movimento di ribellio ne giovanile che hapreso l’avvio dalla svolta del 1968. I ragazzi del Maggio Fran-
51
LA TRAPPOLA E LA NUDITÀ - Intellettuale e Potere
cese hanno contribuito a ridestare molta gente, compresi gliscrittori: il grido, uno fra i tanti, che ha accompagnato pergiorni e giorni la loro lotta nei meandri dei Metro o fra gli al-beri dei boulevards del Quartiere Latino, che oggi sembracosí lontano: «L’imagination au pouvoir» ha assunto un signi-ficato ben preciso, riducendo le distanze e ponendo l’interorapporto scrittore-realtà su basi nuove e diverse. È balzatofuori cioè qualcosa che pur dominava e forse vegetava nel-l’inconscio, e che aveva finalmente trovato una vera ragiond’essere, probabilmente sulla spinta di tutto quanto di esal-tante e di rigenerante possiede il grido giovanile, scagliatoda una generazione senza colpe. Repentinamente lo scrit-tore, il poeta ha reperito nuovamente la propria ragione disopravvivenza, ha compreso che la fantasia, lungi dall’esserevuoto narcisismo, rispecchiamento in se stesso del propriodissolto edonismo, finiva per configurarsi in lui come attivitàrigeneratrice di vita e di ispirazione, una matrice rivoluziona-ria insomma, sulla quale l’universo dei linguaggi avrebbe po-tuto operare piú liberamente.La facoltà di proiezione verso il clima primordiale dellegrandi avanguardie storiche, congenitamente rivoluzionarie,quali il surrealismo, il futurismo russo, la letteratura comegioco e spettacolo sotteso nella filigrana del dolore, dellapena di esistere, ha finito per prevalere come naturale alter-nativa ad ogni forma di tirannide, ad ogni categoria di pre-varicazione.Dal concitato raccontare di tanti scrittori, nelle pagine che se-
52
Walter Mauro_Elena Clementelli
guono, tale rigenerazione balza fuori con evidenza, anche seil salto generazionale, pure all’interno di quella singolare co-munità umana che sono gli artisti, balza fuori senza equivoci,al vivo dell’inevitabile divario tra vecchia concezione dellaletteratura e nuove frontiere della libera creazione artistica.Ma il salto generazionale significa anche dicotomia biogra-fica, momento storico diverso e divergente: ecco perché Ra-fael Alberti, Pablo Neruda, Ilija Ehrenburg, François Mauriac,Levi, preferiscono raccontare il proprio dramma umano diperseguitati, mentre i piú giovani marcano i toni di un di-scorso che finisce per essere piú teorico, in mancanza di unapiú diretta, drammatica esperienza.All’interno del grande oceano della letteratura, il lettore tro-verà un’isola di difficile approdo, ma che oggi ha assuntol’aspetto di una terra di conquista sulla quale i nuovi coloniz-zatori dell’industria editoriale sono sbarcati, saccheggian-done i tesori nascosti: il Sudamerica. Il loro contributo aquesto libro è massiccio, ma si giustifica, e non con ragioni dicomodo. È stato detto piú volte che la narrativa latino-ame-ricana rappresenta oggi il fenomeno piú interessante che lacultura contemporanea possa vantare. Ciò è vero, ma a con-dizione che se ne verifichino le ragioni di fondo, la maggiorparte delle quali tuttavia emergono dalle dirette testimo-nianze degli scrittori incontrati.Il ritardo secolare dovuto ad una colonizzazione che ha finitoper assumere la misura odiosa di un vero e proprio ricattoeconomico, matrice di infiniti lutti e rovine in Cile come in
53
LA TRAPPOLA E LA NUDITÀ - Intellettuale e Potere
Brasile, in Uruguay come in Guatemala, proliferando in talmodo la trista genia del militare-quisling-killer che non per-dona, ha localizzato questa letteratura, pur fra le evidenti di-versità, su posizioni di rivolta che si traducono nell’urgenzadella parola come forza rivelatrice e come potenziale rivolu-zionario: «Bisogna aver fretta - dirà fra poco il messicanoFuentes - perché domani può arrivare Pinochet e distruggerela casa di Neruda e mettere in carcere gli scrittori e uccideremezzo mondo...».Una realtà, quest’ultima, che anziché isolare questi scrittori,finisce per accomunarli a tutti quelli del resto del mondo,poiché tutti oggi, dovunque si trovino a vivere ed operare,anche in paesi apparentemente liberi, si trascinano nella fugasenza speranza, nell’insicurezza e nell’incubo che il passochiodato di un generale qualunque si riprenda con la vio-lenza un dono recupera to, l’immaginazione, la libera attivitàcreatrice dell’uomo.
POST SCRIPTUMNon si aspetti il lettore di trovare nelle pagine che seguono tutti gli scrittoridel mondo: il presente libro infatti è nato da occasioni di incontro e di amiciziache ragioni di lavoro giornalistico hanno provocato. Ci pare tuttavia di averfornito un panorama esauriente. Restava il problema della disposizione in se-quenza: obbedire al criterio alfabetico o a quello del peso specifico? Sarebbestato impossibile sia l’uno che l’altro. E allora, rifiutando sia la fortuna che lavirtú di machiavellica memoria, si è scelto il concetto di fraternità, di comunità,che rappresenta anche la tensione di fondo degli uomini del nostro tempo.
54
Walter Mauro_Elena Clementelli
Ringraziamenti
Un vivo ringraziamento è dovuto agli amici Italo AlighieroChiusano, Claude Couffon, Marco Forti, Giosi Lippolis, Ce-sare Milanese, Dario Puccini, Rolando Renzoni per avere, at-traverso i canali di specifica competenza, collaborato allarealizzazione di questo libro.
Edizione multimediale - Giugno 2011EQUIPèCO
Carmine Mario Muliere Editorewww.equipeco.it
55
LA TRAPPOLA E LA NUDITÀ - Intellettuale e Potere
ConQuesto libro gli autori focaliz-
zano il problema del rapporto fra l’intellet-tuale e il potere. Altresì, chiariscono il senso e
il significato che il termine potere ha assunto sotto variaspetti e soprattutto attraverso la triplice distinzione di Max
Weber tra potere razionale, tradizionale e carismatico. Perciò, puòrisultare importante il recupero del concetto di interconnessione del
sociale che ha improntato tutta l’opera weberiana, anche come sforzo diintendere il potere sia quale «rapporto interpersonale sia come attributodi una collocazione o posizione oggettiva giuridicamente o informal-mente codificata», (F. Ferrarotti, introduzione a La sociologia del potere,
.E tale puntualizzazione può riuscire ancora più utile se si rifletta intorno al-
l’incertezza terminologica che ha accompagnato il vocabolo potere fin daitempi più antichi, da Platone si potrebbe dire, al punto da giustificare la
definizione di Ferrarotti di concetto paravento come diretta conse-guenza di una tradizionale ambiguità concettuale e di una utilizza-
Da qui le domande poste ad alcuni fra i più grandi scrit-tori contemporanei che hanno risposto con te-
s t i m o n i a n z e , g i u d i z i e a z i o n i .(Nota dell’editore)
Laterza ed., Bari 1972).
zione pericolosamente acritica, […].
Walter Mauro nato a Roma nel 1925, è tra i più noti espo-nenti della critica militante ed è consigliere centrale della So-cietà Dante Alighieri. Ha pubblicato numerosi saggi sia dicarattere monografico (ricordiamo gli Inviti alla lettura diAlvaro, di Fenoglio, di Soldati, di Gramsci, di Sartre e diDante Alighieri, pubblicati da Mursia) che di sintesi storio-grafica (Cultura e società nella narrativa meridionale,Realtà mito e favola nella narrativa italiana del Nove-cento, La progettazione letteraria tra formalismo e rea-lismo). È inoltre critico musicale. Collabora ai programmi dimusica jazz della Rai. Ha pubblicato numerosi testi saggisticisul jazz fra i quali: Jazz e universo negro, Il blues e l’Ame-rica negra, una biografia, Louis Armstrong il re del jazz,e per la Newton Compton, Gershwin, la vita e l’opera, edue antologie, Il Blues e Gli Spirituals, in collaborazionecon Elena Clementelli. È inoltre autore della voce Jazz del-l’Enciclopedia Treccani e ospite fisso del programma RAIL’Appuntamento di Gigi Marzullo.
Nata a Roma, Elena Clementelli si laurea nel 1946 in LettereModerne. Poetessa, studiosa delle lingue e delle letteratureiberiche e anglosassoni, svolge al contempo un'intensa atti-vità poetica sfociata nella pubblicazione di vari volumi diversi: Il mare dentro, Le ore mute, Questa voce su noi,La breve luce. Ha vinto diversi premi di poesia tra i quali ilLerici-Pea, il Marina Velca, il Premio Scanno; nel 1987 ilPremio Teramo per un racconto inedito e nel 1993 il pre-mio Piombino Betocchi per la traduzione de Il Teatro diFederico Garcia Lorca. Oltre ad aver curato la traduzioneitaliana di opere fondamentali di Kenneth Allisop: Ribelli evagabondi nell’America dell’ultima frontiera, e di Ar-nold Toynbee: Le città aggressive, ha fatto conoscere inItalia il poeta basco Blas de Otero, il canto flamenco e itados. Ha collaborato e collabora alle pagine culturali di varigiornali e riviste e a programmi RAI. Sue poesie sono uscitesu molteplici riviste e figurano in diverse antologie italianee straniere.