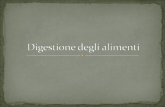Le culture del cibo: - Stefano Beccastrini | Il sito di … · Web viewQuale lezione possiamo...
Transcript of Le culture del cibo: - Stefano Beccastrini | Il sito di … · Web viewQuale lezione possiamo...

LE CULTURE DEL CIBO. UNO SPECCHIO DELL’UNITA’ E DELLA MOLTEPLICITA’ DEI POPOLI DEL PIANETA
“…la storia dell’alimentazione scorre in stretta sintoniacon le altre storie, le determina e ne è determinata…”Massimo Montanari
PREMESSA. IL CIBO COME LINGUAGGIO
Osserviamo l’immagine sovrastante. Raffigura un uomo che sta mangiando ossia un essere animale che sta rifornendo della sua necessaria energia, proveniente appunto dall’alimentazione, il proprio corpo, così garantendogli sopravvivenza e attività. Ci dice soltanto questo, tale quadro? No, ci dice molte altre cose e insegnare ad accorgersi che i quadri ci dicono più cose di quanto non sembri a prima vista, è uno dei compiti specifici dell’educazione scolastica (non soltanto di quella artistica bensì anche, interdisciplinarmente, di quella geografica, all’intermo di progetti che sappiano coinvolgere i colleghi di storia dell’arte). Osserviamo più attentamente… L’uomo è chiaramente di origini europee: ce lo dicono il colore della sua pelle, il suo vestiario, il tipo di ceramica della brocca posta sul tavolo. Non appartiene a un ceto sociale particolarmente elevato e, insomma, è un popolano: ce lo dicono ancora il suo vestiario, il fatto che mangia da solo e non a una tavolata sontuosa e socialmente significativa, la modestia delle stoviglie e delle posate che sono tipiche d’un’umile taverna, la scarsa ricchezza – diciamo pure la povertà – di ciò che mangia. Ma cosa mangia? Mangia una scodella di fagioli, seppure accompagnata da un po’ di pane e da qualche ortaggio: cipolle, parrebbe di riconoscere. Ciò conferma non soltanto la scarsa elevatezza del suo ceto sociale ma indica anche l’epoca a cui il quadro allude e nel quale è stato dipinto. Infatti, i fagioli giunsero in Europa dall’America dopo la scoperta colombiana e non subito si imposero e diffusero come cibo anche in Europa gradito. Tutto ciò, oltre allo stile pittorico, ci dice che esso è stato dipinto all’incirca un secolo dopo la scoperta colombiana (quando i fagioli erano ormai tanto
1

utilizzati da meritare un quadro di vita quotidiana ma ancora così recentemente e dunque innovativamente diffusi da meritare, comunque, un quadro). Infatti l’opera – nota come “Il mangiafagioli” e attualmente collocata presso la Galleria Colonna di Roma - è stata dipinta da Annibale Carracci, un grande pittore bolognese (il Centritalia seppe incorporare i fagioli nella propria cucina tradizionale prima e meglio di altri luoghi d’Europa) vissuto a cavallo tra il XVI e il XVII secolo. Quale lezione possiamo ricavare da tutto ciò? Intanto, una di tipo pedagogico/didattico: dalla pittura, se ben utilizzata educativamente, si possono trarre spunti d’insegnamento che vanno ben oltre quello strettamente connesso con la storia dell’arte. Poi, una relativo al fatto che, pittura a parte, è il cibo stesso a parlarci (insomma, nel quadro i fagioli parlano quanto il grande Carracci): di cultura, di storia, di geografia, di costumi, di tradizioni, di scambi tra i popoli del mondo, di collocazione sociale delle persone... Quindi, non soltanto la pittura (che in tal caso lo raffigura) ma il cibo in sé e per sé “parla” ossia comunica. Lo fa perché, oltre che una fonte alimentare di energia vitale (ma questa dimensione naturale non va mai dimenticata, perché migliaia e migliaia di persone muoiono ancora ogni anno, nel mondo, per carenza di tali apporti energetici), il cibo è un linguaggio. In quanto tale, come ha scritto il nostro maggior storico dell’alimentazione, Massimo Montanari, “…esattamente come il linguaggio, la cucina contiene ed esprime la cultura di chi la pratica… è depositaria delle tradizioni e dell’identità di gruppo. Costituisce pertanto uno straordinario veicolo di autorappresentazione e di comunicazione: non solo è strumento di identità culturale, ma il primo modo, forse, per entrare in contatto con culture diverse…” (Montanari, 2002). Ma la somiglianza tra cibo e linguaggio è ancora più marcata, secondo Montanari (e noi siamo d’accordo con lui), in quanto, come il linguaggio, “…essa possiede vocaboli (i prodotti, gli ingredienti) che si organizzano secondo regole di grammatica (le ricette, che danno senso agli ingredienti trasformandoli in vivande), di sintassi (i menu, ossia l’ordine delle vivande) e di retorica (i comportamenti conviviali)…” (Ibidem). Che si tratti di qualcosa di più profondo d’una pura e semplice, ancorché suggestiva, metafora lo dimostra, per esempio, il fatto che quando un ingrediente (un “vocabolo”) viene trasportato dal suo sistema alimentare (cioè linguistico) d’origine in un altro (cioè in un’altra lingua) esso resta incompreso e dunque inutilizzabile finchè non viene “tradotto”: quando, a seguito del cosiddetto “scambio colombiano” (di cui si tornerà più attentamente a parlare tra qualche pagina), furono portati in Europa alimenti (vocaboli) come il mais e il cacao (che nella nativa America Meridionale venivano consumati, cuocendone e mangiandone la pannocchia, l’uno, e mescolandolo e bevendolo, amaro com’è in natura, col peperoncino, l’altro) essi restarono incomprensibili per gli europei (che infatti non seppero per un po’ cosa farne) finchè non furono, appunto, “tradotti” in europeo: dall’uno ricavando farina gialla e facendoci la polenta, dall’altro (mescolato con latte e zucchero) ricavandone la cioccolata!
TRA NATURA E CULTURA
Ciò che fa dell’animale-uomo un essere completamente diverso da tutti gli altri animali viventi sul Pianeta è il fatto che egli, oltre a essere una creatura naturale, è un produttore di cultura. Ciò è vero anche per il cibo. Per gli altri animali, che sono pura natura, anche il cibo lo è (è vero che gran parte dei cosiddetti animali domestici attualmente mangiano cibo confezionato – e quindi tutt’altro che naturale - ma ciò dipende dal fatto che gli esseri umani hanno imposto loro questo “civilizzato” regime dietetico). L’animale, di per sé, è incapace di manipolare il cibo: manipolare il cibo, invece, è stato fin dai primordi evolutivi della specie Homo Sapiens Sapiens una delle sue caratteristiche peculiari di produttrice di cultura (un passaggio decisivo, in tal senso, è stata la transizione “dal crudo al cotto”, per usare il bel titolo di un classico dell’antropologia, Levi-Strauss, 1976). Cuocere il cibo ha significato dare avvio alla cultura perché ha significato non più soltanto consumare il mondo ma cominciare a cambiarlo. Tuttavia, sull’onda di un approccio ormai irrimediabilmente culturale alla propria alimentazione, gli esseri umani non hanno più neppure bisogno di cuocerlo, il cibo, per fare di esso un prodotto
2

culturale. Basta disporre in un certo modo su un piatto alcune foglie di lattuga o di rucola, accompagnarle con un rosso pomodoro tagliuzzato e un po’ di carote grattugiate, metterci sopra dell’olio e dell’aceto (o limone o yogurt) per costruire, a partire da alcune materie prime naturali, un complesso prodotto culturale denominato “insalata”. Un piatto d’insalata costituisce insomma, oltre che una congerie di elementi calorici e biochimici, un insieme di segni nel quale si intrecciano connotazioni semantiche di tipo storico, geografico, sociale, estetico, eccetera eccetera. Così come la bistecca al sangue con patate fritte che, secondo il Roland Barthes di ‘Miti d’oggi’, “…rappresenta il simbolo della cucina popolare francese (perciò la bistecca deve essere al sangue: non per un retaggio di animalità bensì perché il popolo, e- a detta dei francesi stessi - quello francese in modo particolare, è sanguigno, ricco di umori, colmo di linfa vitale…” (Barthes, 1984) e, secondo un manualetto di “nuova” educazione alimentare, “…così come la ribollita, simbolo di toscanità (ossia, dai tempi di Giotto a quelli di Michelucci, di razionalità, semplicità, universalità) pone al suo centro, in posizione assiale, il pane, elemento ricco di significati ancestrali, di rapporto lavorativo e amoroso con la terra, con le stagioni, con un cosmo gigantesco nel quale l’uomo pur tuttavia non si perde affatto, perché se lo immagina…certamente immenso ma misurato e misurabile (una specie di grande cupola brunelleschiana). Così come i tortellini, grassottelli, pienotti, rotondamente erotici nel loro somigliare al un ombelico, sono simbolo di terre umide e nebbiose, bisognose(e capaci) di calore e d’amore. E così via…” (Beccastrini, Beccastrini, Nannicini, 1995). Potremmo continuare a lungo a portare esempi consimili, dalla cassata siciliana (ov’è leggibile, scritta nel linguaggio della cucina, l’intera storia dell’isola e dei suoi molti invasori, dai normanni agli svevi, dagli arabi agli spagnoli, Scarpinato, 2004) al pesto alla genovese (che è proprio un piatto che soltanto un popolo affacciato sul Mediterraneo dell’olivo e delle piante aromatiche, alquanto economo, sufficientemente paziente da non considerare tempo perso lo stare a lungo a pestar nel mortaio gli ingredienti necessari, poteva inventare, Orengo, 2004), tanto per rimanere all’interno delle cucine regionali italiane e non andare a spasso, il che comporterebbe troppe pagine di scrittura, per le cucine del mondo. “Creare oggetti e raccontare storie – afferma giustamente Charles, il protagonista, con la sua amata Lula, di “I giovedì di Charles e Lula”, un bel romanzo di Marie Cardinal – è il privilegio di questa forma un po’ particolare di essere vivente che è la razza umana. Di generazione in generazione, gli uomini si trasmettono oggetti e storie, è la loro caratteristica peculiare…”(Cardinal, 1994). Di oggetti e di storie, cioè di cultura, è fatto anche il cibo, così com’è fatta la geografia, che col cibo ha molto a che vedere (e noi se n’è continuamente tenuto conto, nel predisporre “Geoviaggi”)..
TERRA MADRE: IL CIBO, LA GEOGRAFIA, L’EQUITA’, L’ECOLOGIA
“Studiare geografia significa sostanzialmente – si legge al capitolo su “Il cibo e il mondo” del manualetto di nuova educazione alimentare già poco sopra citato – studiare anche la storia e l’economia e la cultura ee la politica d’un popolo e di una civiltà…Questo manuale è scritto da due coniugi (e genitori) e dalla loro figlia: ebbene, la geografia che i due autori più anziani studiarono, quando andavano a scuola, era assai diversa (c’era ancora, tanto per dire, l’Algeria Francese e il Congo Belga) da quella che studiò, anni dopo, l’autrice più giovane, ma i suoi figli, quando andranno a scuola, studieranno una geografia ancora assai diversa: essi studieranno un’Europa ove non ci sarà più l’URSS, ad esempio, né la Cecoslovacchia né la Jugoslavia e dove esisterà di nuovo, come nella carta geografica dei loro bisnonni e differentemente da quella dei loro nonni e dei loro genitori, una sola Germania. Tutto cambia e far studiare geografia ai ragazzi senza far loro comprendere soprattutto questo, significa impedire loro di capire davvero come funziona il mondo, sia quello dei cambiamenti lenti che quello dei cambiamenti rapidi…(Beccastrini, Beccastrini, Nannicini, 1995). Il riferimento ai cambiamenti lenti e rapidi è giusto. C’è infatti un mondo dei lenti mutamenti ed è quello che studia la geografia fisica: cambiano le conformazioni territoriali, i profili idrogeografici, le configurazioni geologiche dei continenti. E
3

cambia anche il modo con cui gli esseri umani, facendo geografia, li vanno disegnando: sappiamo, ormai, per esempio, che il tradizionale disegno dei continenti che stava appeso alle pareti delle aule scolastiche fino a pochi anni fa era tutt’altro che preciso, nel suo eurocentrico enfatizzare l’estensione dell’Europa a scapito di quella dell’Africa e dell’Asia, ma c’è voluto qualche secolo perché il “disegno del mondo” cambiasse, alle pareti delle nostre scuole. C’è poi un mondo dai mutamenti più rapidi ed è quello studiato dalla geografia politica: in esso, nel giro di pochi anni, sparisce la Rhodesia e ricompare la Lituania, per esempio! In tutte le geografie (e nei loro rapporti con le altre discipline: la geografia, infatti, è, come sappiamo, una branca del sapere decisamente vocata alla multidisciplinarietà) trova posto, necessariamente, anche una geografia dell’alimentazione e, purtroppo, anche una geografia della carenza di alimentazione, una geografia della fame (la “…madre antica e feroce…” di cui parla il sommo poeta argentino Jorge Luis Borges, Borges, 1984). Ed anche questo tipo di geografia è bene che i nostri ragazzi, all’interno delle nostre scuole, studino, imparino a trattare, per comprendere i motivi delle permanenze e dei mutamenti, in un Pianeta che si va facendo globale (potremmo dire che il mondo sta mondializzandosi, portando a compimento un processo iniziato ai tempi delle gradi scoperte geografiche e delle gradi esplorazioni che stanno all’inizio della modernità) ma ancora, e anzi per certi aspetti sempre più, restando non equo, diviso tra ricchi e poveri, ormai addirittura tra chi mangia troppo e chi patisce la fame! L’alimentazione, e la geografia dell’alimentazione, rappresenta uno specchio fedele di questo contraddittorio farsi mondiale del mondo: si è avviata la nascita dell’uomo planetario (per usare la bella espressione che padre Ernesto Balducci pose come titolo di un suo bel libro, Balducci, 1990) ma resta un uomo frantumato, dal profilo tutt’altro che unitario, diverso persino nella quantità (oltre che nella qualità) di ciò che quotidianamente può mangiare. Il fatto che in larga parte del Pianeta le persone ancor oggi patiscano la fame non è affatto casuale né fatale. Quando gli spagnoli conquistarono il Messico, nel XVI secolo, la civiltà azteca non pativa la fame (seppure aveva anch’essa, al suo interno, divisioni sociali che portavano i funzionari di stato e i dirigenti a mangiare pesci e crostacei e carne di animali sia domestici che selvatici e la gente del popolo a mangiare soprattutto mais e fagioli conditi con pomodoro e peperoncino, Soustelle, 1994; la differenza di accesso al cibo ha a lungo diviso, infatti, non soltanto i diversi Paesi del mondo ma anche le diverse classi sociali di ciascun Paese: per l’Europa, il fenomeno è stato approfonditamente studiato, nel suo “La fame e l’abbondanza” da Massimo Montanari, Montanari, 1993). Il fatto che, nei secoli successivi, l’America Latina sia diventato un “continente affamato” è legato a un certo modello di sviluppo guidato, contro il Sud del mondo, dal Nord del mondo e legato all’ineguale distribuzione delle risorse, allo sfruttamento del lavoro, a scelte di politica agricola e commerciale miranti a soddisfare piuttosto i bisogni voluttuari dei popoli ricchi, importatori e consumatori (di caffè, per esempio) che quelli di alimentazione quotidiana dei popoli poveri, produttori, sfruttati. Ha scritto, in merito, Alexander Langer: “Il circolo vizioso, illustrato attraverso l’itinerario di numerosi prodotti da tanto o da poco tempo familiari alle nostre tavole e alle nostre abitudini quotidiane, genera miseria e dipendenza nel Terzo Mondo, rendendoci complici spensierati di una catena di sfruttamento e di distruzione delle persone e della natura. Il caffè che beviamo, i mobili di legname tropicale che danno lustro e prestigio alle nostre case, le gomme delle nostre automobili o delle nostre biciclette…(sono)…ingranaggi di una macchina complessa e precisa che determina il destino di milioni di persone, di interi paesi e continenti, di vasti ecosistemi…Supersfruttamento degli uomini e delle terre, deforestazione ambientale e sociale sono strettamente legate…” (Langer. 1990). Egli ha scritto tutto questo nella sua introduzione a un libro, ormai di qualche anno fa, che sarebbe stato opportuno avesse circolato più di quanto non sia avvenuto all’interno delle scuole d’Italia: “Lettera a un consumatore del Nord” (Centro Nuovo Modello di Sviluppo, 1990). Negli ultimi anni valenti pensatori (uno per tutti: Carlo Petrini, autore di “Buono, pulito e giusto. Principi di una nuova gastronomia”, Petrini, 2005) si sono occupati della questione – che è, assieme, geografica, storica, economica, sociale, politica, ecologica – e sulla loro scia sono sorti importanti movimenti, quali “Terra Madre”, dallo stesso Petrini fondato e oggi ormai capace di mobilitare agricoltori, produttori alimentari, cittadini di tutto il mondo. “Buono, pulito e giusto”
4

significa un cibo che sia genuino (buono, appunto, d’antichi e sempre nuovi sapori e non artificialmente e insipidamente prodotto in laboratorio), la cui produzione sia ambientalmente sostenibile (pulito, appunto, e non basato sulla distruzione, a fini commerciali, del territorio, dei biomi e della biodiversità), basato sulla valorizzazione e non sullo sfruttamento del lavoro umano (giusto, appunto, e non governato oppressivamente da poche multinazionali dell’industria agroalimentare). Da ciò il richiamo alla Terra Madre come base di una grande alleanza internazionale di produttori di cibo interessati appunto a produrlo “buono, giusto e pulito”: come ha affermato Carlo Petrini, è (anzi, occorre – anche educativamente - impegnarsi affinché diventi) la “…più grande multinazionale del cibo esistente…” (Petrini, 2004). Una multinazionale dell’equità sociale, del rispetto dell’ambiente e del lavoro, della valorizzazione della biodiversità.
LA CUCINA E’ UNA E MOLTEPLICE, COME LA SPECIE UMANA
Osserviamo l’immagine soprastante (come gli insegnanti che vanno leggendoci si saranno accorti, stiamo largamente usando, in questa Guida, il metodo di avviare certi ragionamenti attinenti alla didattica della geografia, e non soltanto della geografia, partendo da un’immagine e commentandola, cercando di leggerci dentro più di quanto non appaia a prima vista: lo facciamo perché ci sembra un modo proficuo e divertente di spiegazione dei problemi che ci pare assai utilizzabile anche a scuola). In tal caso, l’immagine rappresenta una festa paesana, sicuramente un pranzo di nozze, e mostra tanta gente seduta a una grande tavolata, per mangiare convivialmente tutti assieme, mentre alcuni compaesani portano i piatti in tavola e un bambinetto mangia solo solo, separato dal mondo degli adulti ma con esso a stretto contatto e alla festa anch’egli partecipando, in basso a sinistra nella scena, accanto a un uomo che versa del vino. Si tratta di un quadro, attualmente collocato presso il Kunsthistorische Museum di Vienna) del grande pittore fiammingo Pieter Brueghel, vissuto nel XVI secolo (fu un artista assai attento alla vita quotidiana e ai paesaggi della sua terra e, in tal senso, assai utilmente utilizzabile anche per insegnare geografia). Paesani pranzi di nozze si sono avuti e si hanno, nel corso dei secoli, ovunque nel mondo e ovunque sono caratterizzati dal radunarsi dei parenti e degli amici degli sposi in qualche grande sala, per mangiare tutti assieme (eppoi, magari, suonare e ballare e far giochi di vario tipo). Antropologicamente, ma anche geograficamente e culinariamente, parlando siamo quindi di fronte a un esempio di grande unitarietà dell’umana cultura, delle umane abitudini, delle umane tradizioni, a riprova del fatto che, ovunque sia nato e qualunque lingua parli e di qualunque colore sia la sua pelle, quella dell’Homo Sapiens Sapiens è una specie unica e segnata geneticamente e culturalmente da caratteri e nessi assolutamente e stupendamente unitari. E tuttavia… Potremmo credere, se non sapessimo che il
5

quadro è di Brueghel e che raffigura una festa paesana e un pranzo di nozze dei Paesi Bassi di quattro secoli fa, che quest’opera rappresenti una festa paesana e un pranzo di nozze d’una popolazione africana o cinese? Certamente no, e non soltanto perché i commensali raffigurati nel quadro sono chiaramente europei ma perché sono chiaramente europei gli alimenti loro serviti a tavola. Il cibo è così affascinante, come tema non soltanto di discorsi dedicati direttamente all’alimentazione ma anche di riflessione e discussione più complessiva (anche geografica, per esempio) in quanto quella dell’unità e della molteplicità alimentare è la migliore testimonianza (ma anche metafora esplicativa) delle caratteristiche generali dell’umanità stessa: nel mondo: il cibo è infatti uguale e diverso come sono uguali e diversi gli esseri umani. E’ uguale: tutti i popoli del mondo hanno un cereale di base, hanno zuppe di verdura e di pesce, arrostiscono o stufano la carne, dappertutto c’è una “cucina dei poveri” (che è soprattutto “cucina delle donne”) che si assomiglia molto, in Asia come in Europa, in Africa come in America Latina, nel suo essere fatta di ingredienti non costosi, assai nutrienti, poco raffinati. E’ diverso: quel cereale cambia (qui è il grano, là il mais, là il riso), quelle verdure e quei pesci cambiano (nel solo Mediterraneo, non c’è una zuppa di pesce fatta come quella della città costiera più vicina: nella bouilabaisse marsigliese c’è il finocchio, il cacciucco livornese è denso e assai pomodoroso, il brodetto di pesce dell’Adriatico a Termoli ha la cipolla mentre a San Benedetto del Tronto no, e così via), quelle carni vengono arrostite e stufate con legni e spezie differenti, la cucina dei poveri senegalese assomiglia ma è anche assai diversa da quella dei poveri messicana. Verrebbe da dire, alfine (ma è un argomento sul quale si tornerà a riflettere, nel corso di questo scritto), che c’è da augurarsi, e a tal fine lavorare anche educativamente, che il cibo, come l’umanità, resti diverso (affinchè non si finisca per mangiar tutti hamburger e patatine fritte) ma è bene che sappia anche comprendere la fondamentale unità che gli è, ovunque, sottesa: e ciò è vero per qualunque manifestazione della cultura umana, per le religioni (vi immaginate che noia e che impoverimento culturale ci sarebbe in un mondo ove tutti credessero nello stesso Dio), per le lingue (che noia e che impoverimento culturale ci sarebbe in un mondo ove tutti parlassero soltanto inglese o cinese), eccetera eccetera. Certamente l’effettiva mondializzazione del mondo, ciò che usiamo chiamare globalizzazione e che possiede aspetti positivi e negativi insomma largamente contraddittori, non potrà non mescolare le carte della cucina dei poli: quando i popoli si incontrano come mai era avvenuto nella storia dell’umanità sul Pianeta, anche i loro linguaggi, le loro credenze, le loro abitudini si incontrano, anche i linguaggi, le credenze, le abitudini culinarie. Si tratta di capire in che senso. Triste sarebbe se ciò avvenisse all’insegna dell’omologazione forzata, quella che man mano costringe tutti ad adeguarsi alla cultura più forte: economicamente e militarmente e dunque, poi, anche ideologicamente e quindi, poi, anche ecologicamente, linguisticamente, gastronomicamente e così via. Ciò porterebbe alla morte progressiva e inesorabile delle tante lingue, delle tante cucine, delle tante biodiversità, insomma delle tante meravigliose differenze e molteplicità del mondo. Ma non è detto: la globalizzazione, se sa essere – anche educativamente – moltiplicazione e non abolizione della comunicazione, della contaminazione, del meticciato può produrre ulteriore diversità, molteplicità, ricchezza. Massimo Montanari, nel suo “Il pentolino magico” (Montanari, 2002). Egli narra (a noi questa storia piace talmente che la raccontiamo tutte le volte che ci capita l’occasione) di una scuola bolognese ove aveva cominciato a frequentare un alunno nordafricano, figlio d’immigrati. La professoressa, per avviare un dialogo tra lui e i suoi compagni italiani, chiese che ciascuno parli in classe della cucina delle proprie madri. I ragazzi bolognesi narrano, allora, del modo con cui le loro mamme fanno i tortellini. Venuto il suo turno, il ragazzo immigrato parla di come sua madre fa il cous cous. Svolto diligentemente il suo compito, chiede però all’insegnante di aggiungere qualcosa: “In verità - aggiunge più o meno – il piatto più buono che la mia mamma sappia cucinare, ha cominciato a farlo proprio qui a Bologna: mette nel tegame uno strato di cous cous e uno di tortellini, uno di cous cous e uno di tortellini…”. Ecco, c’è da sperare che la cucina della globalizzazione sia fatta, creativamente, così e non soltanto di hamburger e patatine unte e maleodoranti.
6

Le cucine del mondo: identità e scambio
Un bel libro curato da Massimo Montanari, e intitolato “Il mondo in cucina” (Montanari, 2002), ha come sottotitolo: “Storia, identità, scambi” (manca la geografia ma è sottintesa). Parlando, e facendo parlare vari altri studiosi (italiani e non), di cucina mediterranea, ebraica, cinese, africana, americana e così via, egli tratta, appunto, del carattere storico-geografico delle culture culinarie, soprattutto in riferimento alla dialettica, in loro continuamente operante, tra identità e scambio, tra radicamento e comunicazione, tra chiusura in sè stesse e comunicazione. La cucina rappresenta infatti, per le comunità umane sparse sul Pianeta, un fortissimo fattore d’identità ossia di legame di gruppo, di riconoscimento d’una comune origine e di un comune sentire, di un radicamento in un luogo amato, in una regola sociale condivisa, in un essere con gli altri (ma gli altri più vicini e simili a noi) che ci aiuta ad affrontare, non in alienata e disarmante solitudine, la vita che ci sta di fronte con tutti i suoi problemi. Il senso d’identità offerto dal cibo è assai forte, come mostrano decine e decine di scene di film: ne citeremo, qui due sole, piuttosto significative: quella, tratta da “Un americano a Roma” di Steno, 1954, in cui Alberto Sordi, che impersona un bullo romano affascinato dal mito americano, si veste come uno yankee, parla come uno yankee, eccetera eccetera, però quando cerca di mangiare come uno yankee si schifa subito e torna agli amatissimi, italianissimi maccheroni; e quella, tratta da “Frenzy” di Alfred Hitchcock, 1972, nella quale un ispettore londinese di Scotland Yard, la cui moglie segue un corso di cucina francese e quindi gli cucina ogni sera “Soupe de poissons” e altre specialità parigine, finge di gustare il tutto ma invece lo getta via e corre in ufficio a godersi il suo bacon con uova fritte!
In tal senso, possedere (anzi costruirsi) un’identità culturale, anche grazie alla cucina, è certamente un fattore positivo, umanamente legante e coinvolgente, e in quanto tale stimolante all’amore invece che all’odio, all’unione invece che alla disgregazione, alla solidarietà invece che all’egoismo (tutti sentimenti che, senza retorica alcuna, sono materia prima irrinunciabile della sostenibilità della presenza umana nel mondo). Apriamo, per esempio, una pagina, bellissima, del romanzo “Conversazione in Sicilia” di Elio Vittorini (Vittorini, 1966), un grande intellettuale del Novecento italiano. Il romanzo narra di un uomo, un siciliano com’era Vittorini, che, da molti anni essendo emigrato nel nord d’Italia, torna per la prima volta nella propria isola, soprattutto, in un momento d’inquieta e tormentata incertezza per la sua vita personale e sociale, per reincontrare la propria madre. Dopo un lungo e faticosissimo viaggio (siamo nell’Italia degli anni Quaranta del XX secolo e viaggiare era assai più difficile di adesso), giunge al paesino etneo ove la madre vive ancora, vecchia e solitaria. Di cosa finiscono col parlare, per rammemorare il passato a entrambi caro, per riallacciare un rapporto, per testimoniare del fatto che non si sono vicendevolmente dimenticati? Di ciò che, in famiglia (quando ancora la famiglia era unita, il padre era vivo, il figlio non se n’era
7

andato a vivere sul continente), si mangiava: non era gran cosa (non c’era ricchezza, in famiglia: erano pomodori secchi, fave, aringa cotta sulla brace e condita con un filo d’olio, cipolle e cardi, lumache al sugo su cui s’intingeva molto pane, talora ma soltanto pochi giorni al mese salciccia di maiale) però quei sapori e quegli odori s’erano radicati nell’animo profondo sia della madre che del figlio. Costituivano un tuttora vibrante legame tra loro. Questo è l’aspetto positivo, da sostenere anche educativamente in un tempo qual è il nostro di oppressivo sradicamente e di triste omologazione culturale, anche in cucina. Però, la ricerca e il consolidamento dell’identità può diventare anche un fenomeno negativo, quando diventa chiusura verso tutto ciò che è diverso, rifiuto della (e spesso addirittura avversione aggressiva contro la) identità altrui, tendenza a trasformare il gruppo identitario in un branco crudele contro chi dal gruppo e dal branco stia fuori. Soltanto apparentemente il processo di globalizzazione (cioè di reciproca conoscenza tra identità restate spesso, nei secoli, reciprocamente ignote) e quello di chiusura nel branco sono fenomeni diversi e apparentemente opposti: in realtà, troppo spesso è proprio l’incontro - non vissuto con la maturazione e formazione necessarie – con l’altro a provocare la chiusura e il rigetto. Per questo è importante l’educazione, orientata a stimolare e produrre, prima di tutto, curiosità, attenzione, voglia di conoscenza degli altrui radicamenti, non per rinnegare – anzi, per amare e valorizzare ancor più, ma nel dialogo e nel confronto – i propri. Sono discorsi complessi e difficili, che forse vale la pena di sdrammatizzare tornando a parlare di cucina. L’identità diventa negativa, s’è detto, quando diventa chiusura, soppressione della curiosità e dell’attenzione verso tutto ciò a cui non siamo abituati. Due piccoli, apparentemente divertenti (sotto sotto, alquanto tristi) esempi. Quello relativo al fatto, narratoci da amici che si occupano di turismo, che una delle più impegnative preoccupazioni degli operatori turistici che organizzano i viaggi ai tropici degli italiani nel periodo natalizio è quello di far giungere, appunti ai tropici, enormi quantità di tortellini, zamponi, panettoni e cose del genere, che i turisti italiani vogliono tassativamente mangiare in quel periodo dell’anno! Ma vale la pena di andare ai tropici senza avere la minima curiosità verso ciò che la gente del posto mangia per Natale? Che futuri “cittadini planetari” si avviano a diventare coloro che vogliono mangiare come a casa di mamma loro, per Natale, anche ai Caraibi o alle Maldive? E che dire del tassista romano il quale di recente ci ha raccontato, accompagnandoci alla Stazione Termini, che, essendo stato costretto dalla moglie – dopo oltre un decennio di vacanze familiari a Fregene passate mangiando fettuccine – a fare una vacanza a Bali, l’ha trascorsa cercando disperatamente, ogni giorno, un ristorante che cucinasse fettuccine anche lì? In cucina, come in altre e spesso più importanti cose del mondo, l’ideale da perseguire, anche educativamente, è l’equilibrio, quello sostenibile, tra radici e identità da una parte (guai se scomparissero, distrutti dall’omologazione globale) e l’apertura e l’attenzione al nuovo e al diverso dall’altra (senza la quale le radici diventano catene, l’identità diventa una prigione). La cucina del mondo - ma più latamente le molte e molteplici culture, anche non culinarie, del mondo stesso - è produttiva quando, mantenendo orgogliosamente la proprie radici identitarie, sa aprirsi allo scambio, alla comunicazione, alla messa in comune di conoscenze ed esperienze. Facciamo un bell’esempio, ancora una volta tratto dalla cultura della cucina. A Livorno, città portuale toscana (da sempre cosmopolita, essendo nata come “città di frontiera” aperta a chiunque fuggisse dal proprio luogo natio per motivi economici, religiosi, razziali, politici e così via) il più tipico piatto cittadino, oltre al cacciucco, sono le triglie alla livornese. Ebbene, se apriamo un libro di cucina ebraica (per esempio, a pagina 171, quello di Aita, Aita, 2004), ne troveremo la ricetta sotto il nome di “triglie alla mosaica” (o “alla rabbinica”). Si tratta, infatti, di un piatto ebraico. Perché a Livorno sono diventate alla livornese? Perché Livorno è l’unica città al mondo ove, pur ospitando fin dal XVII secolo una folta comunità ebraica, non è mai esistito il ghetto. Per cui l’intera città ha fatto sue le triglie che aveva imparato, a cucinare e apprezzare, dai propri concittadini ebraici. A Roma, ove il ghetto esisteva eccome, i carciofi all’ebraica si mangiano diffusamente ma si chiamano, ancor oggi, “alla giudìa” cioè alla giudea, mica alla romana! Vedete
8

quante belle cose (anche storiche e geografiche) ci insegna, per poi reinsegnarle ai nostri figli e allievi, la cucina!LO “SCAMBIO COLOMBIANO”
Parlando di cucina, s’è parlato di scambi, oltre che di identità. La storia della cucina, ma più latamente quella del mondo stesso in tutti i suoi aspetti, è sempre andata avanti lungo una dialettica tra valorizzazione delle radici e apertura al diverso, tra identità e scambio appunto. Quindi, nei secoli, di scambi culturali (alimentari e non) tra o popoli della Terra ce ne sono stati moltissimi, proficui anche quando i loro protagonisti non ne erano consapevoli e anzi miravano ideologicamente a fini contrari allo scambio stesso cioè alla comunicazione e alla messa in comune di conoscenze e culture (persino le guerre tra i popoli sono state, alla fine e paradossalmente, anche occasioni di conoscenza e scambio tra di essi). Peraltro, il più grande scambio alimentare (ma, ancora una volta, non soltanto: quello alimentare è simbolo di altri, anche più profondi e drammatici, come per esempio quello sanitario, relativo alle malattie), che mai nella storia del mondo sia avvenuto è stato certamente lo scambio colombiano (per usare il titolo di un bel libro di Alfred W. Crosby a esso dedicato, Crosby, 1992). Il sottotitolo dell’edizione italiana del libro è “Conseguenze biologiche e culturali del 1492”: l’analisi di Crosby è infatti dedicata alle grandi conseguenze derivanti dallo scambio, appunto biologico e culturale a un tempo, che la scoperta (o meglio, come ormai si va anche in sede storiografica dicendo, la “conquista”) colombiana (ovvero europea) dell’America mise in moro tra le due diverse e fino allora separate sponde dell’Oceano Atlantico. Si tratta di un tema assolutamente decisivo, per le sorti future del mondo moderno, e sul quale forse non ci si intrattiene abbastanza, a scuola, facendo didattica non soltanto della storia ma anche della geografia. Il fatto è che per millenni e millenni - ossia da quando gruppi umani provenienti dall’Eurasia erano passati sul continente americano )approfittando della percorribilità, essendo il mare ghiacciato, di quello che poi sarebbe stato chiamato lo stretto di Bering ) e vi avevano poi creato le civiltà amerinde (sia quelle dell’America del Nord, i cosiddetti pellerossa, che quelle dell’America del Sud, i Maya, gli Aztechi, gli Incas e così via), i due sistemi di vita (i due macrobiomi continentali, verrebbe da dire) erano rimasti separati e ignari l’uno dell’altro. Il 12 ottobre del 1492 essi si incontrarono, con conseguenze immani e, almeno per il sistema di vita americano, catastrofiche: infatti gli europei erano portatori di germi (virus, microbi eccetera eccetera) che causavano malattie (il vaiolo, per esempio) dagli amerindi mai provate. I loro sistemi immunitari erano perciò del tutto indifesi di fronte a esse e ciò provocò epidemie che, in breve tempo, li decimarono. Si trattò di una vero e proprio “genocidio biologico” (il che spiega perché poche centinaia di spagnoli abbiamo potuto conquistare un impero, come per esempio quello azteco, fatto da milioni di persone: non perché gli spagnoli avessero cavalli e fucili – li avevano, e gli altri no, ma questo non sarebbe affatto bastato - ma perché portavano con sé, pur non sapendolo, lo sterminio per malattia dei loro avversari). Il viceversa non avvenne, seppure resti un problema storico se la sifilide sia stata portata in Europa da marinai colombiani che l’avevano presa in America, avendo rapporti sessuali con donne locali. Aldilà delle malattie, lo scambio colombiano modificò radicalmente i due sistemi biologici, alimentari ma non soltanto alimentari. Gli europei portarono in America il cavallo (che non vi era mai stato e vi era del tutto sconosciuto: poi i pellerossa impararono a usarlo, anche contro gli europei, con grande maestria, come si vede in tanti film western) e vi portarono anche colture come il caffè (che ben presto vi si diffuse, con immense piantagioni e a vantaggio degli europei stessi, che ne erano grandi consumatori). Vennero in Europa per la prima volta, essendo poi man mano incorporati nei sistemi alimentari degli europei, il tacchino, i fagioli, il mais, il peperoncino, il cacao, il pomodoro eccetera eccetera. Oggi, rispettivamente nelle cucine dell’Italia settentrionale, in quelle dell’Italia centrale e in quelle dell’Italia meridionale, immaginare l’assenza, rispettivamente, di polenta gialla, fagioli conditi, pizza coperta di salsa di pomodoro, sarebbe stupefacente, però fino allo “scambio colombiano” tali alimenti ci erano del tutto sconosciuti.
9

CUCINARE COME DIO COMANDA
Uno degli aspetti del rapporto identitario dei gruppi umani con i loro sistemi alimentari è dato dal rapporto tra il cibo e la religione. Infatti, per usare l’arguto titolo di un bel libro di recente pubblicazione, esiste anche “La cucina come Dio comanda” (Castellani, 2007). Il rapporto tra cibo e religione è millenario, ma si è andato imponendo alla nostra attenzione ancor più negli ultimi tempi, a causa del fenomeno migratorio che recentemente ha caratterizzato, in forme sconosciute in passato, il nostro Paese, ormai asilo di persone provenienti da terre e religioni e abitudini alimentari spesso con quelle religioni assai correlate in sé lontane ma diventate vicine per il fenomeno della globalizzazione e delle connesse grandi migrazioni.Illustrando il nesso tra cibo e religione, Castellani parte dal porsi, all’inizio del suo bel libro, una domanda: perché c’è uno stretto rapporto tra cibo e religione? Perché la religione si interessa del cibo, così legando certi costumi alimentari, presso questo o quel popolo, non soltanto ai ricettari di cucina, presso quel popolo usati, ma persino ai libri sacri presso quel popolo letti e ubbiditi? Sostanzialmente per tre motivi: a) il primo è legato all’igiene: nei precetti religiosi, essendo i grandi libri che delle grandi religioni sono ispirativi testi non soltanto devozionali ma di orientamento complessivo della vita d’ogni giorno dei fedeli, si riversano anche i precetti di buon vivre quotidiano. Se nel Corano si afferma che i fedeli debbono mangiare soltanto con la mano destra è perché la mano sinistra era quella adibita ad altre, più sporche, mansioni. C’è quindi, alla base, un principio igienico trasformato in gesto devozionale; b) il secondo è di natura socio-pedagogica: porre limiti e regole, riguardo al cibo (mangiar di magro in certi giorni, digiunare in altri, eccetera, eccetera) è un modo per vincolare la condotta delle persone a norme, privazioni, dettami di vita, che ammaestrano a vivere sobriamente, a saper fare rinunce, a non esagerare, a non cadere in eccessi. C’è persino un principio di richiamo all’eguaglianza sociale, almeno di fronte a Dio se non di fronte al potere terreno: nei gioirei comandati, deve digiunare il ricco come il povero, infatti;c) il terzo è di natura più propriamente religiosa: essendo il cibo non soltanto il mezzo di sostentamento primario degli esseri umani bensì anche un modo, per loro, di esprimere memorie, passioni, piaceri, simboli, il loro Dio – comunque si chiami – non può disinteressarsene. Il terreno del simbolico è suo proprio, in esso Egli principalmente si manifesta, e quindi egli parla ai suoi fedeli anche attraverso quel linguaggio simbolico per eccellenza che è, ben oltre la sua funzione biologica, il cibo. Verrebbe a questo punto da chiedersi quale sia l’atteggiamento prevalente, rispetto al cibo, nelle varie religioni: punitivo o gioioso? Rispondere a questa domanda, sulla quale pure sarebbe interessante far riflettere i nostri giovani allievi, non è facile, poiché un po’ in tutte le religioni l’atteggiamento è, in tal senso, ambivalente. E’ interessante, per esempio, il fatto che il Confucianesimo preveda l’esistenza di un Dio della cucina; che l’Induismo sostenga che gli Dei si cibano degli odori provenienti dalle cucine degli esseri umani (si tratta di un’idea molto bella e poetica: spinge a cucinar bene, altrimenti ammorberemo di sgradevoli puzze il cibo degli Dei); che la religione Zen invita i cuochi a “…maneggiare una singola foglia di verdura in modo tale che in essa si manifesti il corpo del Buddha…” (Roshi, 1986), così istruendo al rispetto anche delle piccole cose, quando prodotte dal lavoro umano e utili al suo sostentamento…ma in generale l’atteggiamento verso il cibo varia assai all’interno delle varie religioni, le quali hanno sempre, storicamente, profeti e maestri che ne danno una lettura più aperta e gioiosa della sua funzione personale e sociale e profeti e maestri che ne danno una lettura più restrittiva e punitiva: per esempio, sembrerebbe quasi che San Gerolamo, che indica nel ventre – il luogo della digestione – e nel sottoventre – il luogo del sesso – le due sedi della peccaminosa immondizia umana sia l’illustre dottore di un’altra religione rispetto a quella il cui fondatore ha fatto, come primo suo miracolo, la
10

trasformazione dell’acqua in vino eppoi ha proseguito moltiplicando pani e pesci, salutando prima d’andare a morire i suoi discepoli cenando con loro – come si vede nella bella tela sull’Ultima cena sotto riportata: è di Jacopo Bassano, pittore cinqucentesco - nonché, del resto, frequentando donne dalla chiacchierata reputazione e impedendo di lapidare le adultere…
Ci sarebbe anche da domandarsi, infine, se possa il cibo, la sua conoscenza per così dire trasversale, la sua fraternizzazion e il suo scambio aiutare il dialogo interculturale e interreligioso? Probabilmente sì, però non da solo, bensì soltanto in presenza di un atteggiamento di fondo ben disposto al dialogo. Insomma, laddove ci sia una almeno iniziale volontà di reciproca comprensione, il cibo affratella: lo dimostrano le tante iniziative che si vanno facendo, anche nel nostro Paese, per favorire il dialogo ebraico-arabo anche organizzando comuni occasioni di convivialità. Esse servono anche, tra l’altro, a far scoprire agli uni e agli altri quanto molti dei loro cibi si assomiglino (basta confrontare, per accorgersene, i ricettari riportarti in Aita, 2004 e Aita, 2005) e quindi, per il nesso cibo-religione fin qui illustrato, quanto probabilmente si assomiglino anche, a saper e voler leggere oltre certe rigidezze di dettato e di interpretazione, i loro basilari principi religiosi. Conclusioni. Insegnare la geografia con la cucina
11

Osserviamo l’immagine soprastante. Rappresenta una famiglia inglese che sta diventando una famiglia di emigranti (probabilmente verso l’America, ma il quadro non ce lo dice). Il padre e la madre sono tristi. in secondo piano i bambini giocano forse ignari del fatto che la loro vita sta per cambiare completamente (forse in meglio, almeno ciò sperano i genitori epperciò hanno deciso, pur con la morte nel cuore, di lasciare il paese natale e di andare a vivere e cercare lavoro e fortuna altrove). Il quadro è del 1852, opera del pittore inglese, preraffaellita, John Madox Ford e si trova attualmente collocato presso il Museum and Art Gallery di Birmingham. I personaggi raffigurati portano con sé, lasciando la terra dei loro padri (e delle loro madri) un po’ di bagaglio (necessariamente non molto: gli emigranti, solitamente, hanno molto da portare con sé nella mente e nel cuore, poco in saccoccia) ma è facilmente immaginabile che in quei pochi bagagli sia contenuto del cibo: il cibo di casa, uno dei simboli più forti dell’identità sociale e culturale di un popolo e del suo attaccamento al luogo d’origine. Una volta giunta nel luogo ove hanno deciso di emigrare e colà stabilitasi, questa famiglia certamente continuerà a mantenere vivo, finchè potrà, il ricordo del cibo natio ma altrettanto certamente finirà con l’adattarsi al cibo della propria nuova, più o meno ospitale, patria. Insomma, i processi che formano una cultura culinaria locale, radicandola nei costumi oltre che nella memoria e nell’affetto d’una popolazione, e quelli che tendono poi, se non a sradicarla, sicuramente a farla dialogare e scambiare con altre culture culinarie locali con essa entrate in contatto (in tal caso, per un fenomeno di emigrazione), non soltanto fanno parte della storia e della geografia dell’umanità nel suo girovagare nel mondo ma ne sono testimonianza, documento, espressione particolarmente fedele, toccante, stimolante la comprensione e la partecipazione cognitiva ed emotiva. Ciò dicendo, e avviandosi a concludere questo breve scritto su un tema vasto quanto il mondo stesso, speriamo di aver fatto comprendere ai colleghi che ci vanno leggendo quanto le culture del cibo siano uno specchio fedele e ricco della biodiversità naturale e culturale del Pianeta nonchè dell’unità e della molteplicità dell’abitare il mondo da parte della specie umana. In ciò consiste la loro interdisciplinare fertilità educativa a vantaggio di tutte quelle discipline che sul saper mostrare, documentare, spiegare, aiutare a comprendere l’unità e la molteplicità della presenza umana sul Pianeta abbiano il loro perno: la storia, per esempio, e la geografia, che qui più ci interessa. L’identità e la comunicazione, il radicamento nel luogo e lo sradicamento nel tempo, il dialogare e il contaminarsi, l’incontrarsi ma anche – purtroppo – lo scontrarsi, il localizzarsi e il rilocalizzarsi altrove (mantenendo elementi di identità ma anche mutandoli in rapporto al nuovo ambiente), della forme di vita culturale, istituzionale, sociale, demografica dell’umanità (tutte cose di cui la geografia, quella umana almeno ma sempre più non solamente, si va occupando da quando è sorta) trovano nella storia e nella geografia, tra di loro strettamente intrecciate, delle culture alimentari una ricca e probante testimonianza nonché, per quanto riguarda noi educatori, un proficuo strumento didattico.
NOTE
C.Aita, 2004: “Viaggio illustrato nella cucina ebraica”, Cardini, Firenze Idem, 2005: “Viaggio illustrato nella cucina islamica”, Cardini, Firenze E. Balducci. 1990: “L’uomo planetario”, Edizioni Cultura della pace, Firenze R. Barthes, 1984: “Miti d’oggi”, Einaudi, Torino S. Beccastrini, V. Beccastrini, M.P. Nannicini, 1995: “Un rapporto cordiale e consapevole. Idee per una buona
educazione alimentare”, Azienda USL Ravenna, Ravenna J.L. Borges, 1984: “Iore complete”, Mondatori, Milano M. Cardinal, 1994: “I martedì di Charles e Lula”, Mondatori, Milano V. Castellani (Chef Kumalè), 2007: “La cucina come Dio comanda”, Einaudi, Torino A. W. Crosbie, 1992: “LO scambio colombiano. Conseguenze biologiche e culturali del 1492”, Einaudi,
Torino A. Langer: “Introduzione” a Centro Nuovo Modello di Sviluppo (a cura di): “Lettera a un consumatoredel
Nord”, Editrice Missionaria italiana, Bologna C. Levi-Strauss, 1975: “Il crudo e il cotto”, Il Saggiatore, Milano
12

M. Montanari, 1993: “La fame e l’abbondanza. Stroia dell’alimentazione in Europa”, Laterza, Bari Idem, 1995: “Il pentolino magico”, laterza, bari Idem (a cura di), 2002: “Il mondo in cucina. Storia, identità, scambi”, Laterza, Bari N. Orengo, 2004: “Il pesto” in “Quaderni di Micromega. Il cibo e l’impegno 1”, Roma C. Petrini, 2004: “Un’emozione collettiva”, in “Quaderni di Micromega. Il cibo e l’impegno 2”, Roma Idem, 2005: “Buono, pulito e giusto. Principi di una nuova gastronomia”, Einaudi, Torino D. Roshi, 1986; “Istruzioni a un cuoco Zen”, Ubaldini, Roma R. Scarpinato, 2004: “Marilyn Monroe e la cassata siciliana”, in “Quaderni di Micromega. Il cibo e l’impegno
1”, Roma J. Soustelle, 1994: “La civiltà azteca”, Newton Compton, Roma E. Vittorini, 1966: “Conversazione in Sicilia”, Einaudi, Torino
13











![Elettrotecnica – esercizi svolti - Altervista · Elettrotecnica – esercizi svolti 26 [6.1] Ricavare gli equivalenti Thevenin e Norton del seguente componente: Equivalente Norton:](https://static.fdocumenti.com/doc/165x107/60a26995fc96395798230b46/elettrotecnica-a-esercizi-svolti-elettrotecnica-a-esercizi-svolti-26-61.jpg)