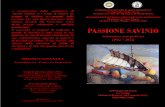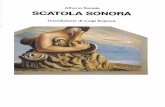Lanuzza savinio
description
Transcript of Lanuzza savinio
STEFANO LANUZZA.ALBERTO SAVINIO. Un terzo della nostra vita se ne va in sonno. Un altro terzo, forse pie per taluni quasi due terzi se ne vanno in cecit. Non gli occhi guardanoma quel terzo occhio che al dire degli Stoici portiamo al sommo del cervel-lo, e non si apre se non agli spettacoli dei sogni. Fuori della nostra cecitalcune forme acquistano un aspetto ridicolo e spaventoso.(Alberto Savinio, Drammaticit di Leopardi, Clio: chiudo. La storia raccoglie le nostre azioni e le deponevia via nel passato. La storia ci libera via via del passato. Una perfetta orga-nizzazione di vita farebbe s che tutte le nostre azioni, anche le minime e piinsignificanti, diventassero storia: per togliercele di dosso, per non sentirce-le pi sulle spalle. L'uso di consegnare a un diario le nostre azioni giornalie-re, una regola d'igiene; e l'uomo di mente operante implicitamente unmemorialista, che nei memoriali, ossia nelle opere, depone le azioni inter-ne. Ci si dovrebbe abituare da piccoli a tenere un diario, siccome ci si abi-tua a pulirci i denti. Quanto a lavarci la faccia la mattina, lo facciamo perpulircela dei sogni, queste azioni del sonno, questi peccati notturni.Quella sar civilt perfetta, che tutto tradurr in storia, e ci consentir di ri-trovarci ogni mattina in condizione di novit, liberi di passato. Ci che noiotteniamo con la storia, altri l'ottengono con la confessione, e chiamanopeccati ci che noi chiamiamo azioni. Per usare lo stesso linguaggio, dire-mo che qualunque azione peccato, e vivere, questo seguito ininterrotto diazioni, un continuo peccare. Certuni pongono anche la poesia tra le for-me di catarsi, dicono che la poesia ci libera dalla servit alla passione; masbagliano. La poesia--e le arti, strumenti della poesia--non ha rapportidiretti con la passione, ma si serve di elementi che stanno di l dalla passio-ne, incorruttibili. S'intende che qui si parla della poesia nella sua qualitmetafisica. I mali del mondo, i suoi ritardi, i suoi intoppi, la sua stupiditsono imputabili all'incompleto funzionamento della storia. Il passato mar-cisce su taluni uomini e si putref. Dentro un apposito buio, costoro s'illu-minerebbero della sozzura che li riveste come una crosta. Cumuli di mate-ria non storificata ingombrano le vie del mondo. Questo continuo but-tarsi il passato dietro le spalle, questo continuo purificarsi... Ha dunqueun fine la vita? Nell'ultimo sguardo che daranno i nostri occhi, nell'ultimaluce che dar la nostra intelligenza, quello sguardo, quella luce non al pas-sato saranno rivolti, posto definitivamente dietro la porta chiusa, maall'avvenire. E l'avvenire, come avrete capito, signori, la morte, inazioneper eccellenza e suprema purit.Al disservizio della storia supplisce in parte una storia non scritta, unastoria non orale, una storia non mnemonica, una storia non storica, mauna catarsi naturale e spontanea: un ..fantasma di storia. E stato smentitofinalmente l'assioma assurdo, l'assioma crudele, l'assioma coatto che nul-la si perde nella natura. Di l dalle pi tenebrose profondit, di l dai piinsondabili abissi, la nostra anima riconoscer la vera mta della vita: spa-rire. Accanto alla storia, che ferma via via le azioni degli uomini, le rinchiu-de, le rende inoperanti, c' il fantasma della storia: il grande buco, il vuotoche assorbe via via le azioni che sfuggono alla storia, e le annienta. La no-stra vista straordinaria, resa straordinariamente acuta in un momentostraordinario della nostra vita, ci ha consentito per un attimo di rivederedentro quel vuoto le azioni annientate, i fatti che non esistono pi, le vicen-de scomparse, ci che nessuno potr mai pi rivedere. Giardino leggerissi-mo, nel quale morivano i fantasmi dei fiori. E se i fatti annientati fossero isoli memorabili? Se il massimo destino delle vicende umane, se la sorte pinobile, pi alta, pi santa di noi e dei nostri pensieri fosse non la storia,ma il fantasma della storia?Arnoldo Boecklin preparava le sue tele in grigio; poi, con una spugnaintrisa d'acqua, campiva a grandi masse la composizione che aveva in men-te; infine si sedeva e contemplava a lungo quel pre-fantasma della sua nuo-va opera. Se l'umido abbozzo lo contentava, tornava su col colore e fissavala traccia; se no, lasciava che questa, a poco a poco, svanisse.Opere che entrano nella storia--opere che entrano nel fantasma dellastoria.Anche i ricordi, lentamente ma inesorabilmente, vaniscono.(Alberto Savinio, Dico a te, Clio, Roma, Edizioni della Cometa, 1940).Questa mia 'polypragmosyne', questa nonch felice ma necessaria ver-satilit che poi il sol mezzo di colorire la vita la quale altrimenti afasica egrigia, gli imbecilli me la rinfacciano sia come una colpa, sia come un'ambi-zione troppo vasta, sovrumana.(Alberto Savinio, Indelicatezza, in Torre di guardia, Palermo, Sellerio,1977).1.Fino a poco tempo fa avremmo potuto sottoscrivere, a proposito di Al-berto Savinio--I'intellettuale italiano che, fra gli anni Dieci e gli anniTrenta, pi di qualunque altro lega la propria formazione a quella culturafrancese ed europea riuscita, nel nostro secolo, determinante--, quantoegli, certo pensando a se stesso e alla sua condizione di abitante unico diun'obliata 'zona di frontiera', ha espresso nell'introduzione ai Dialoghi esaggi (voll. I, II) di Luciano di Samosata, pubblicati nel 1944 da Bompiani:Nel mondo letterario di oggi la congiura del silenzio si stringe con altret-tanto tenace proposito di soffocamento intorno ai pochi, ai pochissimi,all'unico scrittore di mente chiara che illumina di s la selva buia; perchcostui, sebbene animato verso il prossimo di sentimenti cristianissimi, in-congregabile per suo destino e le compagnie, le quali si formano per spiritodi complicit, non tollerano in mezzo a loro chi per suo natural talentoscioglie la complicit, chiarisce l'equivoco, sventa il trucco e per i complici un'accusa e un pericolo: non tollerano colui che disgrega le massonerie(cit., 1, pp. 9-10).Al pari di Luciano, e di Verga, Pirandello, Svevo, o dei pi prossimiGadda, Pizzuto, Landolfi, D'Arrigo, anche Savinio, relegato, col suo bascoda clochard e la sua aria mesta, in un polveroso museo delle cere, estraneoal mondo standardizzato dei suoi contemporanei, appartiene alla speciedei cosiddetti 'intelligenti', alla categoria dei 'disgregatori di massonerie' os-sia a una specie che per gli altri, e soprattutto per gli altri 'scrittori' non do-vrebbe esistere (cit., I, p. 10).Ma, a pi di un quarto di secolo dalla sua morte prematura, egli dive-nuto protagonista di un 'caso', revival o risarcimento che promette di avereprecedenti solo nel processo di rivalutazione postuma toccato a GiovanniVerga.Verrebbe allora confermato come fatto del tutto normale che un'operainnovativa debba essere compresa dal pubblico e dalla critica solo dopo la6 morte dell'autore? Pi verosimilmente, si potrebbe ipotizzare che l'arte diSavinio viene conosciuta in Italia solo adesso perch soltanto adesso si rie-sce ad accettare chi fu legato non tanto alla cultura italiana, spesso ristrettaai circoli o alle caste votate al particolarismo e al conseguente settarismo,ma piuttosto alla grande cultura europea d'avanguardia.Non mancano, adesso, coloro che--confermando un'osservazione diL. Baldacci, secondo il quale la storia del Novecento pu essere fatta solom prospettiva avanguardistica (cfr. Prefazione a M. Bontempelli, in La vi-ta intensa. La vita operosa, Milano, Mondadori, 1961, P. 9)--collocanoSavinio tra i vertici del nostro secolo letterario: Bisogner raccogliere tuttii saggi, tutti gli articoli, per avere veramente 'tutto Savinio' e rendersi contoche si tratta, dopo Pirandello, del pi grande scrittore italiano di questo se-colo (cfr. L. Sciascia, Testimonianza per Savinio, in Scena, n. 5,ottobre-novembre 1976, P. 37); Ci si trova davanti (...) a uno dei pochigeni sicuri (con Bruno Barilli e Carlo Emilio Gadda) della letteratura italia-na di questo secolo (cfr. O. Del Buono, Ha inventato la Nuova Enciclope-dia, in La Repubblica, 15-16 maggio 1977).Le sortite di Sciascia e Del Buono possono sembrare incaute se non si ri-conosce che le 'scuole' letterarie italiane degli anni Trenta e Quaranta--I'una basata sulla 'maniera' e sullo 'stile', I'altra sul cosiddetto 'impegno'--,eliminando Savinio dai propri parametri e, con Savinio, anche Bontempellie, in parte, Landolfi, hanno perso una grande occasione per uscire dal pro-vinciallsmo .Escluso, come hanno ricordato anche S. Battaglia (cfr. L'eterodossia diAlberto Savinio, in Filologia e Letteratura, fasc. 4, nota 5,1970, P. 350)e U. Piscopo (cfr. in Alberto Savinio, Milano, Mursia, 1973, nota 1, p.101), dalla fondamentale antologia di G. Contini, Letteratura dell'ltaliaunita. 1861-1968 (Firenze, Sansoni, 1968), proscritto, ancora--per faresolo qualche citazione--, dalla Storia letteraria d'ltalia. Il Novecento (Mi-lano, Vallardi, 1935,1939,1951) di A. Galletti e dalla pure accuratamen-te aggiornata Storia della letteratura italiana contemporanea. 1940-1975(Roma, Editori Riuniti, 1967,1977) di Giuliano Manacorda--il quale haignorato che gli anni Quaranta hanno visto la pi vasta e alta produzione diSavmlo--, questo autore atipico e ancora enigmatico malgrado il discio-gliersi, nel tempo trascorso dopo la sua morte, dei molti nodi storici, esteti-ci e soprattuto ideologici che hanno condizionato l'esame degli avvenimenticulturali in Italia dagli anni Venti agli anni Cinquanta, ritorna al centro delpanorama culturale italiano con un variegato seguito di numi dissacrati esfatti, di figure antropomorfe arcaiche e bizzarre, di mostri inquietanti, ri-levati come bassorilievi in un'aura di strana dolcezza e pervasi da una ma-linconia che cognizione dell'acuta intelligenza che li ha animati.Emarginato non per propria volont, astuta soluzione o 'spleenetico'bisogno di 'sfumarsi' (si pensi a T. Landolfi), secondo quanto si potrebbeanche supporre considerando la scarsa risonanza di un'pera che certamen-te non si scopre soltanto oggi copiosissima, possiamo vedere, senza sorpre-sa, convinti dello scrupolo e del puntiglio dell'autore sicuro del proprio va-lore, che alla sua morte, nel suo studio romano di viale B. Buozzi, i familia-ri hanno trovato una quantit considerevole di scritti che testimoniano lavolont dell'uomo di non farsi dimenticare; scritti perfettamente catalogatiper argomento e ordinati in una serie di cartelline che oggi costituisconoparte dell'archivio cui hanno attinto e continueranno ad attingere alcunecase editrici, da Adelphi a Sellerio a Einaudi a Rizzoli.Escluso, proscritto ed emarginato, dunque, dalla vita culturale italianain seguito a ben determinate scelte delle congreghe letterarie dominanti inun'ltalia prima liberale, poi fascista e quindi clerico-clientelare fino a tuttigli anni Cinquanta e oltre--anni culminanti nell'estetica dogmatica e nellapoetica assolutistica del neorealismo, del 'metellismo' e di un contenutismoa sua volta degno di essere tacciato di formalismo--, scelte che, nel secon-do dopoguerra, hanno condizionato e spesso terroristicamente impeditoogni nuova ricerca creativa, si pu gi adesso assegnare a Savinio, almenoper quanto riguarda la diffusione del suo nome e della sua opera o il suo ri-pescaggio da una condizione di 'minorit', la piena rivincita su chi troppopresto lo aveva stigmatizzato (cfr. E. Cecchi: Come scrittore, come pittoree musicista, Savinio mostr sempre di preferire strade un po' eccentriche, emagari talvolta ci avr messo anche una certa giovanile tracotanza, in AA.VV., Storia della Letteratura Italiana. Il Novecento, IX, Milano, Garzanti,8 1969, P. 648; E. Falqui, che pure si rammaric per l'esclusione del nome diSavinio dalle raccolte critiche e letterarie del Novecento: In Savinio, l'ordi-to della pagina ha un che di subitaneo, di strapazzato nella sua stessa ironi-ca foga. Accade che, per l'attrito delle idee con la realt circostante, la pen-na gli si riscalda e molti periodi mandano odore di bruciato, cfr. Dico a teClio, in Gazzetta del popolo, 17 ottobre 1940; ora in Novecento lettera-rio italiano. Narratori e prosatori: da D'Annunzio a C.E. Gadda, 111, Fi-renze, Vallecchi, 1970, P. 729). Come considerare certe pedanterie e intol-leranze nei confronti di Savinio in un momento in cui la storia della lettera-tura italiana veniva compiacentemente ingolfata da nomi di scrittori discarsissimo rilievo?La sostanza della diversit fra Savinio e gli autori italiani suoi contem-poranei, pi fortunati di lui, sta nel fatto che in loro vennero a mancare,peraltro con vantaggio, le condizioni per una convergenza interdisciplinarefra le varie arti che avrebbe potuto consentire quell'uscita dalla limitatezzadella norma e dall'ideologia esclusivista che in Italia sarebbe stata tentata,solo negli anni Sessanta, dalla neoavanguardia.Una diversit stante quindi nel fatto che, contrariamente ai suoi colle-ghi, compromessi col mito della 'coerenza', egli, ginnasta dello spirito,volle praticare la 'cattiva strada' della contraddizione, facendosi scettico edubbioso, sicuro soltanto della presenza dell'abisso e dell'l70rror vacui, alpari dei suoi modelli, Luciano, Montaigne, Stendhal, Nietzsche e Weinin-ger, nemlco di certo miope specialismo accademico, giudicato fonte prima-ria del fanatlsmo e del settarismo, esploratore di quel mondo di 'cose di-strutte', di quel corpo in disfacimento avente per ombelico la vecchia Euro-pa.Savinio, c' da credere, stato l'unico scrittore italiano che, in un'epocadi fideismo 'strapaesano' e di supponenti certezze ammantate con la retori-ca delle 'magnifiche sorti e progressive', abbia sentito il dovere e avuto il co-ragglo di andare controcorrente giungendo non soltanto a... 'parlar male diGaribaldi', cosa, all'epoca, impensabile, ma, quando stato necessario, e acosto di sconcertare i propri coevi o, peggio, di farsi compatire, anche adattaccare, e cercare di screditare e demolire, il potente Dio della Bibbia, co-me ogni altra deit e idolo (Se vuoi combattere i dittatori, comincia colprimo dittatore: Dio, cfr. Savinio, La nostra anima, Roma, Documento,1944, p. 26).Questo Dio intoccabile viene da Savinio dichiarato nemico dell'intelli-genza libera, chimera fallocratica e ctonia generata dal sonno della ragione,naturale antesignano dei nuovi Dei del mondo Mussolini e Hitler, i quali,guardati da vicino sono Dio, mentre lo stesso Dio, messo a fuoco da brevedistanza, non che Mussolini o Hitler.Testardo sostenitore della propria scepsi, l'autore, cos come ha semprerespinto il materialismo meccanicistico per aderire alla tesi schopenhaue-riana dell'essenza spirituale del mondo direttamente e indivisibilmente con-giunta alla materia, non ha mai creduto al Dio teologizzato, buono e mise-ricordioso, risplendente nell'infida notte del mondo. Il suo dio un'entitirragionevole, inintelligente, malvagia e infesta, paranoica e ambigua, furi-bonda e grottesca quanto Mussolini o Hitler, questi Dei fallici, monocoli eottusi: un avversario da combattere con le armi luccicanti della ragione eimprigionare nelle reti accortamente ammagliate dell'indifferenza, nonpensandolo per non essere da lui pensati e cos poterlo ricacciare fra gli ar-chetipi rozzi e bestiali dell'umanit primitiva, nell'orrido abisso di lemuriossessivi, imperiosi, autoritari e crudeli creati dalla fantasia infantile degliuomini.Critico agguerrito delle certezze del romanzo ottocentesco e del veri-smo, infaticabile e talvolta gigionesco dissacratore delle idee precostituite,dei miti e di tutti gli schemi dominanti, ha soprattutto la grande capacit,che fu di Schopenhauer e Nietzsche, di porre sempre il soggetto al centrodella storia, con la storia subalterna al soggetto.Smascherato il feticcio-Dio, Savinio passa a demistificare le deforma-zioni dell'altra deit, la Storia, o meglio quello stato patologico-provvidenzialistico della cultura e della coscienza umane che, verso la finedell'Ottocento, Nietzsche definiva malattia storica. Svincolando l'espres-sione dell'Essere dalla storia, destituisce questa di ogni fondamento signifi-cante e la registra fra i normali accadimenti della quotidianit, fra i moduliconformisti e i valori esterni dell'uomo recuperato dall'abbandono al pro-10 cesso storico e a coloro, gli storici, che tale processo pretenderebbero diclassificare o fissare in formule. S che, con J. Chesnaux, autore del volumeDu passfaisons table rase? A propos de l'histoire et des historiens (Paris,Maspero, 1976), Savinio avrebbe potuto sostenere che la storia una cosatroppo importante perch la si lasci agli storici. Ci che poi aveva fatto aproposito della politica: Il pericolo della politica sta soprattutto in questo,che la politica praticata dai politici (cfr. Savinio, Pompierismo, in Sor-te dell'Europa, Milano, Adelphi, 1977, p. 32).In cosiffatta visione della storia, Savinio precorre la crisi di rifiuto delleideologie, dei modelli e dei falsi significati imposti dalle ideologie. Tale ri-fiuto egli certamente non convalida con la patetica e petulante pantomimanihilista molte volte accompagnata alla sottocultura, ma, al contrario, loassocia a una carica di esacerbata, per lucida e tollerante, passione intel-lettuale e d'instancabile esercizio critico, volti ad affermare quell'intelligen-za ottimista di ricerca della verit che promozione del particolare nonparticolaristico e proposta dialettica d'ipseit creativa; cio di un'individua-lit come sorta di grimaldello per aprire il reale.Metaforologo e metafisico laico, teorico raffinato di una metafisica tra-dotta in presenza ed esperienza sensibile, in quintessenza materialista, filo-ellemco presocratico a imitazione di Nietzsche e Bergson, filosofi da luimolto letti e approfonditi anche se poco citati, Savinio oppositore ironi-co, umoristico, satirico, sarcastico e irridente della confessionalit, del vilemisoneismo, dell'estremismo frivolo, dei misticismi apocalittici, della reto-rica di consumo. Artista negato al riposo e alle rilassatezze della volgaritintellettuale, senza aspirazioni velleitarie o miti assolutistici promossi dalviscerale spirito del Tutto, contrario per volont di equilibrio e di armoniaal monocentrismo dei suoi contemporanei, maniaci nell'accumulare conti-nuamente al centro di un angusto cosmo congerie di valori fallaci, il Gran-de Dilettante ed Emarginato o Rimosso delle nostre lettere, poco propenso--perfino oggi che il suo momento--a trasformarsi in prodotto com-merciale o di successo, inventa la pi squisita, solitaria e autolesionista del-le ginnastiche per guadagnarsi la surreale 'morte squisita': la ginnasticadell'intelligenza.I materiali artistici che va producendo, ora di conio illuminista ora ales-Libreria della Voce, s.d.), con dedica al fratello Giorgio De Chirico, rap-presenta la sintesi dell'universo letterario, e non solo letterario, di Savinio.Nel 1947, l'editore Garzanti, nella collana Opera prima diretta da E.Falqui, stampa, emendati dall'autore, i capitoli gi editi dalla Voce".Ristampato integralmente da Einaudi, con allegati, in apertura, LesChants de la Mi-Mort, apparsi per la prima volta nel 1914 sulla rivista diApollinaire Les Soires de Paris, questo vero e proprio incunabolo savi-niano, iniziazione alla lettura in chiave metafisica dei quadri di De Chirico,raccoglie una serie di materiali su cui campeggia, malinconico e ironico,appassionato e metafisico, uno e ancipite, materialisticamente--schopen-hauerianamente--metafisico, l'inquietante araldo ellenistico di Ermafro-dito, creatura divina del pantheon classico, portatrice di ambiguo fascinointriso di apollineo e dionisiaco, di profondo silenzio e di multilingue, am-plificato, anfibologico clamore narcisistico.Pi che nella doppiezza ermafroditica o nell'eraclitea armonia dei con-trari, nel narcisismo che, in quanto figlio europeo delle metamorfosi ovi-diane e dell'Hermaphroditus di A. Beccadelli detto il Panormita (1394-1471), di A. Jarry (1873-1907) e G. Apollinaire (1880-1918), I'H. di Savi-nio rivela il proprio precipuo carattere. Infatti, fin dall'inizio della narra-zione, aperta con un radicale ribaltamento dei modelli letterari dominanti,l'autore impone al lettore il proprio ego giovanile, impetuoso ma anche cal-colatore, 'doppio' e 'ipocrita', invitandolo a trattare il libro come luogoastorico della contraddizione, del 'diverso', dell"altro'.In Narciso, la cui avventura fu ispiratrice dei poeti posteriori a Ovidio,Savinio riflette la sete di conoscenza e di bellezza di un allucinato ermafro-dito, che va svolgendo, in condizione di mezza-morte~, fra il sonno e l'as-senza, fra onirismo e saturnino esistenzialismo, il proprio gioco di mimesi efinzione, di amore e abbandono, di fervide trovate, sacrileghe falsificazio-ni, insanabili angosce, proterve iterazioni descrittive.Assetato di se stesso e afflitto dal desiderio di congiungersi all'immaginedi s che tanto pi gli sfugge o si rivela illusoria quanto pi egli evita di defi-nirsi, il testo-hermaphrodito, ghiribizzoso 'diario di bordo' o aristocratico'arnese' conoscitivo, innesta, nel puro silenzio del proprio inafferrabile sen-so e nello stupore irredimibile che circonda l'universo intorno ad esso, uneloqulo venuto dalla surrealt a testimoniare della solitudine di Narciso-Savinio, nietzscheana e pur miseramente solitaria figura dell'artista comegenio illummato' dissolta nella sostanza corposa di una scrittura 'disgrega-ta' nello specchlo leso del reale. Specchio davanti al quale l'autore mimaun'inappagata sensualit e progetta la propria educazione sentimentale:educazione protesa verso la conoscenza della donna, che egli non si accon-tenta dl accettare cos com', perch anche la donna rientra nel suo disegnodi revlsione metafisica. Ecco quindi che, per conoscere la donna, vuole ri-chiamare dalla notte del mito l'essere che riunisce in s mascolinit e fem-minilit e, rivelando tale differenza come abominevole, suggerisce una cri-tica e un superamento di entrambi, quindi un'alterit che soprattutto pre-rogativa della creativit dell'artista.Cos, poniamo, nel discorso saviniano.Pi esattamente, poi, lo specchio restituisce, gi riflettendo il preludiodei Chants de la Mi-Mort, l'immagine stravolta, simile a certe figurazionidl De Chinco, Dal o Bacon, dell'homme sans voix, sans yeux et sans visa-ge~--Hermaphrodito?--, che fait de doleur, fait de passion e fait deloie. Uomo senza voce, senza occhi e senza volto, fatto di dolore, di pas-sione e dl gioia, provato a tutto, egli parla tutti i linguaggi e aspetta. Aspet-ta chlss cosa, e mtanto ripensa alla sua vita di pretredicenne ricco di ricor-di e libero da deslderi sessuali, dato che sui tredici anni che si determinail sesso: prima, l'incertezza del sesso forma un carattere ambiguo, una vitabianca, un felice ermafroditismo (cfr. Savinio, Scatola sonora, Torino, Ei-naudi, 1977, P. 42).Per seguire questo suo regressus ad inhnitum, l'homme sans voix, sansyeux et sans visage si pone in uno stato di mezza-morte, fra sogno e alluci-nazione. Le sue facolt psichiche si espandono e le percezioni del suo Io siaculscono dolorosamente. Ne consegue la presa di coscienza straziante deiproprl dolori, scacchi, fallimenti, rinunce, repressioni, che ritornano fru-sclando e appoggiandosi con tutto il loro peso traumatico sul protagonistastaghato davantl a una finestra aperta incontro alla notte, tormentato daldesiderio sessuale, grottesco ed erratico personaggio derivato da certe solu-zioni espressive del Mal-Aim Apollinaire.I protagonisti aggirantisi sull'immaginario palcoscenico non hanno ca-lore umano ma, simboli dai vaghi contorni, aleggiano nel vuoto. Si manife-sta l'uomo calvo, forse un'immagine del padre (...); l"uomo giallo' mos-so da un dio-amore invisibile (molto probabilmente l'io, anch'esso sotto ilfuoco incrociato dei suoi lumi), e 'Daisyssina' l'Eterno femminino, la 'ma-dre di pietra' sotto la cui maschera impossibile non riconoscere l'altera edura baronessa De Chirico, nella cui ombra il figlio Giorgio si tante voltedipinto e inabissato (l'uomo giallo 'uccide la madre, poi la bacia; la lanciain alto e la riprende al volo; la getta per terra e la calpesta. Grandi scoppi dirisa'); poi vediamo passare gli 'uomini di ferro battuto' che formano la can-cellata tutta ornamentale della societ, 'due angeli, un re pazzo, gli uomini-bersaglio'; e non dimentichiamo il ragazzetto il cui ingresso sintomatico 'incamicia da notte, con una candela in mano. Con la suola della pantofolaschiaccia un ragno che si arrampica sul muro; poi tremante osserva la be-stia schiacciata che agita un'antenna', basta a situare tutta l'azione ai confi-ni misteriosi dell'io e del super-io (cfr. A. Breton, Alberto Savinio, in An-tologia dell'humour nero, Torino, Einaudi, 1970, pp. 303-304).Raggiungendo, dalla bocca multilingue del sogno, l'Io ricettivo dell'au-tore, la voix de la mi-mort est douce e, suscitando il voluto esito melo-drammatico, chiede di essere rispettata perch degna di rispetto, commeun pape sur son lit de mort.Sfilano, nel frattempo, fra silenziosi giochi d'acqua e di luce, i quadridella scena. In uno c' l'uomo en redingote de ministre, con, al posto del-la testa, una bandierina piantata sopra un'antenna d'acciaio. Si muove sulletre gambe rigide, prive di articolazioni, evocanti un treppiedi per macchinafotografica. Le rotelle metalliche sotto le sue tre gambe scricchiolano orri-bilmente. Giunto in mezzo a una lastra marmorea, si sbottona esibendodue ali di carne viva e, fra queste, gli organi interni. Scava fra i polmoni edestrae il proprio cuore, enorme, rouge comme un boudin gonfl de sang.Comincia a cantare un motivetto che lo stesso autore amer rinnovare so-vente, riconoscendovisi: Ho cuore chiarissimo, amici, / mente come cri-16 sopazio / strani meati d'onde / so cantar i canti di citt / il terribile sogno /vigilato dal semaforo / e l'asinesca guardia. / Vidi morir le statue dei poli-tla: / curvarono le teste e dissero / l'ultimo canto, poi, / rotte su' fianchi,caddero / come Arianne abbandonate... (H., p. 32). Dopo, con un mar-tello inchioda il cuore al centro della lastra. Fatto ci, esce, rigido, patti-nando sulle rotelle delle gambe che stridono atrocemente.Il secondo quadro ha la durata di un lampo e racchiude un'intera vita;quella di una donna che, dopo essersi precipitata sulla scena gridando diavere visto un poisson norme de zinc fuggito da un ghiacciaio, che cor-reva a quattro zampe, rimane immobile, impietrita in una fissit definitiva.Se il primo quadro potrebbe collegarsi al secondo in base a un'interpre-tazione che spiegherebbe come il cuore dell'uomo a tre gambe--che, a far-ne una spiegazione in chiave sessuale, si potrebbe associare a l'Homme diIpousteguy, l'uomo trigambe--, inchiodato sul marmo, simboleggi l'offer-ta d'amore dell'uomo alla donna, la quale, desiderosa di gridare il propriobisogno di un rapporto umano, irrompe sulla scena annunciando stupita diavere visto il pesce di zinco--sorta di simbolo fallico mostruosamentestravolto--, il terzo quadro, completante la sezione del Drame de la villemridiane, apre altri spazi interpretativi. Esso figura, con la metafora delvuoto della vita borghese, una casa con tre finestre illuminate al terzo pianoe con dentro, da un lato, un macellaio, la sua donna, l'amante della donnae un vecchio qui dansaient comme des morts~ e, da un altro lato, lesAmricaines (...). Pendant trois longues minutes on entendit le bruit ryth-m de plusieurs gens qui dansaient sans musique (H., p. 33).Chiude la scena il quadro dove viene proposto, pirandellianamente--prima, la situazione era, si potrebbe pensare, beckettiana--, lo stesso au-tore che se coule sournoisement derrire une porte basse per andare adigrer son clystre, mentre soldati fatti di ferro bianco presentano le ar-mi col sangue che scorre sullo splendore delle baionette. Volano le cicognespiralando nel cielo couleur de sinople e un canto--sardonico, disperato--di viole d'amore passa improvviso, come una folata d'aria.Nella sezione Epoca Risorgimento, che segue Les Chants e le primedue sezioni di H. Prelude. Tete-antichambre de ministre e Drame de laville mridiane, il giovane Savinio, rifacendosi al Risorgimento, e, segna-tamente, al 48--cifra coincidente, nell'interpretazione onirica, con: so-perchiare il nemico in guerra, schiacciare una serpe, balzare di trincea, in-contrare il ladri, le belve, i poliziotti, i carabinieri (H., p. 36)--, scopreuna vena irredentista, interventista e prefascista che lo avviciner, anche inaltre pagine del libro, a certo bellicismo parafuturista: Un cannone belloplasticamente; ma pi bello quando spara; La guerra moderna un fe-nomeno moralizzato (...). Mutarla?... -- tutto non dunque fatalit,null'altro che santa e tremenda fatalit?... (H., p. 58).Rievocando poi Mazzini, che chiama uomo-epoca e consolato-re, Savinio esprime il proprio disprezzo per le teorie socialo-inter-nazionaliste e per Podrecca, Turati, Ferri; proclama il popolo italia-no l'unico che, insieme a quello russo, detenga in privilegio di guardare 11mondo cogli occhi dell'en~ant qui vient de naitre (H., p. 41 ) e invita gli ita-liani a stare all'erta, ammonendoli, con piglio dannunziano, che mentre lo-ro dormono, gli avversari politici, i sovversivi, i consanguinei maleficipassano rampanti e li contaminano, come delle testuggini dall'orina ve-lenosa.11 papa in guerra una reprimenda contro un intervento di Papini,pubblicato dal Resto del Carlino, sul libro di Missiroli ll Papa in guerrae, allo stesso tempo, un'espressione civilissima del credo ateo dell'autore.Savinio esordisce rimproverando a Missiroli e a Papini che ci si possa anco-ra occupare di pontefici e di religione. La religione--spiega-- monetafuori corso, carcame, cadavere gi freddo. Rivolto a Papini, lo esorta acercarsi ben altri gatti da frustare e si prende gioco, peraltro con garbo esuprema eleganza, di Missiroli attardato in problemi ormai triti: Ho unagabbia piena di bei canarini garruli, che ogni mattina appendo fuor della fi-nestra. Signor Missiroli, per carit! ... Il puzzo di rifritto molesta quelle ca-re bestiole (H., p. 47).Pare che le succitate osservazioni non siano rimaste gradite all'irascibilePapini, che pure, nel 1919, aveva recensito H. con molto favore, e sianovalse a Savinio l'esclusione dalle due edizioni (1920 e 1925) dell'antologiadei Poeti d'oggi. Papini, uomo rancoroso e tormentato dalla falsa coscien-18 za, intuendo in Savinio il potenziale nemico ideologico, fu tra i primi aemarginarlo inaugurando una tecnica del silenzio che avrebbe trovato, finoai nostri giorni, non pochi adepti.'Frara' citt del Worbas forse il brano pi sintomatico della poeticabarocca, ma senza l'abituale ottimismo del barocco, di H. In esso, il venti-settenne Savinio d prova di una maturit sfiorante il magistero.Un intelletto torbido e compiaciuto talmente di s da sfiorare lo snobi-smo dandysta possiede il giovane scrittore che racconta Ferrara, citt qua-drata per metafisico spirito di geometria, dai portici illustri e cimiteriali,dalle piazze anguste~ e soleggiate, antropomorfica e coperta di mantellicolor di pietra antica~ contornati da baveri fatti di piume rognose; cittdalla faccia tinta di color mattone, con case come caramelle di masticaposte sotto l'insegna promettente di Cotyto, dea della lubricit. In questoluogo chiuso da quattro porte rosse, si dibatte una terribile turma femmi-nile, fra cui va grufolando lascivamente il ragioniere scrofoloso ( . . . ) e il sen-sale eresipelico (H., p. 50).La ricerca linguistica di Savinio si accende nella descrizione delle donnedi Ferrara, definite spaventose~, di una bellezza bestiale, come una ma-lattia, con occhi peduncolati, pillole purgative che guardano, simili aocchi di pennuti, non soltanto direttamente ma anche di lato e perfino in-dietro. Non ho mai potuto fissare in faccia n un cane, n un cavallo, nuna ferrarese--confessa, turbato dal proprio misoginismo, prima di at-tuare, per quel sortilegio delle analogie in cui maestro, l'identificazionefra la donna, resa oggetto astratto di esperienza estetica, e la citt, l'oscenaFrara con le ragazze dai volti che suppurano lubricit com'un eczema edove le vecchie, accosciate come strani animali nei gabinetti pubblici, ori-nano con fragor di grandine.Vede, poi, dietro le finestre delle case ferraresi, la sarta che, pedalandovertiginosamente alla propria macchina da cucire, cuce le palpebre deineonati, le scannatrici di polli che, livide in volto, bevono il sangue deigallinacei; vede l'ortolana scema che danza nuda in mezzo alla strada. Lasera, prima di tornare in caserma a sognare bizzarri connubi fra Zeus eAfrodite, osserva i macellai sbarrare le loro botteghe lasciando in mezzo ailocali puliti grandi buoi squartati, con le zampe aperte, nella posizione dicrocefissi.Sulle pareti della citt riconosce la traccia di Geova, anzi della partemeno nobile del corpo di costui ( . . . ) e che il dio degli eserciti mostr a Moi-s, quando costui gli chiese di poterlo fissare nel volto (H., p. 51).Si noter come il linguaggio di H. sia carico di letterariet e, divenendoartefatto, gorgheggiante, calcolato, teso alla ricerca dell'effetto esotico,non si ponga tanto lo scopo di raccontare quanto quello di colorare, dise-gnare, fare recitare i personaggi e i fantasmi delineati sotto il velo erraticodelle parole. Personaggi e fantasmi silenziosi, reticenti, elusivi, che nonpartecipano alla strutturalit del libro e, fragili larve racchiuse nel bozzolodi un lessico pellucido, si stanziano dentro squisite icone, paghe di una vitache non ha conoscenza fuori di s.Fanno in qualche modo eccezione il concettuale dittico formato daDio-ruotalibera e Il rocchetto di Venere~, tutto giocato, quest'ultimopezzo, sull'equivoco linguistico e sulle conseguenze che pu causare la scar-sa conoscenza dei dialetti.L'equivoco viene originato da un incontro del protagonista, soldato inattesa di partire per la guerra, con Anita, giovane lucchese di dubbi costu-mi, che una notte, in una camera d'albergo a Bologna, nell'estasi dei sensi,ha l'idea di proporgli: Di', vuoi fare il rocchettone?...Rocchettone, di certo,--immagina il protagonista--doveva essereuno di que' giochi, complicazioni erotiche, ricerche di depravati, sforzi deigiocolieri del letto per differenziarsi dagli amori orizzontali degli antichinostri padri palestiniani (H., p. 79). Egli fantastica uno strano, vorticoso,avvolgente erotismo, una caustica sessualit, una boccioniana mestica diforme anatomiche in movimento, un rapporto sessuale futuristicamenteparolibero. Si,--esclama con slancio--facciamo il rocchettone!Dopo una notte di ripetuti amplessi, col protagonista che sprofonda inun abisso di volutt, alla ricerca dell'arcano ineffabile, di qualcosa che pos-sa somigliare a ci cui egli, nella sua immaginazione, ha dato il nome dirocchetto di Venere, sorta di filo d'Arianna che lo porter verso la meta20 agognata, fulminato dagli occhi beffardi di Anita. Ella gli prende la testafra le mani calde e sorridendo, gli parla stizzita: Non hai capito... bestia!In seguito a un tempestoso congedo dall'amante, il protagonista sciogliel'interrogativo che lo ha tormentato giorno e notte venendo a sapere da uncommilitone, etimologo appassionato, che rocchettone, forma superlativadel meneghino el rocchett, significa, n pi n meno, ruffiano.L'esercizio parolibero-futurista, mai troppo accentuato in Il rocchettodi Venere e condotto pi decisamente in Dio-ruotalibera, fa, nel conte-sto del libro, l'effetto di un rameggiante, iconostatico arabesco, che, nonper questo, risulta superfluo alla natura fantasiosa e soggettivistica che vagradatamente impregnando l'economia testuale. Continua cos Savinio ilsuo itinerario solitario con Un bagno russo, racconto ambientato in unaFirenze dal cielo cupo che favorisce lo sgradevole ricordo, reso in tonoswiftiano, di tale Madame Raymonde de Saint-Saulieux, fumante e tonan-te di profumi puzzosi.Quattro poesie e un poemetto intermezzano la materia sempre pi flu-viale del volume, che va concentrandosi verso le impegnative prose di Isa-bella Hasson, La partenza dell'argonauta, Epilogo, L'orazione sultetto di casa. Si tratta di versi molto moderni per concezione e metro,stringati nell'epigramma, pervasi da un'allegra amarezza e pressati dai rim-pianti. Il viandante-autore paventa che il proprio 'partire' senza essere ama-to un 'soffrire' per non avere lasciato nessuno che possa ricordarlo, equindi un tradursi in sicuro 'morire'. Si rivolge poi all'amore che non saamarlo e sta con lui forzatamente come stanno uniti i borghi africani assa-liti dalle iene; chiama schifosa la propria giovent che lo vuole soldatoin partenza per la guerra e impreca contro Dio e coloro che, costringendoloa partire, gli hanno silurato l'anima. Intanto, la sentinella che va e vienediventa un manichino con fili di ferro nelle vene.Per sottrarsi all'alito della morte, il protagonista--l'autore-Herma-phrodito--si estrania e, divenendo uomo magico sul roseo sof, spettrocon le lenti, consolato alfine, rimane solo, a vegliare, nel tempo e nellospazio, la dolce eternit.Isabella Hasson, dedicato ad A. Soffici, ambientato a Salonicco, lacitt inquietante, assalita da un cancro letale che la rode alle fondamenta. 21L soldati serbi defecano sulle tombe turche e ragazzine turche raccattanofra i rifiuti vecchie scatolette di carne. La realt viene fortemente solcata eogni sostantivo , con puntiglio, connotato da un aggettivo. Infatti, nellacitt inquietante, l'afa compatta; i rombi dei cannoni sono grassi; gli echipigri; la montagna nuda; la nostalgia violetta; il cielo sconsolato; la calmatruce; i bambini guanciuti e chiapputi; gli occhi arsicciati; benigno il buio,opaco il frastuono, rinogutturale la voce, barbarica la strada, grassocce eburrose le mani; i movimenti leggeri, destri, ellittici, rotatori, turbinosi; icapelli rabbuffati, la benevolenza grandinante, i monti rapati; prismatica lasensualit, tragica l'ansia, lupina la voracit; le poltrone infaldate, l'erbettastentata. Isabella, altro sogno impossibile o letterario, andr poi moglie auno di quegli ebrei che l'autore mostra di spregiare.Fenomenologia delle sofferenze dell'umanit sotto le armi, La parten-za dell'argonauta il racconto del viaggio verso la guerra del soldato An-drea De Chirico, inviato, nel giugno del 1917, da Ferrara al fronte greco diSalonicco.Dopo aver salutato senza rimpianti Ferrara, citt della lussuria geome-trica, si addormenta confortato da sogni erotici, mentre un lunghissimotreno composto di vecchi carrozzoni anneriti lo porter a Taranto, luogod'imbarco per la Grecia. Nella solitudine morale che lo accompagna in unmondo estraneo, accettato solo per giovanili velleit guerriere confusamen-te motivate, nascono immagini ora dolci e rassicuranti, ora spaventose,secondo gli usi della bestia intellettuale. Appare il pittore italiano fallito eubriacone, reduce da Parigi, un mirabolano entusiasta per auto-imposizione che battezza lo Zeppelin di passaggio nel cielo zeppellino, co-s come certi emigranti in America fanno di Brooklyn Broccolino.Compaiono anche il genovese snob, che si ostina a considerare il prota-gonista un monsieur grec, e le prostitute intristite, dalla voce rugginosa ei lineamenti sconvolti dalla tubercolosi.Utilizzando, con tratto barocco, una tecnica 'collagista' che raccoglie econnette in trame espressioniste ambienti, situazioni e personaggi, Saviniocontinua a soffermare la propria attenzione sugli effetti da suscitare attra-22 verso il montaggio dei propri materiali. Cos, dal kaflkismo denotato nelpersonaggio del pittore fallito, rimasto preda del gioco canzonatorio di unSavinio che morde fulmineo, si passa al grand guignol connotante le prosti-tute e poi al cinismo volutamente plebeo che sostiene il protagonista, quan-do, dopo aver riflettuto sulla pochezza della vita e sull'incombenza dellamorte, considera: Vabbno, che vale vivere, che giova amar?... (H., p.201). E ormai stufo d'innamorarsi, di sognare, di farsi giocare brutti tiridalla sua sensibilit ridicola; odia, inoltre, i normali spettacoli della na-tura o le confessioni della madama che vuol essere capita. Insomma, nonvuole pi essere disponibile: non vuole pi 'essere giovane'. Vuole discre-zione, pudicizia, maturit.Il tema del pudore, costante nell'etica e nella poetica di Savinio, intro-duce la 'questione' dell'ipocrisia saviniana che, non separata, di solito, dal-la deteriore accezione comune, risulta una metafora per rilevare la ripu-gnanza dell'autore per la superficialit e la vilt dei veri ipocriti che hannoscoperto il modo di falsificare tutto parlando, senza ipocrisia e senzapudore, appunto, di tutto. S che, ribaltato il concetto, l'ipocrisia si faetica o virt. Tanto che lo scrittore si sente di sostenere: Chiunque michiami ipocrita non mi offende. Sciogliamo il sostantivo: ipocrita indica co-lui che esamina da sotto--una posizione che contiene il corollario di duealtre posizioni precedenti: l'esame superno e quello interno. Intendere iltutto, penetrando nel tutto (H., p. 207). Inoltre, il protagonista-autorevanta il fregio di un difetto che sarebbe stato prerogativa dei semidivini er-mafroditi, che furono temuti dagli stessi Dei.Ma anche per l'argonauta, disperso nella guerra e nella propria stessavita, giunge, cadute le velleit marziali, l'odio e le menzogne, il momentodel ritorno. Un ritorno a casa senza entusiasmi affettivi, non avendo nessu-no ad aspettarlo: S, tornare: ma solo per me e per il cuore mio... Ch, in-somma, agli altri che importa che l'Argonauta non torni mai pi?... (H.,p. 222).Il ritorno--ritorno, ancora, nella citt ebrea, Ferrara--, chiosato sulJournal, ormai quasi finito, da un trittico oratorio (Il politico, Il religio-so, 11 lirico), risveglia il fantasma ermafrodito che, mammelluto comeun Tiresias ( . . . ) butta dal meato puzzolente grappoli di carne che per terra23si ritorcono, poi si levano e camminano, indi crescon con vigore--insuf-flati da un calore dilatante--e finalmente si fan uomini seriosi e dottrinaridi morale (H., p. 230).Cos, nell'ordine quadro della sua casa, lo scrittore, consolato daglisconvolgenti processi di significazione avviati dai suoi mostri viscerali, ri-pudia le idee che lo avevano portato ad aderire alle ragioni funeste dellaguerra. Negligo la bestialit d'esser forte--annuncia con mestizia. Frale berciate de' tromboni e gli strilli delle donne in platea, il giocoliere equlll-brista -- Savinio -- si staccher dal firmamento fulgido del circodell'umanit e, con un prillo tragico, piomber nella segatura della pista,come una stella estiva (H., p. 234).1119 maggio del 1947 Savinio ricevette da New York una lettera di G.Prezzolini che, tra l'altro, recava scritto: Quando tu pubblicasti Hermaph-rodito, odiavo, non te, ma quel libro; mi pareva una pustola indecente, unbubbone malefico... E per ci ti stavo lontano, come appestato... (cfr.Savinio, Piccola guida alla mia opera prima, in Hermaphrodito, Milano,Garzanti, 1947, P. 55).Ebbene--scrive Savinio, dando moderata stura al suo antivocianesi-mo, mai, in altre occasioni, pienamente estrinsecato--ho guardato Her-maphrodito in faccia senza paura. Mi sono riconosciuto intero nella suafaccia. Tutto ci che io sono nasce da l. Tutto ci che ho fatto viene da l.Non c' idea, non c' pensiero, non c' concetto, non c' sentimento, nonc' immagine da me espressi ( . . . ) non c' nulla che non tragga da quella 'pu-stola' e da quel 'bubbone', indecente l'uno e malefico l'altro, ma straordina-riamente fecondi ambedue (H., Garzanti, p. 56).Certamente, per, Savinio--mentre con sofistica fierezza respingeva lecensure pusillanimi di Prezzolini, convinto che nel suo primo libro, nato daun vento di libert, c'erano i segni di un'epoca nuova che seppelliva persempre gli antichi idoli aprendo il mondo a un Presocratismo rinnovato enemico della falsa coscienza, degli idealismi, delle false morali e delle falseverit--sapeva di dovere dire, ancora prima che altri lo dicesse e malgradola certezza del proprio valore: Sul mondo mutante e medesimo, la mia ca-sa non rimarr, fra le case degli uomini (H., p. 234). Questa che si direbbeun'affermazione di orgoglio disperato invece la previsione, in forma d'epi-taffio, di un destino.Malgrado ci, scritto Hermafrodito, Savinio avrebbe continuato a scri-vere e pubblicare con regolarit. La casa ispirata (Lanciano, Carabba,1925), SUO secondo romanzo, la storia, resa in una sorta di svolazzantemosaico dell'orrido, della prima esperienza dell'autore a Parigi. Giunto inquesta citt cosmopolita e rutilante, Savinio si stabilisce, con soluzione mi-croborghese, presso una famiglia in rue de Saint-Jacques. Qui, osservandoe registrando, in una fuggente trama, brandelli di fatti e persone che loospitano, immagina di stare in una casa abitata da presenze invisibili. Lalucidit della prosa che descrive tale casa lascia intravedere, in trasparenza,un mondo illogico, straordinario, sulfureo e incantato, sconvolto da ritiraccapriccianti e fredde burle.Fin dal primo dei cinquantanove capitoli, una folla febbricitante si ri-versa davanti agli occhi del lettore affascinato dalla miserabile truculenzadi personaggi-manichini-burattini, come la coppia nomade Lorionov-Gontcharova che, entusiasta della teoria pittorica del cosiddetto sincroni-smo, offre all'autore l'occasione per alcune trovate sarcastiche, il colon-nello in pensione, la vedova, il nano, il giudice, gli spiriti faccendoni cheanimano la casa. Costoro amano mischiarsi con la gente, proteggendola, sidlrebbe, dalle mostruosit di una citt che ogni notte si riempie di prostitu-te transitanti col passo cerimonioso dei tacchini e coi petti enormi chesembrano armati di rostri, di esseri orrendi, ibridi antropomorfi, mostrifuggiti dalla corte dei miracoli, di chimere crapulone, di rettili barocchi, disolitari, dilombati efebi. Nasce da questo 'fantastico quotidiano' qualcosache sfugge al principio di realt e vuole rispondere a un oscuro, lusinghiero,vltalistico disordine dei sensi. Questo qualcosa pu essere, in tante occasio-ni, identificato nell'androgino, il ricordo losco e turbatore, l'essere in-quietante e squisito, tenero e ibrido che ha ossessionato l'infanzia di Niva-sio Dolcemare segnando indelebilmente l'arte saviniana fin dal periodo gio-vanile.Ideale prolungamento de La casa ispirata Angelica o la notte di mag-gto (Milano, Morreale, 1927). Esercizio di raffinata musicalit, storia ora 2comica, ora tragica, ora romantica del barone Rothspeer, manichino dicarne aggirantesi nel mondo surreale di Angelica, mitica Psiche--prostitu-ta e purissima--di un teatrino saviniano per eccellenza, , fra i libri pub-blicati dall'autore nel periodo rondista del ripensamento politico e della re-visione estetica, quello meno coerente con simile attitudine. Attitudine che,nella collaborazione di Savinio alla Ronda, viziata da un atteggiamentosciovinista e didascalico, si svela, oltre che regressiva, volontaristica e, infondo, con superficialit e non senza un certo affanno perseguita.C' cos da dire che il rinnegamento, da parte dello scrittore, delle pro-prie passate posizioni artistiche e culturali--segnatamente quelle espressecon Hermaphrodito--a favore di moduli stilistici pi regolari e classici ri-mane soltanto una buona (cattiva) intenzione, un programma farraginoso eun tantino ingenuo nel suo nazionalismo antieuropeo e antimodernista.Nella pratica, mentre sembra ricercare cadenze classico-normative e strut-ture tradizionali, quelle stesse cadenze Savinio non fa che stravolgere e dis-sacrare sottoponendole a torsioni formali derivate da un vaglio critico irri-ducibilmente eversivo.In undici capitoli privi di unit cronologica, a loro volta suddivisi intanti brani che conferiscono al testo un aspetto di metafisica scacchiera o ditinteggiato collage, condotti con periodare secco e sincopato in frasi di bre-ve respiro, ora liriche ora governate da un automatismo attento a non cade-re nell'asintassi, regolate e accese da una straniante loquela che connette lamateria letteraria con opportuni dosaggi surreali, l'autore rispolvera ununiverso di sordide zimarre, parrucche tignose, lampadine fulminate, al-berghi e caffeucci che si 'tengono per mano' nella calura delle notti estive, diguitti e di squallidi teatrini, di cavalieri della claque, di siparl gonfiati daun fiato scenico", di saracche affumicate, di caciottelle dolci da consuma-re il sabato, giorno di esultanza dei figli di Eloim. Su tutto ci s'innalza,emanando una luce opaca e malinconica, la silhouette della conturbanteAngelica Mitzopulos.Nella cornice di un gioco di specchi che riflette senza soluzioni di conti-nuit il vero e l'immaginario, e che infine reca effigiato l'arcano raffiguran-26 te Angelica, si dipana la trama a piani diacroni del racconto. Ed ecco che,da uno sfondo di grigiastra bruzzaglia, prendono forma le spettrali moven-ze della guercia Eufrosine Mitzopulos, partoriente, sotto la respirazionesabblosa della levatrice, la figlioletta Angelica, annunciatasi portatrice dipacata trascendenza. Staccandola, con felice ges.to da manipolatore verbaleda quello sfondo, l'autore fa crescere Angelica impassibile, eterea, cifrata,con un ascendente fuori del normale per i fratelli pi piccoli, che, a sera,quando lei rincasa, smettono strilli e giochi.Quando la trama sembra potere congegnare la materia narrata, la scrit-tura di Savinio varia e si rapprende in rappresentazioni surreali volte a unprogrammato antmaturalismo, si stilizza in sregolate architetture, si com-pllca con glochi illusivi dovuti a un linguaggio tagliato a lacerti dadaisti esintetizzato quasi crittograficamente. Esempio di emblema crittografico iltitolo, da cui si dipartono le cifre dei personaggi: il barone Felix Von Roth-speer, Arno Brephus, la signora Mitzopulos, Costa Cofins, Emanuele Sal-to, il signor Dsir, la Parasceve, l'angelo, i signori Berger e Mazas, e cosvla. Da questi personaggi-monogrammi, vuoti e risonanti, nasce una sto-ria: Rothspeer, barone ebreo tedesco di professione banchiere, accompa-gnato dal fido segretario Arno Brephus, conosce, durante una sosta ad Ate-ne del suo magnifico panfilo, la ballerina di nome Angelica e, come nei ro-manzi d'appendice, poich le ballerine fanno sempre perdere la testa ai ro-mantlcl baroni, s'innamora perdutamente di Angelica.Oltre a calcare il palcoscenico del variet, la bella Angelica, per arro-tondare i propri guadagni, si prostituisce quotidianamente. Strati sovrap-posti di veli Savinio sparge prima di fare intravedere, o forse solo immagi-nare, un'Angelica portata dall'incubo della gelosia del povero barone Roth-speer in un luogo fatto di una saletta broccata negli angoli e odore chiu-so di genitali profumati. E una clinica, una casa di salute, un luogo dicura: un bordello.Se il suo corpo parrebbe degradarsi, la sua vita spirituale, al contrario,si arricchisce, ed ella, incontaminata e fresca, sposa poi, contro ogni con-suetudine perbenista, il commovente Rothspeer e va via lasciando la casa ela famiglia nel pi sordo rimpianto. Qui si capisce che, al pari di una santa,ella amata e adorata da ciascuno unicamente per tornaconto.Intanto (Savinio accentua la parodia della facile logica del feuilleton) ilbarone, che ha vissuto una vita casta ed educata alla purezza, alla santit eal rispetto delle usanze, finisce per farsi cogliere da rimorsi e senso di fru-strazione, al punto di sentirsi meritevole di punizione e di scoprirsi cos ameditare masochisticamente la catarsi di un suicidio espiatorlo. N c' chl,nella circostanza, in grado d'aiutarlo; non il fedele Brephus e nemmeno 'ilpi importante' psicoanalista europeo (anzi, a proposito della psicoanalisi,lo scrittore, che pure fu estimatore di Freud, non si lascia sfuggire l'occasio-ne per ironizzare su quegli psicoanalisti alla moda i quali non mancano,all'occasione, di brancicare le pazienti: ci che accadr alla stessa Angellcaaddormentata). Rothspeer deve allora porsi nelle condizioni di capire dasolo che, se vuole davvero conquistare definitivamente la serenit, deveuscire per sempre dal proprio egoismo fatto di abitudini, timori, pregiudizie accettare la dolce Angelica per ci che ella : un limpido simbolo metafisi-co,una pura Anima.Naturalmente non vi riesce. Tanto che una notte, impazzito, strozzaBrephus e ne rinchiude il cadavere in cassaforte. Quella stessa notte padreAttanasio lo sente gridare: Ho ammazzato l'angelo! Il barone stringe inmano una piccola browning con la quale ha ferito il giovane nudo, curvatoa baciare Angelica, tenera e aperta nella notte di maggio. L'angelo ora volaa mezz'aria verso la finestra dove stramazza. Si rialza pencolando obliqua-mente fino a precipitare sui gradini della villa e poi--simile all'angelicomessaggero celeste della Kabbalah, creato da Dio solo perch ne canti perun solo istante la gloria e destinato a morire subito--svanisce nel nulla.Gli avvenimenti che seguono i drammatici fatti della notte di maggiohanno il peso tragico di una catastrofica profezia. Profezia che, oltre apreannunciare i massacri nazisti, descrive metaforicamente la guerra fratri-cida che, negli anni della stesura del romanzo, coinvolgeva gli Itallani. Rl-mane, splendente sulle rovine, in una luce rosea e in un'aria odorosa, Ange-lica, femminino saviniano e simbolo di una natura che si esprime nell'asso-luta fisicit e in un estatico, non per questo spensierato, accoglimento dellacondizione umana.28 Io sapevo ci che nessun altro poteva sapere, vedevo ci che nessun al-tro riusciva a vedere (cfr. Savinio, Tragedia dell'infanzia, Torino, Einau-di, 1978, P. 119 d'ora in poi T.I.). Con questo fiero accenno di monologo,effetto di acuta sensibilit e pudore risentito, si annuncia una fase impor-tante della poetica saviniana in un 'personaggio del destino': il fanciullo; ilplccolo Nivasio Dolcemare, protagonista di un dittico. sull'infanzia, chemoltl sarebbero tentati di classificare come psicoanalitico, formato da Tra-gedia dell'infanzia (scritto nel 1919, stampato nel 1937 dalle Edizioni dellaCometa, nel 1945 da Sansoni, nel 1978, infine, da Einaudi) e da Infanzia diNi7Jasio Dolcemare (Milano, Mondadori, 1941; Torino, Einaudi, 1973,da cui si cita; d'ora in poi I.N.D.). I due libri offrono un interessante luogod'mdagine nel contesto dell'opera saviniana: l'inconscio e, in particolare,I'inconsclo mfantile inteso come sottostrato della personalit adulta.L'infanzia di Nivasio ha le caratteristiche di un linguaggio permanente-mente operoso. Questo, nato da una coscienza magmatica e sensuale colpi-ta di continuo dalle interdizioni del mondo adulto e duramente impegnatanell'attraversamento dei traumi, delle fobie, ossessioni, anomalie vincolan-tl quello stesso mondo, condensa il suo rifiuto dell'adultit in parole-chlave, parole-immagini o simboli eufonici che, essendo di esclusivo con-trollo e propriet di Nivasio, concorrono a dargli sicurezza e volont direagire. Per esempio il pech (gli assillanti interrogativi del piccoloNivasio), il diago (un vitellino in gabbia scambiato per un drago), il teatroLanar, il maskar, I'Andromeda, I'occhio (dell'androgino), Apollo-Apolladl T.I. sono gli lconograficl significanti che annunciano e garantiscono, colrlfiuto, la fuga dal mondo adulto e borghese, la vocazione artistica di Niva-SiO. Al pari di parole come Ninfanzia, Ci2Jetta, Atena, Intelligenza, Erma-frodito, Donna, Cleftis (brigante), Pelargos (cicogna) disseminate in I.N.D.con funzione di nomi-simbolo, di significanti esorcistici. Se ne ricava cheInfanzia e Nome--quelli che potremmo chiamare i luoghi del 'ciclo dell'in-fanzia'--intrattengono una relazione costante e inscindibile fra loro. Il no-me e i nomi che Savinio attribuisce a se stesso e agli altri, gli 'adulti', sono i'noml dell'mfanzia', i significati con cui l'autore ha precisato il suo rigettodell'adultit e il suo destino creativo.Relativa espressione di omaggio all'oscuro scrittore francese Albert Sa-vine, lo pseudonimo di Alberto Savinio serve cos ad Andrea De Chiriconon tanto per mascherarsi o nascondersi o addirittura sopprimere il padreo il famoso fratello maggiore mediante abolizione del patronimico, quanto,divenendo, col suo 'nome di battaglia', padre di se stesso, per sottrarsi agliobblighi di una nominalit per lui troppo angusta e limitativa. Inventarsi ilnome, compiacersi della propria polivalente, dilettantesca, giocosa o sedu-cente pseudonimia, per Savinio un modo di sottrarsi a quel destino che luistesso ritiene, deterministicamente e illusoriamente, sia gi predestinato nelnome preesistente prima della nascita. Scopriamo cos che quello del picco-lo Nivasio il gioco di un apprendista d'arte che fa esperimenti di onoma-stica magica, prima su di s (NilJasio, anagramma di Savinio; Dolcemare,dolce-e-amaro, dolce-come-il-mare) e, in seguito, sui propri personaggi: ilcommendator Visanio (altro anagramma, o procedimento di poetica anti-naturalista, per nominare il padre: saviniesca permutazione dei nomi e con-densazione della metafora in una sola parola, secondo quel gioco dell'ana-gramma la cui invenzione pare sia dovuta a Licofrone da Calcide, uno deisette della Pleiade poetica, nel 280 a.C., all'epoca del regno di Tolomeo Fi-ladelfio), la signora Trigliona, il dottor Naso, monsignor Delenda, il conteMinciki, il principe Wasslcikof, il generale Papatrapatkos, il prefettoTsapatakolkis, il sindaco Pestromastranzglu, i Papanastasspulos, i Ca-laroni, gli Skilofranchi, Deolinda Zimbalist, Mikos e Takos, il capitanoTsitsipitikkis, il maggiordomo Pelopida, il signor Stmachos, i giardiniZappeion, Lulca, il colonnello Ts, il cocchiere Trasibulo Cacata, Co-sma il Saltatore, Kokonki il droghiere, il signor Quaranta, la vedova Tri-mis, i sergenti Zizimkis e Cosmazzis, la signorina Tsokas (cfr. I.N.D.).La prodiga epifania del nome posta in effetto da Savinio dunque unmodo per esprimere, con ironia un po' didascalica un po' 'interna' all'auto-re, la contestazione da parte dell'infanzia di Nivasio nei confronti dell'adul-tit, del nome di una borghesia tanto pi futile, ridicola, meschina, boriosae vuota quanto pi maggiorenne e maggiorente.E, quella adulta-borghese, una classe che Nivasio condanna riducendo-la prima a 'cosa' e poi a un segno 'pieno' che della classe connotata dice tut-to 'di per s' e spiega, inoltre, come l'atteggiamento del piccolo Nivasio-Savinio non si limiti alla contestazione e alla condanna, ma giunga alla 'rot-tura'. Una rottura, quella con una borghesia variamente contrassegnata,che segue la rottura dell'autore con le proprie origini. Rottura che anche'metamorfosi' e collocazione puramente 'oggettiva', testimoniale, sempredmamlca e lucida, di fronte agli altri e al proprio medesimo essere. Un esse-re che ha mutato il nome per mutarsi e non soggiacere alla tirannide delmondo adulto contro le tendenze fantasiose, metafisiche e metamorfichedell'infanzia.Libro dei turbamenti della sessualit infantile, dell'istinto di morte edell'angoscia prepuberale, storia dell'infanzia non come 'commedia' o'dramma', ma come 'Tragedia'--sacrificio assoluto e annientamento--T.I., riprendendo una formula semantica dell'autore, una foresta che fatutt'uno con la nostalgia masochista di un terribile lost paradise, 'paradisoperduto' contrassegnato dall'apparizione sconvolgente del dio ambiguo cheporta su di s, nel suo doppio sesso, i sessi del padre e della madre di Niva-SiO, 1I quale, nel momento in cui scopre la natura degli organi sessuali fem-mmili, paventa la minaccia di cstrazione da parte del padre. La rivelazionedei genitali femminili e il terrore di essere, in seguito alla visione del 'proibi-to, castlgato con la castrazione, indicano rispettivamente l'attenzione el'atteggiamento repulsivo suscitati nel piccolo Nivasio dalla scoperta dellasessuallt, incarnata, durante uno spettacolo al teatro Lanar, dal com-mediante ermafrodito.L'epifania sessuale dell'ermafrodito la prefigurazione della sessualitancora indifferenziata o, per dir meglio, della 'bisessualit' dell'infanzia, e,moltre, del rifiuto della differenziazione sessuale dall'altro sesso imposta albambino dalla sessuofobia degli adultiL'ermafrodito, col suo riferimento culturale alla statuaria ellenica delIV secolo, col suo dimorfismo, con la sua indocilit verso la gipsoteca e ilmuseo, col suo richiamo all'unit fra maschile e femminile dell'androgino,dlventa dunque uno stato di grazia, l'ideale aspirazione al superamento deldualismo sessuale e alla mitica riunificazione dell'eros, e annuncia una mi-stlca che dall'ottica dello stato d'infanzia, contempla la natura androgina diun Dlo pagano e, coerentemente con la poetica saviniana, promuove unametafisica antropologica che vede nel sovrumano ermafrodito dagli occhistrabici stellati, voluttuosamente sudato e anelante, dal sesso simile al deltadell'occhio divino, dalla voce acquea, l'andrismo e la tenera femminilit, ilLogos e il Cosmo. S che, al pari di Rilke, che, per essere perfetto come arti-sta, pregava Dio di mutarlo in ermafrodito, Savinio--perfettamente ateo edissacratore--, affermando l'infantile Eros contro l"adulto' Thanatos, rie-voca l'infanzia, onda continua di rivoluzione (...) sistematicamente stron-cata dai 'grandi', questi reazionari ( T.l., p. 99) venduti alla solenne buf-foneria della seriet.Ma il potere esecutivo dell'adultit ha gi falciato l'erba dell'infanzia,ingrato campo di battaglia senza onore, conferma spietatamente crude-le che la vita, per legge, una sconfitta,>. Altro rimedio alla sconfitta parenon esserci al di fuori della ricerca di una dignit del soggetto e della sco-perta del ruolo strutturante del linguaggio enunciato come funzione dell'loche si riscatta orgogliosamente: Non persona al mondo degna di ricevereil mio segreto. A nessuno riveler le traversate vicende, le scoperte fatte, Imondi conosciuti che ho percorso in compagnia della severa e luminosadea ( T.l., p. 95). Funzione che spinge il soggetto-Nivasio-Savinio a opera-re per l'appropriazione della parola, e a festeggiare, col potenziamento edo-nistico di tale appropriazione, l'affrancamento dalle panie parentali e il lie-tO abbandono dell'identit alienata del vissuto familiare.Dopo la fase della tragedia", quella della 'festa', perci. Una 'festa dellinguaggio' che, con allegria lessicale, con estro barocco e dovizia filologi-ca, in l.N.D., Savinio partecipa al lettore. Ripartito in sette lasse compen-diate da una nutrita serie di note (giocano a parte e analogicamente i rac-conti Luis il Maratoneta e Senza donne, pi alcuni Frammenti) il ro-manzo, ambientato in una Grecia che E. Sanguineti, in un suo saggio, tro-va dechirichiana ma anche fabbricata un po' da Klinger e un po' da Boek-lin (cfr. Alberto Savinio, in AA.VV., Studi sul surrealismo, Roma, Offici-na, 1977, p. 408), ha un che di esotico e lussuoso, di galassia cromatica efantasmagorica, di luogo spaziale calorosamente concertato a formare unimpuro disegno araldico. Vuole essere, questo libro stillante acidi corrosi-32 vi, una presa di coscienza formulata nel cinico assetto di una conoscenzadell'inferiorit altrui, da cui Nivasio Dolcemare avrebbe tratto un saluta-re complesso di superiorit. Complesso prodotto dal beneficio ricevutonascendo per caso in una terra epica, eroica e immortale, che ha fattodell'infanzia di Nivasio-Savinio una Ninfanzia, periodo della vita chel'uomo consuma sotto l'autorit di Anzia, ninfa delle primizie. (Anzia da'ante', prima) (I.N.D., p. 17), un catastrofico paradigma di sofferenze, in-comprensione, solitudine, sensualit, un festoso baraccone di delizie finte,di fasti vani, di ambrosie avvelenate. Perci, nient'altro che noia mortale,astio e disprezzo pu provare il bambino Nivasio per gli adulti, specie perquelli delle classi agiate che fanno capo alla sua famiglia, altrettanto agiatae borghese.11 sole picchiava a martello sulla citt della civetta il giorno della na-scita di Nivasio, figlio di Visanio e della signora Trigliona (appellativo con-sono a una Dolcemare fatua e stolida), latrante nell'atto del parto, tanto dasoverchiare il grido di saluto emesso dalla cima dell'Acropoli dal sacro uc-cello di Minerva, risvegliato per l'occasione dal suo antico sonno. Dopo diche, ripulito e parato come un finissimo salume, Nivasio si prepara adentrare nel mondo, a mischiarsi alla vita in qualit di fantasma maschera-to, ma dando prova di una vista cos lucida e fredda, da provocare turba-mento e raccapriccio (I.N.D., p. 24). E una vista che scruta ironica il Go-tha salottiero di Grecia e ne mette a fuoco le minuzie, enumerandole concromatismi linguistici come accesi da un retaggio del Siglo de Oro di Gn-gora o Lope. La grassa borghesia greca vienc stigrnatizzata in nomcndatu-re cerlmoniali e cataloghi inorpellati, avviluppata in uno sfarzo pirotecnicodi feste consumate fra ricchi arredi, vasellami, ninnoli, stanze invase daun'imperversante teratologia, da un carnevale ferino e tartareo, chiusa incarrozze, ficchere, bagherini e land.Il disegno letterario, fatto di giochi mimici, di provocatoria prestidigita-zione, di caustiche caratterizzazioni, invita a una lettura lenta, alla festa ba-rocca e alla ricerca orientativa sopra una pagina che luogo per irrequietegeometrie di tappeto orientale, architetture arbitrarie, talvolta temi del cor-po. Tra questi spicca quello dell'analit o fase anale, argomento che am-piamente affrontato, da psicoanalisti come Jones, Ferenczi, NormanBrown e Karl Abraham, oltre cha da Freud e, oggi, in Italia, dallo 'scatolo-go' L. Parinetto, viene da Savinio, in sardonica polemica con la psicoanali-si, semplificato: Nivasio ( . . . ) vide in mezzo al pavimento lucido quella pic-cola parte di s, quel rotolino nero che ergeva la punta fumante; e tale fu ilsuo accoramento che ruppe in pianto (I.N.D., p. 40). In che modo attri-buire--sembra ammiccare lo scrittore verso quanti sarebbero pronti a but-tarsi nell'esegesi psicoanalitica dell'episodio citato--, al pianto del piccoloNivasio, dovuto a semplice confusione, significato di erotismo sadico-anale, pulsioni di dominio, collegamenti merda-capitale, addirittura dia-lettiche servo-padrone?Avarizia, parsimonia, efficientismo, invidia, cocciutagine, pedanteria--particolari attributi del carattere anale--non sembrano appartenere aquesto libro improntato alla pi dispendiosa sensualit, cui va compresoquel senso disfrenato dell'olfatto che domina anche certe pagine di Casa laVita~ e Tutta la vita e permea il folto barocco dei numerosi aggettivi pre-senti nel testo. Aggettivi che, se paiono servire soltanto a dare alla narrazio-ne un che di fronzuto, compiaciuto, elusivo e artefatto, propalano presto laloro calcolata natura metafisica o estraniante. L'incrocio dei sostantivi ag-gettivati risolve allora non il marginale problema estetico del libro ma quel-lo strutturale, spiegando insieme i meccanismi di una tecnica o metodolo-gia che, nella tensione dell'unit formale, rifiuta risolutamente il modellonaturalistico di narrazione. Tale tecnica del resto dichiarata in uno spla-namento emotivo d'ironica e teatrale retorica, di figure stilistiche ruotantisempre sul centro dell'infanzia, che per l'autore severa, colma di fato eben pi venerabile della vecchiaia, oscuramente animosa e terribile.Superato lo standard tradizionale e abitudinario del romanzo della suaepoca, il laboratorio scrittorio di Savinio si attiva a esaurire molteplici pos-sibilit, a ingrandire il proprio spessore e a fare convergere, nella misurabarocca, la scrittura narrativa con quella poetica e critica. Una scrittura da'incantatore di lettere', la quale, nella sua onnivora totalit, 'brucia' inun'opera d'implacabile autobiografismo l'Io dell'autore, o, meglio, lo fa'sparire' nel gioco della scrittura. Immune dallo psicologismo e dalle intro-spezioni psicoanalitiche, non adeguato ai valori critici dei suoi contempo-ranei, ecco che Savinio, uomo che fa della sua vita opera d'arte, inizia unpercorso che lo porter all'ostracismo e all'emarginazione. Ecco l'autoreimmobilizzato dentro la parola d'ordine-accusa che le accademie e gli av-versari di tutte le avanguardie riservano ai 'diversi' dell'arte, a coloro chenon rientrano nella 'classificazione media': dilettante. In effetti, maggiorecomplimento non pu farsi all'artista, specie a uno come Savinio che, perfantasia e originalit di mente, non pu essere limitato da una qualche eti-chetta specialistica.Sicch il suo dilettantismo andrebbe considerato senza pregiudizi o ca-tegorie prefissate e da un punto di vista il pi lontano possibile dall'occhiomonocolato dell"esperto'. Punto di vista esposto assai bene, per esempio,da M. McLuhan: Il professionismo immerge l'individuo nei modulidell'ambiente totale. Il dilettantismo ricerca lo sviluppo della consapevolez-za totale dell'individuo e la consapevolezza critica delle forme fondamentalidella societ. Il dilettante pu permettersi di perdere (cfr. Il Medium ilMassaggio, Milano, Feltrinelli, 1968, p. 93).Ma Savinio, che ha perso la battaglia coi suoi contemporanei, e, conl'avversare lo specialismo, 'passato al nemico', non si potr permettere,pena la definitiva rimozione, di perdere anche col particolarismo di questianni Settanta in smobilitazione. Uomo Solitario e Durissimo (...), UomoDiamante (...), Achille fuso con Orlando (...), Uomo di Marmo che Cam-mina", l'autore, con il Nietzsche pedagogo, pensa: Di dove nasce quellaforma di pedagogia a fondo solitario e sdegnoso, che disprezza la bolsa sin-cerit e all'azione diretta preferisce la fredda menzogna e l'ipocrisia taglien-te; di dove se non dalla nostra nostalgia dell'Uomo di Marmo, dal desiderioche larga parte dell'umanit si possa rafforzare in Uomini di Marmo, dallasperanza che l'Uomo di Carne, l'Uomo Marsupiale, l'Incurabile Plebeosparisca un giorno dalla faccia del mondo?~> (I.N.D., p. 55).Ma gli uomini di carne, gli uomini marsupiali, gli incurabili plebei, imostri umani, bercianti e tremendi, gi circondano il bambino Nivasio chesi sta educando a essere Uomo di Marmo, Uomo Metafisico. Esseri umani,forse gi mutati in cani, abbaiano e si sbranano chiusi dentro gabbie di fer-ro mentre i corvi gracchiano nella notte sopra ossa calcinate, Cosma il Sal-tatore nei panni di Ermione vola simile a un nibbio nel verde del giardinoPeristri, un Dio freddoloso si pasce della propria solitudine, un odontoia-tra satiro si accoppia con orride creature, un carradore, o forse un autenti-co 'demone meridiano', la bocca tirata, la faccia da diavolo, tra pietre,nugoli di mosche, cumuli di escrementi, vicino al carro e al cavallo, si ma-sturba con ferocia ebete nel caldo cremoso del meriggio, chiudendo, conun presagio di lezzo e putrefazione, conclusione naturale della vita, l'in-fanzia 'mostruosa' di Nivasio Dolcemare (Infanzia e mostruosit vanno diconserva e io non penso altrimenti alla mia infanzia, se non come al tempodei mostri, cfr. Savinio, Introduzione a T. Campanella, La citt del sole,Roma, Colombo, 1944, p. 10).Dalla 'mostruosit' dell'infanzia, l'autore ci accompagna verso quelladella maturit, ossessionata dal pensiero della morte. Attualizzandosi so-pra una moderna, stravolta immagine della teoria pittorica di F. Bacon, Sa-vinio, con i suoi personaggi, potrebbe dichiarare che non c' un solo glornodella sua vita in cui non abbia pensato alla morte. La vertigine del pensierodella morte, che coglie a intermittenze l'esistenza degli uomini, , infatti, lapi palpabile prerogativa dell'arte saviniana. Un'arte che, generalmente ri-conosciuta come surrealista, stata dall'autore segnata con marchio esi-stenziale e neoumanistico: Quanto a un surrealismo mio, se di surrealismo il caso di parlare, esso ( . . . ) non si contenta di rappresentare l'informe e diesprimere l'incosciente, ma vuole dare forma all'informale e coscienzaall'incosciente (...). Nel surrealismo mio si cela una volont formativa e,perch non dirlo? una specie di apostolico fine (cfr. Savinio, Prefazione diTutta la vita, Milano, Bompiani, 1945, pp. 7-8). Il senso del sintagmaapostolico fine non da intendere alla lettera, ma nell'accezione ironica,secondo una pedagogia che inverte i termini di paragone riferiti all'etica co-stituita e, provocatoriamente, compie un esercizio stimolato, appunto, dauna volont formativa (volont formativa derivata da una sana capacitcostruttiva), che connota positivamente ci che di solito viene classificato3~ fra le categorie negative del comportamento: il dilettantismo, l'egoismo,l'indifferenza, la gelosia, il pudore, la disgregazione, l'umanesimo, il ro-manticismo.La Morte qui la volont regolatrice e ordinatrice del bene che non Bene e del male che non Male. Questa morte che ci accompagna / dalmattino alla sera (cfr. C. Pavese)--che significa: la nostra stessa vita,anche dopo che il cristianesimo ci ha privato della pagana serenit di frontea essa--, per l'autore, occasione costante al fine di evidenziare quale siastato il prezzo pagato dall'uomo, il quale, fuggendo la vita universale, ap-prodato alla 'coscienza infelice' individualistica, senza, con questo, potereguadagnare una vera autonomia per la propria persona. Savinio si ribellaalla morte intesa come frutto ed espiazione della colpa, o tributo che l'uma-nit cristiana crede di dovere pagare per il 'peccato' di esistere. Si ribella auna cupido/libido mortis--che, inevitabilmente, nella cultura del cristia-nesimo, diviene paura della morte--opponendo alla retorica della 'cristia-na rassegnazione' dinanzi all'Orco una sorniona serenit. Il suo essere perla morte, che ricompone la dicotomia bene-male in una neometafisica pie-nezza della vita, non l'heideggeriana, angosciosa progettazione della mor-te, ma critlca stoicamente umanistica in bilico sull'abisso della storia al cuitermine c' la morte, che risulta una dura vittoria del genere sull'indivi-duo (cfr. Marx).E alla luce della critica della storia, rinviante alla vita degli altri soggettiil senso della morte del singolo, che Savinio riesce a razionalizzare la tragi-cit del destino umano e a interpretare con volont stavolta non ironica-mente formativa, anche se sgomentate per coraggio conoscitivo, il signi-ficato della sofferenza e del male.Pochissimi sanno morire. Starei per dire: pochissimi muoiono; perchmorire un atto d'energia che da pochissimi compiuto come tale. I pi ar-rlvano alla morte esausti, allo stato di larve e passano di l come risucchiatida un aspirapolvere (cfr. Casa la Vita, Milano, Bompiani, 1943, p. 7).Savmio precisa, con queste parole, quali siano i termini della materia delsuo pi Importante libro sulla morte, e indica, menzionando le biografiestraordinarie di Narrate, uomini, la vostra storia, i modi di morire che inse-gnano il sistema per arrivare alla morte trionfalmente, come la capitana diun'armata vittoriosa che entra nel porto a bandiere spiegate. L'autore do-manda al lettore di riconoscere ai personaggi di cui ha appreso la vita l'ori-ginalit del morire. Originalit che, con atteggiamento tra il parodistico eil romantico-decadente, egli attribuisce soltanto agli artisti. Confida: Solola morte degli artisti m'interessa, come del resto la sola vita che m'interessi quella degli artisti".Naturalmente, fra gli artisti, egli pone anzitutto se stesso, e quindi sipropone di continuo, mimetizzandosi nei suoi personaggi, figli, assai spes-so, di un'infanzia vissuta nella dolce citt visitata dagli Dei, attraversatadal volo triangolare delle cicogne, cosparsa di giardini, stretta fra le casecome per proteggersi dal mare annegrato e furioso. Questa citt dell'infan-zia, l'autore l'ha ormai dentro di s, rimpicciolita fino alle dimensioni di uncuore, con i templi che diventano portatili e le colonne che girano assie-me col girare del sole, le statue animate di serena magia.L'attenzione lessicale di Savinio si esprime in ricercati costrutti e simili-tudini manieristiche, per i quali Mercurio che scende dal cielo scintilla co-me uno scarabeo dall'inusitata corazza d'oro, i velieri all'ormeggio nel por-to greco sono una secca foresta e i palmizi dei giardini somigliano a pen-nuti dal collo spiumato.La citt dell'infanzia, portatrice di antichi miti, dei ricordi del bambi-no e della cultura dell'adulto Savinio--che, di volta in volta, si chiamaAnimo, Carmelo, Nivasio, Andrea, Omero, Malino, Munster, Aniceto,personaggi che, a differenza del piccolo Nivasio di Tragedia dell'infanzia edi Infanzia di Nivasio Dokemare, scorgono, alla fine di un percorso obbli-gato, il termine della loro vita --, , per l'autore, anche 'citt delladigressione': digressione proprio nel significato etimologico latino e, altre-s, nel senso che l'autore si , di fatto, allontanato dalla citt che lo vide fan-ciullo .Vi ritorna e vi esce, cos come divaga e si allontana dall'argomento cen-trale delle prose che va scrivendo, soffermandosi su particolari, interrom-pendo la successione logica della fabula, manipolando gli avvenimenti nar-rati, attuanto spostamenti temporali, spezzando la struttura letteraria con38 aneddoti, brani descrittivi, rimembranze, introduzione di personaggi, ri-mandi storici in funzione referenziale, cesure parentetiche. Un siffatto mo-dello--potr sorprendere il rivelarlo--somiglia straordinariamente al ~i-zoma spiegato da Deleuze e Guattari. Accade, appunto, che sulla radice diun tema viene innestato--e qui, si badi, si cita lo stesso Savinio--un al-bero intero di aneddoti col suo tronco, i suoi rami, le sue foglie (Casa laVita, p. 48), una specie di macchina desiderante (cfr. Deleuze-Guattari)per accrescere, secondo una tecnica antilogocentrica e orizzontale, 'disse-minante', il piacere del testo (cfr. R. Barthes), che, in questo libro acco-rato, dipana 'pe' li rami' la sua metafora mortale.Entrare in Casa la Vita, testo-limite, apologia del frantume narrati-vo, della scheggia esistenziale, del rottame filosofico, dello sprazzo lirico,della pulsione, della dissipazione e del dilettantismo programmato, diventaallora un percorrere i molti tragitti del rizoma, cio del non-sistematico,che, a somiglianza del Castello kafkiano, ha 'molteplici ingressi' di cuiper non si conoscono gli usi.Casa la Vita, testo principale, con Narrate, uomini, la vostra storia(1942) e Tutta la vita (1945), di un ciclo della Vita considerato da unodei pi appassionati studiosi di Savinio, U. Piscopo, d'accordo con E. Cec-chi (cfr. in AA.VV., Storia della letteratura italiana, cit.), il vertice dellaprosa saviniana, fu pubblicato nel 1943, nove anni prima della morte delsuo autore. Anche se non si pu dire con estrema sicurezza che rappresentiil massimo livello dello stile di Savinio, esso probabilmente appartiene allafase pi matura e profonda della riflessione saviniana che ha precorsoquell'atteggiamento interrogante verso la realt, quella contraddizione tor-mentosa fra Io e Superio, quell'interrogazione della morte accompagnatada un bisogno d'infinito compresso dall'esercizio spietato della ragione,all'interno della polarit fra Vita e Morte, che hanno contraddistinto le ul-time avanguardie europee.La struttura di Casa la Vita, tanto pi parcellare quanto pi unitariae sintomatica dell'intera opera-rizoma di Savinio, collegante fra loro anchegli spezzoni pi distanti del proprio lavoro--spezzoni che, riecheggiandola partitura polifonica, si rimandano l'un l'altro temi, linguaggi e idee por-tanti, facendo totalit dell'inventario della frammentazione--, rappre-sentabile in foggia di rete sintagmatica che riassume un testo unitario divisoin capitoli a tema (i titoli dei racconti) e spaziato da epigrafi (gli Occhi).Sedici capitoli, una prefazione, un'introduzione, una postilla, una va-riante e nove occhi sono l'apparato di un manualetto di avviamento ededucazione--anche sentimentale--alla morte, considerata non accidenteestraneo ma carattere peculiare della vita, o, in termini freudiani, tendenzadi tutta la vita.Non c' dunque lotta fra vita e morte perch le due entit--che, per ilpresocratico Savinio, sono unite da una dialettica eraclitea per cui ci che morto, ci che desto e ci che dorme, ci che giovane e ci che vec-chio sono in noi la stessa cosa, e, capovolto, ogni elemento si tramuta nelsuo contrario (cfr. Eraclito)--sono equivalenti. Vivere sar pera Impa-rare a morire. E invano, secondo l'autore, l'uomo combatte la morte inven-tando la storia e, con la storia, la dialettica servo-padrone, cio la lotta diclasse. Quello che importante, per Savinio, l'individualit; la quale nonpu essere raggiungibile separata da quel rapporto univoco fra vita e morteche governa la vita del soggetto. La Casa saviniana, situata dinanziall'orizzonte della morte, contiene in s la Vita.Dopo l'evocazione della citt dell'infanzia, lo scrittore apre l'ingresso diCasa la Vita con Figlia d'imperatore, racconto 'trifase' e anaforico(metafora delle tre tappe della vita: nascita, esistenza, morte) ambientato aParigi (Animo arriv a Parigi nel febbraio del millenovecentotredici;Animo torn a Parigi nel 1924; Animo torn l'ultima volta a Parigi nel1937) che brulica di personaggi irripetibili, fra cui Apollinaire, Picasso,Lger, Derain, Jacob, perfino Lenin (un uomo calvo e barbato a carciofi-no, cui gli occhi obliqui e gli zigomi sporgenti davano un aspetto mongoli-co), e dei fermenti pi importanti della nuova cultura europea suscitatidalle riviste d'avanguardia del periodo 1916-1930, tutte rivolte a Parigi.Fra i numi di un tale spettacolo di vita, la figura della misteriosa baronessadi Oettingen, finanziatrice delle Soires de Paris, la rivista di Apollinaire.Vendetta postuma narra della rappresaglia di Agamennone, il re ven-dicativo, dalla rancorosa, elefantiaca memoria, il quale, sotto l'aspetto diuna nave da battaglia inglese, I'Agamemnon, attacca, ancora, l'antica cittdi Troia. Al posto delle braccia, l'Atride ha cannoni micidiali con cui per-cuote i vecchi fianchi di Ilion, corpo morto gi da trentadue secoli. Per se-COII~ per epoche, per re, Agamennone ha agognato la nemesi vendicativa;e crede di averla finalmente trovata, col favore del tempo che puzza dimorte, felice, alfine, di potere assestare un sia pur ritardatissimo colpo digrazia. Sul puzzo di morte, che, simile a un volatile rizoma, prolifera isuoi effluvi tossici, Savinio regola la distribuzione delle sue dissacratorieepifanie. Dissacratorie perch il sapore mortuario che invade il tempo dellavendetta, grava altres su un tipo di cultura--quella bellicista--da cui lostesso olfatto non pu non restare offeso.Flora una sorta di corrispettivo letterario di certi quadri metafisicidi De Chirico--rifacentesi a piazze che, a differenza di quelle di De Chiri-co, levigate e astruse, si coprono di arbusti e macchie--raffiguranti le ab-bandonate statue delle Piazze d'ltalia: si pensi a Malinconia (1912 ?), LeGioie ed Enigme di un'ora strana ( 1913), La Ricompensa del Poeta ( 1913)Arianna (1913), La statua silenziosa (1913), La Fiacchezza dell7nhnito(1913 ?), L'Enigma di una giornata (1914), ecc. Estraniante effetto di unracconto di crudele ambiguit, costruito sulla metamorfosi e l"orfeizzazio-ne'. Ritratti di capitani di cavalleria che escono dalle cornici e salutano mi-litarmente, di donne scollatissime che porgono la mano da baciare, di pon-tefici sorridenti che fanno segni di benedizione, sono le note surreali di unascrittura alla ricerca della massima resa.Marco, il protagonista, malato di nostalgia per Flora che lo aveva la-sciato e che ora gli riappare in un parco, nelle fattezze di una statua sorri-dente, dal naso mutilo, ((combusta dal tempo e impelosita dal muschio,sogna soltanto di riunirsi al suo amore perduto. E un giorno, mentre vaganel parco, si sente chiamare dalla voce opaca della statua-Flora, che lo tor-menta fino a quando, in un'alba che emana un chiarore da mondo finito,Marco non s'autoannulla penetrando col suo intero corpo nella pietra dellastatua.Walde 'Mare', piccolo gioiello lessicale che, col pretesto del raccontostrutturato nella forma della memoria di viaggio, aumenta la frequenza del-le dlgressioni per cui, il mare, prima configurato in tutto il suo misteriosofascino lirico, diventa, per l'azione demitologizzante dell'autore, foriero dimorte, di una morte immeritevole di orpelli poetici, di morte marina ottu-sa, sillabante il nonsense Amare/del mare/le amare/maree. Non rima-ne, allora--per stare al gioco della morte, questa freddurista--, che scen-dere sul suo terreno, continuando a perseguire lo straniamento, leitmotivche fa da impalcatura a tutto il pensiero saviniano. Non resta che provare atrasformare Nettuno in comune mortale sbarcato sul molo e seduto al ta-volino di un bar ventilato dalla brezza marina, oppure, raggiungendo ilmassimo straniamento, addirittura raccontare una 'visita' del mare chebussa alla porta: oMi svegliai di soprassalto. 'Chi ?' 'La mer', rispose unavoce di fuori (...). Andai ad aprire ma non era la mre: era il mare. Il Marein persona. Il signor Mare (...). Entr lentamente e sed alla mia tavola(Casa la Vita, p. 91).Chiosa alla Partenza dell'argonauta,> di Hermaphrodito, Carmelo e ilgeneralissimo, e rievocazione, in Formoso, di un episodio avvenuto in-torno all'869, riportato nella cronaca di Liutprando, della lotta fra il PapaFormoso, che voleva trasferire la sede pontificia, e Stefano VI. In entrambii brani, il senso della morte viene suggerito da personaggi fortemente carat-terizzati: ((grasse levantine oleose di pelle, olivastri gentiluomini turchinidi ganascia, uomini giganteschi e incredibilmente belluini.In Nuove metamorfosi di Ovidio, rizoma in nuce rapportante i corsie ricorsi della storia ad un unico luogo di coincidenza e di fittizia storicizza-zione fra i margini dilatati e proliferanti di un eterno presente, si legge il re-soconto di una ricerca del poeta Publio Ovidio Nasone, riconosciuto in unvecchio filosofo che, dopo avere dissertato sulle capacit stregoneschedell'autore delle Metamorfosi, sparisce nel nulla, ribadendo, con l'assuntoovidiano della metamorfosi, una variante della tecnica di spaesamento o'fantasia di sparizione' presente in Flora. La morale del racconto, mesta econsolatoria, vuole essere che anche dopo morti i poeti continuano a vive-re.Se ((II castellano di Philippeville la stringata sineddoche della solitu-dine dell'adulto iperattivo che ha paura di morire solo, Un Maus in casa42 Dolcemare ovvero i mostri marini il ritorno alla molteplice tematica delpiccolo Nivasio in lotta per capire i mille enigmi mortali, i 'mostri' che la vi-ta gli prospetta. La famiglia, inferno di ipocrisia e incomunicabilit, rimaneil fulcro, o il bersaglio, che fa scattare la macchina demolitrice prestatadall'autore a Nivasio Dolcemare. Ma come demolisce, Savinio-Nivasio?Abbassando, avvilendo, disistimando, imbestiando, infine ridicolizzando.Cos monsignor Delenda ha mani a palla di burro, la consolessa d'Au-stria Ungheria puzza in modo sconcio, le zitelle si trasformano in salac-che, il generale Papatrapatkos ha una voce da castrato, i giocatori altavolo della famiglia Dolcemare hanno chi occhi di cicogna, chi occhi dilepre; le mani di monsignor Fuagr sono due rosei e grassi fiori di carne,la contessa Corilopsis scuote la cresta>~, batte le ((ali e si spollina, lamoglie del generale Papatrapatkos ha le mani a zampa di tacchino, bu-tirrose madame sudate estraggono brevi lingue di gatte~ leccando mante-cati, fra camerieri che volano come rondini e ragazze che passano vestiteda libellule.In un intervallo dello snocciolamento del taratologico repertorio, loscrittore, a degradare definitivamente l'atmosfera, mischia il lezzo del fiatodel mare col fetore di cose umane~. Riprende poi a ritrarre Messario che sisgrulla come un cane, la madre di Messario fatta tutta di mammelle, an-che sotto la gonna, Oscar Dacosta, direttore del gas, con proboscide ele-fantina, monsignor Fuagr che rivela due occhi di gufo sulle spalle, Cala-roni con due occhi di polpo sul sedere, la pancia del conte Minciaki condue labbra vermiglie boccheggianti. Globi, spire, anelli, cartilagini, fi-brille, lunghi tubi di pelle pnduli come liane invadono, fittoni e rizomianimati, misirizzi sbilenchi di corruzione, la sala da pranzo della famigliaDolcemare, mentre una voce ripete atterrita: I mostri marini... I mostrimarini... " E a questo stadio che, sovrastato dallo spettacolo di budellamein libert, Nivasio capisce inorridendo: i mostri sono fra noi, nella fami-glia, nelle congreghe, nel mondo. Ci un momento prima che i mostri ri-prendano il loro posto a tavola, coperti dalla comoda maschera dell'abitu-dine, in un'aura di chiaroscuri barocchi, di contrasti violenti e trapananti,di ombre sempre pi plumbee.'Mostro' che rassicura il personaggio di ((Angelo, il ragazzo personi-ficante il mito dell'eterna giovinezza, della purezza e di una non entusia-smante vittoria sulla morte. Colpito da una scheggia di granata durante ilfuoco della contraerea (Savinio scrive Casa la Vita in tempo di guerra),Angelo viene trovato ferito al labbro dentro casa Bastiani, steso sul pavi-mento, nudo in mezzo a un grande arruffio di penne.Il pennuto Angelo ha inaugurato la completa metamorfosi zoomorfacui si assiste in Mia madre non mi capisce. La metamorfosi, senza perconnotazioni zoomorfiche, tocca Nivasio, presentato non pi bambino macome uomo che ha superato la cinquantina (gi adombrante il postumo si-gnor Dido), maestosamente vestito e calzato, abitante in una casa confor-tevole lungo una via signorile.Rincasando, carico di pacchi, una sera dell'ultimo dell'anno, Nivasio simette a pensare alla madre morta, la tremenda signora Dolcemare~>, che,prima di morire, aveva agonizzato per due settimane.Il ricordo della madre torturata dal male, senza parrucca in testa, sen-za dentiera in bocca, senza carne sulle ossa, ridotta a una misera creaturache guardava il proprio figlio senza vederlo e non riconosceva pi nessuno,scossa continuamente da un grido strano, strozzato, agghiacciante, ungrido di gallinaccio che attraversava col suo gelo l'intero casamento esembrava implorasse la~morte. Quello stesso grido, ma pi fioco e lamento-so, impuerito, adesso il maturo Nivasio ode echeggiare, proveniente daqualche punto della casa in penombra, forse da una stanza sconosciuta,mai aperta. L'indistinto livello di realt della memoria viene a questo puntointersecato da un livello di realt nuovo, che favorisce il trapasso tra reale e.mmagmarlo.Il grido di gallinaccio si materializzato nell'immagine di una gallina:una gallina piccola piccola che, rivolta a