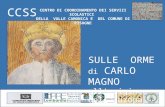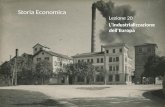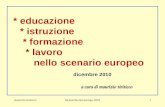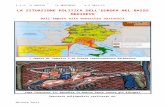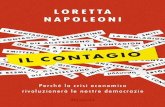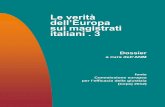La totale incomprensione europea del dossier turco è … · Web viewdea dell’Europa, di una...
Click here to load reader
-
Upload
dinhnguyet -
Category
Documents
-
view
212 -
download
0
Transcript of La totale incomprensione europea del dossier turco è … · Web viewdea dell’Europa, di una...

Per una convivenza nella città globaleReligione e religioni
Claudio Monge op - DoSt-I (Istanbul)
Sappiamo ancora ascoltare, fare nostro il grido dell’umanità? È una domanda che dobbiamo porci e che credo sia almeno urgente come quella che il Cristo stesso si pose, verso la fine della sua vicenda terrena: “…il Figlio dell’uomo, quando verrà, troverà la fede sulla terra?» (Lc 18,8). Il sospetto è quello di uno stato crescente di a patica insensibilità diffusa. Ci verrebbe da dire che la nostra società più che in crisi è in agonia: il che è molto più profondo e radicale perché significa letteralmente essere in “LOTTA”, lotta finale “per la vita o la morte”. Il tema cruciale oggi è quello di sapere se l’uomo occidentale voglia ancora vivere! Piuttosto che circondare il nostro mondo di barriere di ogni sorta, non sarebbe meglio che fosse ridonato all’uomo occidentale questo desiderio? A questo scopo, la questione essenziale non è più tanto quella di un modello da proporre all’uomo: perché tutti i bei modelli sono stati “rottamati”! Detto in termini più filosofici, non è in gioco la questione dell’essenza, bensì quella dell’esistenza. È l’alternativa posta alla fine del libro del Deuteronomio : «… io ti ho posto davanti la vita e la morte; scegli dunque la vita » (30, 19). Il versetto biblico continua: «…scegli dunque la vita, perché possa vivere tu e la tua discendenza». Noi siamo ancora e drammaticamente chiamati a scegliere la vita in termini di futuro che si apre e non solo di presente da godere. Oggi, più che mai, c’è una paura che nasce dall’egoismo e dall’assenza di visione, oltre che di speranza che nutre la visione1. L’avvenire si accoglie non possiamo combatterlo, difenderci da esso! Ma bisogna sapere dove si vuole andare, ci vuole un telos, un fine e ci vuole desiderio. Concordo con Moltmann quando dice che u n’etica della paura vede la crisi mentre un’etica della speranza riconosce le possibilità insite nella crisi, che è diventata oggi permanente e non semplice momento di rottura al cuore di un progresso ineluttabile (la cui nozione stessa, sulla quale si fondavano le Culture Occidentali, è in crisi) ! La cultura Occidentale si era costruita sul concetto di “non ancora” (promessa di una realizzazione futura), carico di promesse messianiche e il futuro non era nient’altro che la metafora di una promessa messianica. Oggi, l’idea stessa di futuro reca ormai il segno opposto: la promessa è diventata una minaccia e le tecno scienze, pur progredendo nella conoscenza del reale, non ci aiutano a risolvere i problemi che ci minacciano, insiti in un reale “privo di una finalità”. Si cerca, allora, una stabilità all’interno della crisi e di evitare l’infelicità in mancanza della felicità. Il grado di forza o di debolezza sembra essere diventato il solo criterio per pensare le nostre vite e concepire le nostre esistenze. L’incredibile violenza nella quale si immerge il nostro quotidiano lo attesta ed esprime il fatto che la forza è diventata una tale ossessione che le nostre società hanno prodotto una concezione della libertà fondata sul dominio: libero è colui che domina, ecco la riedizione dell’asserto dello scientismo positivista in una chiave nuova che si esprime come “attacco contro i legami”, epifenomeno dell’impotenza a spiegare, a dare un senso al reale! L’attacco contro i legami ha come sintomo più significativo quello della crisi del “principio di autorità”, fondativo della relazione tra generazioni: in famiglia, come a scuola, come nel quartiere. La modernità si manifesta quando al principio di autorità si sostituisce quello di libertà, nonostante la resistenza della Chiesa stessa che, fino all’altro ieri ha negato il principio di libertà di coscienza, percependolo come la culla dell’ateismo, come la negazione di Dio e della sua volontà2. La libertà di coscienza è spesso confusa con il libero arbitrio, l’anarchia e la distruzione di ogni autorità (quando, in realtà, il mondo moderno è anche riscoperta del valore cristiano della 1 Sottolineerei il fatto che, il cuore della CRISI DEL VECCHIO CONTINENTE assomma la totale mancanza di visione con la cieca auto-referenzialità di chi si illude ancora di essere al centro del mondo, investito della missione divina di esportare cultura e democrazia in ogni dove, quando da tempo ha finito di coltivarle e applicarle in casa propria... 2 Certo, non si può neppure dimenticare che, alla fine dell’800, libertà di coscienza significasse: diamo fuoco alle chiese, buttiamo giù tutti i crocifissi, trasformiamo le abazie in caserme…)

coscienza). Tornando ai riflessi educativi della crisi del principio di autorità, si constata che, in nome del rispetto della libertà individuale, gli educatori si sentono continuamente tenuti a giustificare le loro scelte nei confronti dei soggetti da educare. Paradossalmente, questa crisi dell’autorità apre la strada a varie forme di autoritarismo, nelle quali ritorniamo al principio di “dominazione” evocato pocanzi: colui che rappresenta l’autorità si impone all’altro grazie alla sua forza, che è l’unica garanzia e l’unico fondamento della relazione (queste annotazioni ci sembrano rilevanti, perché fanno emergere il cuore di un problema che non alberga solo negli universi culturali a riferimento islamico). Si prepara così il terreno all’idea di un post-moderno come banale riscatto nei confronti di una Modernità pensata solo come il contrario della Chiesa. Troppo poco! Se il post-moderno critica la modernità non è detto che ci faccia un favore perché, in effetti, con esso si dice anche che finisce il soggetto e questo, porta non tanto alla riscoperta di Dio quanto alla perdita di ogni senso! La sfida è quindi che la riscoperta del soggetto, rimesso in una rete di rapporti e legami e non solo considerato nella pura assolutezza del singolo! E una pista che ci porta a cogliere immediatamente la differenza tra il principio di autorità3 e l’autoritarismo. Il primo, infatti, si fonda sull’esistenza di un bene condiviso, di un medesimo obiettivo che accomuna i partner in relazione, spezzando la logica del “più forte”. E l’instaurazione di “legami concreti” per spingere le persone fuori dall’isolamento di ideali individualistici. E’ l’emergere di una nuova antropologia della quale vorremmo delineare alcuni aspetti, nella prospettiva particolare dell’incontro con l’Islam, che studio e frequento da decenni. Anche per milioni di mussulmani la sfida sta diventando quella di aprirsi ad una nuova esperienza di fede nel contesto della pluralità e nel riconoscimento e nella cura per quanto è autenticamente umano4. So bene che una tale affermazione solleverà più di una perplessità, ma non potrebbe essere altrimenti, per chi proviene e vive in Europa, e cioè, al cuore di un continente agonizzante e che, tuttavia è ancora convinto di poter passare al vaglio della propria civiltà tutte le culture esistenti5. Ma siamo così sicuri di saper ancora identificare un vero «umanesimo» oggi, che sappia cogliere adeguatamente le sfide provenienti dalla svolta del pluralismo6?
«Che cosa ti è successo, Europa umanistica, paladina dei diritti dell’uomo, della democrazia e della libertà? Che cosa ti è successo, Europa terra di poeti, filosofi, 3 Il mondo post-moderno è l’occasione per pensare la libertà acquisita dalla modernità, ponendola tuttavia in relazione con l’autorità. Questa è la grande nuova sfida che abbiamo di fronte: nel mondo post-moderno la libertà dei singoli è ancora più accentuata, ma proprio perché così accentuata essa entra in crisi e ha un nuovo bisogno di autorità, cosa che può essere certo interpretata come un rigurgito di pre-modernità, ma anche come nuovo equilibrio (sul lavoro, in casa, nel costruire case, nel pensare il territorio ecc.) con la verità delle cose.4 Vorremmo arrivare ad affermare che il primato (cristiano fondativo) della relazione, è l’unico mondo per contrastare sia il relativismo secolaristico che quello fondamentalistico. Il relativismo, come lo intendiamo noi, consiste nello staccare la relazione tra i fatti e i principi, o perché valgono solo i fatti o perché valgono solo i principi. I due relativismi sono figli dello stesso padre: l’idea gnostica secondo cui i principi e i fatti non hanno rapporti. Un Dio che è Padre del Figlio e che dona lo Spirito, questo è un Dio interessato al rapporto col mondo, che fa del rapporto col mondo la sua ragione, il suo logos e il suo pathos. Questo assetto, che noi chiamiamo Santissima Trinità, in fondo nega il secolarismo, l’assenza di senso, ma nega anche la pienezza di un senso che non abbia rapporto con la realtà. 5 Questa vera e propria crisi del pensiero è emblematicamente illustrata dalla profonda contraddizione che abita la stessa filosofia di Emmanuel Lévinas: un pensatore essenziale per immaginare la relazione all’altro inteso come individuo affidato alla nostra responsabilità (tutto questo quando l’antropologia studiava e descriveva soprattutto la collettività). Ebbene, Lévinas stesso sembra paradossalmente mancare l’appuntamento con la storia e la comprensione di coloro che si situano su un’altra riva rispetto a quella della propria tradizione. Il contestatore dell’imperialismo dell’io, in realtà, manifesta un etnocentrismo problematico ed inquietante, come quando in Umanesimo dell’altro uomo (Il Nuovo Melangolo, 2005) parla della civiltà occidentale come di quella che ha saputo comprendere le altre culture particolari che, da parte loro, non hanno mai compreso nulla da se stesse! 6 Certo, non mancano suggestivi percorsi storici, che potrebbero aiutarci a identificare alcune forme originali e maggiori di questo umanesimo (ad esempio quella rinascimentale con la lezione di Niccolò Cusano, all’interno del progetto dell’umanesimo di Marsilio Ficino e Pico della Mirandola, con l’ambizione di forgiare l’uomo nuovo che in Cristo riesce a riprendere e a fare sintesi della sapienza espressa dalle culture e dalle religioni in un clima di pace). Se ne potrebbero ricavare utili indicazioni sulla percezione che si ebbe della sfida proveniente dalla pluralità (anche conflittuale) di confessioni, religioni e culture. Ma il percorso è tremendamente lungo.

artisti, musicisti, letterati? Che cosa ti è successo, Europa madre di popoli e nazioni, madre di grandi uomini e donne che hanno saputo difendere e dare la vita per la dignità dei loro fratelli?». Sono le domande rivolte al Vecchio Continente dall’uomo venuto “dalla fine del mondo” (o, più semplicemente, da un altro mondo rispetto all’Europa auto-referenziale, che ha per altro dato i natali alla sua famiglia), in occasione del Discorso per il Conferimento del Premio Carlo Magno7, nel maggio di quest’anno. Papa Francesco, nel suo discorso di investitura, parlò della necessità di una “trasfusione della memoria” (termine mutuato dallo scrittore Elie Wiesel, che con esso faceva riferimento ad un ascolto del passato che ci libera da quella tendenza attuale, spesso più attraente, di fabbricare in fretta sulle sabbie mobili dei risultati immediati) per rianimare un’Europa, che lungi dal proteggere spazi si renda madre generatrice di processi e finalmente capace di dare alla luce un “nuovo umanesimo” basato su tre capacità: la capacità di integrare, la capacità di dialogare e la capacità di generare.
A mo’ di premessa preciserei che la sfida multi-culturale e multi-religiosa non si gioca mai semplicemente tra due termini, ma sempre tra tre: le culture o religioni in dialogo e quello spazio «tra» che non necessariamente è uno spazio comune disponibile, ma piuttosto ha la figura di un «oltre» che può essere diversamente connotato: come spazio pubblico argomentativo basato su una razionalità neutra condivisa (Jurgen Habermas); come umano fondamentale a cui si appartiene nonostante le differenze etnico-culturali (Paul Ricoeur); come misteriosa e sorprendente ulteriorità derivante dal «pungolo dello straniero» (Bernhard Waldenfels); come mistero oltre il dicibile, che rimanda a un’«armonia cosmoteandrica» mistica (Raimon Panikkar); o semplicemente come «soglia» (limes), intesa come zona di incontro, passaggio o connessione (G. Mazza; B. Waldenfels). Di fatto, la sfida principale in questo incontro di culture e religioni si gioca nell’identificazione di questo spazio «tra» e nel senso che gli viene dato. Sia a livello filosofico che teologico8. In modo molto sintetico direi che l’umanesimo cristiano è interpellato a mantenere salde alcune dimensioni costitutive dell’esperienza umana, resistendo all’alternativa semplificatrice tra due reazioni troppo riduttive di fronte alla sfida del multiculturalismo e del pluralismo religioso: del fondamentalismo/integralismo/tradizionalismo (assolutizzazione della risposta all’appello della verità o alla rivelazione di Dio) da un lato o del relativismo (la relativizzazione di ogni risposta unita alla negazione dell’esistenza di una verità comune che valga per tutti) dall’altro. 1) La prima dimensione costitutiva dell’esperienza umana da salvare è la consapevolezza che le culture e le religioni non vivono le une accanto alle altre, come giustapposte ed estranee, ma piuttosto in uno scambio frutto del loro radicamento storico (dobbiamo parlare di interculturalità più che di inculturazione). In sostanza, le culture non vivono solo la loro propria esperienza di Dio, del mondo e dell’uomo, ma lungo il loro cammino si devono confrontare con le altrui differenti esperienze, confronto che può portare a nuove forme feconde di sintesi.2) L’incontro delle culture/religioni è possibile perché l’uomo, nonostante tutte le differenze della sua storia e delle sue creazioni comunitarie, è un identico e unico essere la cui dinamica trascende tutti i limiti, impedendo l’ipostatizzazione dei modelli culturali.
Dunque, nella comune verità dell’uomo, si gioca la verità su Dio e sulla realtà nel suo complesso. Quanto più una cultura è conforme alla natura umana, quanto più è elevata, tanto più aspirerà alla verità che fino a un certo punto le era rimasta preclusa, sarà capace di assimilare tale verità e d’immedesimarsi con essa, anche a costo di superarsi come cultura. La logica del discorso è dunque quella di un “eccesso”, di un andare oltre rispetto al “proprio”, in un dinamismo di auto-critica dove si resista alla 7 Il Karlpreis della città di Acquisgrana, premio annuale conferito a personalità con meriti particolari in favore dell’integrazione e unione in Europa. 8 Cfr. A. Cozzi, L’UMANO AL PLURALE: la sfida della multiculturalità e del pluralismo religioso all’umanesimo cristiano, XXXVIII Convegno di Studi Religiosi - Lo Spazio dell’Altro - Villa Cagnola 4-6 ottobre 2016,

tentazione di «essere semplicemente presso di sé», pienamente identici a se stessi e solo successivamente in relazione ad altri. « Le culture dunque si incontrano proprio nella loro “dinamica esodica”, ossia nella loro tensione a uscire dal particolare verso la verità universale, in cui l’uomo stesso riconosce e realizza la sua apertura al tutto e al trascendente ».
Come ci ricorda Pierangelo Sequeri: « Un bambino malese, o italiano, non impara dalla sua mamma anzitutto il malese o l’italiano. Impara a parlare, entra nel linguaggio umano. Non impara prima di tutto gli usi e i costumi del suo paese, impara l’ethos e il pathos dell’umano abitare la terra. Imparerà più tardi che il suo modo di parlare il linguaggio è malese o italiano: la parola e il linguaggio, comuni all’umano, gli resteranno per sempre. L’appartenenza all’umano è inespugnabile. Analogamente, il bambino apprende l’ethos e il pathos del dimorare nello spazio e nel tempo dell’umano assimilato e condiviso. Non soffre anzitutto in cinese o in arabo, impara essenzialmente il patire umano. E impara il padre e la madre, il familiare e l’estraneo, la routine e la festa, la solitudine e la comunità, la cura e l’indifferenza, l’umiliazione e la vendetta, l’offesa e il perdono, l’amore e l’odio, il proprio e l’altrui, il bello e il brutto, il giusto e l’ingiusto, l’accessibile e l’interdetto, il grande e l’infimo, il sacro e l’indecifrabile. Impara l’umano una volta, e ogni volta, e per sempre »9.
A partire da queste premesse i riflessi sul dialogo e pluralismo religioso sono evidenti: si deve uscire da una postura competitiva, dove si è preoccupati a delimitare confini, a stabilire ciò che è vero e ciò che è falso, per cercare, piuttosto, convergenze al servizio dell’umano. In questa prospettiva la teologia stessa, “il discorso su Dio”, diventa discorso sulla realtà. Detto altrimenti, dobbiamo capire che la questione su Dio non è primariamente la questione su un Ente, ma la questione sulla realtà! Il primo compito è quello di ridisegnare gli spazi dell’interazione. La grande domanda è: allargare gli spazi, fare posto all’altro, dilatare i confini; oppure, viceversa, difendere i propri confini, erigere muri o barriere, delimitare lo spazio proprio? L’immaginazione dominante la cultura moderna europea è quella di un io o di un popolo che sta al centro di una «sfera del proprio», rispetto alla quale l’alterità o l’estraneo appaiono come una determinazione secondaria, alla periferia o ai confini10. In verità nella scoperta dell’altro, del diverso e perfino dell’estraneo, si risveglia la percezione che «nessuno è padrone in casa propria», poiché l’alterità viene con noi dall’inizio, viene con noi «a casa»11. L’estraneo non è un derivato del proprio ma è qualcosa di co-originario. All’origine, dunque, c’è l’intreccio, un reticolo in cui il proprio e l’estraneo sono co-implicati, con punti nodali e collegamenti trasversali. Ma, allora, esiste ancora un centro? Se si, come funziona? Al centro c’è un rapporto drammatico, teso, pieno di incontri e scontri, che rivela estraneità, ma anche prossimità. Abbiamo una splendida illustrazione di questa dinamica nelle “parabole della vigilanza” di Gesù, laddove si parla del Dio che viene dai suoi (nel suo Regno) come un ladro di notte, che viene all’improvviso, o ancora come il padrone di casa che torna da un viaggio o da una festa «quando meno telo aspetti» e chiede conto della conduzione della casa (Mt 24,37-51). I cristiani non rivendicano uno spazio «proprio» (vedi Lettera a Diogneto) e, comunque, il loro spazio è già abitato da un’alterità, che può avere la figura dell’estraneo che pungola e interpella, mettendo in discussione ciò che si dava per acquisito e pacifico. Questo ripensamento dello «spazio proprio» implica una ridefinizione dei confini come «soglie», ossia zone di transizione. Chi attraversa la soglia non giunge semplicemente in altro luogo, ma diviene un altro. Tale esposizione non ha la forma di un agire comunicativo che argomenta in base a una razionalità universale a priori, dalla quale ricavare un terreno comune (valori, regole, ideali), ma funziona come un rendersi responsabili di fronte all’appello dell’estraneo. Ancora Papa Francesco, proprio qui, a Firenze, circa un anno fa, in 9 F. RIVA – P. SEQUERI, Segni della destinazione. L’ethos occidentale e il sacramento, Assisi 2009, 5.10 La reazione scomposta di alcuni pseudo intellettuali, strenui difensori “dell’identità cristiana dell’Europa” al conferimento del premio Carlo Magno a papa Francesco, un argentino, è paradigmatica, per capire le radice dell’attuale crisi europea.11 B. WALDENFELS, Fenomenologia dell’estraneità, Napoli 2002; idem, Fenomenologia dell’estraneo, Milano 2008.

occasione del suo discorso in occasione del V Convegno della Chiesa Italiana, ribadisce questo principio essenziale, luogo di concretizzazione di un “nuovo umanesimo in Gesù Cristo”, che è quello dell’incontro che porta a fare qualcosa insieme. Perché, dice tra l’altro Francesco «… non esiste umanesimo autentico che non contempli l’amore come vincolo tra gli esseri umani, sia esso di natura interpersonale, intima, sociale, politica o intellettuale…. costruire insieme, …fare progetti: non da soli, tra cattolici, ma insieme a tutti coloro che hanno buona volontà ». Questo comporta il vincere la paura di compiere l’esodo necessario ad ogni autentico dialogo, senza il quale non è possibile comprendere le ragioni dell’altro, né capire fino in fondo che il fratello conta più delle posizioni che giudichiamo lontane dalle nostre pur autentiche certezze. Nell’immagine molto concreta dell’esodo si esprime la necessità, già filosofica, di una certa distanza critica da sé ma, ancora di più, per quanto ci riguarda, di una decostruzione dell’idea d’Europa, evocata mirabilmente da Jacques Derrida nel suo libro sull’Europa intitolato L’altro capo (L’autre cap): « Dobbiamo fare i guardiani di un’idea dell’Europa, di una differenza dell’Europa, ma di un’Europa che consiste per l’appunto nel non rinchiudersi sulla propria identità e nel farsi avanti esemplarmente verso ciò che essa non è, verso l’altro capo o il capo dell’altro»12. Sono qui in gioco le questioni della memoria e dell’identità13 e, lavorando sulla prima Derrida scrive ancora: « La mia famiglia veniva da quella Spagna che ha visto il pensiero greco, il pensiero arabo e il pensiero ebraico fondersi intimamente. E credo che una delle responsabilità intellettuali maggiori che toccano a noi, oggi, sia quella di ritrovare queste sorgenti e questi momenti in cui queste correnti, lungi dall’opporsi, si sono reciprocamente fecondate »14.
Queste parole di Jacques Derrida ci rimandano al tema della ridefinizione dello spazio, nei suoi riflessi sul cammino della teologia delle religioni. Si tratta di ripensare il rapporto tra i paradigmi di pensiero teologico ovvero alla discussione tra esclusvismo, inclusivismo e pluralismo. Ciò che è in gioco nei tre modelli è proprio l’organizzazione dello spazio in cui si collocano le altre religioni e quindi l’universo di pensiero in campo, col suo centro e i suoi confini. Ci pare che la strategia inclusivista si presenti come orizzonte ospitale, generato proprio dallo stile ospitale di Gesù. Tale ospitalità non ha la forma dell’omologazione. Lo stile ospitale di Gesù lascia risuonare nella storia il dono di Dio creatore e indica il principio di concordanza tra la forma e il contenuto e, dunque, non riguarda un contenuto dottrinale dato in sé e per sé, una volta per tutte. Il contenuto, piuttosto, rimanda al donare di Dio che consegna l’uomo a sé, nella sua autonomia donatrice di senso, che chiama «chiunque», nell’interiorità, di fronte al Creatore! In altre parole, l’uomo riconsegnato a se stesso, da senso alla vita, nella sua unicità irripetibile, e in tutta libertà si irraggia in relazioni buone coi fratelli (è questo lo stile). Insomma, l’ospitalità di Gesù permette di abitare il mondo in modo nuovo: nel segno della gratuità. Partendo da queste premesse, l’obiettivo diventa, dunque, quello di pensare teologicamente l’accoglienza a partire dall’esperienza dell’incontro, nello sforzo comune di costruzione di una cittadinanza inclusiva. Si tratta di un obiettivo, a mio modo di vedere, raggiungibile solo se si arriva a prendere sul serio l’esistenza dell’altro nella sua irriducibile differenza15. Detto più teologicamente, bisogna arrivare a intravvedere il posto dell’altro nel disegno di Dio, senza venir meno ad una fedeltà radicale alla propria tradizione! Pensare la differenza significa imparare a camminare con essa, perché solo così di accede all’atrio dell’ospitalità divina che, a differenza dell’ospitalità umana, non
12 Derrida, L’autre cap, p.25 Oggi l’Europa. L’altro capo Id., L'autre cap, Minuit, Paris 1991; tr. it. di M. Ferraris, Oggi l'Europa. L'altro capo. Memorie, risposte e responsabilità, Garzanti, Milano 1994.13 A proposito di identità Derrida scrive in Oggi l’Europa: « Ciò che è proprio di una cultura è il non essere identica a se stessa. Non di non avere identità, ma di non potersi identificare, dire “io” o “noi”, di non poter assumere la forma di un soggetto che nella non-identità a sé, o, se preferite, nella differenza da sé ». Detto in modo più immediato: “io sono” nella misura in cui non mi barrico in una visione fissista dell’identità ma mi confronto con il diverso da me!14 Cercare referenze.15 Intendo, con irriducibilità, l’oggettività di una differenza che deve essere prima di tutto accolta come tale, nella sua consistenza propria e non semplicemente in riferimento a ciò che ha o non ha rispetto a noi

si accontenta di accogliere l’altro nel suo proprio spazio ma si invita nello spazio dell’altro per essere accolto (Ap 3,20)! E quando quest’altro appartiene all’universo islamico? Dicevo nella prima parte di questo intervento che anche per milioni di mussulmani la sfida sta diventando quella di aprirsi ad una nuova esperienza di fede nel contesto della pluralità (aggiungerei, prima di tutto “intra-islamica”) e nel riconoscimento e nella cura per quanto è autenticamente umano. Ora, al cuore della fede islamica, la sovranità assoluta di Dio è il fondamento di ogni attitudine umana nei confronti del proprio simile. Ecco che ogni atto di carità, ogni dono, ogni attenzione verso il bisognoso sono originati da un’esigenza etica della fede più che dal carattere sacro dell’atto in sé. Gli esseri umani, dotati da Dio di capacità e di risorse diverse, sono tenuti, secondo il Corano, ad alimentare la solidarietà sociale nella giustizia e nella generosità. Nello stesso tempo, la presenza del povero, del debole e del bisognoso, interpella tutti perché si tratta di una ferita inferta all’opera della creazione di Dio, che bisogna velocemente curare per tornare a una perfezione originaria. Questo sforzo diventa anche occasione per acquisire meriti spirituali, perché nella concezione antropologica islamica l’uomo è prima di tutto il credente (senza che questa nozione sia limitata solo al mussulmano16). Paradossalmente, potremmo dire che questa antropologia islamica è una forma di umanismo, a causa della portata universale del messaggio coranico e della conseguente pretesa universale alla salvezza di tutta l’umanità, propria del credo islamico. Di fatto, l’Islam afferma l’unità e l’uguaglianza ontologica di tutti gli uomini, al di là della loro origine o del loro credo. Il problema è sapere se l’uomo, tale che Dio l’ha voluto creandolo, può conservare questa disposizione primordiale propria del credente e rivelata nel Corano. La risposta a questa domanda divide l’islam contemporaneo attraversato da un paradigma egemonico che mette in discussione le persone e interi gruppi al suo stesso interno (fenomeno ben conosciuto anche al cuore del cristianesimo). Questo dibattito non è solo intellettuale e religioso ma tocca al cuore l’identità delle persone e, per la prima volta, anche i credenti mussulmani sono chiamati a prendere posizione personalmente (aspetto che è un elemento caratterizzante la modernità, con l’emergenza dell’individuo), obbligati nello stesso tempo a riposizionarsi nel loro rapporto con l’alterità. Il sorgere dell’altro (sia esso accusatore o vittima) rappresenta l’atto di nascita della propria responsabilità, una responsabilità non scelta ma alla quale non ci si può sottrarre, direbbe Levinas, pena l’annullamento della propria umanità creaturale.
« Not in my name » il famoso e sorprendente hashtag partito dal Regno Unito e diventato fenomeno mondiale al momento dell’esplosione della violenza mediatizzata del cosiddetto Stato islamico, da un rilievo iconico all’appartenenza mussulmana: fenomeno rivoluzionario al cuore di una religione storicamente aniconica. La semplice successione di visi di uomini e donne di età e appartenenze etniche diverse, ma accomunate dalla fede islamica, è come una finestra simbolica su una soggettività investita di una responsabilità nei confronti dell’altro, responsabilità non derogabile, pena il rinnegamento della propria soggettività. E anche l’islam, imbocca la sua via antropologica. Sorgono dei credenti mussulmani che ripartono dalla domanda fondamentale « che cos’è l’uomo davanti a Dio?» Come credenti, rifiutano di essere
16 Tradizionalmente, questa definizione è sempre stata accordata ai credenti delle Religioni del Libro (certamente ai cristiani e agli ebrei, probabilmente anche agli zoroastriani e ai Sabei). In più, questa nozione di “credenti” non riguarda solo i mussulmani coscienti di esserlo ma in fondo tutte le creature di Dio, chiamate all’islam, ad un atto di abbandono alla Legge del Creatore. Il concetto è fondamentale perché l’uomo, secondo la concezione islamica, non ha diritti in quanto uomo ma in quanto creatura di Dio. Ora, la lingua araba non ha una radice corrispondente al latino “natura” né al greco “phusis”. Il termine fitra, è la natura frutto dell’intervento creatore di Dio (Roger Arnaldez nel suo, L’homme selon le Coran, coll. Pluriel, Hachette 2002, p.10-11, ricorda che questo termine deriva da una radice che significa “fendere, innovare, inventare”, da cui creare una cosa nella sua novità. Al punto che Dio è anche chiamato al-Fâtir). Dunque tutto ciò che esiste è sottomesso a Dio e non c’è nulla di naturale per l’islam (che abbia leggi proprie ed indipendenti risopetto alla volontà divina): non c’è legge naturale, non c’è diritto naturale (ecco perché la Dichiarazione Universale dei Diritti dell’uomo del 1948 è stata in qualche modo sconfessata dal mondo islamico, che tuttavia, nelle sue sucessive edizioni di Dichiarazione Universale dei Diritti dell’uomo nell’Islam, ha di fatto, accolto una buona parte dei principi introdotti nella carta del ’48), e non c’è neppure una ragione naturale.

ridotti alla dimensione religiosa delle loro convinzioni e respingono, in nome di questo approccio, la possibilità di affermare la possibilità di supposti diritti di Dio anche a scapito dei diritti dell’uomo. Smentendo il postulato, tipicamente moderno, secondo il quale ci sarebbe una contraddizione fatale tra la supposta esistenza di Dio e l’affermazione « dell’umano autentico », essi affermano, pur in assenza di una fede nell’Incarnazione, che la relazione all’Assoluto è all’origine di un surplus di umanità, per se stessi e in termini di apertura all’altro, agli altri17. Il grido « Not in my name » non è negazione di responsabilità ma atto di dissociazione rispetto a persone che, incappucciate (senza viso), negano l’esistenza dell’altro in nome della loro lettura abusiva dei testi sacri. In sostanza, per promuovere l’umano e per accoglierlo, bisogna arrivare a mettere delle parole al cuore del disumano, curando una crisi antropologica che è deturpamento dell’opera creaturale divina. Ecco perché, come abbiamo cercato di ricordare durante tutto questo intervento, l’affermazione della necessità di cercare convergenze al servizio dell’umano per mettersi a servizio “dell’umanizzazione dell’uomo”, è una altro modo di dire che c’è più bisogno di una nuova antropologia per Dio che di nuove teologie per l’uomo!
17 Credo che in questa intuizione vi sia una via islamica verso l’universale concreto antropologico e cioè di una narrazione della modernità che renda possibile la comunicazione tra uomini portatori di mondo-visioni differenti. Bisogna smetterla di concentrarsi ossessivamente sul « Dio in sé », senza mettere in evidenza l’importanza della Sua pertinenza per le sue creature! Il fatto di aver adorato per tanto tempo un Dio senza gli uomini e senza mondo, ci ha portati a vivere in un mondo senza Dio!