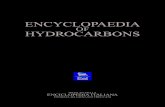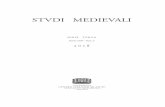La Scuola Culta Cap 18 padoa Schioppa
-
Upload
erika-naro -
Category
Documents
-
view
3 -
download
2
Transcript of La Scuola Culta Cap 18 padoa Schioppa

La Scuola Culta. Cap 18
1. Umanesimo Giuridico.Un primo indirizzo innovatore dell’età moderna è certamente la Scuola Culta. Essa derivò direttamente da un filone dell’umanesimo. Negli umanisti prevaleva l’ammirazione per la cultura antica e la preoccupazione di riscoprirne i profili liberandosi dalla massa di interpretazioni e dottrine delle scuole medioevali. A Firenze Angelo Poliziano si preoccupava di riunire testi antichi con quelli delle versioni correnti rilevandone puntualmente le differenze per predisporne un’edizione critica dei testi giustinianei, cosa fatta anche da altri autori con lo stesso spirito e gli strumenti apprestati dalla cultura umanistica.
2. Il metodo dei Culti e Alciato. Nel giro di poco tempo videro la luce innumerevoli opere, anche innovatrici, di autori di diversi paesi. Budè pubblicava nei primi anni del 500 le sue Adnotaciones ad Pandectas che applicavano ad una quantità di passi del Digesto gli strumenti filologici dell’umanesimo per riprodurne il significato originario stabilendone la versione corretta. Negli stessi anni lo stesso Alciato faceva uscire le Adnotaciones agli ultimi 3 libri del codice, al cui studio applicava molte nozioni storiche fondate sulla sua profonda conoscenza di fonti greche e latine. Allo stesso tempo, divenuto professore ad Avignone diede vita ad una scuola fiorente. Alciato può considerarsi il vero fondatore della Scuola in quanto riuniva in sé le doti di profondo conoscitore delle fonti classiche, di cultore del metodo filologico e di giurista completo, capace non solo di interpretare i passi più complessi della Compilazione, ma anche di redigere corposi apprezzamenti legali. La caratteristica delle opere di queste epoche stava nel duplice criterio di ricercare anzitutto la formulazione originaria dei testi studiati (metodo filologico) per analizzarne il significato alla luce delle fonti greche e latine (metodo storico). A questo scopo si utilizzavano non solo i testi giuridici, ma anche le fonti storiche, retoriche e letterarie nonché poetiche dell’età antica. In tal modo un passo non soltanto poteva venire depurato, ma poteva anche venire interpretato e compreso nel suo contesto originario, correggendo fraintendimenti e incomprensioni spesso secolari. Era infatti frequente che termini e istituzioni ricorrenti nel Corpus Iuris non trovassero una spiegazione né tantomeno una definizione all’interno della compilazione. Il silenzio del testo giustinianeo si spiega in quanto molte espressioni e istituzioni erano talmente evidenti al loro tempo da non richiedere chiarimenti, mentre altre istituzioni si erano trasformate o addirittura erano già scomparse alla fine dell’impero antico e sopravvivevano nella compilazione come meri relitti storici, non più compresi dagli stessi giuristi tardo-antichi.Una folla di testi che riceveva così per la prima volta, per opera dei Culti, un’interpretazione filologicamente e storicamente fondata. Fu anzitutto la passione per lo studio diretto delle fonti della cultura antica a indurre alcuni uomini ad applicare anche alle fonti del diritto i frutti della loro conoscenza di fonti non giuridiche. Il gusto per il contatto senza intermediari con la fonte antica portò con sé l’insofferenza per il greve apparato di interpretazioni accumulatosi nei secoli.

I Culti fecero ricorso alle fonti antiche con l’intento di incidere direttamente sull’interpretazione e dunque sull’applicazione delle fonti del diritto. A ciò si accompagnava negli umanisti il gusto estetico per l’eleganza formale del latino classico, tanto lontano dal latino della scolastica medievale. L’atteggiamento mentale e culturale degli umanisti se da un lato influenzò un filone della cultura religiosa cattolica, dall’altro lato fu particolarmente valorizzato dalla cultura religiosa delle correnti protestanti in sintonia con il criterio del libero esame della Scrittura. Non è perciò un caso che i diversi esponenti di questo indirizzo di studi siano stati attratti dalle correnti della riforma protestante. Nel periodo delle lotte di religione alcuni di loro furono costretti ad emigrare dal loro paese d’origine perché protestanti. Sarebbe tuttavia fuorviante considerare i Culti ribelli per natura o avversi alle istituzioni e ai poteri costituiti. Al contrario furono vicini alla scuola umanistica, uomini destinati a ricoprire alte funzioni pubbliche, mentre altri esponenti espressero opinioni in sintonia con posizioni politiche e giuridiche della monarchia. Budè e molti altri esercitarono alte funzioni nelle magistrature dei loro paesi. L’impostazione umanistica è ben chiara anche negli autori che esaltano la nuova eloquenza sui fatti e su solide ragioni sobriamente esposte più che sulla retorica e sulle metafore.
3. L’indirizzo storico filologico.L’impianto culturale adottato dai maestri della nuova scuola era suscettibile di andare in direzioni diverse se non anche opposte. Cosi nel 500 ad un filone di ricerca prettamente filologico si affiancava un altro prettamente storico o anche metodologico e dunque volto alla ricerca della teoria e sistematicità del diritto comune e un indirizzo critico nei confronti del sistema giuridico coevo. 1. Il primo indirizzo (filologico) si manifesta con la ricerca di nuovi testi giuridici antichi, ricerca tra l’altro deludente. Tuttavia alcuni testi postclassici furono riscoperti ed editi da Pierre Pithou ed altri studiosi umanistici. Fu proprio detto indirizzo che nel 500 ottenne uno sviluppo memorabile. Si curarono le prime edizioni critiche del Corpus Iuris fondate sull’esame di più manoscritti e pubblicate senza il corredo della Glossa Accursiana per meglio concentrare lo studio sul puro testo antico. Importante fu l’opera di Cujas, fu autore di indagini estese e penetranti sull’opera di giuristi classici ricostruite con perizia collocando cioè i frammenti del Digesto nell’ordine originario delle opere da cui erano stati tratti da parte dei compilatori giustinianei per meglio ricostruirne il dettato e comprenderne il significato originario. Egli sottopose all’analisi filologico-storica anche i testi tardo-antichi come il codice Teodosiano e perfino i libri feudorum medievali dei quali propose addirittura una diversa sistemazione. È infatti significativo il fatto che l’attività dei culti non si sia limitata all’analisi dei testi antiche ma che si sia appunto spinta in avanti fino a ricomprendere altre fonti e fasi storiche.
4. L’indirizzo Critico.Strettamente connesso con l’indirizzo filologico fu nei culti un atteggiamento nuovo, ciò perché nonostante i testi della compilazione fossero da loro considerati come dei veri e propri pilastri della cultura antica è anche vero che non si limitavano ad una mera accettazione della validità della normativa romana. Anche la prassi di citare autori classici non era frutto di una sottomissione a quanto dagli stessi sostenuto, quanto piuttosto era frutto di scelte appositamente compiute da parte dei culti stessi. Proprio per questo alcuni dei maggiori esponenti dichiaravano inaccettabile l’adozione dei testi giustinianei senza discussioni a riguardo. Lo stesso Duaren riteneva giusto che le stesse norme della compilazione, ormai inadeguate, venissero dichiarate tali. Alcuni auspicavano addirittura un intervento del re di Francia diretto a sostituire le leggi romane. Nello stesso momento in cui si andava a scomporre la compilazione distinguendo la disciplina del diritto classico da quella del diritto postclassico, l’unità del sistema del Corpus iuris veniva messa in discussione, se non addirittura potenzialmente infranta. Se il diritto classico era preferibile al diritto giustinianeo, se si

condannavano le manipolazioni di Triboniano, quali poteva essere la normativa applicabile nella vita concreta del diritto? Diveniva difficile stabilire i modi della sua vigenza e della sua applicazione pratica.
5. L’indirizzo sistematico.