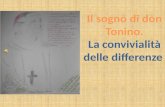La Poesia delle Differenze
Transcript of La Poesia delle Differenze
-
7/24/2019 La Poesia delle Differenze
1/9
LA POESIA DELLE DIFFERENZE
Dove siete diretti?Sempre verso casa
(Novalis)
La rivoluzione filosofica darwinianaLopera di Darwin fu rivoluzionaria non solo dal punto di vista scientifico, ma anche perle molteplici e complesse implicazioni filosofiche. In primo luogo, nellatto di fondareper la prima volta scientificamente la teoria del trasformismo biologico, Darwin inserivanel cuore del mondo naturale una dimensione temporale e storica, un'ineditadinamicit.In secondo luogo, la teoria dellevoluzione segn! una vera e propria fratturaepistemologica", aprendo nuove prospettive al di l del determinismo meccanicisticoradicale di stampo laplaciano#. Darwin sottolinea, infatti, il ruolo decisivo del caso edella probabilit e, pi$ precisamente, li integra in una visione scientifica, in %uanto lavariazione & guidata dal caso, mentre la selezione & regolata dalla necessit razionale nerisulta una teoria della natura che concilia in modo originale meccanicismo e vitalismo,superandoli entrambi. Il ruolo attribuito alla contingenza e l'utilizzo sistematico di unpluralismo esplicativo fanno di Darwin un pensatore pi$ rivoluzionario di %uanto sipensi anche da un punto di vista epistemologico(.In terzo luogo, contrariamente a %uello che spesso viene affermato, Darwin non elabor!l'idea di un'evoluzione piramidale, ma ramificata). *nzi, Darwin defin+ pi$ volte laselezione naturale come cieca o inconscia perch- non conosce il suo obiettivo, in%uanto mutevole, se non come puro obiettivo %uantitativo fitness/0 alimentare sestessa1. Infine, la teoria darwiniana compie una vera e propria scoperta della vita2,
pensandola come forza vis/ originaria che unifica e genera i viventi abitandoli,costituendone l'intima struttura comune, senza essere ad essi riducibile. 3uesta forza, il
1Il concetto di rottura epistemologica stato elaborato dalla tradizione epistemologica francese e, in primis, daGaston Bachelard.
2Laplace espresse, nel suoEssai philosophique sur les probabilits(1814), nel modo picompiuto e piradicalelessenza del determinismo meccanicistico della fisica newtoniana.
3T. Pievani, Anatomia di una rivoluzione. La logica della scoperta scientifica di Darwin, 2013.
4S.J. Gould ha ulteriormente sviluppato e accentuato lidea darwiniana con limmagine del cespuglio (La vitameravigliosa, 1990 (1989), p.30).
5 Il concetto di evoluzione si radica nellidea di progresso tipica dell'Ottocento, ma Darwin preferisce usare itermini discendenza o trasformazione, in modo da evitare il riferimento allo svolgersi di un progetto finalistico.
Per illustrare questo aspetto del pensiero darwiniano, Tarizzo ha utilizzato la categoria kantiana di finalit senza
scopo (D. Tarizzo, La vita, uninvenzione recente, 2010). In effetti, pi che di caso, dovremmo parlare di
evoluzione non-direzionale e non-intenzionale; ha notato, per esempio, Boncinelli: la formulazione ingenua
dell'evoluzionismo neodarwiniano, secondo la quale la selezione naturale favorirebbe gli individui piadatti, sembra
decisamente inappropriata [...infatti] si tratta di un'affermazione d'effetto, ma circolare [ci che pi adatto
sopravvive, ciche sopravvive piadatto] (E. Boncinelli, Prima lezione di biologia, 2010 (2001), p. 169).
6Lintuizione originaria di questo aspetto decisivo della rivoluzione darwiniana va attribuita a Michel Foucault (Leparole e le cose. Unarcheologia delle scienze umane (1966),1985, pp.143 4, 178 9 ).
1
-
7/24/2019 La Poesia delle Differenze
2/9
cui meccanismo fondamentale & la selezione, & analoga alla gdi Newton e fa di Darwin ilfondatore della biologia moderna. La natura non viene pi$ concepita in modorigorosamente meccanicistico e deterministico, ma come una forza perfettibile 4nel suoe%uilibrio perennemente precario e dinamico, in %uanto forza vivente.
La rivoluzione antropologica darwiniana3uando estese la teoria evolutiva all'animale umano, Darwin lo priv! della sua pretesaeccezionalit e unicit, affermando con forza la continuit del vivente 5. La differenzauomo6animale risultava di conseguenza solo %uantitativa, cio& di grado e non diessenza7. Inoltre, la concezione ramificata e non finalistica dellevoluzione facevaperdere all'uomo anche la sua pretesa superiorit evolutiva"8. 9i compiva cos+ ladetronizzazione o decentramento dell'uomo"". L'acceso dibattito che ha per esempiocontrapposto :. Daw;ins e 9.
-
7/24/2019 La Poesia delle Differenze
3/9
Differenza e incoensura!ilit"La riduzione a una differenza %uantitativa riconduce luomo nella dimensione naturale,ma al tempo stesso lo colloca allapice di %uesta dimensione per la sua preminenza, sepure solo %uantitativa. In %uesto modo si rischia di restare all'interno di una definizionedell'uomo come sovrannaturale0 prima in %uanto essere fuori dalla natura, ovvero
non riducibile alla sola dimensione naturale e corporea, poi in %uanto vertice del mondonaturale. In altri termini, la differenza esclusivamente %uantitativa potrebbe risultareriduttiva").In effetti, ogni volta che studiamo gli altri animali presumiamo che siano come noi, econcludiamo %uindi che sono meno di noi. ? molto facile, per!, ipotizzare una speciee@traterrestre che, studiando l'uomo, giunga alle stesse conclusioni. 9i tratta di unmeccanismo di proiezione e di un ragionamento per analogia che sono inevitabili %uantodiscutibili. 9e l'attenzione posta da Darwin sull'aspetto %uantitativo permette disottolineare la continuit del vivente, l'attenzione alla %ualit specifica di ogni specievivente, e non solo dell'uomo, permette di valorizzare la variet e la pluralit del vivente,caratteristiche senza le %uali la selezione non avrebbe luogo in cui accadere.Aossiamo cogliere ancor meglio la %uestione se comprendiamo che la mente non & mai'disincarnata', ovvero che pensiamo sempre a partire dal nostro essere fisicamente nelmondo in un determinato modo"1. Il nostro mondo e %uello di un pipistrello sonoinconfrontabili da un punto di vista %ualitativo, non meramente %uantitativo a rigoredovremmo anzi dire che per noi il mondo del pipistrello & impensabile "2. AarafrasandoB.9. Cuhn"4, i mondi dei diversi esseri viventi sono incommensurabili perch- ogni esserevivente traccia il suo mondo a partire dal suo specifico paradigma cognitivo, il %uale si &sviluppato a partire da una specificit morfologica, da uno specifico e concreto radicarsinell'ambiente e rispondere ad esso.
Il ito dell#origineLa teoria darwiniana sottolinea con forza la continuit del vivente, eppure la storia
dell'uomo, in particolare dell'uomo occidentale, & una lunga storia di tratti diseparazione tra l'uomo e gli altri viventi. Bentiamo allora una breve genealogia dellospecifico e concreto modo di stare nel mondo dell'animale6uomo e chiediamoci se abbia%ualcosa a che fare con %uesto continuo tracciare differenze.Il mito dellorigine narrato da Alatone"5attribuisce allessere umano una incompletezza
14 Il cervello dell'uomo si distingue certamente per alcune peculiari caratteristiche quantitative: la differenza divolume cerebrale relativo, il rapporto tra massa cerebrale e peso corporeo, l'estensione della corteccia cerebrale, la
complessitneuronale; daltro canto Telmo Pievani, in unintervista del 2006, ha notato: E impressionante che non
solo i nostri cugini Neanderthal ma anche i primi Cro-Magnon avessero una capacit cranica leggermente superiore
alla nostra: quindi, per noi, evoluzione potrebbe significare qualitinvece di quantit. Il passaggio da homo abilisa
homo sapiensfu, in effetti, un passaggio non solo quantitativo, ma anche qualitativo, consistendo in uno sviluppoincredibile della corteccia prefrontale.
15Il riferimento a F. Varela, E, Thompson, E. Rosch, The embodied mind,1991.
16Il riferimento al celebre articolo di T. Nagel ( Cosa si prova ad essere un pipistrello?, 1974) in cui il filosofostatunitense sosteneva lirriducibilitdella coscienza allattivitcerebrale.
17T. Kuhn, The Structure of Scientific Revolutions, 1962, 1970.
18 Epimeteo, incaricato di distribuire alle diverse specie viventi le facolt che permettessero ad ognuna disopravvivere, costruun sistema in equilibrio, in cui le specie non si distruggessero reciprocamente. Nel farlo, per,
esaur tutte le caratteristiche a sua disposizione e, quando venne il turno dell'uomo, se lo ritrov nudo, scalzo,
3
-
7/24/2019 La Poesia delle Differenze
4/9
biologica originaria"7. 3uesto mito di un deficit originario, ripreso e sviluppato da tuttala tradizione umanistica, conferirebbe alluomo la sua libert e la sua virtualit0 le duecolonne portanti del paradigma antropocentrico. Banto pi$ che la tecnica, oltre arimediare alla mancanza biologica, permetterebbe alluomo di accedere alla dimensioneculturale e, %uindi, di compiere il balzo oltre la physis, creando i fondamenti del
distanziamento
#8
. a, rileggendo %uesto mito con gli occhi di chi viene dopo Darwin,possiamo chiederci %uale significato biologico racchiuda
$n aniale in esilio
I biologi sono per lo pi$ concordi nel ritenere decisivo, nella speciazione di %uello chechiamiamoHomo sapiens, il momento in cui l'ominide fu costretto a uscire dalla forestache aveva abitato fino ad allora per inoltrarsi nella savana#". Butto comincia con %uestoesilio dallEden originario, perch- le difficolt del nuovo ambiente spingono l'ominide atrasformarsi in modo significativo e specifico. =i nel mito platonico sintravede l'interacostellazione di mutamenti evolutivi che stanno alla base del processo di ominazione.Fediamo emergere un animale dalla peculiare postura eretta, che gli permette di avere le
mani libere per utilizzare strumenti ed esplorare il mondo
##
un animale, %uindi, dalleoriginali abilit tecniche#(, sociali e cerebrali. Lo sviluppo abnorme del cervello portacon s- anche il fatto che la specie umana & caratterizzata da unimmaturit cerebrale,che permette un indefinito prolungamento dellinfanzia e, %uindi, delleducazione#).
scoperto e inerme. Intervenne allora Prometeo, che rub agli di la sapienza tecnica e il fuoco e ne fece dono
all'uomo in modo da renderlo capace di sopravvivere. La nascita dell'uomo era avviata e seguirono altri cambiamenti
tra loro strettamente intrecciati: nacque il culto religioso, si svilupp il linguaggio, vennero costruite le case e
prodotte le vesti, comincil'agricoltura. Rimaneva perun problema: gli uomini erano in grado di procurarsi cibo,
ma non di difendersi dalle fiere che ne facevano strage. Infatti, non possedevano ancora l'arte politica, cio la
capacitdi vivere insieme e di fare insieme la guerra. Temendo che la nostra specie si estinguesse, Zeus incaric
Ermes di portare agli uomini due doni che rendessero possibile agli uomini vivere insieme: il senso del rispetto
(aidos) e il senso della giustizia (dike) (Platone, Protagora, 320C-324A).
19Il mito dellincompletezza stato portato ad una teorizzazione compiuta nellopera di Arnold Gehlen.20R. Marchesini, Il futuro della specie Homo sapiens sapiens, in La Scienza-UTET, 9.L'uomo, 2005, pp. 29-30.
21Cfr., ad es.,J.L Gould e C. Grant Gould, Larchitettura degli animali. Nidi, tane, alveari, 2008 ( 2007), p. 347.
22Secondo Desmond Morris (La scimmia nuda, 1992 (1967), pp.137-39) l'uomo ha sviluppato in modo speciale edenorme un tipico tratto dei primati, in quanto animali opportunisti, ovvero non specializzati: la curiosit, il gusto per
l'esplorazione "fine a se stessa". Dove per "fine a se stessa" si intende l'esplorazione di cose che non hanno un
immediato valore adattivo, ma che potranno averlo in futuro. L'uomo esplora per il gusto di esplorare, perch la
cultura consiste, oltre che nella capacitdi tramandare strumenti o pratiche, nel sapere utilizzare strumenti o pratiche
apprese in un determinato contesto in altri contesti.
23lo strumento che rivela l'uomo. la pietra scheggiata, per esempio, che dice: hic sunt homines, di qui sonopassati e qui hanno abitato gli uomini. In questo senso l'uomo l'essere della tecnica (C. Sini, Passare il segno.
Semiotica, cosmologia, tecnica, 1981, p. 254). Daltra parte, si noti che oggi gli scienziati sono molto meno convinti
nel definire luso di strumenti una specificit unica dellanimale-uomo (v. ad es. J.L Gould e C. Grant Gould,
Larchitettura degli animali. Nidi, tane, alveari, 2008 (2007), p. 339-346).
24Mano a mano che gli uomini divennero bipedi la cintura pelvica si fece pi robusta per lo sforzo di dovercamminare in posizione eretta; cos il canale natale si restrinse determinando un paradosso ostetrico: ad un
cervello pi grande corrispondeva un canale del parto pi stretto. La soluzione trovata sembra essere stata
limmaturit cerebrale, che permetteva al neonato di passare attraverso un canale pi ridotto. Si veda a questo
proposito la raccolta di articoli di Jerome Bruner curata da C. Scurati con il titolo Il significato delleducazione
(1982, pp. 33-4). Per il ruolo decisivo nellominazione della nascita prematura cfr. anche L. Margulis e D. Sagan,
Microcosmo, 1989 (1986), pp. 222 e segg. e R. Gaion, Uomo di Neandertal-uomo moderno: un rapporto dif ficile?,
4
-
7/24/2019 La Poesia delle Differenze
5/9
3uesto aspetto si rivela di fondamentale importanza per la trasmissione della culturaac%uisita di generazione in generazione e ha spinto alcuni scienziati a definire luomocome un animale neotenico#1.
L%aniale tecnico
Lincompletezza biologica alla %uale la tecnica pone rimedio non sarebbe, dun%ue, unaspecificit ontologica, ma piuttosto una carenza percepita a posteriori #20 il ricordo, sottoforma di mito, dellesperienza originaria dellominazione, unesperienza di esilio e diestraneit, e del modo in cui lanimale umano, reagendo a %uella estraneit, preseforma. Di conseguenza, la tecnica non sarebbe una sovrastruttura artificiale, ma lastrategia di adattamento pi$ propria delluomo#4, la sua natura. In %uesto sensoalluomo non & dato spogliarsi dei suoi supporti culturali o tecnologici senza perdere diumanit#5.
La parola e la distanzaBra le tecniche tramite le %uali luomo si rapporta al mondo e lo trasforma occupa unposto di rilievo il linguaggio. In effetti, anche secondo la ricerca scientifica, %uellarelativa allac%uisizione e allo sviluppo del linguaggio sembra essere una biforcazioneevolutiva decisiva#7, in %uanto connessione tra i tre vertici dello specifico umano0cerebrale, tecnologico e sociale. *l centro di %uesto triangolo emerge come dimensionepeculiare dellumano la capacit di creare una distanza tra s- e il mondo (8. La posturaeretta che pone luomo letteralmente di fronte al mondo, la tecnica che media il modo incui il corpo dell'uomo si relaziona al mondo e trasforma tanto il mondo %uanto il corpostesso(", il linguaggio capace di dire ci! che vede e di nominare ci! che non & presente e il
in La Scienza-UTET, 9.L'uomo, 2005.
25Si veda, ad esempio, G. Bocchi e M. Ceruti , Origini di storie, 1993, pp. 181-82.
26 La sensazione di incompletezza nasce a posteriori dal paragone tra una performativit di alto profilo, resapossibile dalla mediazione tecnica, e la prestazione realizzabile in totale autarchia. Dobbiamo pertanto parlare dicarenza percepita, non di incompletezza come condizione originale delluomo (R. Marchesini, Il futuro della specie
Homo sapiens sapiens, in La Scienza-UTET, 9.L'uomo, 2005, pp. 29-30).
27La tecnica non una stampella chiamata a supplire una natura umana incompleta e zoppicante ma comunquechiaramente enucleabile dai supporti culturali. La tchnepenetra profondamente nellessere umano definendolo nei
suoi predicati generali (ibidem, p. 30).
28Ibidem, p. 30.
29 GiDarwin notava: Se si puaffermare che certe potenze, come la consapevolezza di s, lastrazione, ecc.,sono particolari alluomo, pubenissimo essere che questi non siano altro che effetti incidentali di altre facolt
intellettuali molto inoltrate; e queste di nuovo non siano altro che leffetto delluso continuo di un linguaggio
altamente sviluppato(C. Darwin, Lorigine delluomo, 1914 (1871), p. 139).
30Helmuth Plessner (Die stufen des Organischen und der Mensch, Einleitung in die philosophische Anthropologie(1928), p. 363 e segg.) ha definito luomo animale eccentrico per la sua capacitdi porsi alle proprie spalle, di
posizionarsi su tre diversi livelli: corpo, nel corpo (come vita interiore o psichica) e fuori dal corpo, come punto
di vista dal quale esso entrambi. Raggiungendo lautocoscienza, diventa quindi in grado di decentrarsi, di
distanziarsi da s: non agisce soltanto allinterno del mondo, ma anche in grado di osservare e analizzare la propria
relazione con il mondo. Secondo lantropologo, tale caratteristica a determinare nelluomo il bisogno di
unartificialitnaturale, ovvero di uninterazione con il mondo che necessita di strumenti.
31La tecnologia diventata intrusiva, vale a dire capace di entrare direttamente nel corpo non solo potenziandolo,bensmodificando la sua performativit(effetto ibridativo) e di conseguenza il modo in cui luomo percepisce se
stesso (R. Marchesini, Il futuro della specie Homo sapiens sapiens, in La Scienza-UTET, 9.L'uomo, 2005, p. 25).
5
-
7/24/2019 La Poesia delle Differenze
6/9
pensiero astratto capace di ritardare la risposta allo stimolo(# e di muoversi nellospazio e nel tempo((mettono sotto il segno della distanza lo specifico modo di stare nelmondo delluomo.La capacit di pensiero astratto ci permette di vivere altri mondi oltre a %uello attuale0mondi possibili, virtuali, eventuali, passati, futuri, paralleli, ecc(). La distanza si fa cos+
virtualmente infinita e %uesto secondo esilio permette all'uomo un'elasticitsorprendente0 l'intrecciare se non addirittura il sostituire/ l'evoluzione naturale conlevoluzione culturale(1 permette di aumentare enormemente la variabilit culturalerispetto a %uella genetica, moltiplicando la capacit adattiva dell'homo sapiens.Lo sviluppo umano si delinea allora come lo sviluppo progressivo di una capacit didistanziarsi(2e la diversit dell'uomo assume un senso del tutto nuovo0 l'uomo non diverso, ma si sente e si disegna come diverso e non per un peccato di ubrisoriginaria,ma perch- tracciare il solco(4 & il modo umano di affrontare e trasformare il mondo,pervenendo ad un pensiero autocosciente(5. 3uesta distanza & il luogo genetico delsoggetto umano, lo spazio di confine che costituisce il suo habitat pi$ proprio, perch-%uesta distanza & il gesto che definisce attribuisce, letteralmente, dei confini/ l'uomo ela natura. Lo stesso concetto di natura & in effetti un prodotto di %uesto specifico mododi stare nel mondo0 il comprendere la natura & sempre anche un comprendersi nellanatura e ai confini di essa.L'habitat dell'uomo & la frontiera, una frontiera tracciata, costruita, immaginata,sognata. 3uesto confine & un limen soglia/, non un limesperimetro murario/0 & un
32In Prima lezione di biologia(2010), E. Boncinelli ha scritto: una caratteristica degli animali superiori che viavia che si sale la scala evolutiva, aumenta la distanza possibile tra uno stimolo e la corrispondente risposta (p. 133),
diventando nell'uomo virtualmente infinita. Tutto ci che sta tra lo stimolo e la risposta la mente o, se si
preferisce, il pensiero (p. 134). Potremmo dare il nome altisonante di liberta questo ampliato spettro di scelte
comportamentali che caratterizzano certe specie superiori (p.183).
33Lo sviluppo incredibile della corteccia prefrontale ci permise di espandere il pensiero in direzione del futuro,concependo nella nostra immaginazione catene di eventi non ancora accaduti (J.M. Fuster, Cognitive Function of
Frontal Lobe, in Miller e Cummings, Human frontal lobe, 18795). Cfr. anche il celebre caso di danni alla cortecciaprefrontale analizzato in E.Tulving et al., Priming of Semantic Autobiographical Knowledge: A Case Study of
Retrogade Amnesia, Brain and cognition 8: 320, 1988. Su un altro piano, lidea che luomo, a differenza
dellanimale, viva in una dimensione storica non puche rimandare ad una celebre pagina nicciana ( F. Nietzsche,
Considerazioni inattuali. Sullutilite il danno della storia per la vita, 1973 (1874), III, 1).
34 Noi pensiamo sempre a ciche che altrove - scrive Montaigne - e non potrebbe essere altrimenti: esserecoscienti significa, fra l'altro, essere altrove (M. Merleau-Ponty, Lettura di Montaigne, in Segni, 1969 (1960), p.
262).
35 "L'evoluzione culturale dell'umanit procede dritto davanti a s, sempre pi veloce; in questo momento haraggiunto un movimento cos rapido che non esagerato affermare che, al confronto con l'evoluzione culturale,
l'evoluzione genetica puessere considerata trascurabile, e addirittura posta uguale a zero (K.Lorenz, Il declino
dell'uomo, 1984 (1983), p. 7).
36La frattura originaria tra l'Io e il mondo sulla quale si sviluppano moltissime concezioni religiose (si pensi allacacciata dall'Eden) e filosofiche (si pensi alla concezione della natura di J.J. Rousseau) sarebbe allora non una
condanna generata da una colpa originaria, ma piuttosto una specifica estraneitinnescata dall'esilio primordiale.
37Il richiamo al gesto seminale dellagricoltura pucondurre ad una rilettura dei miti della fondazione. Romolotraccia il solco, uccide il fratello che lo attraversa (memoria di uninvasione del territorio da parte di altre specie di
ominidi?) e fonda la citt. Si noti che anche Caino agricoltore, fondatore di citte fratricida.
38L'ego viene prodotto per differenza rispetto a ciche viene definito non-ego dalla percezione/definizione di scome "diverso" dal mondo. Cfr. Diego D'Angelo, La genesi dell'autocoscienza. Da Darwin a Mead e Merleau-
Ponty, in Nema. Rivista online di filosofia, n. 3, 2012.
6
-
7/24/2019 La Poesia delle Differenze
7/9
luogo mobile e marginale che l'animale6uomo abita in %uanto animale che sta nelmondo tracciando differenze, ovvero producendo definizioni che separano econgiungono.
Il risc&io dell#alienazione
La distanza sviluppa la nostra capacit adattiva, ma ci espone anche al rischio di unaestraneazione. 9i pensi allo sviluppo tecnologico che ha creato un'ulteriore distanza,avvolgendo il mondo in un velo di atri@ (7, attraverso il %uale tutto viene filtrato erisignificato al punto da modificare in modo sostanziale la nostra percezione del mondoe il nostro modo di interagire con esso)8. In %uesto senso & come se l'uomo, animale inesilio, avesse cercato di tornare a casa)", cio& di ricostruire un rapporto pi$ simbioticocon lambiente superando l'iniziale estraneit, sviluppando strumenti che lo hanno inrealt reso in grado di costruirsi una nuova casa. In effetti, siamo gli ultimi eredi di unapulsione a costruire che dura da centinaia di milioni di anni, e %uindi a controllare%uello che ci circonda pi$ da vicino. Nel bene e nel male, %uesta spinta architettonica hacreato alla fine il tipo di mente che attualmente possediamo )#. Il rischio & %uello didimenticare che la nostra casa, per %uanto tecnologicamente evoluta, poggia comun%uesulla terra)(. La capacit di allungare la distanza tra i piedi il mondo/ e la testa ilpensiero/, inaugurata dalla stazione eretta, non deve generare l'illusione di non avereradicamento nel mondo)).
La rete della vita? dun%ue necessario)1che lanimale umano trovi un nuovo radicamento)2nella natura,
39Puessere utile ricordare che il celebre film di fantascienza prende spunto dal famoso esperimento mentale delfilosofo e matematico statunitense H. Putnam (Brains in a Vat, 1981, pp. 6-7).
40 In particolare, questa alterazione potrebbe comportare la minimizzazione della nostra capacitdi percepire lasoglia critica dell'ambiente. In generale, il problema nasce dal fatto che lo sviluppo tecnologico rapidissimo, in
termini biologici, ha consentito alluomo una performativitenorme (si pensi alla produzione di cibo o al potenzialebellico), senza che ci fosse il tempo di adeguare in profonditletogramma, ossia i meccanismi biologici di controllo
e gestione di questi nuovi poteri (cfr. R. Marchesini, Il futuro della specie Homo sapiens sapiens, in La Scienza-
UTET, 9.L'uomo, 2005, pp. 20-21).
41Sulla scorta di queste osservazioni il mito di Ulisse acquista un senso profondo di mito dellorigine. La figura diUlisse figura dellabilittecnica e verbale, nonchpersonaggio segnato dalla nostalgia per la casa lontana: tutte
caratteristiche specifiche della dimensione umana. Interessante notare che Piero Boitani (Lombra di Ulisse, 1992)
abbia definito Ulisse segno di unintera episteme.
42J.L. Gould e C. Grant Gould, op. cit., p. 352.
43La Natura un oggetto enigmatico, un oggetto che non del tutto oggetto; essa non completamente dinanzi anoi. il nostro suolo, non ciche dinanzi, ma ciche ci sostiene (M. Merleau-Ponty, La natura. Lezioni al
Collge de France 1956-1960 (1995), 1996, p. 4).
44L'evoluzione, collocando l'uomo in posizione eretta, lo ha messo in una situazione instabile: instabile in unsenso simbolico molto profondo. Poi lo ha abbandonato a se stesso (K.Lorenz, Il declino dell'uomo, 1984, p.7).
45I rapporti tra uomini e animali dovranno cambiare. E dovranno farlo nella duplice accezione di questo termine,nel senso di una necessitontologicae di un dovere etico (Jacques Derrida,lisabeth Roudinesco, Quale domani?,
2004, pp. 93 e 95).
46Dove sono gli uomini? - domandgentilmente il piccolo principe. Un giorno il fiore aveva visto passare unacarovana: - Gli uomini? Ne esistono, credo, sei o sette. Li ho visti molti anni fa. Ma non si sa mai dove trovarli. Il
vento li spinge qua e l. Non hanno radici, e questo li imbarazza molto" (A. de Saint-Exupry, Il Piccolo principe,
1986 (1943), cap. XVIII).
7
-
7/24/2019 La Poesia delle Differenze
8/9
procedendo oltre la distinzione tra uomo da una parte e animali dall'altra)4, ripensandola vita Zo/ come una rete)5di interrelazioni tra i viventi Bios/, ognuno dei %uali & unaprospettiva di corpo, un orizzonte di mondo. Ai$ precisamente, il mondo & appunto larete di differenze)7 reciproche e dinamiche tra %ueste pratiche di mondo, il lorocombattersi e incontrarsi, il loro essere interrelate e interdipendenti. In %uesto modo
diviene possibile passare da una visione dualistica e gerarchica della vita ad una visioneplurale e molteplice, in cui l'uomo possa dare alle sue specificit tecniche e linguisticheun compito di congiunzione e non di separazione.La prospettiva postumanistica18, ad esempio, cerca di dare un senso nuovo alla nostraspecificit tecnica1", concependo la tchnenel suo significato coniugativo1#, ossia nellasua capacit di attivare dialoghi sempre pi$ profondi e articolati con le alterit nonumane, animali o tecnologiche, perch& & in un rapporto referenziale 1(con %ueste alteritche luomo continuamente ridefinisce se stesso. Luomo viene di conseguenza ripensatocome unentit in continua trasformazione1)e viene sottolineato lo statuto dialogico eibrido dellontologia umana. Il sapere assume cos+ lo scopo di perfezionare la propriacapacit di partecipazione empatica, in %uanto atto di ospitalit che allarga lorizzontedelluomo. In %uesto senso, il ruolo dell'animale6uomo in %uanto animale dotato dilinguaggio diverrebbe %uello di com6prendere la natura11, di dire il mondo senzaconfondere la mappa con il territorio, la parola con la cosa. In %uesto modo si pu!superare il bivio obbligato tra la superstizione della differenza tra uomo e animale dauna parte e la superstizione di una troppo facile identit tra l'uomo e gli altri viventi
47"Lanimale, che parola! Lanimale una parola che gli uomini si sono arrogati il diritto di dare" (J. Derrida,Lanimale che dunque sono, 2006, p. 71).
48Il riferimento a F. Capra, che,dopo aver delineato le caratteristiche di una concezione sistemica e biocentricadella vita, conclude: Per riconquistare la nostra piena natura umana, dobbiamo riconquistare lesperienza della
connessione con lintera trama della vita. Questo riconnettersi, religioin latino, la vera essenza del fondamentospirituale dellecologia profonda (La rete della vita. Una nuova visione della natura e della scienza. (1996), 1997,
p. 325).
49La dif-ferenza porta il mondo al suo esser mondo, porta le cose al loro esser cose. Portandoli a compimento, liporta l'uno verso l'altro []. La differenza, in quanto linea mediana (stacco del frammezzo), media il realizzarsi del
mondo e delle cose nella loro propria essenza, ciostabilisce il loro essere l'uno per l'altro, di questo fondendo e
compiendo l'unit (M. Heidegger, In cammino verso il linguaggio, 1973 (1959), p. 37).
50Roberto Marchesini, Post-human. Verso nuovi modelli di esistenza, 2002; Roberto Marchesini, Il tramontodelluomo. La prospettiva post-umanista, 2009.
51Si delinea in questo modo anche un modo originale di fare i conti con la storia della metafisica e con il suodestino tecnico (M. Heidegger, La questione della tecnica, 1953) e quindi con il (preteso) dominio umano sul pianeta
e sul vivente.
52R. Marchesini, Il futuro della specie Homo sapiens sapiens, in La Scienza-UTET, 9.L'uomo, 2005, p. 42.53Luomo non solo non pupiconsiderarsi misura del mondo, ma sta scoprendo di non essere nemmeno misuradi se stesso (R. Marchesini, ibidem, p. 43).
54 Entit in continua trasformazione: sotto il profilo evoluzionistico, ovvero dello statuto filogenetico; sotto ilprofilo antropopoietico, ossia del dimensionamento culturale e dellemergenza di nuove qualit; sotto il profilo
ontogenetico, vale a dire di definizione del ssulla base dei contributi referenziali (R. Marchesini, ibidem, p. 42).
55Non a caso la ricerca filosofica contemporanea [si pensi, ad esempio, a Hans Jonas] ha sottolineato la necessit di unetica allargata nel suo orizzonte operativo sia da un punto di vista temporale, nei confronti delle future
generazioni, sia da un punto di vista spaziale, nei confronti dei referenti non umani (Roberto M., ibidem, p. 19).
8
-
7/24/2019 La Poesia delle Differenze
9/9
dall'altra.
La poesia della !iodiversit"3uest'ultima soluzione, in apparenza eticamente pi$ corretta, nasconde una nuovaperdita di diversit, mentre la vita vive di differenze reciproche12, di diversit, di
pluralit14
. Aensiamo alla drammatica e rapidissima perdita di biodiversit alla %ualestiamo assistendo e cerchiamo, con l'aiuto di Garlo 9ini 15, di comprenderne il senso pi$profondo0 9e viene meno la differenza siamo perduti, perch- l'essere umano non & altroche la differenza tra tutte %ueste differenze e, in pi$, la parola che dovrebbe custodirle 17,che dovrebbe nominarle per custodirle, non per possederne la propriet. 9i comprende,allora, perch- l'uomo & sempre stato pensato come l'essere intermedio0 la sua parola & laparola di tutti gli animali. Luomo assume dun%ue idealmente il ruolo di custode di%uesta variet e assumono un senso pi$ ampio e pi$ profondo i doni che, nel mitoplatonico, Ermes, dio del linguaggio28, porta agli uomini su ordine di Heus2"0 il senso delrispetto aidos2#/ e il senso della giustizia di!e/.Il compito dell'uomo & il canto della vita, & la poesia2( delle differenze, perch- senza
differenza non c'& vita. Il contrario della differenza & l'indifferenza
2)
.
56Ogni vivente let dellaltro (C. Sini, Luomo e la differenza animale, Fondazione Faraggiana Novara, 7marzo 2013). Questo riferimento e quello precedente ad Heidegger conferiscono un inedito spessore filosofico al
concetto di coevoluzione, concetto centrale in alcuni filoni del neodarwinismo (J. Lovelock, The Ages of Gaia. A
Biography of Our Living Earth, 1988; S.J. Gould, The Structure of Evolutionary Theory, 2002; F. Capra, The Web
of Life, 1996; G. Bocchi e M. Ceruti, Origini di storie, 1993).
57Darwin, nel concepire per primo la forza della vita come qualcosa che travalica le singole differenti forme, fa
coincidere fondamentalmente la vitalitcon la variabilit (D. Tarizzo, La vita, uninvenzione recente, 2010, p. 111).Non possibile creare armonia se non in presenza di una varietdi differenze.
58C. Sini, Luomo e la differenza animale, Fondazione Faraggiana Novara, 7 marzo 2013.
59 Nel Genesi (2,15), accanto alla figura delluomo signore e dominatore del mondo, compare anche la figuradelluomo custode del giardino dellEden. Si veda a questo proposito la relazione di E. Bianchi nel Convegno
Luomo custode del creato (www.monasterodibose.it/content/blogcategory/339/1874/lang,it/).
60 Ermes il dio del linguaggio e della comunicazione, ma anche il protettore dei ladri e dei mercanti, deivagabondi e dei viandanti: la specie umana da sempre sotto il suo segno.
61Platone, Protagora, 320C-324A.
62Aidosera la dea greca della vergogna e dellumilt; intesa come qualitquella sensazione di riverenza o divergogna che trattiene gli uomini dal male.
63In questo contesto il termine poesia riacquista il senso forte e originario della sua radice etimologica (poiein=fare, creare), che lo intende come ciche crea e fa esistere un mondo.
64Lanimale mi guarda e io sono nudo davanti a lui. Il pensare, forse, comincia proprio da qui (J. Derrida,Lanimale che dunque sono, 2006, p. 58) [...] Lanimale possiede un punto di vista su noi, che possiamo ignorare, ma
al quale non possiamo sottrarci. Comincia un nuovo modo di concepire lessere umano e di concepire lessere
vivente in generale, perch la nudit originaria del vivente, quella totalit unitaria divisa dal solco che separa
lanimale dalluomo, di fronte allo sguardo dellaltro al quale siamo esposti, riaffiora, potente e inarrestabile. la
vita stessa che nella sua immediatezza reclama il diritto di essere riconosciuta e rispettata in tutte le sue
manifestazioni, senza differenze, senza esclusioni (M.T. Speranza, Lanimale che dunque sono? Intorno a Derrida
per una genealogia del rapporto uomo-animale, in Scienza e Filosofia, n. 6, 2011, pp. 101 e 114).
9