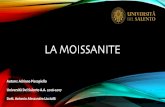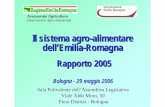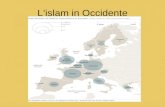L’ - ENEA — it · corso che per il 2008. La Cina ha raggiunto nel 2005 una popola-zione di 1,3...
Transcript of L’ - ENEA — it · corso che per il 2008. La Cina ha raggiunto nel 2005 una popola-zione di 1,3...

1
L’economia mondiale sta assistendo in questi ultimi anni ad una crescita vigoro-sa dei paesi asiatici ed in particolare di Cina e India. Dal 1990 al 2005 il prodot-to interno lordo della Cina è cresciuto con una media annua del 9,9% e quellodell’India del 6%, a fronte del 2,5% di quello dei paesi OCSE.Uno sviluppo così intenso di queste economie comporta da un lato una fortedomanda di materie prime, incluse quelle energetiche, dall’altro effetti nega-tivi preoccupanti sull’ambiente globale.Queste preoccupazioni hanno spinto l’Agenzia Internazionale dell’Energia afocalizzare il rapporto annuale World Energy Outlook 2007 (WEO) proprio sul-le performance energetico-ambientali di Cina e India. Il tasso di crescita di que-ste due economie, secondo l’Agenzia, richiederà in futuro ancora più energia permigliorare lo standard di vita della popolazione e non si può chiedere loro di ri-durre la crescita per poter risolvere i problemi su scala mondiale. Ciò che oc-corre è la collaborazione di tutti per realizzare un sistema energetico più sicu-ro e a minor contenuto di carbonio.Gli aspetti salienti delle analisi dell’AIE sono riportati nella sintesi ufficiale delWEO che anche quest’anno pubblichiamo nella nostra Rivista.Abbiamo inoltre voluto approfondire il quadro economico, energetico e am-bientale cinese attraverso un breve articolo che esamina anche le risposte aiproblemi del cambiamento climatico, definite dalla Cina in programmi appro-vati recentemente.Allo stesso tempo abbiamo intervistato l’ambasciatore della Repubblica Popo-lare di Cina in Italia Dong Jinyi per fornire un importante contributo alla com-prensione delle posizioni ufficiali cinesi su questi temi.Nel settembre scorso, l’ambasciatore Dong Jinyi ha accompagnato il Ministrocinese della Scienza e Tecnologia, Wan Gang, nella sua visita all’impianto so-lare ad alta temperatura e ai laboratori del Centro Ricerche ENEA della Casac-cia, a dimostrazione dell’interesse della Cina alle tecnologie sviluppate dall’ENEA,che potrebbe portare ad un possibile ampliamento delle collaborazioni già esi-stenti.Con l’articolo sulla Programmazione Finanziaria 2007-2013 dell’Unione Euro-pea intendiamo fornire un quadro delle grandi opportunità offerte dai pro-grammi UE, per tutti coloro che nel nostro Paese operano nel campo dell’ener-gia, dell’ambiente e dell’innovazione tecnologica, opportunità che spesso nonsono pienamente sfruttate dall’Italia.Nella rubrica Studi & Ricerche ospitiamo tre contributi di ricercatori ENEA. Ilprimo riguarda la possibilità di ottenere idrogeno dall’acqua attraverso unasoluzione alternativa al ciclo zolfo-iodio, garantendo un notevole risparmionel bilancio massa-energia; il secondo sulla Supply Chain integrata, espone ilmodello di gestione di catene di PMI basato sui cosiddetti metodi di coordina-mento decentralizzato finalizzati ad una gestione ottimale della catena, mes-so a punto dall’ENEA; il terzo infine affronta il tema della ricerca psicologicain un ambiente estremo, quale quello in cui si trovano ad operare i ricercatoridella spedizione scientifica in Antartide.
Il Direttore Responsabile Flavio Giovanni Conti
editoriale
ENERGIA, AMBIENTE E INNOVAZIONE 6/2007
energia, ambiente e innovazione

2
IL PROGRAMMA NAZIONALE SUI CAMBIAMENTI CLIMATICI: LA SFIDA DELLA CINATHE NATIONAL CLIMATE CHANGE PROGRAMME:
THE CHALLENGE FOR CHINAA cura di Flavio Giovanni Conti e Paola Molinas
INTERVISTA A DONG JINYIINTERVIEW WITH DONG JINYIA cura di Paola Molinas
ENERGIA, AMBIENTE E INNOVAZIONE 6/2007
4
sommario
12
primo piano
l’intervista
16
48
riflettore suWORLD ENERGY OUTLOOK 2007 - CHINA AND INDIA INSIGHTSWORLD ENERGY OUTLOOK 2007International Energy Agency
LE OPPORTUNITÀ DEI PROGRAMMI UE 2007-2013OPPORTUNITIES PROVIDED BY THE EU’S 2007-2013 PROGRAMMESFlavia Amato
LA SUPPLY CHAIN INTEGRATATHE INTEGRATED SUPPLY CHAINRoberto Tononi, Gilda Massa, Raimondo Raimondi, Giuseppe Spagna
34

ENERGIA, AMBIENTE E INNOVAZIONE 6/2007 3
MISSIONE SCIENTIFICA IN ANTARTIDE: RICERCA PSICOLOGICA IN AMBIENTE ESTREMO SCIENTIFIC MISSION IN ANTARCTICA: PSYCHOLOGICAL RESEARCH IN AN EXTREME ENVIRONMENTDenise Giuliana Ferravante
LA SCISSIONE TERMICA DELL’ACQUA: MITO O REALTÀ?THERMAL WATER SPLITTING: MYTH OR REALITY?Pier Paolo Prosini
72
80
82
studi& ricerche
LA STORIA GEOLOGICA DELL’ANTARTIDEA cura di Emilio Santoro
appunti di
64
cronacheDAL MONDO, DALL’UNIONE EUROPEA, DALL’ITALIA, DALL’ENEA, EVENTI, LETTURE
dal Mondo • WEC 2007: una strategia comune 82per preparare il dopo 2012
• ITER: un futuro per la fusione 83
dall’Unione Europea • Mobilità intelligente 84• Favorire le nanotecnologie 84• Ricerca & industria per il fotovoltaico 85
dall’Italia • Approvata la Finanziaria 2008 86Censis: puntare sulle minoranze attive 87Il progetto CRESCO nella TOP500 88Quote emissioni 2008-2012 88
dall’ENEA • I 50 anni del Sincrotrone di Frascati 89• A consulto per l’ambiente marino 90• SICENEA: “Pura energia di Sicilia” 90• Igiene e sicurezza ambientale 90• Banca Mondiale 91• Carbone: obiettivo zero emission 92
Eventi • Dialogo tra arte e scienza 93• Il colore perduto di Giotto 93• La comunicazione tra reale e virtuale 94• Intelligenza Artificiale 10° Congresso AI*IA 94
Letture • Catastrofi climatiche e disastri sociali 95• La Governance dello sviluppo 96
– esperienze di politica industriale

4 ENERGIA, AMBIENTE E INNOVAZIONE 6/2007
Presentato al Summit G8 del giugno scorso in Germania,
il documento inserisce ufficialmente la Cina nell’acceso
dibattito su come coniugare sviluppo e utilizzazione
delle risorse salvaguardando l’ambiente Nel corso degli ultimi venti anni l’econo-
mia cinese è cresciuta ad un tasso medioannuo superiore all’8%, con incrementiprevisti intorno all’11% sia per l’anno incorso che per il 2008.La Cina ha raggiunto nel 2005 una popola-zione di 1,3 miliardi di abitanti (il 20,4%di quella mondiale), di cui 750 milioni nel-le aree rurali ed il 43% del totale residen-te nelle aree urbane. Il processo di urba-nizzazione è destinato ad accelerare, conuno spostamento annuale verso le aree ur-bane di circa dieci milioni di abitanti, chelasciano i campi per andare a lavorare nel-le fabbriche e nei cantieri delle città.Ciò che preoccupa le autorità cinesi è ilforte squilibrio esistente tra lo sviluppodelle grandi città della costa e l’arretra-
prim
o p
iano Il Programma
Nazionale sui Cambiamenti
Climatici: la sfida della Cina
A cura di Flavio Giovanni Conti e Paola Molinas
The National Climate Change
Programme: The challengefor China
This document, presented last June at the G8Summit in Germany, brought China officially
into the heated debate on how to couple development and resource use with
protection of the environment
1. Indice di Povertà Umana (IPU): indice messo apunto dall’UNDP (United Nations DevelopmentProgramme) che identifica la povertà non solocome condizione di privazione materiale dell’in-dividuo ma anche come perdita di opportunitàconcrete, di impossibilità a realizzare traguardie funzionamenti fondamentali della vita umana:vivere una vita quanto più lunga possibile, nu-trirsi e coprirsi, godere di buona salute, istruirsi,partecipare attivamente alla vita comunitaria ecosì via.

Il Programma Nazionale sui Cambiamenti Climatici: la sfida della Cina
prim
o p
iano
ENERGIA, AMBIENTE E INNOVAZIONE 6/2007 5
tezza dell’interno e delle campagne.Sebbene questo serva a garantire un ser-batoio inesauribile di manodopera abasso costo, oggi si moltiplicano gli al-larmi sull’insostenibilità sociale di que-sta situazione, che ha portato nel 2006l’indice di povertà1 del paese all’11,6%2.I contadini delle zone più remote checoltivano le terre meno fertili vivono in-fatti in condizioni precarie rispetto ai ci-nesi delle grandi metropoli industriali,e questo divario si esplicita nel valoredel PIL pro-capite estremamente bassorispetto al PIL totale.
Ciò nonostante, la strategia volta a rie-quilibrare le disparità regionali diventauno stimolo per gli investimenti nelnord-est, nel centro e nell’ovest, che so-no le aree più sofferenti del paese: lanecessità di infrastrutture in queste zo-ne diviene dunque un altro motore diinvestimenti e di crescita. Ma quando i cinesi meno abbienti di-venteranno consumatori, la domanda dienergia, e dunque di risorse, sarà mol-to rilevante. E considerando che la Cinaconsuma essenzialmente carbone, l’al-larme determinato dal costo ambienta-
Cina
India
Giappone
Stati Uniti
UE 27
1995
16000
mld
US
$ pp
a
14000
12000
2000
4000
6000
8000
10000
0
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Figura 1PIL (ppa)* in diversi paesi ed aree. Anni 1995-2008*a parità di potere di acquisto. Fonte: World Economic Outlook Database, FMI, aprile 2007
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
1800
1971 1973 1975 1977 1979 1981 1983 1985 1987 1989 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005
Coal Oil Natural Gas Nuclear Hydro/Other Combustible Renewables
Figura 2Cina: consumi energetici totali. Anni 1971-2005 (Mtep). Fonte: Energy Economics, 6/2006
2. Human development Report 2006, United Nations Development Programme.

negli ultimi 25 anni. La Cina è il primopaese al mondo sia come riserve dienergia idraulica che come potenzialidella stessa; dopo oltre 20 anni di svi-luppo, il paese ne ha letteralmenteraddoppiato la produzione. La costruzione della Diga delle Tre Go-le sul fiume Yangtze, ultimata nel mag-gio 2006, ne è la più recente ed ecla-tante dimostrazione. Con una produ-zione annua di energia elettrica di cir-ca 85 TWh, ovvero il 3% dell’energiaelettrica consumata nel paese, la cen-trale può far risparmiare al pianeta cir-ca 100 milioni di tonnellate di anidri-de carbonica all’anno rispetto ad unimpianto a carbone della stessa capa-cità di generazione6.Costi ambientali, uso intensivo di ener-gia, degrado delle risorse naturali im-pongono alla Cina di affrontare il te-ma del suo modello di sviluppo, ancheper permetterle di agire in un conte-sto internazionale più favorevole.
Il China’s National Climate Change Programme
Nell’ambito del Summit G8 sul climache si è svolto ad Heiligendamm, inGermania, il 7 giugno 2007, la Cina hapresentato il China’s National Clima-te Change Programme, ovvero il pro-prio Programma nazionale sui cambia-menti climatici, predisposto dalla Na-tional Development and Reform Com-mission, organo del governo prepostoalla programmazione energetica, nelquale si definiscono obiettivi, princi-pi base, aree di azione, politiche e mi-sure che il governo del paese intendemettere in atto al 2010.Nella premessa, il documento riprendequanto definito nelle conclusioni delSummit, in cui l’United Nations Fra-mework Convention on Climate Chan-ge (UNFCCC), sotto la cui egida ver-
Flavio Giovanni Conti, Paola Molinas
le di questo riequilibrio sociale divieneulteriormente pressante.La crescita economica vorticosa degli ul-timi due decenni ha alimentato un au-mento sostenuto dei consumi di ener-gia. La Cina è il mercato energetico conil più alto tasso di crescita. Relativamente all’utilizzazione delle sin-gole fonti energetiche, va sottolineatoche nel 2005 il paese ha assorbito da so-lo il 37% dei consumi complessivi di car-bone a fronte del 19% degli Stati Uniti edel 13% dell’Europa, con un impiego dicirca 2 miliardi di tonnellate. L’utilizzoprevalente del carbone è legato alla ge-nerazione di energia elettrica, ma è an-che forte la domanda che proviene dalsettore residenziale per il riscaldamen-to delle abitazioni3.Divenuto paese importatore di petrolionel 1993, dopo averlo esportato per ol-tre 40 anni, la Cina si attesta nel 2006sull’8,4% dei consumi mondiali, percen-tuale quasi raddoppiata rispetto al 1995,con 7,1 milioni di barili/giorno. Nono-stante produca parte del petrolio checonsuma, il paese è costretto a ricorre-re in maniera massiccia alle importazio-ni. Nel 2005 si poneva al terzo posto do-po Stati Uniti e Giappone, con 3,3 milio-ni di barili/giorno4. Per consumo di gas naturale, la Cina sicolloca nel 2005 all’undicesimo posto,con un impiego che ha raggiunto i59,76 miliardi di metri cubi. Nel 1995ne utilizzava poco più di un terzo.5Ad oggi, è ancora il carbone la fonteenergetica più utilizzata in Cina, conuna quota sui consumi totali al 2005del 68,9%, a fronte del 21% del petro-lio e del 10,1% di gas naturale, idroe-lettrico, nucleare, eolico e solare. Anche la produzione di energia idroe-lettrica è cresciuta molto rapidamente
prim
o p
iano
ENERGIA, AMBIENTE E INNOVAZIONE 6/2007 6
3. Rapporto Energia e Ambiente 2006, ENEA4. World Oil and Gas Review 2007, Eni5. World Oil and Gas Review 2007, Eni6. www.ctgpc.com (sito ufficiale dell’impianto)

Il Programma Nazionale sui Cambiamenti Climatici: la sfida della Cina
prim
o p
iano
ENERGIA, AMBIENTE E INNOVAZIONE 6/2007 7
ranno definite le strategie del postKyoto, evidenzia l’impegno di tutti ipaesi nella lotta ai cambiamenti cli-matici, concordando inoltre che lastrategia per la protezione del climadeve tuttavia rendere possibile la cre-scita dei paesi in via di sviluppo. Ed inparticolare l’UNFCCC stabilisce la de-finizione di strategie a lungo terminecon paesi, fra i quali la Cina, le cui at-tività economiche producono elevatilivelli di emissioni.Parte 1Nella prima parte del programma cinesevengono riportati i dati che rappresenta-no i trend dell’aumento delle tempera-ture, delle precipitazioni, dei fenomeninaturali estremi, quali effetti dei cam-biamenti climatici in corso. Un paragrafo rilevante è quello relati-vo alle emissioni di gas serra, passate dai3.650 Mt del 1994 ai 5.600 Mt del 2004,con un incremento annuo del 4%; diquesta quota, le emissioni di CO2 sul to-tale dei gas serra sono passate dal 76%all’83%. Il documento sottolinea poi co-me le emissioni storiche attribuite alla
Cina siano molto basse (circa il 33% diquelle dei paesi OCSE), così come quellepro-capite, ben al di sotto della mediamondiale.Nonostante queste considerazioni fac-ciano trasparire quale sia la responsabi-lità che il documento attribuisce ai pae-si industrializzati, esso vuole evidenzia-re quanto la Cina sia sensibile al proble-ma delle emissioni ed elenca le azioni giàmesse in atto. Una nuova politica indu-striale, anzitutto, volta a promuovere ilsettore terziario (telecomunicazioni, tu-rismo e finanza in particolare) e a ristrut-turare il secondario (con l’informationtechnology e l’elettronica in primo pia-no), mentre la quota legata all’agricol-tura decresce sensibilmente fra il 1990 eil 2005. Con una crescita così accentuatadel settore dei servizi, il paese ha otte-nuto significativi risultati dal punto di vi-sta del consumo di energia, raggiungen-do fra il 1991 e il 2005 un tasso di cresci-ta del 10,2%, con un incremento dei con-sumi energetici del 5,6% fra il 1991 ed il2005, ovvero lo 0,55 di elasticità nei con-sumi di energia.
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
4500
5000
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
19992000
2001
2002
2003
2004
Figura 3Cina: emissioni totali di anidride carbonica. Anni 1971-2004 (Mt)Fonte: Emissions from fuel combustion, IEA 2006

Con l’introduzione di tecnologie innova-tive e di nuovi meccanismi di risparmioenergetico, anche l’intensità energeticaè calata sensibilmente, con una mediaannua del 4,1% sempre nello stesso ar-co temporale. L’energia pulita ha avuto un forte svilup-po, in particolare con l’incremento del-l’idroelettrico, il nucleare e le rinnovabi-li (biomassa, eolico, fotovoltaico); la lo-ro utilizzazione, insieme a quella deigrandi impianti idroelettrici, ha portatonello stesso anno ad evitare 380 MtCO2di emissioni.Il programma passa quindi ad elencaregli interventi messi in atto nei campi del-la riforestazione e della protezione am-bientale, della pianificazione demogra-fica, della formulazione di leggi e nor-mative che dettano gli impegni e gli ob-blighi delle aziende e degli utenti nel-l’utilizzo di fonti rinnovabili, della for-mulazione di progetti di ricerca sull’im-patto e le previsioni, e di programmi dieducazione e di formazione.
Parte 2Nella seconda parte del programma si of-fre un breve quadro della Cina, che dalpunto di vista naturale già rappresenta
un ecosistema vulnerabile, con un impo-nente numero di abitanti ed un enormesquilibrio economico e sociale esistentenelle varie aree che lo compongono. Si passa quindi ad una analisi degli ef-fetti dei cambiamenti climatici già in at-to nel paese, in particolare su agricoltu-ra e zootecnia, patrimonio forestale, ri-serve idriche.Il programma enfatizza la sfida che ilpaese deve affrontare: il percorso dellosviluppo economico, in tutti i paesi incui questo è avvenuto, ha sempre rive-lato una stretta correlazione fra emis-sioni di CO2 pro-capite e consumo dienergia pro-capite. In altre parole, perraggiungere il livello di sviluppo dei pae-si industrializzati è inevitabile che il con-sumo di energia e le emissioni pro-capi-te arrivino a livelli alti. Ma le politichedi mitigazione imporranno alla Cina dicreare un modello di sviluppo innovati-vo e sostenibile. E questo, che già di persé è un obiettivo difficile da consegui-re, trova degli ostacoli anche in altri fat-tori concorrenti: - il mix energetico cinese è dominato dalcarbone;- esiste un fortissimo gap tecnologico ri-spetto ai paesi industrializzati su tutto
Flavio Giovanni Conti, Paola Molinas
prim
o p
iano
ENERGIA, AMBIENTE E INNOVAZIONE 6/2007 8
Ener
gy
inte
nsi
ty o
f GD
P
Co
ntr
ibu
tio
n o
f en
erg
y ty
pes
by
end
use
(%)
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0 0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
1.2
19801981
19821983
19841985
19861987
19881989
19901991
19921993
19941995
19961997
19981999
20012002
Coal Petroleum Natural gas Electricity Energy intensity GDP
Figura 4Struttura energetica dell’economia cineseFonte: Energy balances of Non-OECD countries 2004-2005, IEA 2007

Il Programma Nazionale sui Cambiamenti Climatici: la sfida della Cina
prim
o p
iano
ENERGIA, AMBIENTE E INNOVAZIONE 6/2007 9
il processo di estrazione, trasformazio-ne, trasporto e utilizzazione delle fontienergetiche;- il patrimonio di foreste e di altre risor-se naturali non è sufficiente al paese;- l’agricoltura è già sofferente a causadi frequenti disastri meteorologici;- le regioni costiere, notoriamentequelle più ricche e sviluppate del pae-se, con un’altissima densità di popola-zione, sono molto vulnerabili: la Cinamanca completamente di un sistemadi monitoraggio sulle emergenze ed infuturo l’erosione, l’intrusione del ma-re, la salinizzazione dei suoli causeran-no realisticamente dei gravissimi pro-blemi.
Parte 3Nella terza parte il programma delinea iprincipi e gli obiettivi che il paese mettein campo per fronteggiare il problemadei cambiamenti climatici.I principi sono:• affrontare i cambiamenti climatici nel-la cornice dello sviluppo sostenibile;• seguire il principio dell’UNFCCC “del-le responsabilità comuni, ma differen-ziate”;• dare uguale enfasi alla mitigazione eall’adattamento;• integrare la politica sui cambiamenticlimatici con le altre politiche;• puntare sull’innovazione tecnologica;• interagire in maniera proattiva con lacomunità internazionale.
A fronte di questi principi, gli obietti-vi che il paese si pone sono i seguenti:1) tenere sotto controllo le emissioni digas serra;2) sviluppare la capacità di adattamen-to ai cambiamenti climatici;3) incrementare le politiche di ricerca esviluppo;4) sensibilizzare la popolazione e forma-re il management.
Parte 4Nella quarta parte del programma sianalizzano nel dettaglio le politiche ele misure finalizzate agli obiettivi de-scritti precedentemente, di cui si dà con-tezza in maniera schematica proprio perfavorire la loro intelligibilità:
Obiettivo 1 (Tenere sotto controllo leemissioni di gas serra)Produzione e trasformazione dell’ener-gia: - formulare ed implementare leggi chefavoriscano la mitigazione delle emis-sioni;- rafforzare i meccanismi innovativi nel-le istituzioni (accelerando per esempiola riforma del settore energetico);- adottare nuove politiche e misure nel-l’industria energetica, quali quelle rela-tive all’idroelettrico, al nucleare, allabioenergia, agli impianti da fonti rinno-vabili;- sviluppare tecnologie avanzate per l’u-tilizzazione delle fonti tradizionali.
Efficienza e risparmio di energia: - migliorare la normativa già esistente;- rafforzare le politiche e misure;- incrementare lo sviluppo e la dissemina-zione delle tecnologie per il risparmioenergetico nei settori chiave, quali l’indu-stria dell’acciaio, quella dei metalli non-ferrosi, l’industria petrolchimica, quella deimateriali da costruzione, dei trasporti, deimacchinari agricoli, così come nell’edilizia.
Processi industriali:- ridurre e riciclare i rifiuti;- risparmiare ferro e acciaio;- rafforzare il controllo delle emissionidi gas serra attraverso la promozione diprogetti di collaborazione internaziona-le, quali i CDM.
Gli altri settori individuati nell’ambitodi intervento dell’Obiettivo 1 sono quel-

Flavio Giovanni Conti, Paola Molinas
prim
o p
iano
ENERGIA, AMBIENTE E INNOVAZIONE 6/2007 10
li dell’agricoltura, della silvicoltura e deirifiuti urbani.
Obiettivo 2 (Sviluppare la capacità diadattamento ai cambiamenti climatici)Agricoltura:- migliorare le infrastrutture;- orientare le colture in base alle esigen-ze climatiche;- selezionare colture più resistenti;- incrementare la ricerca e lo svilupponelle nuove tecnologie.
Silvicoltura:- formulare leggi nel settore;- rafforzare la protezione delle forestee di tutti gli ecosistemi naturali;- sviluppare tecnologie per la conserva-zione delle biodiversità ed il monitorag-gio delle foreste.
Acqua:- migliorare la gestione del patrimonioidrico;- pianificare e realizzare nuove infra-strutture;- sviluppare tecnologie per il risparmiodell’acqua e la desalinizzazione dell’ac-qua marina.
Zone e regioni costiere:- formulare leggi nel settore;- promuovere tecnologie innovative perla protezione degli ecosistemi marini;- realizzare sistemi di monitoraggio al-tamente innovativi.
Obiettivo 3 (Incrementare le politiche diricerca e sviluppo volte ai cambiamenticlimatici)- rafforzare il coordinamento della ricer-ca scientifica nel settore;- promuovere la ricerca e lo sviluppo nel-le aree chiave del cambiamento clima-tico, con una attenzione particolare alletecnologie di monitoraggio, all’efficien-za energetica, all’energia pulita, al con-
trollo delle emissioni, al sequestro diCO2;- incrementare i finanziamenti volti al-la ricerca tecnologica.
Obiettivo 4 (Sensibilizzare la popolazio-ne e formare il management)- ideare campagne di sensibilizzazione sututti i mass media per il risparmio dell’e-nergia e dell’acqua, la classificazione, lariduzione e il riciclaggio dei rifiuti;- incoraggiare i comportamenti virtuosi;- rendere trasparenti tutte le azioni po-litiche su temi legati ai cambiamenti cli-matici;- rafforzare la cooperazione e la comuni-cazione a livello internazionale;- creare una sorta di cabina di regia chesovrintenda alle politiche sui cambia-menti climatici;- stabilire un sistema che coordini a li-vello regionale queste politiche, attra-verso agenzie che implementino il pro-gramma nazionale e che organizzino leattività locali;- rendere possibile l’utilizzo del Fondoper il Clean Development Mechanism(CDMF).
Parte 5La quinta e ultima parte del Program-ma esprime la posizione del governo ci-nese sui punti chiave relativi ai cambia-menti climatici e sulla necessità dellacooperazione internazionale.Per quanto riguarda la Mitigazione, inaccordo con quanto stabilito in ambitoUNFCCC circa “le responsabilità comunima differenziate”, la Cina ha come prio-rità quella di perseguire lo sviluppo so-stenibile attraverso misure di efficienzae risparmio energetico, sviluppo dellerinnovabili, sistemi di afforestazione,preservazione degli ecosistemi, control-lo delle proprie emissioni di gas serra.Relativamente all’Adattamento, ilpaese assume l’impegno di attribuirgli

Il Programma Nazionale sui Cambiamenti Climatici: la sfida della Cina
prim
o p
iano
ENERGIA, AMBIENTE E INNOVAZIONE 6/2007 11
l’importanza che mai nel passato erastata concessa a questa voce. A questoscopo, la Cina è pronta a cooperare conla comunità internazionale su proget-ti e attività comuni finalizzati alla rea-lizzazione di misure di adattamento.Un punto importante è anche quellodella Cooperazione in campo tecno-logico e del Technology transfer, intermini di politica, procedure e risorsefinanziarie, con la creazione di un fon-do speciale per la cooperazione tecno-logica internazionale.Il Programma riconosce nell’UNFCCC enel Protocollo di Kyoto le cornici uf-ficiali in cui la comunità internaziona-le deve cooperare, senza trascurare
però la cooperazione anche a livello re-gionale. Il Programma cinese sui cambiamenti cli-matici inserisce ufficialmente il paese al-l’interno di uno dei dibattiti più impor-tanti ed accesi in cui è coinvolta la co-munità internazionale: quello relativoalla necessità di coniugare lo sviluppoeconomico con l’utilizzazione delle ri-sorse energetiche limitando il loro im-patto sugli effetti climatici.Il Programma enuncia con chiarezza l’im-pegno del paese verso la definizione diuna politica internazionale comune, con-siderando il rafforzamento della prote-zione del clima una vera e propria sfidanazionale.

ENERGIA, AMBIENTE E INNOVAZIONE 6/2007 12
Dong Jinyi, Ambasciatore Straordinario e Plenipotenziariodella Repubblica Popolare Cinese in Italia dal 2005, è nato aTianjin nel 1949. Laureato, sposato, con un figlio. Ha iniziato la carriera diplomatica nel 1974 presso l’Amba-sciata Cinese in Francia.Nominato nel 1990 primo segretario del Cerimoniale del Mi-nistero degli Affari Esteri Cinese, ha raggiunto il titolo di Con-sigliere nel 1994.Ministro-Consigliere all’Ambasciata della Repubblica Popola-re Cinese in Belgio nel 1997, è stato Vice Direttore della Dire-zione Generale del Ministero degli Affari Esteri Cinese dal2000 al 2002 e Direttore Generale dal 2002 al 2005.
Gentile Ambasciatore, l’articolo che apre questo numero della nostra rivista offreun quadro socio-economico sintetico della Cina attuale, per soffermarsi poi sul Pro-gramma Nazionale sui Cambiamenti Climatici prodotto nello scorso mese di giu-gno, con il quale il paese delinea la propria strategia politica volta a combattereil riscaldamento globale ed i cambiamenti climatici. Quali sono a suo parere le
misure più rilevanti da mettere in cam-po?Innazitutto vorrei ringraziare la vostra rivistaper questa opportunità di presentare il qua-dro dello sviluppo economico e dell’ambien-te in Cina. Il governo cinese presta grande attenzioneal problema del cambiamento climatico, in-tegrando la politica di contenimento di que-sto fenomeno con la strategia nazionale disviluppo sostenibile, per la costruzione diuna società armoniosa e di un paese innova-
tivo che tenga conto del risparmio energetico, dei problemi ambientali, dell’equilibrio del-lo sviluppo economico nazionale e locale, per mitigare le emissioni di gas serra e migliora-re la sua capacità di adattamento ai cambiamenti climatici. L’obiettivo strategico cinese inrelazione ai cambiamenti climatici è quello di ottenere significativi risultati nel controllodelle emissioni di gas serra, di rafforzare la capacità di adattamento, di promuovere lo svi-luppo della scienza e tecnologia e gli investimenti in ricerca e sviluppo, di sensibilizzarel’opinione pubblica, di rafforzare ulteriormente le istituzioni e i meccanismi connessi con lamitigazione del cambiamento climatico. La Cina è impegnata ad adottare le misure legislative, politiche, economiche, amministra-tive e tecnologiche al fine di raggiungere questi obiettivi. Rispetto all’anno 2005, al 2010 èprevista la riduzione del 20% del consumo energetico per unità di PIL e della quantità to-tale delle emissioni da principali inquinanti del 10%, mentre il contributo delle fonti rinno-vabili raggiungerà il 10% dell’energia primaria totale e l’estensione delle foreste coprirà il20% del territorio nazionale. Il governo cinese svilupperà l’innovazione tecnologica e scien-tifica con l’obiettivo di raggiungere una posizione di avanguardia a livello internaziona-le nel settore del cambiamento climatico per definire efficaci strategie politiche parteci-pando attivamente alle iniziative internazionali.
l’in
terv
ista
Intervista a Dong Jinyi
A cura di Paola Molinas

Il governo cinese ha definito 5 linee di sviluppo nel settore delle fonti energetiche nuove erinnovabili: la generazione elettrica da energia solare, con particolare riguardo al settoreresidenziale, da biomassa, da energia eolica; l’idrogeno e le celle a combustibile; gli idratidi metano.
La discussione su Kyoto è incentrata prevalentemente sulle emissioni correntimentre la Cina, così come tutti i paesi in via di sviluppo, si richiama spesso alconcetto della responsabilità storica (assente peraltro nel dibattito negoziale).Questi due concetti risultano essere incompatibili sul terreno negoziale. Sembratuttavia che i Paesi Annex 11 vogliano cominciare a ragionare anche sul temadella responsabilità storica. La Cina è disposta allo stesso passo e a consideraredunque con attenzione il livello attuale delle proprie emissioni come un seriopericolo per il Pianeta?Il cambiamento climatico è un problema a carattere globale che riguarda sia l’ambienteche lo sviluppo, ma fondamentalmente lo sviluppo. Come rilevato dalla Convenzione Qua-dro delle Nazioni Unite sul Cambiamento Climatico (UNFCCC), la quota più consistente diemissioni di gas serra storiche e attuali a livello globale è stata prodotta dai paesi svilup-pati, mentre per i paesi in via di sviluppo le emissioni pro-capite sono ancora relativamen-te basse e quelle globali cresceranno come conseguenza dello sviluppo economico e so-ciale. L’UNFCCC stabilisce chiaramente che i paesi aderenti alla Convenzione dovrannoproteggere il clima a beneficio delle generazioni presenti e future su una base di equità, se-condo responsabilità comuni ma differenziate e specifiche capacità e che il gruppo deipaesi sviluppati dovrà essere in prima linea nel combattere il cambiamento climatico ed i suoieffetti negativi. I dati mostrano che dalla rivoluzione industriale fino al 1950, i paesi indu-strializzati hanno prodotto il 95% delle emissioni di CO2, a causa dell’utilizzazione di fon-ti fossili. In 50 anni, dal 1950 al 2000, le emissioni dei paesi industrializzati hanno rappresen-tato il 77% delle emissioni totali. Quindi i paesi industrializzati devono assumersi la maggio-re responsabilità per i cambiamenti climatici ed hanno gli obblighi maggiori a ridurre leloro emissioni, investendo in tecnologie per aiutare i paesi in via di sviluppo a contrasta-re il cambiamento climatico. Secondo i dati del World Energy Outlook 2006, nel 2004 leemissioni di CO2 pro capite in Cina erano di 3,65 tonnellate, pari solo all’87% della mediamondiale e al 33% di quella dei paesi OCSE. Altri dati indicano che negli anni compresifra il 1950 e il 2002, le emissioni pro capite cinesi di CO2 occupavano il 92° posto nella clas-sifica mondiale. La Cina, quale grande paese in via di sviluppo, attribuisce enorme attenzio-ne al problema del cambiamento climatico ed ha quindi istituito un Leading Group na-zionale per affrontare questo tema, operando nel campo del risparmio energetico e dellariduzione delle emissioni. Sotto la guida del Primo Ministro Wen Jiabao è stata adottata unaserie di politiche e di misure per affrontare il cambiamento climatico secondo la strategiadello sviluppo sostenibile. Il governo cinese ha firmato il Protocollo di Kyoto nel 1998 rati-ficandolo nel 2002 e, secondo quanto previsto dall’UNFCCC, ha approvato un Program-ma Nazionale per il Cambiamento Climatico con la definizione di obiettivi, settori priorita-ri di intervento, politiche e misure fino al 2010. L’art. 4, paragrafo 7 dell’UNFCCC prevedeche “la portata con la quale il gruppo dei paesi in via di sviluppo attuerà i propri impegnisecondo la Convenzione, dipenderà dalla effettiva attuazione dei propri impegni da par-te del gruppo dei paesi sviluppati riguardo alle risorse finanziarie e al trasferimento del-le tecnologie e terrà conto pienamente che lo sviluppo economico e sociale e lo sradica-mento della povertà rappresentano le priorità per il gruppo dei paesi in via di sviluppo”.
Intervista a Dong Jinyi
l’in
terv
ista
ENERGIA, AMBIENTE E INNOVAZIONE 6/2007 13
1. In ambito UNFCCC gli “Annex 1 Parties” sono i paesi industrializzati.

Paola Molinas
In quest’ottica, pur perseguendo lo sviluppo economico e sociale, la Cina sarà fortementeimpegnata in iniziative di cooperazione con la comunità internazionale e con i singoli pae-si, volte ad agire sul cambiamento climatico in termini sia di mitigazione che di adatta-mento, con il fine di costruire una società in armonia con l’ambiente.
Il boom economico degli ultimi venti anni ha prodotto un forte aumento deiconsumi di energia. La Cina, quantunque paese produttore, ha necessità di im-portare risorse energetiche in maniera massiccia. Quali sono i suoi mercati pri-vilegiati e quali politiche intende mettere in atto per ridurre questa dipenden-za energetica?Dal 1978 al 2005, il consumo di energia primaria in Cina ha avuto un incremento annualedel 5,16%. Il grado di autosufficienza energetica è pari al 90%, superiore del 20% rispet-to alla media dei paesi OCSE e del 30% rispetto a quello degli Stati Uniti. Per il propriofabbisogno, la Cina importa petrolio e gas naturale. Nel 2005, l’importazione netta delpetrolio ammonta a 136 milioni di tonnellate, equivalenti al 5,5% del commercio mon-diale, mentre nello stesso periodo gli Stati Uniti sono stati importatori netti di 613 milionidi tonnellate, equivalenti al 25% del commercio mondiale, 4,5 volte superiore alla quotacinese. La Cina è anche un grande produttore di energia, con immense risorse di carbo-ne, di acqua ed altre fonti che hanno una grande potenzialità di sviluppo. Il governo ci-nese ha intensificato gli sforzi per sviluppare le tecnologie e le energie rinnovabili e nuoveforme di energia per ridurre la dipendenza dall’estero, ed ha lanciato una campagna peril risparmio energetico e la riduzione delle emissioni in tutto il paese. Come paese in viadi sviluppo la Cina ha l’esigenza di sviluppare la cooperazione internazionale nel settore del-l’energia per la riduzione delle emissioni di gas serra. Il paese è attualmente impegnatonella costruzione di infrastrutture su vasta scala ed ha un forte fabbisogno di tecnologie permitigare l’emissione dei gas serra, in particolar modo le tecnologie avanzate dei settorienergetico e manifatturiero, di nuovi materiali per l’edilizia ecc.
Il 1° gennaio 2006 è entrata in vigore nel suo paese la legge sulle Energie rinno-vabili, che rappresenta un passo decisivo per migliorare la sicurezza energetica ela tutela ambientale. Una recente analisi condotta da Frost & Sullivan sostieneche questa legge aumenterà “la capacità di energie rinnovabili della Cina fino araggiungere il 16% entro il 2020, il che costituirebbe un aumento dell’8,5% ri-spetto al 2006”. Quali sono in particolare le fonti sulle quali punta il paese?Ha ragione lei, lo sviluppo delle energie rinnovabili è uno degli obiettivi della Cina perpercorrere la strada dello sviluppo sostenibile. Il governo presta attenzione a tutte le for-me di energia rinnovabile che vengono sviluppate secondo le caratteristiche locali: nellearee rurali e più remote, ad esempio vengono utilizzate l’energia solare, la geotermia,l’eolica e le biomasse, mentre nelle zone costiere viene sviluppata l’energia dalle maree.Al tempo stesso è impegnato nella produzione di energia elettrica da carbone a basseemissioni, da nucleare, idroelettrico e dal gas naturale ed in generale da tutte le fonti rin-novabili. Vorrei sottolineare inoltre che il Primo Ministro Wen Jiabao ha ripetutamenteasserito che le colture per lo sviluppo della bioenergia non devono mai entrare in compe-tizione con quelle di cereali, nel senso che mai l’energia può rischiare di comprometterel’agricoltura a fini alimentari né mai danneggiare l’ambiente.
Dopo qualche anno di stasi alla fine degli anni Novanta, attualmente, per la cre-scita apparentemente senza controllo dei prezzi del petrolio (e conseguentemen-te di gas naturale e carbone), i timori sulla stabilità dei paesi produttori e lel’
inte
rvista
ENERGIA, AMBIENTE E INNOVAZIONE 6/2007 14

preoccupazioni crescenti per il riscaldamento globale del pianeta, è di nuovo vi-vo in tutto il mondo un forte interesse per il nucleare. Qual è il programma del-la Cina in questo ambito?La Cina persegue da tempo la politica dell’utilizzazione pacifica dell’energia nucleare qua-le parte fondamentale della strategia nazionale. Nel 1991 la Cina ha costruito la sua primacentrale elettrica nucleare nel Qinshan. Ad oggi, il paese dispone di 6 centrali in produ-zione con una potenza di 9,068 GW, mentre altre sono in costruzione per una potenza7,9 GW. Le caratteristiche di sicurezza, la data di costruzione e il livello di attività rendo-no le centrali cinesi notevolmente migliori rispetto alla media mondiale. Abbiamo pianifi-cato che al 2020 la capacità installata raggiungerà i 40 GW, con una produzione elettrica paria 260-280 miliardi KWh e con una eventuale capacità aggiuntiva di 23 GW; con questi risul-tati il nucleare contribuirà per il 4% alla fornitura di energia primaria. In Cina è in corsouna forte politica di sviluppo nazionale dell’industria dell’energia nucleare, anche con l’im-portazione di tecnologie per migliorare la capacità totale.
Ricerca e innovazione tecnologica: è stato pubblicato recentemente un rappor-to dell’OCDE sulle politiche della Cina in questi settori, che rivela quanto dallafine degli anni Novanta ad oggi il paese abbia sviluppato proprie capacità inno-vative ed abbia radicalmente cambiato la struttura delle esportazioni. Qual è il ruo-lo di ricerca e innovazione nello sviluppo economico del paese, di quale entitàsono i finanziamenti destinati alla ricerca e verso quali settori in particolare sonodiretti?La Cina è impegnata con tutti i mezzi a disposizione a costruire una paese innovativo esenza dubbio ricerca e innovazione giocheranno un ruolo cruciale in questo senso. Nelpiano dello sviluppo scientifico e tecnologico nel medio e lungo periodo, il tasso del contri-buto della scienza e tecnologia arriverà al 60% (gli investimenti in R&S rappresenterannoil 2,5% del PIL). Gli investimenti del governo saranno indirizzati ad undici obiettivi: energie,risorse idriche e minerali, ambiente, agricoltura, manifatturiero, trasporti, industrie infor-matiche e servizi moderni, popolazione e salute, urbanizzazione e sviluppo urbano, sicurez-za pubblica, difesa nazionale.
Tornando al Programma nazionale sui cambiamenti climatici, esso menziona fragli strumenti da utilizzare anche quello della cooperazione internazionale in cam-po tecnologico. Lo scorso 14 settembre il Prof. Luigi Paganetto, Presidente del-l’ENEA, ha accolto la delegazione cinese guidata dal Ministro della Scienza e Tec-nologia della Repubblica Popolare Cinese, Wan Gang, per una visita ai laborato-ri della Casaccia. Quali sono i progetti ENEA in campo energetico ritenuti più in-teressanti dal suo paese?La collaborazione con l’ENEA è un capitolo importante all’interno del rapporto scientifi-co e tecnologico tra Cina e Italia. Il Vice Ministro Shang Yong del Ministero della Scienza edella Tecnologica cinese (MOST) ha firmato con il Presidente Luigi Paganetto un accordoquadro sulla cooperazione, che individua le aree principali dell’energia, dell’ambiente edelle nuove tecnologie. Il governo della Provincia di Guangdong ha firmato nel gennaio2007 un memorandum d’intesa sulla cooperazione nel campo del solare termico. Il nuoveMinistro del MOST Wan Gang si è recato nei centri di ricerca ENEA nel settembre scorso, du-rante la sua prima visita ufficiale in Italia, e ciò mostra significativamente l’importanza chela Cina attribuisce alla collaborazione con l’ENEA. Oltre che sul solare termico, il Ministeroauspica una collaborazione anche nel settore della generazione da energia eolica e da so-lare, dal fotovoltaico a batteria, dalle biomasse e dall’idrogeno.
Intervista a Dong Jinyi
l’in
terv
ista
ENERGIA, AMBIENTE E INNOVAZIONE 6/2007 15

Cina ed India sono i giganti emergen-ti dell’economia mondiale e dei merca-ti internazionali dell’energia. Lo svilup-po energetico di Cina ed India sta trasfor-mando il sistema energetico mondiale perl’importanza delle loro dimensioni e del lo-ro peso crescente nel commercio interna-zionale dei combustibili fossili. Analogamen-te, entrambi i paesi sono sempre più espostialle variazioni dei mercati energetici mon-diali. I marcati tassi di crescita economica diCina ed India negli ultimi anni, piú alti diquelli di tutti gli altri principali paesi, han-no aumentato in maniera netta i fabbiso-gni energetici di questi due paesi, costrettiad importare sempre di più. Queste tenden-ze economiche sembrano destinate a con-tinuare e a mantenere forte la crescita del-la loro domanda di energia. Diventando piùricchi, gli abitanti di Cina ed India utilizza-no sempre più energia per uffici e industrie,e acquistano un numero crescente di appa-recchiature elettriche e automobili. Questocontribuisce ad un netto miglioramento del-la loro qualità di vita, aspirazione legittimache deve essere favorita ed aiutata dal re-sto del mondo.
ENERGIA, AMBIENTE E INNOVAZIONE 6/2007 16
Cina e India sono i giganti emergenti nell’economia mondiale.Il tasso di crescita senza precedenti
della loro economia richiederàancora più energia, migliorandoanche il livello di vita di miliardi
di persone. Ma come si può giungeread un sistema energetico più sicuroed a minor contenuto di carbonio?
Il WEO 2007, del quale pubblichiamo
la sintesi ufficiale, fornisce alcune risposte
riflettore
su
World Energy Outlook 2007
China and IndiaInsights
China and India are the emerging giants in the global economy. The unprecedented growth
rates of their economies will improve billions of people’s standard of living but will require ever
more energy. But how can an energy system be madesafer and with less carbon content?
World Energy Outlook 2007, of which we publish the official summary,
gives some answers
World EnergyOutlook 2007
China and India Insights
International Energy Agency

World Energy Outlook 2007 - China and India Insights
riflettore
su
ENERGIA, AMBIENTE E INNOVAZIONE 6/2007 17
Le conseguenze per Cina ed India, peri paesi OCSE e per il resto del mondodi una crescita incontrollata della do-manda mondiale di energia sono, tut-tavia, allarmanti. Se i governi del mon-do si fermassero alle attuali politiche, pre-messa di base del nostro Scenario di Riferi-mento, i fabbisogni energetici mondiali,nel 2030, sarebbero oltre il 50% più eleva-ti rispetto ad oggi. In questo scenario Cinaed India, considerate insieme, contano peril 45% dell’aumento della domanda mon-diale. A livello globale, i combustibili fos-sili continuano ad essere la principale fon-te di energia. Complessivamente, i combu-stibili fossili continuano ad essere prepon-deranti nel mix energetico. Questi trendportano ad un continuo aumento delleemissioni di anidride carbonica (CO
2) lega-
te al consumo di energia e ad un aumentodella dipendenza dei paesi consumatoridalle importazioni di petrolio e gas, in granparte provenienti da Medio Oriente e Rus-sia. Entrambi questi fattori aumentereb-bero le preoccupazioni riguardanti il climae la sicurezza energetica. La sfida che si presenta a tutti i paesidel mondo è quella di creare le condi-zioni per un sistema energetico più si-curo e a più basso contenuto di carbo-nio, senza rallentare lo sviluppo eco-nomico e sociale. Questa sfida sarà piùimpegnativa e di maggior importanza inCina ed India che nel resto del mondo. Perindirizzare il mondo verso un percorsoenergetico più sostenibile sono necessarieazioni politiche decise, immediate e coordi-nate da parte di tutti i governi. Nella mag-gior parte dei paesi, alle parole non sonoseguite adeguate misure pratiche. Se tuttele politiche attualmente in esame da partedei governi nei diversi paesi fossero attua-te, come ipotizzato nello Scenario Alter-nativo, sia la domanda mondiale di ener-gia mondiale sia le relative emissioni ver-rebbero sostanzialmente ridotte. I provve-dimenti volti a migliorare l’efficienza ener-
getica si rivelano essere il sistema più eco-nomico e veloce per frenare l’aumento del-la domanda e delle emissioni a breve termi-ne. Anche in questo Scenario, tuttavia, leemissioni di CO
2nel 2030 sono ancora più
elevate di un quarto rispetto ai livelli at-tuali. Per ottenere una riduzione molto piùsignificativa delle emissioni, bisognerebbeattuare immediatamente misure politichee trasformazioni tecnologiche senza pre-cedenti. Le proiezioni di entrambi gli Scenari,quello di Riferimento e quello Alter-nativo, si basano su ipotesi di cresci-ta economica dei due giganti che sipotrebbero considerare conservative.Esse si basano su un costante e marcatorallentamento dei tassi di crescita duranteil periodo considerato. In uno Scenario diCrescita Elevata, che ipotizza che l’econo-mia di Cina ed India aumentino in mediadi 1,5 punti percentuali per anno più rapi-damente rispetto allo Scenario di Riferi-mento (sebbene più lentamente del recen-te passato), la domanda di energia in Cinaed India considerate insieme è, nel 2030,del 21% più elevata. L’incremento mon-diale della domanda di energia risulta pa-ri al 6%, rendendo ancora più urgente peri governi del mondo attuare misure poli-tiche, quali quelle considerate nello Scena-rio Alternativo, per frenare la domanda dienergia legata ai combustibili fossili e lerelative emissioni.
Il mondo affronta un futuro legatoai combustibili fossili fino al 2030
Nello Scenario di Riferimento, i fab-bisogni di energia primaria mondia-le aumentano del 55% tra il 2005 edil 2030, con un tasso medio annuopari al 1,8%. La domanda raggiunge i17,7 miliardi di tonnellate equivalenti dipetrolio (tep), rispetto ai 11,4 miliardi ditep nel 2005. Nell’arco di tempo com-preso tra il 2005 ed il 2030, i combusti-

International Energy Agengy
riflettore
su
ENERGIA, AMBIENTE E INNOVAZIONE 6/2007 18
bili fossili continuano a rimanere la prin-cipale fonte di energia primaria, soddi-sfacendo l’84% dell’aumento totale del-la domanda. Il petrolio rimane il com-bustibile più utilizzato, nonostante lasua percentuale nella domanda mondia-le subisca una fiessione dal 35% al 32%.La domanda di petrolio raggiunge i 116milioni di barili al giorno nel 2030, 32 inpiù rispetto al 2006, equivalente al 37%di aumento. In linea con il marcato au-mento degli ultimi anni, il carbone re-gistra il più grande incremento della do-manda in termini assoluti, aumentandodel 73% tra il 2005 ed il 2030, e vedendocrescere in tal modo la propria percen-tuale nella domanda totale di energiadal 25% al 28%. La maggior parte del-l’incremento del consumo di carbone èrichiesto da Cina ed India. Anche la per-centuale del gas naturale aumenta, perquanto in misura minore, dal 21% al22%. Il consumo di energia elettrica rad-doppia, e la sua percentuale nel consu-mo finale di energia sale dal 17% al22%. Per soddisfare la domanda mon-diale prevista saranno necessari investi-menti per le infrastrutture per l’approv-vigionamento energetico pari a circa 22mila miliardi di dollari. Una delle sfidefuture è il finanziamento di questi inve-stimenti. I paesi emergenti, dove economia epopolazione crescono più rapida-mente, assorbono il 74% dell’au-mento del consumo mondiale dienergia primaria, in questo scena-rio. Cina ed India da sole contano per il45% di questo aumento. I paesi OCSEcontano per un quinto e le economie intransizione per il restante 6%. Comples-sivamente, i paesi emergenti contanoper il 47% del mercato mondiale dell’e-nergia nel 2015, fino ad arrivare a piùdella metà nel 2030, partendo dal 41%attuale. La percentuale dei paesi emer-genti nella domanda mondiale aumen-
ta per tutte le fonti di energia primaria,con l’esclusione delle rinnovabili diver-se dall’idroelettrico. Circa metà dell’au-mento della domanda mondiale è im-piegata per la generazione di energiaelettrica e un quinto viene assorbito dalsettore del trasporto, quasi interamen-te sotto forma di derivati del petrolio.Le risorse mondiali di petrolio sono rite-nute sufficienti per soddisfare la crescitadella domanda prevista al 2030, con laproduzione che si concentra sempre piùnei paesi OPEC, a condizione che venga-no finanziati gli investimenti necessari.Nello Scenario di Riferimento, la produ-zione complessiva nei paesi OPEC digreggio convenzionale, di frazioni liqui-de di gas naturale e di petrolio non con-venzionale (principalmente la liquefa-zione del gas) sale dai 36 milioni di bari-li al giorno del 2006 ai 46 nel 2015, finoad arrivare a 61 milioni di barili al gior-no nel 2030. Di conseguenza, la percen-tuale dei paesi OPEC sul totale della pro-duzione mondiale di petrolio sale dal42% attuale al 52% entro la fine del pe-riodo considerato. La produzione deipaesi non OPEC aumenta lentamente fi-no al 2030. La maggior parte dell’au-mento è dato dalle fonti non conven-zionali, soprattutto le sabbie oleose ca-nadesi, mentre la produzione conven-zionale si stabilizza a circa 47 milioni dibarili al giorno attorno al 2015. Questeproiezioni si basano sul presupposto cheil prezzo medio del petrolio greggio im-portato nei paesi della IEA cali dagli ele-vati livelli attuali di più di 75 dollari perbarile ai circa 60 dollari (in dollari del2006) entro il 2015, per poi riaumentarelentamente, fino ad arrivare a 62 dolla-ri (equivalenti a 108 dollari in termininominali) entro il 2030. Nonostante siaprevisto un incremento nei prossimi cin-que anni della capacità produttiva di pe-trolio da progetti greenfield, rimane tut-tavia molto incerto se tale aumento sarà

World Energy Outlook 2007 - China and India Insights
riflettore
su
ENERGIA, AMBIENTE E INNOVAZIONE 6/2007 19
sufficiente per compensare il declino del-la produzione dei campi esistenti e pertenere il passo con il previsto incremen-to della domanda. Una contrazione del-l’offerta entro il 2015, comportante unbrusco rialzo dei prezzi del petrolio, nonpuò essere esclusa. La ripresa del carbone, determinatasoprattutto dal boom della doman-da di energia elettrica in Cina ed In-dia, è una differenza importante ri-spetto alle edizioni precedenti del-lo WEO. Prezzi più elevati di petrolio egas rendono il carbone più competitivocome combustile per la generazione dibase. Cina e India, che già utilizzano il45% del carbone mondiale contano, nel-lo Scenario di Riferimento, per più diquattro quinti dell’aumento fino al 2030.Nei paesi OCSE, il consumo di carboneaumenta in maniera molto lenta, con lamaggior parte dell’incremento dovutoagli Stati Uniti. In tutte le regioni, le pre-visioni sull’utilizzo del carbone dipendo-no soprattutto dal suo prezzo in relazio-ne agli altri combustibili fossili, dalle mi-sure politiche volte alla diversificazionedelle fonti energetiche, dal cambiamen-to climatico e dall’inquinamento atmo-sferico, dagli sviluppi delle tecnologieper la produzione di energia elettricacon carbone pulito. Ci si aspetta che unlargo impiego di tecnologie più efficien-ti per la produzione di energia elettricariduca il fabbisogno di carbone per ge-nerare un kWh di energia elettrica, maaumenti l’interesse per il carbone rispet-to ad altre forme di energia, incremen-tandone in tal modo la domanda. Nello Scenario Alternativo, la domandamondiale di energia primaria aumentadell’1,3% annuo durante il periodo2005-2030, mezzo punto percentuale inmeno rispetto allo Scenario di Riferimen-to. Nel 2030, la domanda mondiale dipetrolio è più bassa di 14 milioni di bari-li al giorno, cifra equivalente all’attua-
le produzione complessiva di Stati Uni-ti, Canada e Messico. Il carbone subiscela fiessione più marcata, sia in assolutoche in percentuale. Le emissioni di CO
2le-
gate al consumo energetico si stabiliz-zano attorno alla seconda decade e, nel2030, sono inferiori del 19% rispetto al-lo Scenario di Riferimento. Nello Scena-rio di Crescita Elevata, l’aumento più ra-pido dell’economia di Cina ed India, inassenza di cambiamenti politici, spingeal rialzo la loro domanda di energia.Questo aumento é maggiore della con-trazione della domanda causata dall’au-mento dei prezzi dell’energia. A livellomondiale, la domanda di energia prima-ria aumenta di circa 6% nel 2030 rispet-to allo Scenario di Riferimento. La do-manda risulta più elevata in alcune re-gioni ed inferiore in altre.
Il peso della Cina nella domandamondiale di energia continueràad aumentare
È quasi indubbio che la Cina conti-nuerà a aumentare i fabbisogni ener-getici per alimentare il proprio svilup-po economico. Tuttavia, lo sono moltomeno il tasso di crescita ed il modo concui questi fabbisogni saranno soddisfat-ti, poiché dipendono dalla velocità diespansione dell’economia e dal panora-ma mondiale economico e delle politi-che energetiche. Nello Scenario di Rife-rimento, si prevede che la domanda dienergia primaria in Cina più che raddop-pi passando da 1.742 milioni di tep nel2005 a 3.819 milioni di tep nel 2030, conun tasso di crescita medio annuo pari al3,2%. La Cina, con una popolazionequattro volte superiore, sorpassa gli Sta-ti Uniti diventando il più grande paeseconsumatore poco dopo il 2010. Nel2005, la domanda degli Stati Uniti erapiù alta di un terzo. Fino al 2015, la do-manda della Cina aumenta del 5,1% an-

International Energy Agengy
riflettore
su
ENERGIA, AMBIENTE E INNOVAZIONE 6/2007 20
nuo, grazie soprattutto alla continuaespansione dell’industria pesante. Più alungo termine, la domanda rallenta conil maturare dell’economia, con lo spo-stamento della struttura della produzio-ne verso attività a minore intensità ener-getica e con l’introduzione di tecnolo-gie più efficienti dal punto di vista ener-getico. La domanda di petrolio del setto-re del trasporto quasi quadruplica nelperiodo preso in considerazione (2005-2030), contribuendo così per più di dueterzi all’aumento totale della domandadi petrolio in Cina. Il parco veicoli au-menta di sette volte, raggiungendo qua-si i 270 milioni. La vendita di nuovi veico-li in Cina supera quella degli Stati Unitiintorno al 2015. Le nuove normative peri carburanti, adottate nel 2006, attenua-no comunque l’aumento della doman-da di petrolio. L’aumento della ricchezzasostiene la forte crescita del settore im-mobiliare, l’uso di apparecchiature elet-triche, di riscaldamento e di raffredda-mento degli ambienti. Il maggior utiliz-zo di combustibili fossili provoca un au-mento delle emissioni di CO
2e delle so-
stanze inquinanti locali, specialmentenei primi anni del periodo considerato:le emissioni di SO
2, per esempio, passano
da 26 milioni di tonnellate nel 2005 a 30milioni di tonnellate nel 2030. Le risorse energetiche della Cina,ed in modo particolare il carbone,sono notevoli, ma non saranno suf-ficienti per soddisfare tutto l’au-mento dei suoi fabbisogni energe-tici. Più del 90% delle risorse di carbo-ne della Cina si trova nelle province in-terne, mentre si prevede che il maggio-re aumento della domanda sia richiestonella regione costiera. Questo aumen-ta la pressione sul trasporto interno dicarbone e rende le importazioni versole zone costiere più competitive. Nellaprima metà del 2007, la Cina è diventa-ta un netto importatore di carbone. Nel-
lo Scenario di Riferimento, le importa-zioni nette raggiungono, nel 2030, il3% della domanda interna ed il 7% delcommercio internazionale di carbone.La produzione di petrolio convenziona-le in Cina raggiunge il suo apice a 3,9milioni di barili al giorno all’inizio delprossimo decennio, per poi cominciare adiminuire. Di conseguenza, le importa-zioni nette di petrolio in Cina salgonoda 3,5 milioni di barili al giorno nel 2006fino a 13,1 milioni di barili al giorno nel2030, mentre la loro percentuale sulladomanda cresce dal 50% all’80%. An-che le importazioni di gas naturale au-mentano rapidamente, poiché l’incre-mento della produzione durante il pe-riodo delle previsioni risulta più lentodi quello della domanda. La Cina deveaggiungere più di 1300 GW alla propriacapacità di produzione elettrica, corri-spondente a più dell’attuale capacitàcomplessiva installata negli Stati Uniti. Ilcarbone rimane il combustibile princi-pale per la produzione di energia elet-trica. Gli investimenti complessivi per leinfrastrutture energetiche in Cina am-montano a 3.7 mila miliardi di dollari(in dollari del 2006) per il periodo consi-derato, tre quarti dei quali viene richie-sto dal settore elettrico.La Cina sta già compiendo notevolisforzi per risolvere i problemi derivan-ti dal crescente consumo di energia,ma saranno necessarie misure ancorapiù decise.La Cina sta cercando di intensificare leproprie politiche energetiche ed il si-stema di regole e di strutture istituzio-nali per risolvere i problemi attuali e lesfide future. Nello Scenario Alternati-vo, un ventaglio di provvedimenti at-tualmente in esame porterebbe, nel2030, ad una riduzione del consumo dienergia primaria di circa il 15% rispettoallo Scenario di Riferimento. Le emis-sioni di CO
2e degli inquinanti locali di-

World Energy Outlook 2007 - China and India Insights
riflettore
su
ENERGIA, AMBIENTE E INNOVAZIONE 6/2007 21
minuiscono in misura ancora maggio-re. Nello Scenario Alternativo, tuttavia,la domanda di energia aumenta di qua-si il 90%, tra il 2005 ed il 2030. Il 60%del risparmio energetico è dato da mi-glioramenti dell’efficienza lungo l’in-tera filiera energetica e da sostuzionetra fonti energetiche. Ad esempio, iprovvedimenti per veicoli più efficientidal punto di vista energetico portanoad importanti risparmi nel consumo diderivati del petrolio. Cambiamentistrutturali dell’economia sono alla basedei restanti risparmi energetici. La do-manda di carbone e petrolio viene so-stanzialmente ridotta. Al contrario, ladomanda per gli altri combustibili, qua-li il gas naturale, il nucleare e le rinno-vabili, aumenta. In questo scenario, l’o-biettivo del governo di diminuire del20% l’intensità energetica (l’energiaconsumata per unità di PIL) tra il 2005ed il 2010, è raggiunto poco oltre taledata. La maggior parte delle misureconsiderate ha un periodo di ritornodegli investimenti molto breve. Inoltre,ogni dollaro investito in apparecchia-ture elettriche più efficienti porta adun risparmio di 3,50 dollari sugli inve-stimenti per l’approvvigionamento. Glisforzi compiuti dalla Cina per migliora-re l’efficienza dei veicoli e delle appa-recchiature elettriche contribuisconoad un miglioramento dell’efficienza an-che nel resto del mondo, poiché la Ci-na è un netto esportatore di questi pro-dotti. Queste misure politiche risulte-rebbero ancora più importanti nel ca-so che l’economia cinese aumentassepiù rapidamente di quanto previsto nel-lo Scenario di Riferimento e in quelloAlternativo. Nello Scenario di CrescitaElevata, la domanda di energia prima-ria della Cina è più alta del 23%, nel2030, ed il solo consumo di carbone del21% più elevato rispetto a quello del-lo Scenario di Riferimento.
Analogamente, il consumo di energia dell’India è destinato a una rapida crescita
La rapida crescita economica conti-nuerà inoltre ad aumentare la do-manda di energia dell’India, incre-mentandone il peso nel consumo dienergia mondiale. Nello Scenario diRiferimento, la domanda di energia pri-maria dell’India più che raddoppia en-tro il 2030, con un aumento medio an-nuo del 3,6%. Il carbone rimane il com-bustibile principale in India, con un con-sumo quasi triplicato tra il 2005 ed il2030. Il settore elettrico è responsabiledella maggior parte dell’aumento delladomanda di energia primaria, a causadell’incremento della domanda di elettri-cità nell’industria e negli edifici residen-ziali e commerciali, con la maggior par-te della nuova capacità di produzionealimentata dal carbone. Tra gli utilizzifinali, il settore dei trasporti registra lacrescita più veloce della domanda dienergia, in seguito ad una rapida espan-sione del parco veicoli, dovuto all’au-mento dell’attività economica e della ric-chezza. La domanda del settore residen-ziale aumenta molto più lentamente,principalmente a causa della sostituzio-ne della biomassa tradizionale, attual-mente utilizzata in modo molto ineffi-ciente, con combustibili moderni. Il nu-mero di abitanti che utilizzano la bio-massa per la cottura di cibi e per il riscal-damento si riduce da 668 milioni nel2005 a circa 470 milioni nel 2030, mentrela percentuale della popolazione con ac-cesso all’energia elettrica sale dal 62%al 96%. La maggior parte dei fabbisogni ag-giuntivi di energia dell’India al 2030dovrà essere importata. È sicuro chel’India continuerà a dipendere dalle im-portazioni di carbone a causa della qua-lità richiesta dalle acciaierie e per moti-

International Energy Agengy
riflettore
su
ENERGIA, AMBIENTE E INNOVAZIONE 6/2007 22
vi economici, poiché le centrali sono si-tuate lontane dalle miniere ma vicine aiporti. Nello Scenario di Riferimento, siprevede che le importazioni totali di car-bone aumentino di quasi sette volte, conla loro percentuale sulla domanda tota-le di carbone che aumenta dal 12%, nel2005, fino al 28% nel 2030. Anche le im-portazioni nette di petrolio aumentanoin maniera sostenuta, fino a 6 milioni dibarili al giorno nel 2030, dal momentoche le accertate riserve nazionali di pe-trolio sono esigue. Prima del 2025, l’In-dia sorpassa il Giappone diventando ilterzo importatore netto mondiale di pe-trolio, dietro Stati Uniti e Cina. D’altraparte, l’importanza dell’India comeesportatore di prodotti petroliferi raffi-nati continua ad aumentare, a condizio-ne che gli investimenti necessari sianofinanziati. Nonostante ci si aspetti chele recenti scoperte portino ad un aumen-to della produzione di gas, si prevedeche essa raggiunga il suo tra il 2020 ed il2030, e che poi cominci a calare. Unaquota crescente dei fabbisogni di gasdell’India deve, quindi, essere soddisfat-ta dalle importazioni, quasi interamen-te sotto forma di gas liquefatto. La ca-pacità di generazione elettrica, la mag-gior parte della quale è alimentata a car-bone, più che triplicherà tra il 2005 edil 2030. La capacità aggiuntiva totale su-pera i 400 GW, quanto l’attuale capacitàcomplessiva di Giappone, Corea del Suded Australia. Nello Scenario di Riferimen-to, per soddisfare la domanda di ener-gia prevista, l’India deve investire, nel-l’arco di tempo compreso tra il 2006 edil 2030, circa 1,25 mila miliardi di dollariper le infrastrutture energetiche, trequarti dei quali nel settore elettrico. At-trarre adeguati investimenti per il set-tore dell’energia in tempi relativamentebrevi, una sfida impegnativa per l’India,sarà fondamentale per sostenere la cre-scita economica.
Provvedimenti più decisi attualmen-te all’esame del governo indiano po-trebbero portare ad importanti rispar-mi energetici. Nello Scenario Alternativo,la domanda di energia primaria dell’In-dia, nel 2030, è inferiore del 17% rispettoallo Scenario di Riferimento. I risparmi dicarbone, soprattutto per la produzionedi energia elettrica, sono i maggiori sia inassoluto che in percentuale, grazie ad unminore aumento della domanda di elet-tricità, ad una migliore efficienza nellagenerazione di energia elettrica ed allasostituzione tra fonti energetiche per laproduzione di energia elettrica e per usiindustriali. Come risultato, nel 2030 le im-portazioni di carbone nello Scenario Al-ternativo sono poco più della metà diquelle dello Scenario di Riferimento. Leimportazioni di petrolio sono di 1,1 mi-lioni di barili al giorno inferiori, nel 2030,rispetto allo Scenario di Riferimento, ma ladipendenza dalle importazioni di petro-lio rimane comunque alta, al 90%. Un mi-nor utilizzo dei combustibili fossili portaad una riduzione delle emissioni di CO
2del 27% nel 2030, la maggior parte dellaquale deriva da un miglioramento dell’ef-ficienza energetica sia dalla parte delladomanda sia da quella dell’offerta. Unaminore domanda di energia per la gene-razione elettrica e per il settore dei tra-sporti riduce inoltre le emissioni di sostan-ze inquinanti locali: le emissioni di SO
2ca-
lano del 27% e quelle dei NO diminuisco-no del 23%, nel 2030, rispetto allo Scena-rio di Riferimento. Il quadro si presentadecisamente diverso nello Scenario di Cre-scita Elevata. La domanda di energia pri-maria è del 16% più alta rispetto allo Sce-nario di Riferimento, con carbone e pe-trolio responsabili della maggior partedella differenza. La crescita economicapiù rapida accelera la riduzione della po-vertà energetica, ma comporta maggioriimportazioni di energia, piú sostanze in-quinanti locali ed emissioni di CO
2.

World Energy Outlook 2007 - China and India Insights
riflettore
su
ENERGIA, AMBIENTE E INNOVAZIONE 6/2007 23
Il mondo trae vantaggi economicidalla crescita di Cina e India
Il rapido sviluppo economico di Ci-na e India comporterà inevitabil-mente un aumento della domandamondiale di energia, ma porterà consé anche importanti vantaggi eco-nomici per gli altri paesi. L’espansio-ne economica di Cina ed India sta crean-do opportunità di export per alcuni pae-si verso questi due paesi, mentre incre-menta la possibilità per altri di accede-re ad un ventaglio più ampio di prodot-ti importati e di servizi a prezzi competi-tivi. Tuttavia, le crescenti esportazioni diCina ed India aumentano anche la pres-sione per la competizione sugli altri pae-si, portando ad aggiustamenti struttu-rali, in particolar modo in quei paesi conindustrie dell’export in competizione conCina ed India. I bisogni crescenti di be-ni rischiano di far aumentare i prezzi in-ternazionali di diversi beni, inclusi quel-li energetici, in particolar modo se gli in-vestimenti sul lato dell’offerta sono li-mitati. I paesi esportatori di beni trarreb-bero vantaggi ancora maggiori daun’espansione economica di Cina edIndia ancora più veloce di quantoprevisto nello Scenario di Riferimen-to. Nello Scenario di Crescita Elevata, ilMedio Oriente, la Russia ed altri paesiesportatori registrano, nel 2030, un si-gnificativo aumento del loro prodottointerno lordo rispetto allo Scenario diRiferimento. La crescita del PIL in altripaesi asiatici emergenti, negli Stati Uni-ti, nell’Unione Europea e nei paesi OC-SE del Pacifico subisce una fiessione mar-ginale, soprattutto a causa dei costi piùelevati dei beni importati. In assenza dinuove politiche nei paesi piú importan-ti, il prezzo medio di import del greg-gio nei paesi IEA cresce, nel 2030, finoa 87 dollari per barile (in dollari del
2006), 40% in più rispetto allo Scenariodi Riferimento. Nell’insieme, il PIL mon-diale aumenta in media del 4,3% annuorispetto al 3,6% dello Scenario di Rife-rimento. Cambiamenti strutturali a livelloeconomico in Cina ed India influen-zeranno gli scambi dei due paesi conil resto del mondo, incluse le loroimportazioni di energia. Ci si aspettache l’industria leggera ed i servizi svol-gano un ruolo più importante per lo svi-luppo economico di questi due paesi nellungo termine. Le politiche economichedi tutti i paesi saranno cruciali per soste-nere il tasso di crescita dell’economiamondiale e per riequilibrare gli attualisquilibri. L’aumento del protezionismopotrebbe modificare radicalmente l’im-patto positivo della crescita economicadi Cina ed India. D’altra parte, un’attua-zione più rapida di politiche energeti-che ed ambientali volte al risparmioenergetico e a ridurre le emissioni inqui-nanti a livello mondiale, come quelleconsiderate nello Scenario Alternativo,aumenterebbe notevolmente i beneficinetti mondiali, riducendo la pressionesui mercati internazionali e diminuendoi costi delle importazioni di energia pertutti. Un più rapido sviluppo economi-co mondiale potrebbe inoltre aprire lastrada ad un’attuazione e ad una diffu-sione più rapidi di nuove tecnologie perun’energia più pulita, come i biocombu-stibili di seconda generazione e le tec-niche di cattura e stoccaggio del carbo-nio, a condizione che siano favorite daun adeguato ambiente politico.
Ma bisogna risolvere minacce legate alla sicurezza energeticamondiale
L’aumento della domanda mondialedi energia pone una minaccia reale ecrescente alla sicurezza energetica

International Energy Agengy
riflettore
su
ENERGIA, AMBIENTE E INNOVAZIONE 6/2007 24
mondiale. La domanda di petrolio e digas e la dipendenza di tutti i paesi con-sumatori dalle importazioni di questidue combustibili aumentano in tutti etre gli scenari presentati nel presente“Outlook”. Nello Scenario di Riferimen-to, le importazioni complessive di petro-lio di Cina ed India aumentano dai 5,4milioni di barili al giorno nel 2006 finoa 19,1 milioni di barili al giorno nel 2030,più delle attuali importazioni comples-sive di Giappone e Stati Uniti. Garanti-re degli approvvigionamenti affidabilied economicamente accessibili sarà unanotevole sfida. Gli scambi interregiona-li di petrolio e di gas aumentano rapi-damente durante il periodo delle previ-sioni, con un ampliamento del gap trala produzione interna e la domanda inogni regione consumatrice. Il volume delcommercio di petrolio aumenta da 41milioni di barili al giorno nel 2006 a 51milioni di barili al giorno nel 2015, finoad arrivare a 65 milioni di barili al gior-no nel 2030. Il Medio Oriente, le econo-mie in transizione, l’Africa e l’AmericaLatina esportano una quantità maggio-re di petrolio. Tutte le altre regioni, in-cluse Cina ed India, devono importarnedi più. Dal momento che la capacità diraffinazione per le esportazioni aumen-ta, ci si aspetta che una percentuale cre-scente del commercio di petrolio saràsotto forma di prodotti raffinati, soprat-tutto dalle raffinerie del Medio Orientee dell’India. La crescente dipendenza dei paesiconsumatori dalle importazioni dipetrolio e di gas da un numero esi-guo di paesi produttori minaccia diaccentuare i rischi legati alla sicu-rezza energetica nel breve periodo.Una più grande dipendenza dalle im-portazioni in un dato paese non impli-ca necessariamente una minore sicurez-za degli approvvigionamenti energeti-ci, non più di quanto l’autosufficienza
garantisca rifornimenti continui. L’au-mento degli scambi potrebbe portare,infatti, mutui vantaggi economici pertutti i paesi interessati. D’altronde, po-trebbe comportare un rischio di crescen-te insicurezza energetica nel breve ter-mine per tutti i paesi consumatori, dalmomento che la diversificazione geo-grafica degli approvvigionamenti si ri-duce ed aumenta la dipendenza dallerotte a rischio. È probabile che la mag-gior parte delle importazioni aggiunti-ve di petrolio provengano dal MedioOriente, teatro di molte delle passateinterruzioni degli approvvigionamenti,e attraverseranno rotte marittime a ri-schio sia verso i mercati orientali che ver-so quelli occidentali. È inoltre possibileche aumenti anche il potenziale impat-to di un’interruzione degli approvvigio-namenti sul prezzo internazionale delpetrolio. La domanda di petrolio sta di-ventando meno reattiva ai cambiamen-ti del prezzo dal momento che la do-manda del settore del trasporto, che èinelastica ai prezzi rispetto agli altri ser-vizi energetici, registra un aumento per-centuale sul totale del consumo di pe-trolio in tutti i paesi. Anche i rischi a lungo termine perla sicurezza energetica sono desti-nati a crescere. Con una maggior do-manda mondiale di energia, tutte le re-gioni si dovranno confrontare con prez-zi dell’energia più elevati nel medio elungo periodo, in assenza di concomi-tanti aumenti di investimenti per l’of-ferta o di provvedimenti politici più de-cisi per frenare l’aumento della doman-da in tutti i paesi. La crescente concen-trazione delle rimanenti riserve di pe-trolio del mondo in un gruppo ristrettodi paesi, in modo particolare i paesi delMedio Oriente membri dell’OPEC e laRussia, aumenterà il loro predominio sulmercato e potrebbe mettere a rischio ilnecessario tasso di investimenti richiesti

World Energy Outlook 2007 - China and India Insights
riflettore
su
ENERGIA, AMBIENTE E INNOVAZIONE 6/2007 25
per la capacità di produzione. La quotadel mercato complessivo dei paesi OPECaumenta in tutti gli scenari, soprattut-to in quello di Riferimento ed in quellodi Crescita Elevata. Maggiore è l’aumen-to di petrolio e di gas richiesto a questeregioni, maggiore sarà la probabilità chequesti paesi cerchino di ottenere gua-dagni più importanti dalle loro esporta-zioni e di imporre prezzi più elevati nellungo periodo, rinviando gli investimen-ti e riducendo la produzione. Alti prezzisarebbero un peso soprattutto per i pae-si emergenti che stanno ancora cercandodi proteggere i propri consumatori tra-mite sussidi. La crescente partecipazione di Cinaed India agli scambi internazionaliaumenta l’importanza del loro con-tributo agli sforzi collettivi per accre-scere la sicurezza energetica mondia-le. Il modo in cui Cina ed India affronta-no le crescenti minacce per la loro sicu-rezza energetica si ripercuoterà anche sulresto del mondo. Entrambi i paesi stan-no già agendo. Più le loro politiche sa-ranno effcaci nell’evitare o gestire leemergenze per gli approvvigionamenti,più gli altri paesi consumatori, tra i qualila maggior parte dei paesi della IEA, netrarranno dei vantaggi, e viceversa. Inol-tre, molti dei provvedimenti per miglio-rare la sicurezza energetica supportanopolitiche volte a limitare il danno ambien-tale correlato alla produzione e al con-sumo dell’energia. La diversificazione delmix energetico, della provenienza delleimportazioni di petrolio e gas e delle rot-te dei rifornimenti, insieme con una mi-gliore preparazione nell’affrontare leemergenze, specialmente attraverso lacreazione di stock di emergenza e di mec-canismi di risposta coordinati, sarannonecessari per garantire la sicurezza ener-getica. Cina ed India sono sempre piùconsapevoli che gli acquisti di assets pe-troliferi stranieri risulteranno poco utili
nel caso di emergenze per gli approvvi-gionamenti. Garantire la sicurezza degliapprovvigionamenti di petrolio di Cinaed India, come quello di tutti gli altri pae-si consumatori, dipende sempre più daun buon funzionamento del mercato in-ternazionale del petrolio.
Un aumento incontrollato del con-sumo di combustibili fossili acce-lererà il cambiamento climatico
L’aumento della CO2
e degli altri gasad effetto serra nell’atmosfera, pro-vocato in gran parte dalla combu-stione dei combustibili fossili, stacontribuendo all’innalzamento del-la temperatura del globo ed al cam-biamento climatico. L’aumento delconsumo di combustibili fossili conti-nuerà ad accrescere le emissioni di CO
2legate all’energia durante il periodo con-siderato. Nello Scenario di Riferimento,le emissioni aumentano del 57% tra il2005 ed il 2030. Stati Uniti, Cina, Russiae India, contribuiscono per i due terzi diquesto aumento. La Cina è di gran lun-ga la maggior responsabile delle emis-sioni aggiuntive, superando gli Stati Uni-ti quale maggior responsabile delle emis-sioni nel 2007. L’India diventa il terzomaggior responsabile intorno al 2015.Nello Scenario di Riferimento, tuttavia,le emissioni pro capite della Cina nel2030 sono solo il 40% di quelle degli Sta-ti Uniti e circa i due terzi di quelle deipaesi OCSE in aggregato. In India, leemissioni rimangono di gran lunga infe-riori rispetto a quelle dei paesi OCSE, an-che se aumentano più velocemente diquelle di quasi tutte le altre regioni. Se si vogliono stabilizzare le concen-trazioni dei gas ad effetto serra ad unlivello tale da evitare di creare effettidannosi sul clima bisogna agire subi-to. Lo Scenario Alternativo mostra che lemisure politiche attualmente allo studio

International Energy Agengy
riflettore
su
ENERGIA, AMBIENTE E INNOVAZIONE 6/2007 26
dei governi nei diversi paesi del mondopotrebbero portare ad una stabilizzazio-ne delle emissioni totali verso il 2025, e aduna diminuzione del loro livello nel 2030pari al 19% rispetto allo Scenario di Riferi-mento. Le emissioni dei paesi OCSE rag-giungono il loro apice e cominciano ascendere dal 2015. Tuttavia, le emissionitotali continuerebbero ancora ad esserepiù alte del 27% rispetto al 2005. Ipotiz-zando una continua riduzione delle emis-sioni dopo il 2030, le previsioni dello Sce-nario Alternativo sono consistenti con unastabilizzazione, nel lungo periodo, dellaconcentrazione equivalente di CO
2 nell’at-
mosfera pari a circa 550 parti per milione.Secondo le migliori stime dell’Intergovern-mental Panel on Climate Change (IPCC),questa concentrazione corrisponderebbead un aumento della temperatura mediadi circa 3°C rispetto ai livelli preindustriali.Per limitare l’aumento medio delle tem-perature ad un massimo di 2,4°C, l’aumen-to minimo previsto in tutti gli scenari del-l’IPCC, la concentrazione dei gas effettoserra nell’atmosfera dovrebbe essere stabi-lizzata a 450 parti per milione. Per otte-nere questo risultato, le emissioni di CO
2dovrebbero raggiungere il picco entro il2015 al più tardi, per poi scendere di unlivello compreso tra il 50% e l’85% al disotto delle emissioni del 2000 entro il 2050.Abbiamo stimato che questo richiedereb-be una riduzione delle emissioni di CO2 le-gate all’energia ad un livello di circa 23 Gtnel 2030, 19 Gt in meno rispetto allo Sce-nario di Riferimento e 11 Gt in meno ri-spetto allo Scenario Alternativo. In un “Ca-so Stabilizzato a 450”, che descrive un per-corso ipotetico per raggiungere questoobiettivo, le emissioni totali raggiungonoil loro picco nel 2012 a circa 30 Gt. La ri-duzione delle emissioni deriva da un uti-lizzo più efficiente dei combustibili fossilinell’industria, per gli edifici e per il settoredei trasporti, da una loro sostituzione sem-pre maggiore con il nucleare e con le rin-
novabili, e tramite una diffusione massic-cia della cattura e stoccaggio del carbonio(CSC) nella produzione di energia elettricae nell’industria. Per rendere questa ipote-si reale, sarebbe necessario attuare in tut-ti i paesi provvedimenti politici particolar-mente rapidi e decisi ed innovazioni tec-nologiche senza precedenti, con gli eleva-ti costi che ciò comporterebbe. L’azione dei governi deve focaliz-zarsi sull’abbassamento della rapidacrescita delle emissioni di CO
2pro-
vocato dalle centrali a carbone,principale causa di questo aumen-to durante gli ultimi anni. L’efficien-za e la conservazione dell’energia gio-cheranno un ruolo cruciale nel limitarel’aumento della domanda di elettricitàe nel ridurre gli input richiesti per la pro-duzione. L’energia nucleare e le fonti rin-novabili possono dare un aiuto rilevan-te per ridurre le emissioni. Le tecnologieper un carbone pulito, in particolar mo-do la CSC, rappresentano una delle stra-de più promettenti per mitigare le emis-sioni nel lungo periodo, specialmente inCina, in India e negli Stati Uniti, dove ilconsumo di carbone aumenta più velo-cemente. La CCS potrebbe riconciliare uncontinuato uso del carbone con la neces-sità di ridurre le emissioni a lungo termi-ne, a condizione che ne venga dimostra-ta l’attuabilità su vasta scala e che gli in-centivi adeguati siano finanziati.
È necessaria un’azione collettivaper affrontare le sfide globali per l’energia
L’emergere di Cina ed India tra i princi-pali protagonisti dei mercati energe-tici mondiali rende ancora più impor-tante che tutti i paesi intraprendanoprovvedimenti incisivi e rapidi per fre-nare la crescente domanda di energia.Il problema più pressante non é la scarsitàdi risorse naturali o di denaro, ma la man-

World Energy Outlook 2007 - China and India Insights
riflettore
su
ENERGIA, AMBIENTE E INNOVAZIONE 6/2007 27
canza di tempo. Gli investimenti che sonostanziati oggi per le infrastrutture dell’inte-ra filiera energetica decideranno i tipi ditecnologie che saranno presenti nei prossi-mi decenni, specialmente per la produzio-ne di energia elettrica. I prossimi dieci an-ni risulteranno cruciali, visto che il tasso diespansione delle infrastrutture per gli ap-provvigionamenti energetici sarà particolar-mente rapido. Le sfide energetiche di Ci-na ed India sono le sfide energetiche delmondo, e questo richiede risposte comu-ni. Nessuno dei più importanti paesi con-sumatori può essere certo della sicurezzadegli approvvigionamenti se quelli deglialtri paesi sono a rischio, e non ci sono pos-sono essere soluzioni valide nel lungo ter-mine per la minaccia posta dal cambiamen-to climatico se tutti i più importanti paesiconsumatori non partecipano. L’adozionee la completa realizzazione delle misurepolitiche nei paesi dell’IEA per risolvere iproblemi riguardanti la sicurezza energeti-ca ed il cambiamento climatico sono essen-ziali, ma lungi dall’essere sufficienti. Molte delle misure volte a limitare l’in-sicurezza energetica possono ancheaiutare ad attenuare l’inquinamentolocale ed il cambiamento climatico, eviceversa. Come dimostrato nello Scena-rio Alternativo, in molti casi questi provve-dimenti comportano anche benefici eco-nomici, grazie alla riduzione dei costi dell’e-nergia, con un risultato “tre volte vincen-te”. Un approccio complessivo nella for-mulazione delle politiche è quindi essen-ziale. Il giusto mix di interventi politici pergarantire la sicurezza energetica e risolve-re i problemi legati al clima dipende dalrapporto tra costi e benefici, rapporto chedifferisce da paese a paese. Non possiamopermetterci il lusso di escludere nessunadelle opzioni che possono indirizzare il si-stema energetico mondiale verso un per-corso più sostenibile. L’approccio più eco-nomicamente conveniente deve coinvol-gere gli strumenti del mercato, inclusi quel-
li che pongono un’esplicita valutazione fi-nanziaria sulle emissioni di CO
2.
Saranno necessarie inoltre norme, qua-li standard e obblighi, e sovvenzioni go-vernative per la ricerca, lo sviluppo e ladiffusione di nuove tecnologie sul lungoperiodo. In Cina ed India l’urgente ne-cessità di limitare l’inquinamento atmo-sferico locale continuerà senza dubbioad essere il motivo principale per ulte-riori sforzi per contenere l’aumento del-le emissioni dei gas ad effetto serra. Una maggiore cooperazione politicapuò portare grandi vantaggi sia peri paesi IEA da una parte, sia per Ci-na ed India dall’altra. I paesi IEA han-no da lungo tempo riconosciuto i vantag-gi di una cooperazione con Cina ed India,cooperazione che si riflette in una conti-nua espansione di attività coordinate dal-la IEA, e tramite accordi multilaterali e bi-laterali. Queste attività devono essere am-pliate con rapporti di collaborazione sem-pre più stretti di Cina e l’India con l’Agen-zia. La cooperazione tra la IEA e la Cina el’India per migliorare la preparazione pereventuali emergenze petrolifere e per svi-luppare tecnologie più pulite ed efficien-ti, specialmente per il carbone, rimane unapriorità. La collaborazione tra i paesi IEAed i paesi emergenti, comprese Cina ed In-dia, sta già accelerando lo sviluppo di nuo-ve tecnologie, uno sviluppo che frutterànotevoli vantaggi nel lungo periodo. Biso-gna migliorare i meccanismi per facilitareed incoraggiare il finanziamento di que-ste tecnologie in Cina, in India e negli al-tri paesi emergenti. Data la dimensionedella sfida energetica che il mondo deveaffrontare, è necessario un sostanziale au-mento di fondi pubblici e privati per la ri-cerca, lo sviluppo e la diffusione di tecnolo-gie energetiche, che rimangono molto aldi sotto dei livelli raggiunti nei primi anniOttanta. L’onere finanziario per supporta-re la ricerca continuerà a gravare soprat-tutto sui paesi dell’IEA.

International Energy Agengy
riflettore
su
ENERGIA, AMBIENTE E INNOVAZIONE 6/2007 28
Note: These assumptions also apply to the Alternative Policy and High Growth Scenarios.Fonte: World Energy Outlook 2007, pag. 62, “Table 1:World Population Growth (average annualgrowth rates, %)”
Crescita effettiva mondiale del Prodotto Interno Lordo nello Scenario di Riferimento
* Average annual growth rate. **Includes agriculture sector. *** Includes other transformationand non-energy use.Fonte: World Energy Outlook 2007, pag. 314 “Table 9.10: Energy-Related CO2 Emissions by Sector inthe Reference Scenario” (million tonnes)
Emissioni di CO2 correlate all’energia, per settore, nello Scenario di Riferimento (milioni di t)

World Energy Outlook 2007 - China and India Insights
riflettore
su
ENERGIA, AMBIENTE E INNOVAZIONE 6/2007 29
China India Rest of the world
Primary energy demand
Primary coal demand
Primary oil demand
Oil imports
CO2 emissions
0% 20% 40% 60% 80% 100%
* Based on preliminary estimates for 2006.Fonte: World Energy Outlook 2007, pag. 54, “Figure 1: Share of China and India in Incremental EnergyDemand, Imports and Energy-Related CO2 Emissions, 2000-2006”
Quota di Cina e India della domanda incrementale di energia, delle importazioni e delle emissioni di CO2 correlate all’energia, 2000-2006*
100%
80%
60%
40%
Coal Oil Gas Nuclear Hydro TotalRest ofrenewables
20%
0%
China India Rest of the world
There are some important differences between IEA energy statistics for China and India and officialnational data, because of methodological differences and statistical discrepancies. IEA data for totalprimary energy use are markedly higher than official estimates for China, largely because the latter donot include traditional biomass. The differences are smaller for India, but there are significant differen-ces at the sectoral level. See Box 8.1 in Chapter 8 and Box 15.1 in Chapter 15 for further details.Fonte: World Energy Outlook 2007, pag. 118, “Figure 2.1: Shares of China and India in the Increase inWorld Primary Energy Demand by Fuel in the Reference Scenario, 2005-2030”
Quota di Cina e India dell’aumento della domanda mondiale di energia primaria, per combustibile, nello Scenario di Riferimento, 2005-2030

International Energy Agengy
riflettore
su
ENERGIA, AMBIENTE E INNOVAZIONE 6/2007 30
Domanda pro-capite di energia primaria in Cina, India e altri Paesi, 2005
8
7
6
5
4
3
2
1
0
toe
per
cap
ita
UnitedStates
Russia Japan European Mexico China Brazil Indonesia India
Fonte: World Energy Outlook 2007, pag. 266, “Figure 8.2: Per-Capita Primary Energy Demand in Chi-na, India and Other Selected Countries, 2005”

World Energy Outlook 2007 - China and India Insights
riflettore
su
ENERGIA, AMBIENTE E INNOVAZIONE 6/2007 31
-2 0 2 4 6 8 10
China
billion tonnes
Reference Scenario
High Growth Scenario
Alternative Policy Scenario
India
OECD North America
Rest of developing Asia
Middle East
Latin America
Transition economies
Africa
OECD Europe
OECD Pacific
Fonte: World Energy Outlook 2007, pag.193, “Figure 5.2: Incremental Energy-Related CO2 Emissionsby Scenario, 2005-2030”
Emissioni incrementali di CO2 correlate all’energia nei vari scenari, 2005-2030

International Energy Agengy
riflettore
su
ENERGIA, AMBIENTE E INNOVAZIONE 6/2007 32
Domanda cinese di energia primaria nello Scenario di Riferimento
4.000
3.500
3.000
2.500
2.000
1.500
1.000
500
1980 1990 2005 2015 20300
Coal
Biomasse
Oil
Other renewables
Gas Nuclear Hydro
Fonte: World Energy Outlook 2007, pag.289, “Figure 9.1: China’s Primary Energy Demand in the Re-ference Scenario”

World Energy Outlook 2007 - China and India Insights
riflettore
su
ENERGIA, AMBIENTE E INNOVAZIONE 6/2007 33
Emissioni cinesi di CO2 nello Scenario Alternativoe nello Scenario di Riferimento
Fonte: World Energy Outlook 2007, pag. 370, “Figure 11.5: China’s CO2 Emissions in the AlternativePolicy Scenario Compared with the Reference Scenario”

ENERGIA, AMBIENTE E INNOVAZIONE 6/2007 34
La programmazione finanziaria2007-2013 dell’Unione Europea
offre grandi opportunità per tutti i soggetti che nel nostro
Paese operano nel campo dell’innovazione tecnologica, dell’energia e dell’ambiente
Una presentazione delle opportunità of-ferte dal nuovo ciclo di programmazionefinanziaria a chiusura quasi del primo annodi operatività potrebbe sembrare “ritarda-taria”. In realtà, se già il negoziato sulleprospettive finanziarie era stato oggettodi un lungo braccio di ferro interistituziona-le tra gli organi dell’Unione Europea, lostesso vivace dibattito si è poi traslato insede di adozione dei singoli programmi dilavoro ritardando, di fatto, l’effettivo av-vio delle singole iniziative su basi giuridi-che consolidate. La rassegna dei program-mi analizzati (che opportunamente com-prende, ma va oltre il più noto VII PQ diRS&T) costituisce solo una selezione del-l’offerta per il prossimo settennio, effet-tuata sulla scorta dei possibili interessi de-gli attori che operano sul terreno dell’in-novazione, dell’energia e dell’ambiente.
Le prospettive finanziarie matricidei singoli programmi UE
Le prospettive finanziarie (PF) adottatesulla base di un accordo interistituzio-nale tra il Parlamento europeo, il Consi-
riflettore
su Le opportunità
dei programmi UE2007-2013
Flavia Amato
Opportunities provided by the EU’s 2007-2013
programmes
The European Union’ s 2007-2013 financial planoffers great opportunities for everyone operating in Italy in the fields of new technology, energy
and the environment
ENEAUfficio di Presidenza, Unità Relazioni Internazionali

Le opportunità dei programmi UE 2007-2013
ENERGIA, AMBIENTE E INNOVAZIONE 6/2007 35
glio e la Commissione, definiscono, sudi un periodo pluriennale, i confini del-le spese comunitarie prevedibili, espli-citandone massimali e composizione.Una volta raggiunto un accordo defini-tivo sul testo, tutti gli strumenti legisla-tivi relativi ai vari settori di attività e aivari programmi devono essere sottopo-sti a revisione ed essere adottati con-giuntamente dal Consiglio e dal Parla-mento.Nell’arco della programmazione 2007-2013, a fronte di un impegno di 862.363milioni di euro1, sono state identificatecinque “rubriche”, ovvero grandi cate-gorie di spesa, che riflettono le prioritàpolitiche dell’UE.
• Crescita sostenibile, suddivisa nelle sub-rubriche (1a) Competitività per la cresci-ta e l’occupazione e (1b) Coesione perla crescita e l’occupazione.• Sviluppo sostenibile e tutela delle ri-sorse naturali, comprendente la Politicaagricola comune e lo sviluppo rurale.• Cittadinanza, libertà, sicurezza e giu-stizia.• L’UE come partner mondiale.
riflettore
su
Ciascuna rubrica dispone di una quotadi budget che consente la copertura fi-nanziaria dei programmi che rientranonella priorità. Da un punto di vista ge-stionale, gli strumenti che discendonodalle singole rubriche si distinguono infondi a gestione diretta o indiretta: nelprimo caso, che riguarda i cosiddetti pro-grammi tematici, i finanziamenti vengo-no gestiti direttamente dalla Commis-sione che, oltre a fissare i principi e leregole di partecipazione, governa l’in-tero arco di vita dei progetti; nel secon-do caso invece, le risorse, a fronte di nor-me stabilite da appositi regolamenti,vengono trasferite agli Stati membri(SM) e da questi gestite attraverso le Au-torità centrali e locali (Regioni). È que-sto il meccanismo regolatore della poli-tica strutturale.
Rubrica Crescita Sostenibile
Gli insoddisfacenti risultati registrati nelprocesso di costruzione della “Societàdella conoscenza”, emersi con forza inoccasione della revisione di medio ter-mine dell’Agenda di Lisbona2, hanno ri-
1. L’impegno originariamente proposto dalla Commissione superava i 1000 miliardi di euro.2. COM(2005) 24 definitivo, Lavorare insieme per la crescita e l’occupazione. Il rilancio della Strate-gia di Lisbona.
1%
46%
6% 9%
38%
1a Competitività per la crescita el’occupazione
1b Coesione per la crescita el’occupazione
2 Sviluppo sostenibile e tuteladelle risorse umane
3 Cittadinanza, libertà, sicurezzae giustizia
4 L’UE come attore mondiale
Figura 1Budget 2007-2013. Distribuzione per rubriche di spesa, escluse le spese per l’amministrazione e di compensazioneFonte: elaborazione ENEA

Flavia Amato
ENERGIA, AMBIENTE E INNOVAZIONE 6/2007 36
portato al centro delle discussioni poli-tiche e tecniche la questione della cre-scita in Europa ed hanno favorito, da unlato l’emergere della consapevolezzadell’irrinunciabilità dei traguardi fissatinel 2000 e, dall’altro hanno dato impul-so a nuove strategie e impegni tesi a re-cuperare il ritardo accumulato nella pri-ma fase di attuazione del piano.In questo contesto, il rilancio della Stra-tegia passa sia attraverso la definizionedi un’apposita parte dedicata alla cre-scita sia dando il via a una nuova gene-razione di programmi, scissa in due ca-tegorie: Competitività per la crescita eoccupazione e Coesione per la crescitae l’occupazione.
1a) Competitività per la crescita e l’oc-cupazioneL’asse 1a punta ad integrare i tre verti-ci del cd “Triangolo europeo della cono-scenza”, alla base della strategia di Li-sbona: ricerca, innovazione e istruzione.Per questo motivo, in questo capitolotrova spazio la copertura finanziaria de-dicata a programmi apparentemente di-versi tra loro.
VII Programma Quadro di ricerca e Sviluppo Tecnologico (VII PQ)
Con un budget di oltre 50 miliardi di eu-ro, che si sommano ai 2,7 miliardi desti-nati a finanziare EURATOM, il VII PQ, ilprimo nella nuova Europa a 27, costitui-sce il maggior strumento di supporto al-la politica di R&S dell’UE fino al 2013. IlProgramma copre sia la ricerca top-down,con priorità di R&S indicate dalla Com-missione europea, sia la ricerca curiosity-driven, in quattro programmi specifici:Cooperation, per il conseguimento daparte di partenariati tra università, entidi ricerca, imprese, intra ed extraeuropei,della leadership europea in dieci aree diricerca ritenute chiave;ri
flettore
su
Ideas, volto a favorire il dinamismo, lacreatività e il primato della ricerca euro-pea alle “frontiere della conoscenza” va-lutando i progetti alla luce dell’unico cri-terio dell’eccellenza. Il programma è ge-stito dalla prima agenzia paneuropea difinanziamento alla ricerca di frontiera;People: nel segno della continuità rispet-to alle azioni Marie Curie e incentratosulla valorizzazione delle risorse umane,riveste grande importanza nel VII PQ,nell’intento di formare e reclutare nuo-ve competenze, trattenere risorse esi-stenti ed attrarre i migliori ricercatoridall’estero. Il programma offre l’oppor-tunità a ricercatori giovani ed esperti dipercorrere esperienze di mobilità sia in-ternazionali che intersettoriali;Capacities, per il miglioramento delle ca-pacità di ricerca e innovazione in Europaed il loro uso ottimale attraverso misurerelative destinate alle infrastrutture di ri-cerca, in particolare quelle definite prio-ritarie dell’ESFRI (European Strategy Fo-rum on Research Infrastructures), allePMI, alle regioni della conoscenza, alleregioni convergenti, alla scienza e società,alla cooperazione internazionale.Inoltre, il PQ destina fondi ad hoc per lapartecipazione del Centro Comune di Ri-cerca ai consorzi transnazionali che si co-stituiscono intorno ai vari bandi, nelquadro di attività non nucleari. Infine, Il VII PQ RST costituisce inoltre lafonte di finanziamento per il Program-ma Quadro EURATOM (2007- 2011) di at-tività di ricerca e formazione nel settorenucleare, che interessa gli ambiti dell’e-nergia da fusione e fissione nucleare ela radioprotezione. In particolare, l’atti-vità di ricerca legata allo sviluppo soste-nibile dell’energia da fusione guarda al-la diversificazione delle fonti pulite diapprovvigionamento energetico, men-tre gli studi e la formazione sulla fissionesono legati agli aspetti della sicurezza,della gestione dei rifiuti, dell’efficacia e

Le opportunità dei programmi UE 2007-2013
riflettore
su
ENERGIA, AMBIENTE E INNOVAZIONE 6/2007 37
della competitività. Strettamente con-nesso a fissione e fusione nucleare, ilcampo della radioprotezione investe lostudio dei rischi connessi a una prolun-gata esposizione a dosi ridotte di radioat-tività e alla gestione di situazioni diemergenza.
Programma Competitività ed Innovazione (CIP)
Il CIP rientra tra i programmi di nuovagenerazione lanciati dalla programma-zione 2007-2013, con un budget di 3,6miliardi di euro. Il CIP punta alla razio-nalizzazione di strumenti già previsti,ma rivisitati rispetto alla scorsa program-mazione, dedicati a settori strategici,quali la capacità di innovazione, lo svi-luppo di una società dell’informazionee la crescita sostenibile. Il programma sisuddivide in tre blocchi in cui il tema del-l’eco-innovazione risulta trasversale.Imprenditorialità e Innovazione: questoblocco di attività racchiude numerose ini-ziative volte al supporto delle varie tipo-logie di imprese, quali start-up, «gazzel-le» (imprese a forte potenziale di cresci-ta) ad alta tecnologia, fino alle microim-prese e alle imprese familiari rappresen-tanti la grande maggioranza delle im-prese europee. In quest’ambito, sonopreviste misure per agevolare l’accessoal credito e la semplificazione ammini-strativa. In questo blocco, trovano spa-zio anche le attività previste dal Pianod’azione per le tecnologie ambientali.Sostegno alla politica in materia di ICT:lo strumento è volto allo sviluppo di unospazio europeo dell’informazione e diun mercato comune dei prodotti e deiservizi. Ingloba il programma eCONTENTper lo sviluppo di contenuti digitali in-novativi, eTEN (TEN Telecom) per la pro-mozione di reti trans-europee per la for-
nitura di servizi ICT e MODINIS, per lostudio e il confronto tra migliori prati-che e la diffusione del concetto di eEuro-pe3, una società dell’informazione pertutti.Energia Intelligente per l’Europa: l’ini-ziativa è volta allo sviluppo e all’appli-cazione della normativa energetica euro-pea, alla promozione del risparmio ener-getico e al ricorso a fonti energetichealternative. In particolare il programmainclude i seguenti temi:uso razionale del-l’energia nelle abitazioni e nell’industria(SAVE); fonti energetiche nuove e rin-novabili per la produzione di calore edenergia elettrica (ALTENER); energia le-gata ai trasporti, alla loro alimentazio-ne e alla loro efficienza energetica.
Programma d’azione integrato per l’apprendimento permanente
Insieme a ricerca ed innovazione, il temadell’istruzione, o meglio l’istruzione per-manente, costituisce il terzo asse attornoa cui ruota la strategia di Lisbona. Per que-sto motivo, le PF riservano al tema un’im-portanza notevole. L’apprendimento lun-go l’arco della vita, con un budget di 6,97miliardi di euro, riguarda i vari stadi diistruzione, cui vengono dedicati 4 subpro-grammi settoriali: educazione scolatica,Comenius; istruzione superiore, Erasmus;formazione professionale, Leonardo daVinci; istruzione degli adulti, Grundtvig.Questi si sommano ad un programma tra-sversale a sostegno dei 4 programmi set-toriali.
Safer Internet Plus e IDABC
Il programma Safer Internet Plus, in vi-genza fino al 2008, con 45 milioni di eu-ro finanzia, attività legate, da una parteall’uso più sicuro delle nuove tecnolo-
3. COM(1999) 687 def.

gie e di internet, specie da parte di bam-bini, dall’altra richiede lo sviluppo di for-me di protezione contro i contenuti il-legali o comunque indesiderati, attra-verso la messa a punto di tecnologie difiltraggio dei contenuti e la formazioneagli educatori sui potenziali rischi deri-vanti da un uso distorto della rete.Il programma IDABC (Programma per l’e-rogazione interoperabile di servizi paneu-ropei di governo elettronico), che disponedi una dotazione finanziaria 148,7 milio-ni di euro per il quadriennio 2005-2009,sostiene la fornitura all’interno dell’Unio-ne Europea di servizi online da parte del-le pubbliche amministrazioni europee afavore di cittadini e imprese, attraverso ilricorso a tecnologie ICT, nel quadro delpiù ampio obiettivo di realizzazione delcosidetto “Governo elettronico”.
TEN-T e TEN-E
L’UE sostiene lo sviluppo di reti transeu-ropee ai fini della completamento delmercato interno e del rafforzamento del-la coesione economica e sociale. Il siste-ma di reti riguarda i trasporti, TEN-T, l’e-nergia, TEN-E, e le comunicazioni eTEN.Per i trasporti, il piano varato nel 1996 enovellato nel 2004, prevede la costruzio-ne, entro il 2020, di trenta “corridoi”
transeuropei, che vanno dal Baltico alMediterraneo, dall’Atlantico al Danubio.Sul versante energetico, invece, a frontedei nodi geopolitici legati a dipenden-za energetica, diversificazione delle fon-ti, cambiamenti climatici, i finanziamen-ti puntano alla creazione di un mercatointerno dell’energia a favore di approv-vigionamenti sicuri. In entrambi i casi, le domande di contri-buto finanziario sono presentate allaCommissione, in risposta a bandi annua-li, da uno o più Stati membri o, previoaccordo degli Stati membri interessati,dalle organizzazioni internazionali, dal-le imprese comuni o da organismi pub-blici o privati.
1b) Coesione per la crescita e lo sviluppoLo sviluppo armonioso e coerente in tut-to il territorio UE, da sempre al centrodell’impegno delle istituzioni europee,e divenuto assolutamente nodale a se-guito dell’allargamento a 27, trova spa-zio nella rubrica “Coesione per la cresci-ta e lo sviluppo”.A fronte infatti del divario tra regioniavanzate e regioni in ritardo di svilup-po, l’UE dedica circa 1/3 del proprio bud-get a favore della politica regionale, cer-cando di stimolare gli investimenti nelle
Flavia Amato
riflettore
su
ENERGIA, AMBIENTE E INNOVAZIONE 6/2007 38
Tabella 1 - Confronto tra la programmazione 2000-2006 e 2007-2013, con relativi strumenti di finanziamento
Programmazione 2000-2006 Programmazione 2007-2013 StrumentiObiettivo Obiettivo
1) Sviluppo e adeguamento strutturale delle regioni Convergenza FESR, FSE, Fondo di Coesionein ritardo di sviluppo2) Riconversione Competitività regionalesocio-economica delle regioni e occupazione FESR, FSEcon problemi strutturali3) Formazione Cooperazione territoriale FESR
europea (nuovo obiettivo)
Fonte: elaborazione ENEA

Le opportunità dei programmi UE 2007-2013
riflettore
su
ENERGIA, AMBIENTE E INNOVAZIONE 6/2007 39
aree depresse. Per l’Italia, il contributoprevisto nei prossimi sette anni ammon-ta a 28,8 miliardi di euro.Rispetto alla precedente programmazio-ne, la nuova politica di coesione risultarinnovata, nel segno della razionalizza-zione e semplificazione, sia negli obiet-tivi che negli strumenti (tabella 1).L’obiettivo “Convergenza”, che sosti-tuisce l’obiettivo 1 del periodo 2000-2006, punta alla riduzione della forbicetra regioni sviluppate e in ritardo di svi-luppo, prevedendo azioni a sostegnoai seguenti settori: ricerca e sviluppo
tecnologico, innovazione e imprendi-torialità; società dell’informazione; pro-tezione dell’ambiente; prevenzione deirischi; turismo; cultura; trasporti; ener-gia; istruzione; sanità. La Convergenza è finanziata dal FESR(Fondo Europeo di Sviluppo Regionale),cui accedono due tipologie di regioni (fi-gura 1): regioni il cui PIL pro-capite è in-feriore al 75% della media comunitaria;regioni che per il mero effetto statisti-co portato dall’allargamento, superanola soglia del 75% e beneficiano quindidi un regime di aiuti transitorio, speci-
Figura 2Mappatura delle regioni italiane in funzione dell’ammissibilità agli obiettivi 1 e 2 Fonte: Commissione Europea, DG REGIO

Flavia Amato
riflettore
su
ENERGIA, AMBIENTE E INNOVAZIONE 6/2007 40
fico e decrescente (phasing-out). Alla realizzazione della convergenza, con-tribuisce anche il Fondo Sociale Europeo(FSE), specificatamente destinato alla va-lorizzazione del capitale umano, che aiu-ta i cittadini comunitari a migliorare leproprie competenze e ad accrescere leproprie opportunità occupazionali.Inoltre, la convergenza si avvale dellosupporto del Fondo di coesione a sup-
porto di quei SM con un reddito na-zionale lordo inferiore al 90% rispet-to alla media comunitaria. L’Italia nonè pertanto ammissibile a questo regi-me di aiuti.Il secondo obiettivo, “Competitività re-gionale e occupazione”, dedicato alle re-gioni che non sono ammissibili alla con-vergenza, investe: da una parte progettilegati all’innovazione e alla società della
Tabella 2 - Cooperazione territoriale europea, regioni ammissibili e interventi prioritari
Tipologia cooperazione Regioni ammissibili Temi prioritariterritoriale
Cooperazione transfrontaliera- Regioni d’Europa Protezione e gestioneInterreg IVA confinanti* congiunta dell'ambiente;
ma appartenenti miglioramento dell'accessibilitàa Stati diversi** dei trasporti; reti d'informazione
e di comunicazione; acqua, gestione dei rifiuti e
sistemi di gestione dell'energia.
*Sono ammissibili le regioni situate lungo le frontiere terrestri interne e lungo alcune frontiere esterne, non-ché alcune frontiere marittime adiacenti, separate da un massimo di 150 chilometri.**L’Italia è coinvolta in 7 programmi transfrontalieri interni: Italia-Francia Alpi, Italia-Francia Isole, Italia-Austria, Ita-lia-Slovenia, Italia-Grecia, Italia-Malta. Inoltre, nella cooperazione transfrontaliera con statinon UE, l’Italia aderisce al programma Adriatico finanziato dall’IPA e al Programma sulla Tunisia finan-ziato dall’ENPI (v. § L’UE come partner mondiale).***Delle 13 zone ammissibili, l’Italia rientra nelle seguenti: Spazio alpino, Europea centrale e orientale,Mediterraneo, Europa sudorientale. Inoltre, nella cooperazione transnazionale con stati non UE, l’Italiapartecipa al programma Med, finanziato dall’ENPI (v. § L’UE come partner mondiale).****Oltre al programma IV C, sono previsti 3 programmi trasversali già finanziati nel periodo 2000-2006:Interact, Urbact ed Espon.
Fonte: elaborazione ENEA
Regioni unite da matiche comuni
ma non necessariamenteconfinanti e rientranti
nelle zone di cooperazionetransnazionale***
Cooperazione transnazionale-Interreg IVB
Innovazione e ricerca, ambiente,
efficienza energetica; sviluppo sostenibile,
prevenzione dei rischi.
Tutte le regioni UE, la Norvegia e la Svizzera
Cooperazione interregionale-Interreg IVC****
Scambi di buone prassi su gestione delle acque e dei rifiuti; biodiversità
e preservazione dell’ereditànaturale; energia
e trasporto sostenibili.

Le opportunità dei programmi UE 2007-2013
riflettore
su
ENERGIA, AMBIENTE E INNOVAZIONE 6/2007 41
conoscenza, all’accessibilità e ai servizid’interesse generale, all’ambiente e prote-zione dei rischi; dall’altra tematiche riferi-bili all’adattabilità dei lavoratori, alla crea-zione di posti di lavoro, all’accessibilità almercato del lavoro per le persone vulne-rabili e alla riconversione economica e so-ciale delle zone con problemi strutturali.Sono ammissibili a questa priorità anche leregioni che, per risultati conseguiti nelquadro dell’obiettivo 1 nel 2000-2006, so-no usciti dal regime di sostegno più for-te, ed entrano a far parte nell’obiettivo2, con finanziamenti supplementari tran-sitori (regioni cosiddette in phasing-in, (fi-gura 2).Il terzo obiettivo, “Cooperazione territo-riale europea”, che prende le mosse dalProgramma d’iniziativa comunitaria Inter-reg III, costituisce la vera novità della poli-tica regionale. La cooperazione è intesa a rafforzare unosviluppo territoriale integrato e comple-mentare ai livelli transfrontaliero, transna-zionale e interregionale, e a supportare lacreazione di reti di cooperazione, per for-nire risposte a problematiche comuni adaree confinanti (tabella 2).Infine, la Commissione Europea ha adot-tato, d’intesa con la Banca europea pergli investimenti, tre nuove iniziative vol-te a migliorare la collaborazione tra en-ti locali e istituzioni finanziarie interna-zionali ed europee, al fine di promuo-vere l’occupazione, la crescita e la coe-sione nelle regioni dell’Unione Europeae dei paesi candidati all’adesione: Jasper,Jeremie e Jessica. Il primo, in particolare,concentra l’attenzione sui temi del tra-sporto, l’ambiente, l’efficienza energe-tica e le energie rinnovabili.
Rubrica Sviluppo Sostenibile e Tutela delle Risorse Naturali
La seconda rubrica comprende la spesaper la politica agricola, la politica del-
la pesca e la politica legata all’ambien-te, con la doppia finalità di creare, daun lato nuovi e migliori opportunità dilavoro nelle aree rurali e, dall’altro diintegrare le sfide legate all’ambientenelle altre politiche comunitarie. Risul-ta importante sottolineare che la nuo-va programmazione, diversamente dal-la precedente, scinde quindi le politi-che a tutela del territorio dalla politicadi coesione economica e sociale.Per questo motivo, trova spazio in questarubrica la rinnovata struttura finanziaria asostegno della Politica Agricola Comune,che si articola in un quadro unico che pog-gia su due pilastri: (a) Misure di sostegnodiretto al reddito degli agricoltori e (b) Svi-luppo rurale, che si avvale del Fondo eu-ropeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEA-SR). Quest’ultimo, in particolare, strumen-to finanziario unico per lo sviluppo rurale,cofinanzia i vari Programmi di Sviluppo Ru-rali elaborati da ciascuna regione, in unquadro di coerenza con le linee strategi-che e dell’UE e dei singoli SM, conforme-mente alle previsione del Piano StrategicoNazionale. Nel dettaglio, la politica di svi-luppo rurale viene implementata attra-verso quattro assi di intervento prioritari,di seguito riportati (tabella 3).A completamento della politica di tuteladel territorio, è stato elaborato il nuovoFondo Europeo per la Pesca (FEP), con unadotazione di 3,849 milioni di E. Il FEP sup-porta la relativa politica comunitaria, cheinveste in particolare le tematiche dellaconservazione e della limitazione dell’im-patto della pesca sull’ambiente, al fine diproteggere le risorse ittiche, regolamen-tando le quantità di pesce catturato in ma-re e garantendo la riproduzione del novel-lame e il rispetto delle norme.
Life+
La promozione della politica ambien-tale dell’UE e della rilevante legislazio-

Flavia Amato
riflettore
su
ENERGIA, AMBIENTE E INNOVAZIONE 6/2007 42
ne è invece assicurata dal programmaLife+, che raccoglie e razionalizza l’e-redità dei precedenti programmi tema-tici Life, Quadro comunitario di coope-razione per lo sviluppo sostenibile del-l’ambiente urbano, Programma di azio-ne comunitario per le ONG attive nel-la protezione ambientale e Forest fo-cus.Il programma, attraverso un unico stru-mento finanziario, offre sostegno spe-cifico alle misure e ai progetti aventi va-lore aggiunto europeo per l’attuazione,l’aggiornamento e lo sviluppo della po-litica e della normativa comunitaria inmateria di ambiente, in particolare perla realizzazione del Sesto programmaquadro di azione comunitario in mate-ria di ambiente. Life dispone di 2,143 mi-liardi di euro, il cui 22% è riservato allaCommissione per finanziare le ONG eper assicurare la diffusione delle infor-mazioni e la sensibilizzazione sulle te-matiche ambientali. Il restante 88% èdestinato agli SM, ed è regolamentato
secondo una modalità di “gestione cen-tralizzata indiretta” della Commissione,con delega agli SM per l’esecuzione delbilancio.Ogni SM beneficia di una quota-parteprefissata del budget ma è comunqueprevisto che, nel caso in cui l’ammonta-re complessivo del finanziamento per iprogetti selezionati fosse inferiore all’al-locazione prevista per lo SM la Commis-sione possa disporre dei residui per co-finanziare i progetti di altri SM che mag-giormente contribuiscono al raggiungi-mento degli obiettivi comunitari.Tre sono gli assi di intervento di Life+(tabella 4).
Rubrica Cittadini, Libertà, Sicurezza, e Giustizia
La crescente importanza riconosciuta aitemi legati alla giustizia, alla sicurezzadei confini a fronte di possibili minacceesterne all’UE e allo sviluppo della figu-ra del cittadino europeo, è testimonia-
Tabella 3 - FEASR, Assi prioritari di intervento
Asse Priorità d’intervento
Miglioramento della competitivitàdei settori agricolo e forestale.
Miglioramento dell’ambiente e dello spazio rurale.
Qualità della vita nelle zone rurali e diversifi-cazione dell’economia rurale.
Approccio leader.
Trasferimento delle conoscenze, della moder-nizzazione, dell’innovazione, della qualità
nella catena alimentare.
Biodiversità, preservazione e sviluppo dell’attività agricola e dei sistemi forestali
ad elevata valenza naturale e dei paesaggiagrari tradizionali, regime delle acque,
cambiamento climatico.
Creazione di posti di lavoro e delle condizio-ni per la crescita, sviluppo di strategie locali,
conservazione dell’attrattiva delle zone ruraliformazione, informazione e imprenditoria-lità devono tener conto, in particolare, delleesigenze delle donne, dei giovani e dei lavo-
ratori anziani.
Miglioramento della governance, mobilita-zione del potenziale di sviluppo endogeno
delle aree rurali, contributo al conseguimen-to delle priorità degli Assi 1 e 2 e soprattutto
dell’Asse 3.
Fonte: elaborazione ENEA

Le opportunità dei programmi UE 2007-2013
riflettore
su
ENERGIA, AMBIENTE E INNOVAZIONE 6/2007 43
ta dal maggiore sforzo finanziario del-la programmazione 2007-2013 rispettoalla precedente. I programmi che insi-stono nella terza rubrica sono stati or-ganizzati in programmi quadro temati-ci, di durata settennale.
Programma d’azione comunitaria in materia di salute
Il secondo Programma d’azione comunita-ria in materia di salute che, a causa del ri-tardo nel raggiungimento di un accordointeristituzionale sulla dotazione finan-ziaria (365 milioni di euro, secondo il re-cente compromesso) partirà nel 2008, èespressione dello spirito europeo di crea-re un’area comune di prosperità, solida-rietà e sicurezza. Pur restando infatti i si-stemi sanitari nel terreno di competenzaesclusiva degli SM, quelle sfide che, in ap-plicazione del principio di sussidiarietà,possono essere meglio affrontare a livellosoprannazionale, quali pandemie, malat-tie legate all’invecchiamento della popo-
lazione, minacce del bioterrorismo, espo-sizione a prodotti chimici o prevenzionedegli incidenti sul lavoro, possono essereoggetto di trattazione comune. Il pro-gramma, in particolare, intende accelera-re la capacità europea di rispondere aemergenze sanitarie transfrontaliere inmodo coordinato ed efficiente.Nel dettaglio, il programma insiste su treassi prioritari così articolati (Tabella 5).
I programmi Cultura e Media 2007-2013
Il Programma Cultura, con una dotazio-ne di 400 milioni di euro è un program-ma plurinennale unico aperto a tutti glioperatori culturali non audiovisivi e asettori culturali. Rispetto al suo prede-cessore, il nuovo programma supera lalogica settoriale per aprirsi a progetti dicarattere marcatamente multidiscplina-re. Cultura è gestito dall’Agenzia Esecu-tiva per l’Istruzione e la Cultura e l’Au-diovisivo (EACEA) che, sotto la supervi-
Tabella 4 - Assi prioritari Life + con relativi obiettivi strategici
Asse Priorità d’intervento
Natura e biodiversità
Politica ambientale e governance
Informazione e comunicazione
Attuazione delle direttive comunitarie su conservazione degli habitat e tutela
degli uccelli selvatici.Potenziamento delle competenze
per sviluppo, monitoraggio e verifica di poli-tica e legislazione comunitaria, per di ridurrela perdita di biodiversità in UE entro il 2010.
Sviluppo e dimostrazione di approcci, tecno-logie, metodi e strumenti innovativi di politi-
ca ambientale.Sostegno al miglioramento della governance
ambientale, favorendo la partecipazione dei soggetti interessati all’attuazione
delle politiche.
Diffusione delle informazioni e sensibilizza-zione alle tematiche ambientali.;
Misure di accompagnamento, azioni e campagne d’informazione, conferenze
e formazione.
Fonte: elaborazione ENEA

Flavia Amato
riflettore
su
ENERGIA, AMBIENTE E INNOVAZIONE 6/2007 44
sione della Direzione Generale Istruzio-ne e Cultura (DG EAC) della Commissio-ne Europea, riconosce priorità ai proget-ti più creativi ed innovativi. Il programma, si concentra su tre obiet-tivi prioritari: favorire la mobilità tran-snazionale dei professionisti del settoreculturale; incoraggiare la circolazionetransnazionale delle opere e dei pro-dotti artistici e culturali; favorire il dia-logo interculturale. Nessun settore diattività culturale e artistica è escluso apriori e gli operatori possono propor-re progetti che corrispondono ai lorointeressi, purché perseguano almenodue degli obiettivi citati. Nella prospettiva di realizzare uno spa-zio culturale europeo comune, il pro-gramma Cultura è affiancato dal Pro-gramma Media, specificamente dedi-cato al settore degli audiovisivi. Il so-stegno ai servizi digitali e ai cataloghieuropei costituisce una delle priorità
del programma al fine di ovviare allaframmentazione del mercato audiovi-sivo europeo.In particolare, i finanziamenti banditi,per un totale di 755 milioni di euro, fa-voriscono il ricorso alle tecnologie di-gitali per la produzione, postproduzio-ne, distribuzione, commercializzazionee archiviazione dei programmi audio-visivi europei.
Programma quadro Sicurezza e tutela delle libertà
Sul versante della “security”, muoven-do dal principio che ogni minaccia ter-roristica o ogni altra forma di criminilitàriguarda l’UE nel suo insieme e non ilsingolo SM in cui i fatti si verificano, ilProgramma quadro Sicurezza e tuteladelle libertà contribuisce a rendere pos-sibili società sicure, fondate sullo statodi diritto4.
Tabella 5 - Programma d'azione comunitaria in materia di salute. Assi e priorità di intervento
Asse Priorità d’intervento
Migliorare la sicurezza sanitaria dei cittadini.
Promuovere la salute al fine di promuoverela prosperità e la solidarietà.
Generare e diffondere conoscenze sulla salute.
Protezione da malattie trasmissibili e non tra-smissibili, da infezioni di origine nosocomialee da minacce deliberate di origine fisica, chi-mica o biologica; miglioramento della sicu-rezza e della qualità di organi e sostanze diorigine umana quali sangue ed emoderivati;miglioramento delle capacità di risposta alleemergenza con attrezzature di protezione,impianti di isolamento e laboratori mobili.
Studio dei determinanti sanitari per promuo-vere e migliorare la salute, inclusi quelli am-bientali, ed esame dei determinanti che com-portano dipendenza; analisi dei fattori dispa-rità della salute delle popolazioni UE, in par-
ticolare dei nuovi SM.
Raccolta e scambi di informazioni relative al-le principali problematiche sanitarie; elabora-
zione di meccanismi di consultazione.
Fonte: elaborazione ENEA
4. COM(2005) 124 definitivo, Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento Euro-peo che istituisce il programma quadro “Sicurezza e tutela delle libertà”per il periodo 2007-2013.

Le opportunità dei programmi UE 2007-2013
riflettore
su
ENERGIA, AMBIENTE E INNOVAZIONE 6/2007 45
Con la nuova programmazione, il te-ma della sicurezza è stato razionaliz-zato e, con un budget complessivo di745 milioni euro, sull’argomento insi-stono due subprogrammi: il primo,“Prevenzione e lotta contro la crimi-nalità”, orientato soprattutto alla pre-venzione e alla lotta contro i criminisu bambini, traffico di armi e drogaterrorismo; il secondo, invece, è inti-tolato “Prevenzione, preparazione egestione delle conseguenze del terro-rismo”.Questo secondo, in particolare, offre unquadro di riferimento e contribuisce al-lo sviluppo del Programma europeo perla protezione delle infrastrutture criti-che (EPCIP), laddove per infrastrutturecritiche si intende quel complesso di ri-sorse, servizi, funzioni informatiche, re-ti ed infrastrutture che, se interrotti odistrutti, metterebbero a repentaglio l’e-rogazione di servizi primari o il funzio-namento degli apparati statali o comu-nitari. Il concetto di infrastruttura criticainclude quindi le reti energetiche, le tec-nologie informatiche, il settore banca-rio e i mercati, erogazione di servizi sani-tari, distribuzione alimentare, acqua (ri-serve, stoccaggio, trattamento), la pro-duzione, il trattamento e il trasporto dimateriali pericolosi, trasporti, servizi am-ministrativi di base.
Rubrica “UE come partner mondiale”
Quale attore di primo piano della co-munità internazionale, l’UE dedica in-genti risorse alla promozione dellastabilità e della prosperità nei paesiterzi, riservando, com’è ovvio, un’at-tenzione particolare ai paesi di mag-giore prossimità geografica. Anche per le relazione esterne, lanuova programmazione ha cercato dicreare regole più semplici ed omoge-
nee. Per questo motivo, i nuovi stru-menti di finanziamento, suddivisi peraree geografiche, coprono i cinqueContinenti. All’interno di questa nuo-va generazione di programmi, vale lapena soffermarsi sullo strumento diassistenza di pre-adesione (IPA) e sul-lo strumento europeo di vicinato epartenariato (ENPI).L’IPA, che sostituisce i vecchi program-mi dedicati agli stati di pre-adesione(PHARE, ISPA, SAPARD), lo strumentodi assistenza per la Turchia e CARDSper i Balcani occidentali, è il nuovostrumento attraverso cui l’UE suppor-ta i paesi beneficiari nell’allineamen-to alla politiche di settore e agli stan-dard comunitari, in particolare in queisettori nei quali le norme comunita-rie sono sempre più rigorose, qualiambiente, energia, agricoltura. I fon-di messi a disposizione ammontano aoltre 11 miliardi di euro per i prossi-mi sette anni.Due sono le categorie di paesi interes-sati: Paesi Candidati, Turchia, Croaziaed ex Repubblica Jugoslava di Mace-donia) e i potenziali paesi candidati(Albania, Bosnia-Erzegovina, Monte-negro Serbia, incluso il Kosovo), conlivelli di assistenza di portata differen-ziata.Per ciascuno dei citati paesi, l’assisten-za è fornita sulla base di bandi apertiad entità giuridiche degli SM o degliStati beneficiari, attivati ai fini del-l’implementazione di documenti indi-cativi pluriennali stabiliti per paese instretta consultazione con le autoritànazionali. Occorrerà quindi valutare i Piani plurien-nali di ciascun paese che inevitabilmen-te riguarderanno temi quali l’ambiente,i trasporti, l’industria, la qualità dei pro-dotti, le condizioni di lavoro ecc.,ovve-ro settori nei quali le norme comunitariesono sempre più rigorose.

Flavia Amato
riflettore
su
ENERGIA, AMBIENTE E INNOVAZIONE 6/2007 46
L’ENPI sostituisce invece i precedenti pro-grammi MEDA e, in parte, TACIS. Lostrumento, con un budget di oltre 11 mi-liardi euro, è volto a consolidare ed acce-lerare l’integrazione tra l’UE e i suoi“partner”: Algeria, Autorità palestine-se della Cisgiordinaia e di Gaza, Arme-nia, Azerbaigian, Bielorussia, Egitto, Fe-derazione russa, Giordania, Georgia,Israele, Libano, Libia, Marocco, Moldo-va, Siria, Tunisia, Ucraina.L’assistenza sosterrà svariati settori tra iquali la promozione dello sviluppo soste-nibile e della protezione ambientale, lacooperazione nei settori dell’energia edei trasporti, la sicurezza alimentare, latutela del patrimonio storico e culturale.
Conclusioni
Un volo ad ampio raggio sulle opportu-nità di finanziamento 2007-2013 costi-tuisce il tentativo di organizzare in ma-niera ragionata una selezione di possibi-li aree di interesse in campo energeti-co-ambientale e della innovazione, sot-tolineando, di volta in volta, le differen-ze con la precedente tornata di pro-grammi europei. Si tratta, com’è ovvio,di una panoramica che non pretende diessere esaustiva e che, anzi, intende la-sciare spazio a successivi approfondi-menti dedicati. In altre parole, si è cerca-to di fornire una sorta di piccola busso-la per districarsi nel complicato quadrodei finanziamenti europei.
Tabella 6 - Programmi europei 2007-2013
Rubrica PF Programma/Finanziamento Per maggiori informazioni
1.B Coesione perla crescita e l’occupazione
1.A Competitivitàper la crescita e l’occupazione
VII PQ RSTCIPApprendimento permanenteSafer Internet PlusErogazione interoperabile diservizi paneuropei di governo elettronicoReti TENFondi strutturali e di coesione
Sviluppo ruraleFondo europeo pescaLife+Programma d’azione comuni-taria in materia di saluteCultura 2007Media 2007PQ Sicurezza e tutela delle libertàIPAENPI
http://cordis.europa_eu/fp7/home_en_htmlhttp://ec.europa.eu/enterprise/enterprise_policy/cip/index_en.htmhttp://ec.europa.eu/education/programmes/newprog/index_en.htmlhttp://europa.eu.int/information_socety/activities/sip/index_en.htmhttp://ec.europa.eu/idabc/en/home
http://ec.europa.eu/ten/index_en.htmlhttp://www.dps.mef.gov.it/
http://www.politicheagricole.it/http://www.politicheagricole.it/http://europa.eu/environment/life/http://ec.europa_eu/health/ph_overview/pgm2007_2013_en.htm
http://ec.europa_eu/culture/eac/index_en.htmlhttp://ec.europa_eu/information_society/media/index_en.htmhttp://ec.europa_eu/justice_home/finding/intro/founding_intro_en.htmhttp://ec.europa_eu/enlargement/financial_assistance/ipa/index_en.htmhttp://ec.europa_eu/world/eup/index_en.htm
2. Sviluppo soste-nibile e tutela del-le risorse naturali
3, Cittadinanza, li-bertà, sicurezza egiustizia
4. UE come partner mondiale

Le opportunità dei programmi UE 2007-2013
riflettore
su
ENERGIA, AMBIENTE E INNOVAZIONE 6/2007 47
Inoltre, pur nella consapevolezza chenon tutti le iniziative menzionate ri-scuotono la stessa attenzione da par-te dei potenziali proponenti, è pur ve-ro che la partecipazione ai progetticomunitari impone di aver presente ilpanorama generale per meglio coglie-re le specificità del singolo program-ma per non incorrere nel rischio dell’“out of scope”.
Infine, l’esposizione degli strumentiderivanti dalle nuove prospettive si èresa necessaria alla luce di un progres-sivo declino degli aiuti a favore delleregioni italiane, la cui ammissibilitàverrà messa seriamente in discussionedopo il 2013. Occorre, quindi in qual-che modo approfittare delle opportu-nità offerte oggi, non conoscendonela disponibilità per il futuro.

ENERGIA, AMBIENTE E INNOVAZIONE 6/2007 48
Come noto, si definiscono Piccole e Me-die Imprese (PMI) quelle aziende chedanno lavoro a meno di 250 dipendentied hanno un fatturato inferiore a 50 mi-lioni di euro (oppure un bilancio infe-riore a 43 M€). Esse rappresentano, in-sieme alle microimprese con meno di 10addetti e meno di 2 M€ di fatturato, il94,9% del totale nazionale [1] e, pertan-to, costituiscono la trama fondamentaledel sistema produttivo nazionale.In un sistema siffatto, quasi per defini-zione, dietro ogni prodotto e servizionon possiamo che avere tutto un insie-me di imprese dedicate alle diverse at-tività che, insieme, sono necessarie pertradurre risorse primarie in quel prodot-to e/o servizio; questo insieme è chiama-to “catena di imprese” o, in inglese,“Supply Chain” (figura 1). L’insieme del-le catene che forniscono la stessa tipo-logia di prodotto o di servizio costitui-sce una “filiera”.È fin troppo evidente che la bontà di unsistema produttivo sostanzialmente fon-dato su PMI dipende, certo, dalla bontàdelle sue singole imprese, ma anche, e
Le crescenti esigenze di competitività e di alti livelli
di qualità hanno spostato l’attenzione della ricerca
nella logistica verso approcci innovativi al coordinamento
delle catene di imprese e all’utilizzodelle tecnologie informatiche.
L’ENEA propone un modello innovativo di gestione delle catene
di PMI che punta a coniugare competizione e collaborazione
tra le imprese
studi
& ricerc
he La Supply Chain
integrataRoberto Tononi, Gilda Massa,
Raimondo Raimondi, Giuseppe Spagna
The integrated supply chain
Growing needs of competitiveness and highlevels of quality have shifted the focus
of logistics research to innovative approaches to coordinating supply chains and usinginformation technology. ENEA proposes
an innovative management model for SMEsupply chains, with the aim of coupling
intercompany competition and cooperation
ENEADipartimento Biotecnologie,
Agroindustria e Protezione della Salute

La Supply Chain integrata
studi
& ricerc
he
ENERGIA, AMBIENTE E INNOVAZIONE 6/2007 49
sfruttando anche le nuove tecnologiecome fattori abilitanti, che permettano,cioè, l’adozione di soluzioni il cui gradodi complessità, a volte troppo alto perle PMI, viene reso trasparente alle im-prese della catena. Questa attività di ricerca è condotta dal-l’ENEA con partner tanto nazionali, co-me la “e-Business Management School”dello ISUFI (Università di Lecce) e la“School of Business” del Politecnico diMilano, quanto internazionali, come laIBM, il MIT di Boston (USA), l’ImperialCollege of Science (UK).L’attività è concentrata sulle catene delsettore agro-alimentare, poiché, comeben noto, sono quelle che soffrono mag-giormente dei problemi di sistema del-le catene.
Quadro della ricerca condotta daENEA/ sulla Supply Chain Integrata
Molti dei problemi delle “catene” sonoconosciuti anche al grande pubblico, inparticolare nell’agro-alimentare, comela notevole lievitazione dei prezzi dallaproduzione primaria al consumo e l’ec-cessivo livello di intermediazione. Co-munque sia, la gran parte di questi pro-blemi è riconducibile all’insufficiente li-vello di coordinamento tra le impresemembri della catena o, come si usa di-re, al basso livello di integrazione, so-prattutto verticale, cioè tra imprese di
soprattutto, dalle capacità operative del-le catene che esse realizzano. È ancoraevidente che questo sposta il focus deiproblemi delle realtà produttive, daicontesti della singola impresa a quellidel ‘sistema’ che ogni catena costituisce,con un inevitabile aumento dei livelli dicomplessità dei problemi e delle relati-ve soluzioni, difficilmente individuabilie attuabili dalla singola impresa.È questa caratterizzazione di ‘sistema’che ha spostato nel tempo l’attenzionedelle ricerche che si sono condotte perdecenni sulla logistica, verso i problemidi gestione delle catene, riconoscendoche le soluzioni logistiche finiscono peressere tanto buone quanto i sistemi diimprese che li devono attuare sulla inte-ra catena. Dette attività di ricerca hanno,pertanto, assunto il nome di “LogisticaIntegrata” o “Supply Chain Integrata”.L’ENEA da anni conduce attività in que-sti contesti, con una iniziale concentra-zione sulle tecnologie che favorisconoalti livelli di cooperazione tra le impresedelle catene, come quelle dell’informa-tica di livello enterprise e degli strumen-ti di progettazione condivisa, contem-plati in occasione dei progetti condottialla fine degli anni 90, sotto l’egida del-la legge 488/92. La concentrazione si èpoi gradualmente spostata sulla neces-sità di proporre nuovi modelli gestiona-li, capaci di risolvere i grossi problemi diintegrazione tra le PMI delle catene,
Figura 1Generico schema di una Supply Chain

Che detti metodi di coordinamento de-centralizzato possano costituire una so-luzione è intuibile se si considera che, inun contesto in cui il citato allineamen-to sia stato già realizzato, ogni specifi-ca impresa membro potrà essere lascia-ta libera di operare autonomamenteverso il naturale obiettivo della massi-mizzazione dei suoi interessi, visto che,ad allineamento avvenuto, il suo opera-to andrà anche in favore dell’interessegenerale della catena/sistema.Il modello di gestione proposto dall’E-NEA introduce i metodi di coordinamen-to decentralizzato nelle seguenti 6 areecritiche del funzionamento di una cate-na di PMI indipendenti:
• i contratti di fornitura, che regolanolo scambio di risorse tra le imprese dellacatena;• le ottimizzazioni di esercizio dell’inte-ra catena;• la gestione unificata della logistica;• l’allineamento delle caratteristiche diqualità del prodotto finale, che la cate-na porta sui mercati al consumo;• il sostegno all’innovazione, sia di pro-cesso che di prodotto;• la definizione del piano strategico dicatena.
tipologie diverse, che svolgono attivitàtra loro complementari (per es. tra pro-duttori primari e aziende dedite alla tra-sformazione). Ma il basso livello di integrazione è, asua volta, causato dalla difficoltà di tro-vare, tra le stesse PMI della catena, l’im-presa che sia in grado di ricoprire inmaniera efficace e autorevole il ruolodi coordinatore centrale [2]. Per “auto-revole” qui s’intende la capacità e fi-nanche la possibilità di imporre, a tuttele imprese della catena, comportamen-ti che siano sempre coerenti con l’inte-resse generale dell’intera catena, con-siderata come un tutt’uno, “come siste-ma”.L’ENEA, in collaborazione con i suoipartner, ha sviluppato e propone unmodello di gestione di catene di PMIbasato sui cosiddetti “metodi di coor-dinamento decentralizzato” [3], fina-lizzati a una gestione ottimizzata del-la catena.Questi metodi consistono in regole dicollaborazione tra le imprese membridella catena, progettate in maniera dacondurre all’allineamento degli specifi-ci interessi delle singole imprese, con l’in-teresse complessivo della catena consi-derata come sistema.
Roberto Tononi, Gilda Massa, Raimondo Raimondi, Giuseppe Spagna
studi &
ricerc
he
ENERGIA, AMBIENTE E INNOVAZIONE 6/2007 50
Figura 2Schema degli interventi del modello SMEC

La Supply Chain integrata
studi
& ricerc
he
ENERGIA, AMBIENTE E INNOVAZIONE 6/2007 51
Ma il modello propone anche il ricorsoa un insieme di tecnologie innovative,tra le quali una piattaforma informati-ca, architettata ad hoc, per automatiz-zare l’esecuzione dei metodi di coordi-namento decentralizzato in maniera ta-le da facilitarne l’adozione.Il modello punta complessivamente aspecializzare la collaborazione tra le im-prese della catena in modo da poten-ziarne la capacità competitiva.Con le sei linee di intervento prima ci-tate, questo viene perseguito attraver-so modalità diverse e complementari (fi-gura 2):
• con i contratti di fornitura si punta adelevare quantitativamente l’offerta del-la catena sui mercati al consumo peravere maggiori ricavi, a parità di doman-da del mercato e di capacità produttivedella catena;• con le ottimizzazioni di esercizio e lagestione unificata della logistica si pun-ta a diminuire i costi operativi dell’inte-ra catena;• con l’allineamento delle caratteristi-che di qualità, il supporto all’innovazio-ne e il piano strategico di catena, si pun-ta a potenziare la capacità della catenadi soddisfare le esigenze del consuma-tore.
Le sei linee di intervento corrispondonoanche ai sei moduli del modello di ge-stione. Poiché detti moduli sono sostan-zialmente indipendenti, il modello puòessere adottato anche in quelle catenenelle quali alcune delle linee d’interven-to proposte non possano essere adotta-te: si perderanno certamente i benefici ele sinergie ad esse associate, ma si man-terranno almeno i benefici delle altre.Il criterio che il modello propone perl’effettiva adozione dei metodi di coor-dinamento decentralizzato da una qual-sivoglia catena, è che questi devono
esplicitamente condurre ad un aumen-to del profitto netto dell’intera catenae che, inoltre, l’operazione di ripartizio-ne del profitto di catena, tra i membri,deve assicurare che ciascuna impresa ri-ceva una quota di profitto che la ripa-ghi sufficientemente dei costi che ha do-vuto sopportare, per allineare i suoi inte-ressi a quelli della catena.Con tale criterio l’adozione dei metodidi coordinamento decentralizzato puòdavvero avvenire senza pressione eser-citata da un coordinatore centrale, il cuicompito si ridurrà, ormai, a quello di il-lustrare l’insieme dei benefici e dei co-sti connessi con l’adozione del modellodi gestione.Questo è stato sviluppato dall’ENEA nel-l’ambito del progetto di ricerca europeo“e-MENSA” [4] che si è concluso nel lu-glio del 2006, prende il nome di SMEC(Small Medium Enterprise Chain) ed èstato anche presentato a una commis-sione del Parlamento Europeo che hasollecitato la presentazione di un ampioprogetto di sperimentazione del model-lo stesso.Le attuali attività di ricerca, relative al-l’applicazione del modello SMEC, sonoconcentrate sulla sperimentazione concatene del settore agro-alimentare, nel-l’ambito di due progetti cofinanziati dalMinistero della Ricerca e che prendono ilnome di LEMURE e FOODSYS.Obiettivo finale della sperimentazioneè quello di costituire il cosiddetto “Cen-tro Dimostrativo Virtuale” consistentein un servizio, disponibile su internet,che permetterà alle catene di PMI di ve-rificare “quantitativamente” i maggio-ri benefici economici che esse potrebbe-ro raccogliere con l’adozione del model-lo SMEC, rispetto a quanto risulta dalleloro pratiche operative correnti. Il seguito di quest’articolo passa a illustra-re le sei linee di intervento del modelloe, brevemente, la proposta tecnologica.

Roberto Tononi, Gilda Massa, Raimondo Raimondi, Giuseppe Spagna
studi &
ricerc
he
ENERGIA, AMBIENTE E INNOVAZIONE 6/2007 52
I contratti di fornitura
La prima delle sei linee di intervento delmodello SMEC riguarda i contratti di for-nitura.Come noto, la tipologia di contratto difornitura più diffusa è quella con la qua-le un’impresa della catena acquista ri-sorse dalle imprese che sono a montenella catena e vende i risultati della suaattività alle imprese che sono a valle nel-la catena.Questi scambi di compravendita avven-gono a prezzi che sono maggiori dei co-sti di produzione per garantire profittoalla parte fornitrice. Questa tipologia di
contratto, in gergo, è chiamata “con-tratto del grossista”, è tipica delle cate-ne composte da imprese tra loro indi-pendenti e ha il grande vantaggio del-la semplicità di amministrazione.Purtoppo però ha anche lo svantaggioche, a seconda dei casi, può risultarepiuttosto pesante, di limitare l’offertadella catena sul mercato al consumo avalori che sono al di sotto di quello chegarantisce il massimo profitto alla cate-na stessa, quindi a valori che sono sub-ottimi.Per rendersene conto rapidamente, ba-sta fare il confronto tra il comportamen-to di una catena formata dalle divisioni
Figura 3Definizione della offerta ottima
Figura 4Contrazione dell’offerta per una catena di PMI indipendenti

La Supply Chain integrata
studi
& ricerc
he
ENERGIA, AMBIENTE E INNOVAZIONE 6/2007 53
o dipartimenti di una sola grande azien-da, cioè quella che gli economisti chia-mano “catena verticalmente integrata”,e il comune comportamento di una cate-na di imprese indipendenti che adotti ilcontratto del grossista.Nella catena verticalmente integrata,normalmente, le varie divisioni o dipar-timenti si scambiano risorse senza ven-dersele e il livello dell’offerta, da porta-re sul mercato, è definito dalla divisio-ne commerciale, l’ultimo anello della ca-tena, che conosce la domanda di mer-cato e seleziona quel livello di offertache garantisca il massimo profitto alla“azienda” (azienda che qui coincide conla catena). Una delle nozioni base di microecono-mia [5] ci ricorda che questo livello è de-terminato dall’incrocio tra la curva delladomanda, che l’impresa vede sul merca-to, e la curva della sua offerta, coinci-dente con la curva dei suoi costi margi-nali, come evidenziato nel grafico ripor-tato in figura 3, nel quale viene anchevisualizzato l’incrocio che individua l’of-ferta che massimizza il profitto della ca-tena.Nella catena verticalmente integrata, lacurva dei costi marginali risulta dallasomma dei costi sostenuti da tutte le di-visioni dell’azienda impegnate nel ren-dere disponibile il prodotto finale suimercati al consumo, dalla produzioneprimaria, alla trasformazione, alla distri-buzione e così via fino alla vendita aldettaglio.Se ora, per lo stesso prodotto, conside-riamo una catena di imprese indipen-denti che adotti il contratto del grossi-sta, avremo che il livello di offerta del-la catena è definito, ancora, dall’ultimoanello della catena, cioè dal dettaglian-te, quando questo emette gli ordini ver-so i suoi fornitori.Anche il dettagliante, evidentemente,definisce il livello di offerta in maniera
tale da massimizzare il profitto che eglistesso raccoglierà dal mercato; e il crite-rio è ancora lo stesso, cioè quello di sce-gliere il valore corrispondente all’incro-cio tra curva della domanda e curva del-l’offerta; solo che, ora, la curva dell’of-ferta è quella del dettagliante ed è de-terminata dalla somma dei costi che eglisopporta, quindi dalla somma dei suoicosti operativi più il prezzo che egli de-ve pagare ai suoi fornitori; ma questoprezzo è certamente maggiore dellasomma dei costi della catena a montedel dettagliante, poiché include anche iprofitti delle varie imprese che operanoin quella parte della catena.Tutto ciò conduce ad una curva dei co-sti marginali (indicata a tratto pieno infigura 4) che sarà, quindi, al di sopra del-la curva data dalla somma dei costi che siaveva nella catena verticalmente inte-grata e indicata, in figura 4, dalla curvapunteggiata. Ne deriva che il livello di offerta sceltodal dettagliante è minore che nel casoprecedente, comportando minori ricavie quindi minori profitti per la catena nelsuo complesso.La diminuzione sarà tanto maggiorequanto più elastica sarà la domanda equanto meno pendente sarà la curva deicosti marginali.Qual è la proposta del modello SMECper aggirare questo problema?È quella, tutto sommato anche intuiti-va, di far comportare la catena di impre-se indipendenti in maniera analoga aquella di una catena verticalmente inte-grata. Questo si traduce nel chiedere al-le imprese della catena di scambiarsi ri-sorse a valore di costo e, quindi, nel di-stribuire poi tra le stesse imprese il pro-fitto che il dettagliante raccoglie dallavendita, sul mercato al consumo, delprodotto finale.Si tratta, evidentemente, di una tipolo-gia di contratto ben più difficile da gesti-

Roberto Tononi, Gilda Massa, Raimondo Raimondi, Giuseppe Spagna
studi &
ricerc
he
ENERGIA, AMBIENTE E INNOVAZIONE 6/2007 54
re rispetto al contratto del grossista; mala maggior complessità andrà confron-tata con la potenzialità di maggior rica-vo, e quindi maggior profitto, che river-sa sulla catena e, soprattutto, sulle sin-gole imprese membri.Con la sperimentazione e con il serviziodel “Centro Dimostrativo Virtuale”,ENEA sta lavorando proprio per metterele catene di PMI in condizione di farequesti tipi di verifiche.Una tipologia di contratto, come quellasopra accennata, viene proposta dagliesperti di settore con varie formulazioni,che prendono nomi un po’ esotici, comeil contratto di “Revenue Sharing”, il con-tratto di “Buy Back” [6] ecc. Ma il concet-to base è quello appena illustrato.Come esempi concreti di chi ha già ap-plicato questa tipologia di contratto, sipuò citare la catena di film in DVD rife-ribile al dettagliante Blockbuster, il cuirisultato è stato straordinario: una cre-scita della propria quota di mercato dal24% al 40% [6].
Ottimizzazione del funzionamento della Catena
La seconda delle sei linee d’interventodel modello SMEC riguarda le ottimiz-zazioni dell’esercizio della catena.Le ottimizzazioni possono essere rivol-te a parametri differenti, quali i costi, itempi di consegna o altro. Normalmen-te, si può ottimizzare l’esercizio su unsolo parametro; se però c’è interesse supiù parametri, si può formulare un’op-portuna funzione di utilità che riflettal’importanza relativa che hanno i diver-si parametri considerati; quindi si va adottimizzare questa stessa funzione.Al momento, il modello SMEC conside-ra come unico parametro il costo di eser-cizio complessivo della catena; in tal ca-so, l’ottimizzazione coincide con la mi-nimizzazione di questo costo.
La minimizzazione del costo di una ca-tena ha l’obiettivo di individuare quel-la distribuzione delle attività - quindidelle sub-forniture tra le imprese dellacatena - che minimizzi il costo comples-sivo per ciascuna fornitura richiesta allacatena stessa.Normalmente, nelle catene di impreseindipendenti ogni singola impresa cer-ca di minimizzare i propri costi; ma que-sto non corrisponde, in genere, alla mi-nimizzazione dei costi di catena.Difatti, ogni impresa riesce a tenere i co-sti al minimo solo in un intervallo ristret-to del proprio livello di produzione equesto garantisce il minimo costo dellacatena solo se la fornitura di quest’ulti-ma è quella che si ha quando ogni im-presa membro effettua forniture in cor-rispondenza del proprio minimo. Nonappena la fornitura della catena devecrescere o diminuire, per seguire la do-manda di mercato, questa condizionenon è più verificata ed è necessario,quindi, individuare la specifica distribu-zione di sub-forniture, che porti al mi-nimo il costo di catena per quella speci-fica fornitura. È importante sottolineare che questaoperazione va fatta considerando con-temporaneamente i costi di tutte le va-rie imprese che operano nella catena.Questa operazione è, in genere, abba-stanza complessa e viene effettuata conl’ausilio di programmi software specia-lizzati, che utilizzano tecniche riconduci-bili alla Programmazione Lineare.Nel servizio del Centro Dimostrativo Vir-tuale del modello SMEC, questi program-mi sono messi a disposizione dall’ENEAper permettere alle catene di PMI di indi-viduare le proprie configurazioni opera-tive che minimizzano i costi di catena.È evidente che l’adozione sistematicadella minimizzazione dei costi costitui-sce un forte incentivo alla competitivitàtra le imprese della catena che si trova-

La Supply Chain integrata
studi
& ricerc
he
ENERGIA, AMBIENTE E INNOVAZIONE 6/2007 55
no sullo stesso segmento, cioè che for-niscono gli stessi prodotti o servizi; di-fatti, le imprese che forniscono a costipiù bassi sono quelle che riceveranno lesub-forniture maggiori.Questo è assolutamente necessario se sivuol incentivare la competitività dell’in-tera catena nei riguardi delle cateneconcorrenti.Si sottolinea che l’approccio della mini-mizzazione dei costi può essere adottatosolo se si utilizzano contratti di forniturabasati sullo scambio di risorse a valore dicosto, per esempio con i contratti di Re-venue Sharing, come proposto dal model-lo SMEC; difatti, solo in tali casi, si può la-vorare sui costi di produzione di ogni im-presa per minimizzare il costo di catena.Da quanto sopra riportato si evince chei moduli del modello SMEC sono tra lorosinergici; ma essi sono anche indipen-denti. Infatti se, ad esempio non si adot-tasse il contratto di Revenue Sharing esi utilizzasse il contratto tradizionale delgrossista, l’approccio alla minimizzazio-ne dei costi avrebbe ancora una sua va-lenza, in quanto condurrebbe a mini-mizzare i prezzi pagati dal dettaglianteal resto della catena; questo non è equi-valente alla minimizzazione del costo dicatena, che è quello che più conta perla sua competitività; però fornisce, co-munque, un vantaggio competitivo neiconfronti delle catene concorrenti cheadottano contratti tradizionali.È superfluo sottolineare che l’approcciorelativo alla minimizzazione dei costi èesattamente quello che viene praticato,normalmente, in una grande catena ver-ticalmente integrata, controllata da unagrande impresa.
Gestione unificata della logistica
Un’altra linea importante del modelloSMEC è quella della gestione unificatadella logistica.
Nelle catene di imprese indipendenti è ingenere pratica corrente che ogni singo-la impresa si gestisca tanto le proprie scor-te, quanto i trasporti delle risorse che uti-lizza, in maniera tale da minimizzare i co-sti che l’impresa deve sostenere; ma ana-logamente a quanto si è visto per la ot-timizzazione dell’esercizio, questo nongarantisce che i costi complessivi della ca-tena siano minimizzati, mentre è proprioquesto che conta per il successo del pro-dotto che la catena offre sui mercati.L’approccio che propone il modelloSMEC per le catene di PMI indipendenti,e che trova già riscontro nelle pratichedelle più avanzate catene controllate dagrandi imprese, è quello di riconsidera-re le scorte di ogni singola impresamembro come componenti del più am-pio sistema costituito dalle scorte del-l’intera catena; lo stesso dicasi per i tra-sporti che interessano le singole impre-se e che vanno ridefiniti nel quadro del-l’intero sistema di movimentazione del-le risorse per tutta la catena.Nei trasporti si tratta, sostanzialmente,di coordinare i tempi e le rotte delle va-rie movimentazioni che di volta in vol-ta minimizzino i costi, compatibilmentecon le situazioni operative in cui si tro-vano già i singoli trasportatori della ca-tena; per esempio, se due produttori pri-mari sono soliti spedire risorse a dueaziende di trasformazione della stessacatena, servendosi, in maniera autono-ma, di due vettori diversi, può risultareconveniente coordinare le spedizioni perriempire un solo vettore e risparmiaresul costo di trasporto anche in misuraconsistente.In generale, le situazioni reali, con mol-te aziende che si scambiano risorse, pos-sono essere piuttosto complesse e richie-dono opportune analisi che vengonoeseguite con programmi software spe-cializzati messi a disposizione nel Cen-tro Dimostrativo Virtuale.

Roberto Tononi, Gilda Massa, Raimondo Raimondi, Giuseppe Spagna
studi &
ricerc
he
ENERGIA, AMBIENTE E INNOVAZIONE 6/2007 56
Ancor più interessanti sono i potenzialirisparmi di gestione che si possono rac-cogliere con la gestione unificata dellescorte nel senso prima precisato. Difat-ti, quest’ultima permette di sfruttareuna sorta di economia di scala, con laquale i costi di gestione delle scorte, siaquelle medie che quelle di sicurezza, cre-scono meno rapidamente delle quan-tità, quando si aggregano le scorte del-le singole imprese della catena [7]. I po-tenziali risparmi di gestione sono sem-pre notevoli, quantificati da cifre per-centuali a due cifre, e crescono all’au-mentare del numero di imprese membrie della complessità della catena, soprat-tutto quando, oltre a coordinarsi tra im-prese dello stesso segmento di catena,ci si coordina tra imprese che operanosu segmenti diversi, per esempio tra pro-duttori e dettaglianti. Questo approccioallargato di coordinamento viene chia-mato VMI, che sta per “Vendor Mana-ged Inventory”. Un esempio ben notodi applicazione di questa metodologiaè quello della catena della pasta Baril-la, che, con l’approccio unificato, è riu-scita a dimezzare il costo di gestione del-le sue scorte, con un risparmio stimabilein varie decine di milioni di euro all’an-no. Un caso, questo della Barilla, che co-stituisce un “case study” [8] utilizzatonelle migliori business school, ancheamericane.
Allineamento delle caratteristichedi qualità del prodotto che la catena porta sui mercati
Un contributo significativo, nell’ambitodel modello SMEC scaturisce dall’allinea-mento delle caratteristiche di qualità.È di dominio pubblico quanto sia impor-tante, oggi giorno, portare sul mercatoprodotti di alta qualità; ma anche notoche all’aumentare del livello di qualitàdel prodotto, aumenta il numero delle
caratteristiche che contano per quel li-vello di qualità. Naturalmente, questecaratteristiche dovranno essere tra lorocongruenti o, in gergo, allineate.Di solito queste diverse caratteristiche sa-ranno sotto il controllo di diverse impre-se della catena, dipendendo alcune daiproduttori primari, altre dalle imprese ditrasformazione e molte, soprattutto perquanto riguarda i servizi accessori al pro-dotto, dipenderanno dal dettagliante.Il problema nelle catene di PMI indipen-denti è che, se ci sono bassi livelli dicoordinamento centralizzato, c’è anchescarsa garanzia che queste caratteristi-che siano e vengano mantenute tra loroallineate; in altre parole, manca quelloche, nelle catene verticalmente integra-te, è il manager della qualità, operantesu tutta la catena; mentre potremo tro-vare, comunemente, i responsabili del-la qualità, ma per le singole imprese.Il modello SMEC propone, per questoproblema, una soluzione che è emble-matica dell’approccio dei metodi di coor-dinamento decentralizzato.Infatti, la relativa linea di intervento con-siste di tre elementi:innanzitutto, deve essere esercitato uncostante e appropriato monitoraggiodelle reazioni del consumatore all’offer-ta della catena, per coglierne pronta-mente le percezioni su eventuali caren-ze del prodotto causate da disallinea-menti tra le caratteristiche reputate im-portanti dal consumatore;una volta rilevati i disallineamenti, de-ve essere eseguita una valorizzazione dimercato dei necessari riallineamenti; inaltre parole, va determinato quale au-mento delle vendite del prodotto e/oaumento del suo prezzo accettato dalconsumatore, si può prevedere, ragio-nevolmente, come conseguenza del rial-lineamento del prodotto;infine va valutato il costo degli allinea-menti necessari.

La Supply Chain integrata
studi
& ricerc
he
ENERGIA, AMBIENTE E INNOVAZIONE 6/2007 57
Evidentemente, questo costo deve esse-re sufficientemente inferiore al valoredi mercato degli allineamenti; inoltre,la ridistribuzione degli extra profitti chegenerano i riallineamenti deve esseretale da ripagare, sufficientemente, le im-prese della catena che hanno dovuto so-stenere i costi degli allineamenti. In talmodo, questi ultimi potranno essere in-trapresi per iniziativa delle stesse impre-se, senza forzature da parte di un coor-dinatore centrale, che può limitarsi a ri-ferire su queste analisi.Evidentemente, un ruolo importante èsvolto dal dettagliante che è a strettocontatto col mercato. È inoltre necessa-rio concordare i trasferimenti di profittotra le imprese, in modo che ripaghino icosti sostenuti.Le metodologie da seguire per il monito-raggio delle reazioni del consumatore eper la valorizzazione di mercato degliallineamenti sono le stesse che il model-lo SMEC utilizza nell’altro modulo rela-tivo al sostegno all’innovazione di pro-dotto.
Sostegno all’innovazione di processo e di prodotto
Un’altra linea di intervento del model-lo SMEC è relativa al sostegno all’innova-zione di processo e di prodotto. Questalinea di intervento sulla innovazione ri-guarda in realtà due contesti piuttostodiversi [9, 10]:
• l’innovazione di processo che, come cidicono le statistiche, è generalmente at-tuata nella realtà produttiva delle PMIitaliane, però con ritardi notevoli rispet-to agli altri paesi con cui ci confrontia-mo, e questo conduce, inesorabilmente,a perdite di competitività;• l’innovazione di prodotto, che invecevive una situazione più grave perché èsempre meno presente tra le PMI italia-
ne, con conseguenze gravissime per lanostra economia che si vede sempre piùrelegata in una posizione passiva e ditraino, anziché attiva e propulsiva.
Il modello SMEC fornisce proposte rivol-te a mitigare entrambi i problemi.Per quanto riguarda l’innovazione diprocesso, è opinione diffusa che i ritardidi attuazione siano in parte dovuti alleseguenti due cause:
• quando un processo innovativo è resodisponibile dai risultati della ricerca ap-plicata questo, in genere, non riguardacontemporaneamente tutte le impresedella catena, ma solo alcune e spessouna soltanto. Si viene, pertanto, a crea-re una situazione di asimmetria, in cuiuno o pochi membri della catena devo-no sostenere i costi del progetto di in-novazione, mentre tutti gli altri ne rac-colgono i benefici, che scaturiranno daun più funzionale esercizio della cate-na;• c’è, inoltre, il solito problema della dif-ficoltà di accesso al credito per le PMIche devono attuare il progetto di inno-vazione.
Come reazione a entrambe le cause, hasenso, pertanto, la linea di interventodel modello SMEC che propone il cofi-nanziamento del progetto di innovazio-ne da parte di tutte le imprese della ca-tena, in quote che saranno proporzio-nali ai benefici che ogni impresa, si pre-vede, raccoglierà dalla attuazione delprogetto. Si tratta quindi, in concreto, di prepara-re un business plan, per così dire, “col-laborativo”, del progetto di innovazio-ne. Evidentemente, i benefici previsti dalbusiness plan, in pratica gli extra profit-ti che scaturiranno dal miglior funzio-namento della catena, dovranno esseresufficientemente maggiori dei costi del

Roberto Tononi, Gilda Massa, Raimondo Raimondi, Giuseppe Spagna
studi &
ricerc
he
ENERGIA, AMBIENTE E INNOVAZIONE 6/2007 58
progetto; inoltre, nel pieno spirito del-l’approccio SMEC, anche i ritorni perogni singola impresa dovranno superaredi un fattore significativo il finanziamen-to che ogni impresa ha erogato.L’approccio SMEC affronta con attenzio-ne anche il delicato problema della pro-prietà degli impianti e delle attrezzatu-re che attuano il processo innovativo eche sono acquisiti grazie alla operazio-ne di cofinanziamento da parte delle va-rie imprese della catena. Per quanto ri-guarda l’innovazione di prodotto, la suascarsa diffusione fra le PMI è dovuta alfatto che questa attività, col crescere del-la competizione internazionale, è dive-nuta sempre più rischiosa dal punto divista economico; si stima, infatti, che so-lo il 20-30% delle idee di nuovo prodot-to [11] si traduca in prodotti di successosul mercato. Ma al crescere del rischio non ha fattoriscontro, nel nostro Paese, un incremen-to delle infrastrutture specializzate nelfinanziamento di attività ad alto rischio,come ad esempio delle società di Ven-ture Capital. L’approccio, che qui propone il modelloSMEC, consiste in una metodologia di
sviluppo del nuovo prodotto che mira acontenere quanto più possibile il suo co-sto e, di conseguenza, il rischio finanzia-rio ad esso connesso.La metodologia fa uso di tecnicheavanzate di raccolta ed elaborazionedelle reazioni del consumatore alleproposte di nuovo prodotto, contenen-done quanto più possibile i relativi co-sti. Inoltre, la metodologia è struttura-ta in maniera tale da permetterne l’at-tuazione con l’intervento di tutte le im-prese della catena. Difatti, per l’esigen-za di presentare prodotti di qualitàsempre maggiore, è necessario aver cu-ra di un numero sempre più alto di ca-ratteristiche del prodotto stesso; carat-teristiche che sono, in genere, sotto ilcontrollo delle diverse imprese, per cuiè necessario coinvolgere, a priori, tuttele imprese della catena. In questa pro-spettiva, il maggior valore aggiuntoche scaturisce dalla adozione di unametodologia di innovazione di prodot-to, consiste nel fatto che la metodolo-gia stessa va a costituire un vero e pro-prio strumento di comunicazione e,quindi, di collaborazione, tra le impre-se della catena. Basti pensare a quanto
Figura 5Schema del Quality Function Deployment

La Supply Chain integrata
studi
& ricerc
he
ENERGIA, AMBIENTE E INNOVAZIONE 6/2007 59
spesso risulti difficile raggiungere unconsenso fra produttori primari ed im-prese di trasformazione su una idea diinnovazione per un prodotto dell’agro-alimentare; l’adozione di una metodo-logia di sviluppo va invece a stabilirequelle azioni, quelle misure e quelleverifiche, tutte preordinate, che si do-vranno intraprendere per dare una va-lutazione oggettiva, di merito, allanuova idea, favorendo così l’inserimen-to del continuo studio e della defini-zione di nuovi prodotti, tra le normaliattività di catena.
Piano Strategico di Catena
L’ultima, ma non meno importante, li-nea di intervento del modello SMEC èproprio sulla definizione del Piano Stra-tegico di Catena. Con questa linea di in-tervento, il modello di gestione SMECpunta a promuovere il passaggio da uncontesto in cui ognuna delle impresedella catena ha un proprio piano strate-gico, come è comune nelle catene di PMIindipendenti, a un contesto in cui vienedefinito, con la collaborazione di tuttele imprese membri, un piano strategicoche, essendo valido per tutta la catena,ne costituirà un fondamentale elemen-to di coesione e di caratterizzazione asistema.Il piano strategico proposto dal modellodefinisce i tre seguenti elementi:
• il primo è costituito dall’identikit delconsumatore al quale si rivolge la catenacon i suoi prodotti; in pratica, quindi,l’individuazione delle esigenze del grup-po target di consumatori;• il secondo elemento consiste nella de-finizione del miglior marketing mix chela catena può offrire al suo gruppo tar-get di consumatori, tenendo conto del-le attuali capacità realizzative della ca-tena stessa; quindi, non soltanto il pro-dotto con le sue caratteristiche, ma an-che i servizi associati, con adeguate po-litiche di distribuzione, di prezzo e dipromozione;• il terzo elemento è costituito dal po-sizionamento di mercato della catena ri-spetto alla concorrenza.
Per i primi due elementi, identikit delconsumatore e marketing mix, SMECpropone, come metodologia da adot-tare, quella del Quality Function De-ployment (QFD) [12], uno schema delquale è riportato nella figura 5. Al dilà del risultato immediato fornito dalQFD e costituito dall’insieme dei valo-ri ottimizzati degli elementi del marke-ting mix che la catena dovrà perseguire,questa metodologia, come rilevato insperimentazioni già eseguite dall’ENEA[13] nei progetti della 488, ha il gran-de vantaggio di sviluppare, nelle im-prese membri, un forte senso di coesio-ne e di appartenenza alla catena, che
Figura 6Architettura essenziale della Piattaforma Informatica del Modello SMEC

Roberto Tononi, Gilda Massa, Raimondo Raimondi, Giuseppe Spagna
studi &
ricerc
he
ENERGIA, AMBIENTE E INNOVAZIONE 6/2007 60
così si comincia a vedere come sistemaconcreto e non più come concettoastratto.Per quanto riguarda il posizionamentonei riguardi della concorrenza, poiché ilQFD implica un approccio di tipo sog-gettivo, basato cioè sulle valutazioni de-gli imprenditori delle aziende che for-mano la catena, il modello SMEC propo-ne anche l’adozione di una innovativametodologia, basata su un approccio“oggettivo”, chiamata SCOR [14], chesta per Supply Chain Operation Referen-ce model. L’oggettività dell’approccio èfornita dall’utilizzo di dati statistici sulfunzionamento delle catene, per i varisettori produttivi, che vengono raccoltied elaborati da un comitato internazio-nale che si chiama Supply Chain Coun-cil. La disponibilità di questi dati permet-te ad ogni catena, con opportuni pro-cessi standard di valutazione, di confron-tarsi con le altre catene e di decidere see come riposizionarsi sul mercato.
La proposta tecnologica del modello SMEC
L’adozione delle linee d’intervento delmodello SMEC, inevitabilmente, intro-duce maggiori livelli di complessità ope-rativa nelle attività delle PMI della cate-na, poiché comporta l’esecuzione di ope-razioni nuove per molte imprese (es. ladefinizione del piano strategico di cate-na) o, semplicemente, più articolate ri-spetto a quelle che già si conducono (es.i contratti di fornitura di tipo “revenuesharing”). Per superare questo poten-ziale grave inconveniente, il modelloSMEC arriva anche con una proposta tec-nologica, il cui principale scopo è quel-lo di automatizzare i processi di colla-borazione tra le imprese della catena,così da rendere praticamente invisibilile complessità operative introdotte colmodello.
La proposta include:
• una piattaforma informatica che assi-cura l’esecuzione, in gran parte in ma-niera automatizzata, dei processi di col-laborazione tra le imprese della catena,connettendo, in network, sia persone(gli operatori della catena) che macchine(computer e altri strumenti adoperatidalle imprese); • un set di applicazioni software, specia-lizzate a risolvere problemi ricorrentidella catena, come i programmi appli-cativi dedicati alle operazioni di ottimiz-zazioni delle subcommesse affidate al-le imprese membri, e alle schedulazionidei trasporti, o come le applicazioni diBusiness Intelligence, dedicate alla ac-quisizione ed elaborazione dei dati dimercato per fornire il forecasting di ri-ferimento per le pianificazioni operativeo per fornire opportune mappature del-la risposta dei consumatori ai prodottidella catena, utilizzate per il supportoalla innovazione di prodotto;• il ricorso all’utilizzo di dispositivihardware utilizzati per il monitoraggiodelle operazioni di catena e per la distri-buzione dei relativi dati in contesti di al-ta mobilità e, quindi, con supporti wire-less. Tra questi spicca l’utilizzo degli RFiDper le operazioni di tracciabilità e rin-tracciabilità (ma non solo) delle risorseadoperate dalla catena.
Per quanto riguarda la piattaformainformatica, la proposta è quella di adot-tare un sistema integrato di BusinessProcess Management (BPM) [15], i cuicomponenti, ormai, sono offerti sul mer-cato dai maggiori produttori di informa-tica, come ultima frontiera degli stru-menti software di livello enterprise. Nel-le attività di messa a punto del model-lo SMEC, si è curata la definizione dellapiù appropriata architettura che un BPMdeve presentare per costituire la piat-

La Supply Chain integrata
studi
& ricerc
he
ENERGIA, AMBIENTE E INNOVAZIONE 6/2007 61
taforma più adatta al supporto, nel sen-so sopra precisato, delle attività della ca-tena di PMI.Succintamente, le funzionalità che lapiattaforma deve fornire sono:
• il supporto alla modellazione dei pro-cessi di collaborazione a livello manage-riale, con l’adozione degli adeguati stan-dard (BPEL - Business Process ExecutionLanguage);• la codifica dei processi di collaborazio-ne modellati, con l’adozione, ove neces-sario, degli standard d’integrazione deiWeb Services;• il supporto al deployment e alla ge-stione a run time dei processi modella-ti e codificati;• la simulazione dei processi di collabo-razione modellati, ancor prima della lo-ro reale messa in servizio, in maniera ta-le da evidenziarne eventuali criticità, perpoterle così rimuovere tempestivamen-te;• il monitoraggio dei processi durantela loro esecuzione, confrontando i valo-ri correnti di selezionati parametri diprocesso, con valori limite, il cui supera-mento segnala situazioni di inadegua-tezza operativa;• il supporto alle comunicazioni con di-spositivi mobili, sia quelli utilizzati daoperatori umani che devono partecipa-re ai processi di collaborazione sia quel-li che ospitano applicazioni software chedevono intervenire nei processi stessi;• l’utilizzo di un Portale Web, come di-spositivo di interfacciamento con leutenze previste, con possibilità, quindi,di contestualizzare contenuti e formaticon la particolare tipologia delle impre-se utenti;• l’utilizzo di opportuna infrastrutturadi integrazione generalizzata, tra appli-cazioni e sistemi eterogenei (es. l’utiliz-zo di un Enterprise Service Bus);• il supporto alla “governance” dei ser-
vizi realizzati e utilizzati nella piattafor-ma, così da permetterne la gestione piùefficiente e la verifica delle condizionid’uso.La figura 6 riporta uno schema dell’ar-chitettura essenziale della piattaformainformatica proposta col modello SMEC.Per quanto riguarda, poi, il ricorso allatecnologia RFiD (Radio Frequency iDen-tification), questa permette l’identifica-zione automatica e la raccolta dei datiattraverso le frequenze radio [16]. La caratteristica principale di questa tec-nologia è la possibilità di associare aqualsiasi oggetto, animale o addirittu-ra persona, una serie di informazioni,memorizzate su microchip di silicio edestraibili successivamente mediante undispositivo senza fili a corto raggio. Un sistema RFiD è costituito da: un “tag”di adeguate forme e dimensioni compo-sto da microchip e microantenna inca-psulati in un supporto isolante e rinfor-zante, un lettore tipo telefonino equi-paggiato con apposita antenna, un si-stema computerizzato di elaborazione.All’interno del tag viene depositata unaserie di informazioni relative all’oggettoda monitorare; quando l’oggetto, alquale è incollato il tag, si viene a trova-re nel campo di azione del lettore a ra-diofrequenza, si attiva e trasmette il suocontenuto di informazioni al lettore, chea sua volta lo manda al sistema automa-tico di elaborazione. In questo modo siviene a realizzare un sistema dilettura/scrittura automatizzato che su-pera i limiti intrinseci del codice a bar-re, attualmente utilizzato nella identifi-cazione degli oggetti.Il codice a barre, infatti, permette di in-dividuare un prodotto, ma non una spe-cifica unità di quel prodotto, e deve es-sere letto di volta in volta singolarmen-te e manualmente a ogni stazione del-la linea di movimentazione.La tecnologia RFiD velocizza e rende

Roberto Tononi, Gilda Massa, Raimondo Raimondi, Giuseppe Spagna
studi &
ricerc
he
ENERGIA, AMBIENTE E INNOVAZIONE 6/2007 62
tracciabile il percorso della merce attra-verso la lettura/scrittura con una solapassata di interi bancali di prodotti prov-visti di tag.Gli attuali utilizzi industriali degli RFiDsi hanno, soprattutto, nei magazzini al-l’ingrosso, quindi con tag posizionali uni-camente sui pallet [17]. Nelle attività condotte in ENEA sul mo-dello SMEC si stanno studiando, invece,applicazioni avanzate di utilizzo a livel-lo di vendita al dettaglio e, quindi, diposizionamento dei tag sulle singoleconfezioni di prodotto. Questo apre sce-nari applicativi ricchi di notevole valoreaggiunto per il consumatore, quali, so-lo per citare due esempi, la possibilità dievitare la fila alla cassa di uscita di unsupermercato o la possibilità di riceveresul proprio telefonino “i consigli dell’e-sperto” allorquando ci si avvicina a unprodotto di nostro interesse. Inoltre,queste potenziali applicazioni si sposa-no con gli sviluppi tecnologici che l’E-NEA sta conducendo sulla produzionedi dispositivi RFiD realizzati con mate-riali diversi dal silicio e particolarmenteadatti per fare da tag su confezioni sin-gole di prodotto.
Conclusioni
Nella premessa si è cercato di mettere inevidenza che, ad oggi, i problemi dellerealtà produttive, popolate massicciamen-te da PMI, sono essenzialmente proble-mi di sistema, non più risolvibili sempli-cemente con approcci di enterprise ma-nagement. I problemi più insidiosi risie-dono nelle interfacce tra le imprese dellacatena e sono difficili da evidenziare, daesaminare obiettivamente e da risolverecon la sola prospettiva della singola PMImembro della catena. C’è bisogno di unapproccio sistemico, ad ampio respiro,che anticipi l’insorgenza di quei proble-mi di interfaccia e predisponga le impre-
se membri a una pronta reazione basa-ta, inevitabilmente, su alti livelli di colla-borazione tra i membri stessi della catena.Il modello SMEC è stato concepito, so-stanzialmente, con questa finalità e conla speranza di fornire agli imprenditoridelle nostre PMI uno strumento ulterio-re di analisi e di intervento operativo,per rispondere alle dure sfide competiti-ve che vengono dal mercato globale.Soltanto la sperimentazione con reali ca-tene di PMI, sulla quale in ENEA si è giàiniziato a lavorare (es. con la catena delParmigiano Reggiano), potrà dirci se - ein che misura - queste finalità vengonoeffettivamente raggiunte.

La Supply Chain integrata
studi
& ricerc
he
ENERGIA, AMBIENTE E INNOVAZIONE 6/2007 63
Bibliografia
[1] ISTAT (2003), La situazione del Paese nel 2003,Rapporto Annuale.
[2] R. Tononi, G. Amorosi (2002), Managing Vir-tual Web Organizations in the 21st Century: Is-sues and Challanges, pag. 198-212, Idea GroupPublishing, Hershey PA (USA).
[3] A. G. de Kok, S.C. Graves (2003), Supply ChainManagement: Design, Coordination and Control,Elsevier, Amsterdam.
[4] R. Tononi, G.C. Holt et. al. (2007), Research agen-da for SMEs in electronic Platforms for the Euro-pean food industry, FORESIGHT, Vol. 9, Nr. 3, pag.42-53, Emerald Group Publishing, Bradford (UK).
[5] J. L. Pappas, E. F. Brigham, M. Hirschey, Ma-nagerial Economics, ch. 10 the Firm’s Price/Out-put Decision, CBS College Publishing – The Dry-den Press, 1983, pag. 374-378.
[6] G. P. Cachon, M. A. Lariviere (January 2005),Supply Chain Coordination With Revenue Sha-ring Contracts: Strength and Limitations, Manage-ment Science, vol. 51 N°1, pag. 30-44.
[7] G. Ghiani, G. Laporte, R. Musmanno (2004),Introduction to Logistic Systems Planning andControl, pag. 149-151, John Wiley & Sons.
[8] J.H. Hammond (2000), Barilla SpA (A-D) TN,Harvard Business School Teaching Note 695-063
[9] MUR (Marzo 2005), Programma Nazionale del-la Ricerca 2005-2007, Quadro di Sintesi, pp 4 e 7.
[10] ISTAT (2006), L’innovazione delle imprese ita-liane - anni 2002-2004, pp 1, 2, 5, 6, 8 e 9.
[11] M. Crawford (1977), Marketing research andthe new product failure rate, Journal of Marke-ting, vol 41, April 1977, pp 51-61.
[12] Yoji Akao (1990), Quality Function Deploy-ment – Integrating Customer Requirements intoProduct Design, Productivity Press, Portland Ore-gon.
[13] R. Tononi, G. Amorosi (2002), EXPERIENCESGAINED APPLYING CONCURRENT ENGINEERINGTOOLS TO NETWORKS OF SMES, 8th InternationalConference on Concurrent Enterprising, pag. 47-54, University of Nottingham, UK.
[14] Supply Chain Council (2006), SCOR 8.0 Over-view Booklet, http://www.supply-chain.org/pa-ge.ww?name=SCOR+8.0+Model+Download&sec-tion=SCOR+Model
[15] R. N. Khan (2004), Business Process Manage-ment – A Practical Guide, Meghan-Kiffer Press,Tampa, Florida (USA).
[16] R. A. Kleist, T. A. Chapman, D. A. Sakai, B S.Jarvis (2005), RFID Labeling – Smart Labeling Con-cepts & Applications for the Consumer PackagedGoods Supply Chain 2nd Edition, Printronix Inc.,Irvine CA.
[17] U. Bertelè, A. Rangone (2006), RFID alla pro-va dei Fatti, Politecnico di Milano – Dipartimentodi Ingegneria Gestionale, Milano.

ENERGIA, AMBIENTE E INNOVAZIONE 6/2007 64
La ricerca psicologica in “Ambiente estre-mo” nasce dall’esigenza di indagare l’esse-re umano in condizioni di vita e di lavoroparticolari, per studiarne la modalità diadattamento e le strategie di coping*, glieffetti sull’umore, le strategie di relazione,le dinamiche di gruppo, l’organizzazionedel lavoro, la gestione della leadership.L’Antartide, che rappresenta uno dei luo-ghi più ostili della terra, è il continente piùfreddo, più alto, più ventoso, più arido,più inesplorato del pianeta. Vasto 52 voltel’Italia, una volta e mezza l’Europa, è co-perto per il 98% da una coltre di ghiaccio,la temperatura varia da 0° in estate sullacosta, fino a sfiorare i 90° sotto lo zero ininverno a 3.000 metri di quota, i venti pos-sono superare i 200 km orari. È stato calcolato che, in certe condizio-ni estreme, il tempo di sopravvivenza diun uomo, senza un abbigliamento ade-
I ricercatori operano in Antartidein strutture che rappresentano
il trionfo di scienza e tecnologia.Ma l’ambiente estremo e isolato
induce a studiarne i condizionamenti, le strategie di adattamento e le dinamiche
di gruppo
studi
& ricerc
he Missione scientifica
in Antartide:ricerca psicologica
in ambienteestremo
Denise Giuliana Ferravante
ENEA Direzione Risorse Umane
Researchers in Antarctica operate in structuresthat epitomize the triumph of science
and technology. But because they are living in an extreme, isolated environment,
it is important to study their psychologicalconditioning, adaptation strategies
and group dynamics
Scientific mission in Antarctica: Psychological
research in an extremeenvironment
*Il concetto di coping, che può essere tradottocon “fronteggiamento”, “gestione attiva”, “ri-sposta efficace”, “capacità di risolvere i proble-mi”, indica l’insieme di strategie mentali e com-portamentali che sono messe in atto per fronteg-giare una situazione particolarmente stressante.

Missione scientifica in Antartide: ricerca psicologica in ambiente estremo
studi
& ricerc
he
ENERGIA, AMBIENTE E INNOVAZIONE 6/2007 65
guato, potrebbe non superare i 20 mi-nuti.In queste condizioni si trovano ad operarericercatori di tutto il mondo che si occupa-no di tematiche che riguardano l’evoluzio-ne del pianeta ed anche di aree di ricercache avranno importanza per il futuro, qua-li lo studio dell’assottigliamento dello stra-to di ozono, l’effetto serra, la contamina-zione a livello planetario. Le aree di ricer-ca spaziano nei campi che vanno dall’astro-nomia al geomagnetismo, dalla sismologiaalla glaciologia, dalla fisica dell’atmosferaalla biologia e medicina, e molto altro anco-ra.Durante il periodo di permanenza in An-tartide i ricercatori vivono presso strutture,basi di ricerca, che rappresentano il trionfodella scienza e della tecnologia, costruiteper resistere a tali condizioni atmosferiche,dotate, per quanto possibile, di tutti icomfort.L’Italia è presente in Antartide con due ba-si, la base Mario Zucchelli, sulla costa a BaiaTerra Nova e la base Concordia, sul platauantartico, a 3300 metri di altitudine.Presso quest’ultima base, alcuni ricercatoridi nazionalità italiana e francese, passanonove mesi completamente isolati dal restodel mondo, con la consapevolezza di nonpotersi sottrarre a questa situazione per-ché la base nel periodo che va da febbraioa novembre non è raggiungibile in nessunmodo e con nessun mezzo. Queste condizioni di confinamento rendo-no l’Antartide il luogo più adatto per la ri-cerca psicologica in un ambiente estremoe isolato, per molti versi simile a quello spa-ziale: infatti, le attività di ricerca svolte pres-so la base Concordia rivestono un particola-re interesse per l’Ente Spaziale Europeo.
Selezione e addestramento per la spedizione
L’ambito della ricerca psicologica in Antar-tide è stato presidiato, fino allo scorso anno,
da Antonio Peri, autorevole psichiatra cheha partecipato a numerose spedizioni e cheha fatto parte, anche con il ruolo di Respon-sabile, del gruppo internazionale che si oc-cupa della ricerca in Antartide per l’areamedico-psicologica. Dallo scorso anno chi scrive è subentrata aPeri nello svolgimento dell’attività di ricer-ca per il PNRA (Programma Nazionale diRicerche in Antartide) nel cui ambito giàda qualche anno operava per la valutazio-ne psicodiagnostica dei candidati. Infatti i componenti delle spedizioni in An-tartide vengono selezionati attraverso stru-menti standardizzati di valutazione psico-diagnostica: test di personalità e test proiet-tivi, assessment, colloqui individuali e altreprove finalizzate all’individuazione dellecaratteristiche di personalità predittive diun adeguato adattamento in ambiente an-tartico. Successivamente le persone selezio-nate partecipano ad un corso di addestra-mento, anch’esso valutativo, di due setti-mane: una presso il Centro ENEA del Bra-simone, sull’Appennino, focalizzata essen-zialmente sulle misure di sicurezza e sullereazioni da adottare in situazioni di emer-genza; la seconda settimana, a cura dellaScuola Militare Alpina di Aosta, si svolge intenda sul ghiacciaio del Monte Bianco, apiù di 2.000 metri di quota. L’obiettivo èquello di sperimentare le proprie capacità diadattamento in condizioni simili a quelleantartiche e di acquisire nozioni legate all’u-so di dispositivi satellitari per l’orientamen-to, oltre che ad abituarsi a camminare sulghiaccio, a muoversi in cordata, a calarsi neicrepacci, e molto altro ancora.Infatti, le condizioni in cui il personale sitrova ad operare, durante la spedizione,sono particolari a partire dalle attrezzaturedi protezione (figura 1) che sono spesso po-co confortevoli, ingombranti, poco pratici.I locali della base possono essere rumorosi acausa del funzionamento degli impianti,dove la temperatura e l’umidità possonoessere difficilmente controllabili. A questi

Denise Giuliana Ferravante
studi &
ricerc
he
ENERGIA, AMBIENTE E INNOVAZIONE 6/2007 66
fattori si aggiungono la mancanza di alter-nanza di luce e buio (durante le missioniestive è sempre giorno per 24 ore, duran-te il periodo invernale è sempre notte). Lebasi sono confortevoli ma si ha sempre laconsapevolezza che si vive una situazionedove l’emergenza è in agguato: c’è rischiodi incendio (l’aria è molto secca e il mate-riale è per lo più sintetico a partire dall’ab-bigliamento), si può guastare qualche im-pianto (le basi sono dotate di complessi im-pianti che consentono di avere ambienti ri-scaldati e confortevoli, di avere l’acqua cor-rente, di utilizzare docce e bagni), si puòalzare improvvisamente il vento catabati-co che soffia a più di 200 km l’ora. Oltre aqueste limitazioni, legate a fattori ambien-tali, si aggiungono delle limitazioni di na-tura psicologica, dovute all’isolamento e alconfinamento, ma anche limitazioni dovu-te alla convivenza forzata per 24 ore al gior-no, alla suddivisione dei compiti, all’orga-nizzazione delle attività. Inoltre in ambien-ti isolati e confinati, quali le stazioni di ri-cerca antartiche con personale permanen-te, può verificarsi una situazione di ridottastimolazione ambientale (REST) che può es-sere causa di effetti psicologici consistentinel peggioramento delle prestazioni, de-pressione, e ritiro dal gruppo, alterazionidella percezione dello spazio e del tempo.
La ricerca su stress e fattori di disagio
La problematica delle fonti di stress nellespedizioni antartiche è stata oggetto di stu-di fin dalle prime spedizioni. A questo pro-posito è interessante analizzare i risultati di
una ricerca [1] condotta su un gruppo dipartecipanti (95 soggetti) alla XII spedizio-ne nazionale in Antartide che si propone-va di identificare eventuali fonti di stress o didisagio (stressor) nelle spedizioni antarticheitaliane, di confrontare la valutazione sog-gettiva degli stressor con quella attribuitaagli altri, di acquisire indicazioni sui mecca-nismi di gestione. È stato chiesto ai parteci-panti alla campagna antartica di compilareun questionario in cui erano elencate 53possibili fonti di disagio, ricavate dalla let-teratura internazionale, ossia “qualcosa cheha procurato malessere, irritazione, fastidioo che si è avuto difficoltà ad affrontare, agestire durante la permanenza in Antarti-de”. Si chiedeva ai partecipanti anche di va-lutare l’intensità e la frequenza delle fonti didisagio nei compagni della spedizione in unanalogo questionario, usando gli stessi para-metri di risposta. Dall’analisi dei risultati èemerso che, sebbene non ci siano livelli didisagio importanti, le fonti di disagio più ri-levanti sono, a livello personale, la separa-zione dalle persone care, la restrizione del-l’intimità personale, la difficoltà nelle comu-nicazioni con l’Italia, l’insufficienza di spaziricreativi. Si rileva, invece, la scarsa inciden-za di stressor di tipo fisico-ambientale, a dif-ferenza di quanto si poteva prevedere. Ilmoderato livello di disagio prodotto dai fat-tori stressanti non produce effetti dannosiimmediati, e ciò forse è dovuto alle note-voli risorse materiali disponibili nelle spedi-zioni ma anche alla rigorosa selezione e pre-parazione, anche sul piano psicologico, delpersonale. Si riscontra un diverso grado disensibilità verso gli agenti stressanti se si con-
Figura 1Attrezzature di protezione indispensabili in inverno all’esterno della base Concordia

Missione scientifica in Antartide: ricerca psicologica in ambiente estremo
studi
& ricerc
he
ENERGIA, AMBIENTE E INNOVAZIONE 6/2007 67
fronta la propria percezione dell’intensitàe della frequenza delle cause di disagio conquella degli altri compagni di spedizione.Questi vengono giudicati molto più sensi-bili al disagio di quanto ciascuno voglia am-mettere per se stesso. Le tematiche proposteper gli altri sono sempre quelle dell’isola-mento e del confinamento. Questo feno-meno porta ad ipotizzare, secondo gli au-tori, che: a) si attivino meccanismi proiettiviche porterebbero a ridimensionare il disa-gio per se stessi e a riconoscerlo soprattut-to nell’altro; b) si tenti, in maniera più o me-no consapevole, di mantenere elevata, so-prattutto nei confronti degli altri, la propriaautostima, messa alla prova in un ambientedifficile. Risultano, invece, prive di effettinegativi le seguenti fonti di disagio: ripensa-menti sulla decisione di partecipare alla spe-dizione; sensazione di discriminazione nel-l’assegnazione degli incarichi; trasferimentida e per la base; adattamento al clima ester-no, attività continua con lo stesso gruppodi persone. Fra le strategie efficaci utilizzate,si evidenziano la programmazione e l’ese-cuzione di azioni correttive oltre alla ricer-ca di sostegno sociale, vale a dire di consi-gli ed aiuto. Agli ultimi posti, nel senso chevengono poco utilizzati come comporta-menti adattivi, si trovano il rifiuto della si-tuazione, il fantasticare una situazione di-versa e l’autocritica. Le strategie, a livellocognitivo comportamentale, più frequen-temente impiegate per gestire il disagio so-no l’accettazione della situazione e la suariconsiderazione in termini positivi. Infattitrattandosi di una situazione in cui l’am-biente è scarsamente modificabile, l’approc-cio utilizzato è quello centrato sulla personapiuttosto che sulla modificazione della si-tuazione problematica.
La ricerca su fattori predittivi e adattamento
La ricerca psicosociale ha permesso di affina-re i criteri di selezione e di preparazione
psicologica del personale delle spedizioniitaliane, e di identificare gli elementi pre-dittivi e le manifestazioni comportamenta-li dell’adattamento.A questo proposito un’interessante ricerca[2] ha riguardato il concetto di adattamen-to attraverso la identificazione e valutazio-ne dei principali indicatori comportamen-tali dell’adattamento nello specifico conte-sto antartico.La ricerca parte dall’ipotesi che la rappre-sentazione personale del processo adattivonell’ambiente delle spedizioni antartiche sipossa esprimere in un insieme articolato,complesso, dinamico di manifestazioni com-portamentali che assume caratterizzazioniindividuali connesse all’esperienza prece-dente, alle aspettative, ai valori oltre che alruolo svolto e all’esperienza maturata sulcampo. Lo strumento utilizzato è il questio-nario C/A PSO AD (Comportamenti/Atteg-giamenti Personali, Sociali Operativo-Pro-fessionali dell’Adattamento) ed è finalizza-to all’individuazione dei comportamenti chei partecipanti ritengono indicativi dell’adat-tamento sul piano personale, sociale e pro-fessionale in ambiente antartico. Ai parte-cipanti veniva chiesto di scegliere da un elen-co di 32 tratti comportamentali, desunti daprecedenti ricerche, e da debriefing forma-li e informali effettuati al termine delle spe-dizioni precedenti, i 10 comportamenti piùsignificativi, indicativi dell’adattamento inambiente antartico, nonché il grado di im-portanza, la frequenza di comparsa di que-sti comportamenti in sé, negli altri e nei re-sponsabili, il grado di soddisfazione e il ri-specchiamento dei valori personali. Inoltre èstato chiesto di valutare quanto ognuno deicomportamenti scelti fosse considerato im-portante dagli altri partecipanti. Hanno par-tecipato alla ricerca 116 soggetti. I tre comportamenti maggiormente scel-ti, con una percentuale superiore al 50%,sono stati: a) mostrare solidarietà e fornire aiuto a chiè in difficoltà (59% del campione);

Denise Giuliana Ferravante
studi &
ricerc
he
ENERGIA, AMBIENTE E INNOVAZIONE 6/2007 68
b) dimostrare competenza nel proprio la-voro (56% dei soggetti). In questo caso siriscontra qualche differenza a seconda del-le attività professionali svolte, per cui risul-tano valori superiori, relativamente a que-sti comportamenti, fra Ricercatori e Tecni-ci di laboratorio rispetto ad Amministrati-vi e Medici; c) dimostrarsi affidabile in caso di bisogno(56% dei soggetti).Dall’analisi del contenuto di questi 3 com-portamenti risultati maggiormente scelti,si può desumere che esiste una rappresen-tazione delle manifestazioni comportamen-tali dell’adattamento comune alla maggiorparte dei partecipanti basata sulla solida-rietà, sull’affidabilità e sulla competenzaprofessionale. L’associazione fra competen-za professionale e solidarietà nelle situa-zioni di difficoltà e di emergenza è emer-sa fin dalle prime spedizioni come fattorefondamentale all’interno di gruppi umaniimpegnati in ambienti ostili, quale l’am-biente antartico [3, 4, 5].A livello sociale tra i più giovani sono consi-derati adattivi i tratti comportamentali cheesprimono un approccio energico, stimo-lante sull’ambiente unito alla capacità disdrammatizzare, di ridimensionare le situa-zioni di tensione facendo un uso efficacedell’umorismo. Fra i meno giovani, invece,l’adattamento sociale si manifesta partico-larmente con azioni che indicano solida-rietà, disponibilità, senso della comunità,appartenenza al gruppo. Tra i comporta-menti più scelti dal gruppo maschile pre-valgono gli aspetti professionali rispetto aquelli sociali, aspetti che nel gruppo fem-minile risultano più bilanciati.Dal confronto fra le risposte dei soggetticon maggiore o minore esperienza antar-tica emerge che entrambi i gruppi attribui-scono valore alla collaborazione, al contri-buto per la soluzione di problemi, special-mente lavorativi, nonché al rispetto degliorari, delle disposizioni, dei programmi eall’autocontrollo emotivo, tutti fattori que-
sti che assumono una funzione preventivanei confronti di eventuali tensioni e con-flitti estremamente pericolosi in queste cir-costanze. Per ciò che riguarda le categorieprofessionali è possibile cogliere nelle scel-te dei comportamenti adattivi una relazio-ne cognitiva e sociale con le mansioni lavo-rative svolte, come già emerso da altre ri-cerche (6). Infatti tra i ricercatori l’aspetto che assumeun valore superiore è la capacità di tollera-re i cambiamenti e gli imprevisti, molto co-muni date le condizioni meteorologichedell’ambiente antartico, soggette a rapidimutamenti, costringendo i ricercatori acambiare continuamente la programma-zione dell’attività di ricerca. Altro elemento che caratterizza le rispostedella categoria dei ricercatori si riferisce al-la solidarietà e al supporto verso i compagniin difficoltà. Tra gli amministrativi (staff edirezione), anche per il ruolo che svolgo-no, diventa invece particolarmente impor-tante partecipare alla vita sociale del grup-po, ma soprattutto mostrare affidabilità incaso di bisogno, quando la situazione im-pone risposte precise e adeguate. Tra i tecnici di laboratorio sembra particolar-mente utile la capacità di sdrammatizzare lesituazioni di tensione, ma soprattutto la di-mostrazione di affidabilità in caso di neces-sità. Tra i tecnici logistici gli elementi più si-gnificativi sono l’adattamento allo stress fi-sico e ambientale. In generale i comporta-menti più frequentemente adottati implica-no un atteggiamento di tolleranza e di ri-spetto interpersonale, di valorizzazione del-l’ambiente sociale e dell’atmosfera socio-emotiva di gruppo accanto alla autorealiz-zazione lavorativa. Fra i comportamenti ritenuti importanti peril successo delle spedizioni, un posto di ri-lievo spetta al rispetto delle misure di sicu-rezza che è nettamente superiore, per im-portanza, ad altri comportamenti. I comportamenti più frequentemente os-servati nei responsabili sembrano caratte-

Missione scientifica in Antartide: ricerca psicologica in ambiente estremo
studi
& ricerc
he
ENERGIA, AMBIENTE E INNOVAZIONE 6/2007 69
rizzare una leadership efficace anche se piùattenta ai problemi di produttività che aquelli interpersonali. Tutti i comportamen-ti rispecchiano molto i valori dei soggetti,in particolare la competenza professiona-le. Da ciò emerge la centralità del sistemavaloriale nella costruzione del concetto diadattamento e nella sua attuazione con-creta. In sintesi il comportamento di unmembro di spedizione ben adattato è quel-lo di una persona che dimostra competen-za nel proprio lavoro, si dimostra affidabilein caso di bisogno, si adatta alle condizio-ni di stress fisico e ambientale, sviluppa emantiene buoni rapporti sociali, mostra tol-leranza verso i cambiamenti e gli imprevisti,dimostra stabilità emotiva e senso di re-sponsabilità, rispetta la privacy e si attienealle norme di sicurezza.
La ricerca sulle spedizioni invernali
Un’area di ricerca estremamente interes-sante è quella che riguarda il personale chepartecipa alle spedizioni invernali presso lastazione italo-francese Concordia.Come già detto, si tratta di una base che sitrova sul platau antartico, nel sito denomi-nato Dome C, dove si svolgono ricerche ditipo atmosferico, glaciologico, astronomi-co e astrofisico, geofisico e medico-psicolo-gico. La base dista circa 1000 Km dalla sta-zione francese di Dumont D’Urville e 1.200Km dalla stazione italiana di Baia Terra No-va, la pressione atmosferica equivale a3.600-3.800 metri di altitudine [7]. Qui dal 2005 gruppi di ricercatori e logisti-ci, italiani e francesi, passano nove mesicompletamente isolati dal resto del mon-do, sapendo di non potersi sottrarre a que-sta situazione perché la base, in quel perio-do, è completamente irraggiungibile. In-fatti la temperatura scende anche a 80° sot-to lo zero, nei lunghi mesi della notte an-tartica non c’è l’alternanza del giorno e del-la notte per cui il buio è totale, l’unico con-tatto con il resto del mondo è rappresen-
tato dal telefono satellitare e dalla postaelettronica.Al termine del periodo di isolamento vie-ne effettuato un debriefing, a cura di psi-cologi italiani e francesi, attraverso un’in-tervista semistrutturata utilizzando il “que-stionario di debriefing psicosociale antar-tico” e schede di self assessment finalizzatea valutare alcune dimensioni relative all’a-dattamento e al benessere psicofisico nelcorso dei diversi mesi di permanenza pres-so la base, durante i quali viene chiesto lo-ro di rispondere a questionari e test specifi-ci, riferendosi sia al vissuto individuale chea quello di gruppo. L’intervista semi-strut-turata è focalizzata sull’elaborazione del-l’esperienza vissuta durante l’inverno ed inparticolare approfondisce quelle che sonostate le sensazioni e le emozioni provate,le eventuali differenze rispetto alle aspet-tative, gli elementi piacevoli e quelli spia-cevoli e le relative motivazioni.Inoltre vengono approfonditi aspetti affe-renti alla sfera relazionale, in particolare al-la qualità delle relazioni all’interno delgruppo, all’eventuale presenza di sotto-gruppi, alla relazione con il reponsabile dispedizione, all’evoluzione delle dinamicheintergruppo ed intragruppo, alle eventua-li differenze fra ricercatori e logistici, fra ita-liani e francesi, fra uomini e donne. Il de-biefing approfondisce anche le variazioninei rapporti con familiari ed amici, e leaspettative riguardanti il rientro. Viene inol-tre indagata la percezione dei soggetti ri-guardo a quanto e a quali influenze l’espe-rienza in Antartide può aver determinatoper le decisioni e gli obiettivi futuri e, infine,viene indagato quale comportamento lapersona ha adottato in caso di difficltà.Nel novembre 2006, ho partecipato, insie-me ad E. Rosnet, psicologa francese, allaXXII spedizione in Antartide per effettua-re il debriefing con il personale italiano cheaveva trascorso il secondo inverno a Con-cordia [8]. Il gruppo era costituito da 10 per-sone, 4 italiani e 6 francesi, 3 ricercatori (2

Denise Giuliana Ferravante
studi &
ricerc
he
ENERGIA, AMBIENTE E INNOVAZIONE 6/2007 70
italiani e 1 francese) e 7 logistici (2 italiani e 5francesi, fra questi ultimi c’erano il capo spe-dizione, il responsabile tecnico e il cuoco).Era composto da 8 maschi e 2 donne, unaitaliana e una francese che aveva il ruolo dimedico e capo spedizione, l’età era compre-sa tra i 23 e i 59 anni, con un’età media di37 anni circa. Il debriefing ha avuto, fra glialtri scopi, dal punto di vista dei partecipan-ti quello di riflettere sull’esperienza vissutae di pervenire ad una prima elaborazione(figure 2 e 3). Dal punto di vista dell’organizzazione hapermesso di rilevare i problemi e le criticitàper apportare cambiamenti nel corso del-le prossime missioni invernali. Tutti si sono
dimostrati molto disponibili e collaborativi,lo stato emotivo e le condizioni psichichegenerali degli intervistati sono apparse as-solutamente soddisfacenti. Dai risultati èemerso che il gruppo degli invernanti si per-cepisce come un gruppo reale, che ha obiet-tivi comuni, che si adopera anche pratica-mente per rendere la base più confortevo-le. Si è osservato che la strategia di adatta-mento è basata sulla riduzione della reatti-vità nei confronti del disagio, una sorta di“economizzazione” delle risorse.Si è evidenziato che, nel tempo, gli indivi-dui tendono a prendere le distanze dalla si-tuazione, riducono gli sforzi mentali e com-portamentali, tendono a procrastinare e a
Figura 2Comparazione tra le difficoltà riscontrate dai gruppi di “invernanti” francesi (media su 7 spedizio-ni presso la Base francese Dumont D’Urville) e il primo gruppo di “invernanti” italiani a Concordia Fonte: E. Rosnet, A. Periordia, “Open Science Conference”, Hobart, 14.7.2006
Figura 3Comparazione tra i gruppi di “invernanti” francesi (media su 7 spedizioni presso la Base franceseDumont D’Urville) e il primo gruppo di “invernanti” italiani a Concordia nel corso dei diversi me-si dell’anno 2005Fonte: E. Rosnet, A. Peri“Open Science Conference”, Hobart, 14.7.2006

Missione scientifica in Antartide: ricerca psicologica in ambiente estremo
studi
& ricerc
he
ENERGIA, AMBIENTE E INNOVAZIONE 6/2007 71
rinviare l’analisi e la gestione di eventualiproblemi. Attualmente, la ricerca è ancora incorso dal momento che si sta effettuandola terza campagna invernale per la stazio-ne italo francese ed è in corso il debriefingrelativo all’ultima spedizione. Oltre al “Que-stionario di debriefing psicosociale antarti-co”, è stata svolta un’ulteriore attività di ri-cerca utilizzando il test di Rorschach, il no-to reattivo proiettivo di personalità compo-sto da 10 tavole, su ciascuna delle quali è ri-portata una macchia d’inchiostro simmetri-ca: 5 monocromatiche, 2 bicolori e 3 colo-rate. Le tavole vengono sottoposte all’at-tenzione del soggetto una alla volta e, perciascuna e senza limiti di tempo, viene chie-sto di esprimere tutto ciò cui la macchia so-miglia, secondo il soggetto. Il test di Ror-schach si basa sul meccanismo della proie-zione: attraverso le risposte fornite a stimo-li indeterminati, costituiti dalle macchie, unsoggetto evidenzia le sue caratteristiche piùinconsapevoli che costituiscono l’asse por-tante della personalità. Il test è stato som-ministrato nella fase di indagine psico-atti-tudinale che è stata effettuata prima dell’i-nizio della spedizione invernale, insieme adaltri strumenti di indagine della personalitàquali test, assessment, colloquio individuale.Lo scopo era quello di rintracciare nello stru-mento del Rorschach, alcuni indicatori utiliad effettuare un approfondimento degliaspetti della personalità dei ricercatori e lo-gistici che scelgono di partecipare ad un’e-sperienza così particolare di confinamento,per durata, intensità, per condizioni atmo-sferiche e climatiche. Oltre a ciò era interes-sante verificare quali tratti si mantenevanostabili e quali, eventualmente, subivano mo-difiche al termine del periodo di permanen-za in Antartide.È stato somministrato il test ai 4 parteci-panti italiani alla spedizione invernale del2006. In fase di debriefing il test è statosomministrato nuovamente, a distanza dicirca 14 mesi, 9 dei quali trascorsi in totaleconfinamento e isolamento.
Gli aspetti presi in considerazione sono sta-ti i seguenti: • qualità e quantità dei processi ideativi;• quantità e qualità dei processi elaborati-vi ed espressivi;• quantità e qualità dei processi relazionali;• meccanismi di difesa.Fra la prima fase della somministrazione ela seconda non si sono riscontrate differen-ze significative. È da rilevare, tuttavia, chetrattandosi di un campione ancora tropporistretto, i risultati sono soggetti ad un trat-tamento che tuteli la riservatezza e la pri-vacy dei partecipanti. Per avere dati che siano maggiormente at-tendibili e significativi occorre attendere laprosecuzione dell’indagine, tuttora in corso.
Bibliografia
[1] Peri A., Barbarito M., Ciufo A., Ruffini M. C. Lecause di disagio nelle spedizioni antartiche italiane,Giornale di Medicina Militare, n. 1-2/2002.
[2] Peri A., Barbarito M., Ruffini M. C. L’adattamen-to psicosociale nelle Spedizioni Antartiche: studio de-gli indicatori comportamentali, Il Polo, vol. 1-2 2002.
[3] Zavatti, S. L’esplorazione dell’Antartide, Milano,Mursia, 1974.
[4] Taylor, A.J.W. Antarctic Psychology, DSIR bulletinN° 244, Wellington, NZ: SIPC, 1987.
[5] Alexander, C. Endurance la leggendaria spedizio-ne di Shackleton al Polo Sud, Sperling & Kupfer, 1999.
[6] Palinkas, L. A. Going to extremes: The culturalcontext of stress, illness and coping in Antarctica, So-cial Science and Medicine, n. 5, 1992.
[7] AA.VV.: 1985-2005 Venti anni di ricerche in An-tartide, PNRA, 2006.
[8] Ferravante D. G., L’adattamento psicosociale inun gruppo isolato e multiculturale nella Base Con-cordia, in Rapporto sulla campagna antartica, Esta-te australe 2006-2007, XXII Spedizione, PNRA, 2007.

ENERGIA, AMBIENTE E INNOVAZIONE 6/2007 72
Nel novembre del 1963 venne presentatoal Dipartimento USA della Difesa (DARPA)un ambizioso progetto chiamato “EnergyDepot”. Si immaginava di costruire un si-stema facilmente trasportabile, che per-mettesse di ottenere combustibili liquidiper autotrazione partendo da materialiubiquitari ed abbondanti, quali l’aria o l’ac-qua, ed utilizzando come fonte energeticail calore prodotto da reazioni termonuclea-ri. L’impresa era completamente da realiz-zarsi con tecnologie disponili al momento.Il progetto era molto vasto in quanto nonveniva scartata nessuna possibilità e coin-volse parecchi gruppi di ricerca.Dopo sei anni di studio, in un rapporto fi-nale, si presentavano i risultati. La via piùpromettente tra quelle studiate consiste-va in un sistema componibile di carrelli fer-roviari (figura 1). Il primo trasportava unpiccolo reattore nucleare compatto da 10-30 MW, già sviluppato per scopi sottomari-ni. Un secondo carrello trasportava ungruppo elettrogeno a turbine a vapore chetrasformava il calore prodotto dal reattorein energia elettrica. Un terzo carrello corre-
La possibilità di decomporre termicamente l’acqua per ottenere
idrogeno da usarsi come vettoreenergetico rappresenta una vera
sfida tecnologica. Per rendere il processo energeticamente
favorevole occorre individuarenuove metodologie. Nel lavoro
si propone una soluzione alternati-va al ciclo zolfo-iodio in grado
di garantire un notevole risparmionel bilancio massa-energia
studi
& ricerc
he La scissione termica
dell’acqua: mito o realtà?
Pier Paolo Prosini
Thermal water splitting cycles to obtain hydro-gen from water represent a real technological
challenge. To make the process energeticallyconvenient, new methodologies are expected.
In the paper an alternative solution to the clas-sic sulfur-iodine cycle allowing a great increase
in the mass-energy balance is proposed
Thermal water splitting:myth or reality?
ENEA, Dipartimento Tecnologie per l’Energia, le Fonti Rinnovabili e il Risparmio Energetico

La scissione termica dell’acqua: mito o realtà?
studi
& ricerc
he
ENERGIA, AMBIENTE E INNOVAZIONE 6/2007
sigeno per scissione termica dell’acqua. Da-to che di per sé questa non può avvenirese non a temperature superiori ai 4.000 K,è stato proposto di separare la produzio-ne dell’ossigeno da quella dell’idrogeno indue o più reazioni, ognuna capace di av-venire a temperature più basse di quellanecessaria per la decomposizione direttadell’acqua. Per molti anni questi cicli ter-mochimici rimasero una curiosità di la-boratorio, fin quando nel 1974, circa 10anni dopo la presentazione del proget-to Energy Depot, in occasione del 1°Congresso Internazionale sull’Idrogeno[2], l’interesse dei ricercatori per questoattraente argomento venne ridestato daN. Verzigoglu. Verzigoglu ipotizzò di riconsiderare l’ideaoriginaria dell’Energy Depot per scopi sta-zionari e civili. Venne proposto, in quellaoccasione, di utilizzare l’energia termica direattori nucleari stazionari per produrreidrogeno tramite cicli termochimici ed uti-lizzare l’idrogeno prodotto per fornireenergia alle industrie ed alle abitazioni ci-vili. Nel giro di pochi anni il numero di pub-blicazioni su cicli termochimici aumentò ra-pidamente raggiungendo oltre le 180 pub-blicazioni nel 1977. Ed è del 1978 la riven-dicazione depositata dalla General Atomic(GA) relativa ad un “Nuovo ciclo termochi-mico basato sullo zolfo e sullo iodio” benconosciuto tra gli addetti ai lavori come ci-clo S-I [3].Nello stesso anno fu depositato un bre-vetto della GA nel quale si rivendicava unavariante [4] dello stesso senza la quale ilciclo risulta difficilmente praticabile. Do-po un decennio di enfasi, l’interesse per icicli termochimici andò progressivamentediminuendo e questo soprattutto per ladifficoltà di trasferire il ciclo dalla scala dilaboratorio ad un prototipo preindustria-le. Il numero di pubblicazioni diminuì pro-gressivamente e negli ultimi trenta annisi contano poco più di 5-6 pubblicazioniper anno.
73
dato di elettrolizzatori, provvedeva a pro-durre idrogeno dall’acqua, a spese dell’e-nergia elettrica. Un quarto carrello, sem-pre alimentato elettricamente, era dotatodi un gruppo di crio-generazione, capacedi liquefare l’aria, producendo azoto liqui-do. In un quinto carrello erano alloggiatidei reattori chimici, nei quali l’idrogeno el’azoto si combinavano a formare ammo-niaca. L’ammoniaca era quindi trasferita inun ulteriore reattore dove condensava aformare l’idrazina. L’idrazina è un liquidoincolore, vischioso, miscibile con l’acqua,che bolle a 113 °C, con una energia liberadi formazione pari a 12 kcal mol-1. In ge-nerale un composto è tanto più stabilequanto più negativo è il valore dell’ener-gia libera di Gibbs (ΔG). L’idrazina, pur es-sendo termodinamicamente instabile (l’e-nergia di formazione è positiva), è stabilecineticamente in quanto la velocità di rea-zione, a temperatura ambiente, è lentissi-ma. Al contrario, se scaldata, l’idrazina èfacilmente esplosiva. L’idrazina può esse-re usata sia come combustibile per motoria combustione interna (ovviamente modi-ficati) o in veicoli dotati di celle a combu-stibile. Pure se il progetto fu ritenuto fatti-bile da un punto di vista teorico, nel rap-porto si concludeva che non si vedeva al-lo stato della tecnologia attuale e prospet-tata per i prossimi dieci anni, la possibilitàdi realizzarlo e il “Deposito d’Energia” fudefinitamene congedato [1]. Tra i vari metodi di produzione dell’idro-geno, che già di per sé poteva considerar-si un buon combustibile, furono indagatianche i cosiddetti cicli termochimici di scis-sione dell’acqua (dall’inglese, thermochemi-cal water splitting cycles).
I cicli termochimici per la scissionedell’acqua
I cicli termochimici di scissione dell’acqua,come dice il nome, consistono essenzial-mente nella produzione di idrogeno ed os-

Pier Paolo Prosini
studi &
ricerc
he
ENERGIA, AMBIENTE E INNOVAZIONE 6/2007 74
Il ciclo zolfo-iodio
Da qualche anno l’interesse sui cicli termo-chimici si è di nuovo destato in quanto èstata presa in considerazione la possibilitàdi utilizzare calore solare concentrato co-me fonte di energia primaria. Tra i diffe-renti cicli termochimici, compatibili contemperature raggiungibili in impianti so-lari, il ciclo S-I [3, 4], il ciclo UT3 [5] ed il cicloZn/ZnO [6] sono stati presi di nuovo in con-siderazione. Tra questi il ciclo S-I sembra ilpiù promettente da un punto di vista ener-getico [7]. Il ciclo prende nome dai due elementi chi-mici (zolfo e iodio) da cui si originano gliacidi coinvolti nelle reazioni, cioè l’acidosolforico e quello iodidrico. L’acido iodidri-co è una soluzione acquosa di ioduro diidrogeno (HI). Lo ioduro di idrogeno è gas-soso in condizioni standard (temperaturaambiente e pressione atmosferica). Lo io-duro di idrogeno è solubilissimo in acqua ein questa si scioglie formando una soluzio-ne che, quando satura, contiene il 57% inpeso di acido. Tale soluzione, formata dacirca 5 moli di acqua per mole di acido, bol-le a 127 °C e genera un vapore che ha lastessa composizione del liquido (soluzione
azeotropa). Lo ioduro di idrogeno è un aci-do forte e in acqua è completamente disso-ciato in ione ioduro e ione idrogeno (H+).L’acido solforico è un acido che in soluzio-ne acquosa può cedere due protoni (aci-do biprotico). L’acido è completamente dis-sociato in prima dissociazione, mentre lacostante di seconda dissociazione (che cor-risponde al rapporto tra le concentrazionidella forma dissociata rispetto a quella in-dissociata) vale ka2=10-2. Il valore relativa-mente alto della costante indica che l’acidoè quasi totalmente dissociato anche in se-conda dissociazione. L’acido è solubile inacqua in tutte le proporzioni e forma conessa un azeotropo, contenente il 98% diacido, che bolle a 330 °C. Il ciclo S-I può es-sere scomposto in tre reazioni, due reazio-ni di decomposizione in cui i due acidi sonodecomposti, ed una reazione, detta di Bun-sen, in cui i due acidi sono rigenerati (figu-ra 2).Nella reazione di Bunsen, che procede conrilascio di calore a temperatura di 110 °C,si producono acido iodidrico e acido solfo-rico per riduzione dello iodio da parte del-l’anidride solforosa. I prodotti di reazionedella Bunsen, in presenza di un eccesso diacqua e di iodio, si separano spontanea-
Figura 1Il “Deposito di energia” così come immaginato nella prima metà degli anni 60

La scissione termica dell’acqua: mito o realtà?
studi
& ricerc
he
ENERGIA, AMBIENTE E INNOVAZIONE 6/2007 75
mente in due fasi liquide. Lo iodio è unelemento ad elevato peso atomico (PA =114,5) che forma molecole apolari immi-scibili con l’acqua. Quando sciolto in unasoluzione azeotropa di acido iodidrico, loiodio può solubilizzarsi per formazione dicomplessi iodio-iodurati, contenenti finoa 4 moli di iodio per mole di ioduro. Que-sta soluzione, che contiene quindi anche5 moli di acqua, prende il nome di solu-zione iodidrica. A causa della massiccia pre-senza di iodio, la soluzione iodidrica è mol-to densa e poco restia a solubilizzare l’a-cido solforico, e si separa spontaneamen-te verso il basso. La fase superiore è invececostituita essenzialmente da una soluzionedi acido solforico e contiene circa 4 molidi acqua per mole di acido. Per determi-nare la separazione di fasi nella reazione diBunsen, ed evitare reazioni collaterali in-desiderate, è necessario aumentare di 10volte rispetto al valore stechiometrico laquantità di acqua e di 8 volte la quantità diiodio. Nel ciclo S-I l’idrogeno è ottenuto per de-composizione termica dello ioduro di idro-geno. Lo ioduro di idrogeno è instabile infase gassosa (ΔG = 0,38 kcal mol-1) mentrela formazione in soluzione acquosa è fa-vorita (ΔG = -12,35 kcal mol-1) a causa del-
l’energia liberata dalla solvatazione dellemolecole di acido con l’acqua. Pur essen-do la reazione di decomposizione dello io-duro di idrogeno termodinamicamente fa-vorita, per accelerarla, si tende a farla avve-nire a temperature variabili tra i 350 e i 550°C in presenza di catalizzatori al platino. In pratica, la soluzione iodidrica è separatadallo iodio per distillazione e concentrataa formare una soluzione azeotropa di aci-do iodidrico. La soluzione è vaporizzata edil gas scaldato a temperature superiori ai350 °C. In presenza di opportuni catalizza-tori, circa il 20% dell’acido è decompostoa formare idrogeno e iodio. La miscela direazione allo stato gassoso, contenente ac-qua (50 moli), ioduro di idrogeno (8 moli),idrogeno (1 mole) e iodio (1 mole), è raf-freddata. A temperature intorno ai 110 °C,lo iodio liquefa ed è separato. A tempera-tura più bassa, l’acqua condensa solubiliz-zando lo ioduro di idrogeno. La soluzionedi acido iodidrico è separata, concentrata einviata di nuovo alla reazione di decom-posizione. Il gas che si raccoglie è costitui-to essenzialmente da idrogeno puro. La decomposizione dell’acido iodidrico rap-presenta tuttora una sfida di tecnologiaingegneristica. Circa 50 moli di acqua de-vono essere evaporate per mole di idroge-
Figura 2Schema semplificato che mostra le reazioni coinvolte nel ciclo zolfo-iodio

no prodotto. L’entalpia di evaporazione èpari a 486 kcal a fronte di 54 kcal di ener-gia prodotta (che corrispondono alla quan-tità di energia liberata dalla combustionedi una mole di idrogeno). L’impianto chi-mico di decomposizione dell’acido iodidri-co deve essere dimensionato in manieratale da gestire una quantità di calore paria circa 10 volte la quantità di energia che lostesso è capace di produrre. Tale calore nonè direttamente correlato a reazioni termo-chimiche in quanto serve esclusivamentead evaporare l’acqua.Differenti metodi di separazione sono sta-ti proposti per ridurre la quantità di acquanella soluzione iodidrica. Un brevetto diNorman et al. descrive l’uso dell’acido fo-sforico che, mescolato con la soluzione io-didrica, permette di avere un sistema terna-rio HI/I2/H2O dal quale è possibile ottene-re ioduro di idrogeno anidro per distilla-zione [4]. Questo processo, noto come di-stillazione estrattiva, è comunque un meto-do che consuma un’elevata quantità dienergia per la concentrazione dell’acidofosforico. Sempre per lo stesso motivo èstato proposto un metodo di distillazionereattiva sotto pressione [8]. Più recente-mente è stato mostrato come sia possibi-le ottenere ioduro di idrogeno anidro tra-mite l’elettrodialisi di soluzioni concentra-te e la successiva distillazione della soluzio-ne sovra-azeotropica ottenuta [9]. Il limi-te di questa tecnologia risiede nell’uso dimembrane per elettrodialisi che aumenta-no la complessità e i costi dell’impianto.L’ultimo passo del ciclo S-I, la decomposi-zione dell’acido solforico, è realizzato trami-te una serie di reazioni che avvengono atemperature progressivamente superiori.La fase solforica è scaldata. Occorre rag-giungere la temperatura di circa 400-450°C affinché tutte e quattro le molecole diacqua legate all’acido solforico siano eva-porate. Quindi, a seguito di un ulteriore au-mento di temperatura, a circa 850-900 °C,l’acido solforico decompone a formare os-
sigeno ed anidride solforosa. I due gas sonoseparati e l’anidride solforosa è usata co-me agente riducente nella reazione di Bun-sen. Almeno 4 moli di acqua devono essereevaporate durante tale reazione, e comevisto in precedenza, questo passaggio con-suma energia. Per ridurre la quantità dienergia in gioco, sono stati proposti nume-rosi diagrammi di processo che vanno dal-la semplice colonna di distillazione [10] alladistillazione a multiplo effetto [11]. L’efficienza energetica, definita come il rap-porto tra la quantità di energia prodottaper unità di energia consumata, del cicloS-I varia tra il 28 e il 35% [7]. Per ottenerealti valori di efficienza energetica, i calorilatenti di condensazione devono esserescrupolosamente recuperati. Il recuperopuò avvenire tramite voluminosi sistemi discambio termico con conseguente aumen-to delle dimensioni dell’impianto. Nel mo-mento in cui andiamo a considerare le di-mensioni dell’impianto nel bilancio globa-le, occorre introdurre accanto all’efficienzaenergetica, l’efficienza di processo, inten-dendo con questo termine il rapporto tra laquantità di energia prodotta per unità dienergia processata. Solo considerando lagestione dell’acqua nella porzione iodidri-ca l’efficienza di processo del ciclo S-I è in-feriore al 10%. È chiaro che per aumenta-re l’efficienza di processo è necessario ri-durre la quantità di acqua e di iodio du-rante la reazione di Bunsen.
Un nuovo approccio al ciclo zolfo-iodio
Da un punto di vista impiantistico, i fluidisono stati da sempre preferiti rispetto aisolidi in quanto sono più facili da maneg-giare e si prestano ad operazioni in conti-nuo. Per tale motivo, poca attenzione èstata finora rivolta a cicli che prevedonol’impiego di reattivi solidi. D’altra parte l’u-so di fasi solide, facilmente separabili dafasi liquide per filtrazione, permetterebbe
Pier Paolo Prosini
studi &
ricerc
he
ENERGIA, AMBIENTE E INNOVAZIONE 6/2007 76

La scissione termica dell’acqua: mito o realtà?
studi
& ricerc
he
ENERGIA, AMBIENTE E INNOVAZIONE 6/2007 77
di diminuire la quantità di acqua durante lareazione di Bunsen. In ENEA è stato studiato un ciclo termochi-mico per la scissione dell’acqua basato sul-la interconversione di sali insolubili di piom-bo, effettuato tramite una serie di reazio-ni chimiche chiamate “reazioni di doppioscambio” o “metatesi”. Il ciclo, che rappre-senta una variante del ciclo S-I, è stato re-centemente brevettato [12]. Lo schema direazioni proposto è mostrato in figura 3.In maniera del tutto generale le reazionipossono così essere descritte: un acido edun sale reagiscono tra di loro, e mentre l’a-cido dona i suoi protoni al sale, quest’ulti-mo dona ioni metallici all’acido. La forzache spinge tali metatesi è da ricercare nel-la differente solubilità dei sali o nella vo-latilità degli acidi coinvolti. Ci sono pochi ioni metallici che formano conlo ioduro sali poco solubili. Tra questi l’ar-gento, l’antimonio, il piombo il mercurio, ilrame ed il bismuto. In particolare lo iodurodi piombo ed il solfato di piombo sono am-bedue sali poco solubili. La costante di so-lubilità (il cui valore è tanto più basso quan-to meno solubile è il sale) mostra che lo io-duro di piombo (ks=9,8*10-9) è meno solubi-le del solfato di piombo (ks=2,53*10-8). Que-
sta differenza di solubilità, anche se picco-la, è stata sfruttata al fine di separare unafase iodidrica solida da una solforica liqui-da. In particolare durante la reazione di Bun-sen è stato aggiunto del solfato di piombo. Nelle condizioni di reazione, si assiste allaprima reazione di metatesi in cui il solfatodi piombo reagisce con lo ioduro di idro-geno, generando acido solforico e iodurodi piombo che precipita come solido giallo(Reazione I, figura 3). Dato che non occor-re più la separazione tra fasi liquide, è pos-sibile evitare di aggiungere un eccesso diiodio e di acqua essendo sufficienti soloquelle quantità che necessitano per la rea-zione. La riduzione delle quantità di acquae di iodio è così ottenuta in un solo pas-saggio insieme alla separazione di una fa-se solida contenente iodio, da una liquidacontenente acido solforico e acqua. La seconda reazione di metatesi è neces-saria per ottener lo ioduro di idrogeno, cheessendo gassoso, può essere facilmente eli-minato dall’ambiente di reazione, spostan-do l’equilibrio verso la formazione dei pro-dotti. Per garantire cinetiche di reazioneveloci ed evitare indesiderati effetti collate-rali, l’acido da usarsi nella reazione di me-tatesi, deve essere abbastanza forte, sta-
Figura 3Schema di reazioni proposto per diminuire il calore necessario al ciclo S-I

ti della reazione di metatesi sono il solfatodi piombo e la silice idrata, che precipita-no (Reazione IV, figura 3). I solidi sono se-parati dall’acqua per filtrazione ed avviatialla reazione di decomposizione. Quandoscaldati la silice perde l’acqua di idratazione(circa 1 mole) e a temperatura di 850-900°C, il solfato di piombo decompone libe-rando anidride solforosa e ossigeno (Rea-zione V, figura 3). Il residuo della reazioneè silicato di piombo che appare come unsolido vetroso amorfo ed è usato comeagente precipitante della fase solforica. An-che in questo caso la riduzione della quan-tità di acqua da evaporare incrementa l’ef-ficienza di processo del ciclo. I vantaggi (egli svantaggi) che derivano dal ciclo propo-sto possono essere valutati in accordo con icriteri esposti da J.F. Funk [13].
1. I calori da recuperare sono minimizzatie l’acqua e lo iodio ridotti per cui il ciclo haun’alta efficienza energetica e di processo.2. La conversione degli intermedi chimiciè pressoché completa a causa della bassasolubilità o all’elevata volatilità dei prodot-ti intermedi.3. Le reazioni collaterali sono limitate: infat-ti la precipitazione degli ioduri nella rea-zione di Bunsen modificata ne limita lareattività nei confronti dei solfati.4. Il piombo risulta sicuramente il più tossi-co tra tutti gli elementi coinvolti nel ciclo.C’è da considerare comunque che la scarsasolubilità dei sali (ioduro, fosfato e solfa-to) ne riduce notevolmente la tossicità.5. Da un punto di vista economico, rispettoal ciclo iodio-zolfo tradizionale, si introdu-ce il piombo, la cui reperibilità e costo sonocompatibili con quelle degli altri elementi,ma si diminuisce lo iodio (che è il più costo-so tra gli elementi che costituiscono il ciclo).6. Le quantità dei reagenti (esclusa l’acqua)corrisponde a quella stechiometrica; pertan-to non vi è un eccesso di materia da gestire.7. Grazie alla differente solubilità e volati-lità dei composti coinvolti nei differenti
Pier Paolo Prosini
studi &
ricerc
he
ENERGIA, AMBIENTE E INNOVAZIONE 6/2007 78
bile anche ad alta temperatura e non os-sidante. L’acido fosforico rappresenta il mi-glior candidato. L’acido fosforico è un aci-do stabile (ΔG = -269 kcal mol-1) ed è ab-bastanza forte in prima dissociazione(ka=7,5*10-3). L’acido fosforico è stato mescolato con loioduro di piombo e scaldato (Reazione II,figura 3). Inizialmente si osserva l’elimina-zione di acqua e formazione prima (≈250 °C)di acido di fosforico (H4P2O7; ka=1,5*10-1) epoi (≈300 °C) di acido metafosforico (HPO3),ambedue solidi. Aumentando ulteriormen-te la temperatura a circa 410 °C lo ioduro dipiombo liquefa e per un leggero ulterio-re aumento di temperatura, ioduro di idro-geno anidro si sviluppa dall’ambiente direazione. Il sale che si genera dalla reazio-ne di metatesi è piombo pirofosfatoamorfo. Esso si presenta come un solidovetroso, poco solubile in acqua. La solubilità di questo sale è però abba-stanza elevata da permettere la terza rea-zione di metatesi, tra il pirofosfato di piom-bo e l’acido solforico, che determina la for-mazione di solfato di piombo e di acidofosforico (Reazione III, figura 3). Il solfatodi piombo è separato per filtrazione edusato come agente precipitante nella rea-zione di Bunsen, mentre l’acido fosforicoè concentrato ed utilizzato per la genera-zione dello ioduro di idrogeno. È da nota-re che l’unico processo in cui occorre evapo-rare l’acqua è proprio la concentrazionedell’acido fosforico. Minimizzando la quan-tità di acqua durante questa reazione èpossibile incrementare notevolmente l’ef-ficienza di processo del ciclo. Sorprendentemente è stato trovato che lareazione di metatesi può essere utilizzataanche per ridurre la quantità di acqua pre-sente nella fase solforica. Infatti, la soluzio-ne acquosa di acido solforico provenientedalla Bunsen, costituita da 4 moli di acquaper mole di acido, può essere addizionata disilicato di piombo usato come agente pre-cipitante nei confronti del solfato. I prodot-

La scissione termica dell’acqua: mito o realtà?
studi
& ricerc
he
ENERGIA, AMBIENTE E INNOVAZIONE 6/2007
ambienti di reazione, la separazione deimateriali è quantitativa.8. Problemi di corrosione possono essereconsiderevolmente ridotti in quanto la de-composizione dell’acido iodidrico e delsolforico avvengono in ambiente anidro. 9. I materiali solidi possono essere maneg-giati meno agevolmente rispetto ai fluidirendendo poco agevole la realizzazione disistemi in continuo. Problemi di tipo im-piantistico possono incontrarsi nella gestio-ne dell’acido fosforico ad alta temperatu-ra e nel trattamento di fasi vetrose.10. La massima temperatura del processoè relativamente alta (870 °C) ma compati-bile con quelle ottenibili da un concentra-tore solare a torre.11. Le due fasi ad alta temperatura coin-volgono reazioni in fase solida, pertantopossono presentarsi problemi di trasferi-mento di calore.
Conclusioni
L’idea di ottenere combustibili chimici di-rettamente dall’acqua, originariamenteproposta nel 1963, rimane ancora attualeal giorno d’oggi e aumenta di interesse acausa dei recenti progressi nel campo del-la realizzazione degli impianti solari, del-l’accumulo di idrogeno e dello sviluppo dicelle a combustibile. In questo lavoro è sta-to mostrato come l’uso di fasi solide per-metta di ridurre notevolmente la quantitàdi acqua e di iodio durante il ciclo S-I, di-minuendo la quantità di energia necessariaper la loro vaporizzazione e aumentandol’efficienza di processo. Il ciclo propostopermette inoltre di generare idrogeno eanidride solforosa in ambiente anidro, conconseguente riduzione dei fenomeni dicorrosione, sensibilmente più attivi in pre-senza di acqua.Problemi di tipo impiantistico potrebberoincontrarsi nella gestione dell’acido fosfori-co ad alta temperatura e nel trattamentodi fasi vetrose. Solo la realizzazione di un
79
impianto pre-industriale basato sul ciclo ter-mochimico proposto potrebbe mettere inluce la fattibilità dello stesso e forse rende-re la scissione termica dell’acqua una realtà.
Bibliografia
1. Nuclear Power: An Option for the Army’s Fu-ture, by R. A. Pfeffer and W. A. Macon, Jr.,http://www.almc.army.mil/alog/issues/Se-pOct01/MS684.htm.
2. The Hydrogen Economy Miami Energy Conferen-ce (THEME), 18-20 March 1974, Miami Beach, FL.
3. J.H. Norman et al., 16 May 1978, U.S. Pat. No.4,089,939.
4. J.H. Norman et al., 28 Nov 1978, U.S. Pat. No.4,127,644.
5. M. Sakurai, E. Bilgen, A. Tsutsumi, and K. Yo-shida, Solar Energy, 57, pag.51,1996.
6. A. Steinfeld, International Journal of Hydro-gen Energy, 27, pag.611, 2002.
7. S. Goldstein, X. Vitart, and J.M. Bogard, Inter-national Scientific Journal For Alternative Energyand Economy, ISIAEE n °3, 11, pag. 20, 2004.
8. H. Engels, K.F. Knoche and M. Roth, Int. J. Hy-drogen Energy, 12, pag.675 1987; M. Roth and K.F.Knoche, Int. J. Hydrogen Energy, 14, pag. 545,1989.
9. S. Kubo, S. Kasahara, H. Okuda, A. Terada, N.Tanaka, Y. Inaba, H. Ohashi, Y. Inagaki, K. Onuki,and R. Hino, Nuclear Engineering and Design, 23,pag.355, 2004.
10. S. Goldstein, J.M. Bogard, X. Joulia, and P. Guit-tard, AIChE Spring National Meeting, New Orleans,April 2003.
11. H. Engels and K. F. Knoche, Int. J. HydrogenEnergy, 11, pag. 703, 1986.
12. P.P.Prosini, A.Giaconia, S. Sau, G. Caputo, Bre-vetto Italiano RM200700143 2007.
13. J.E. Funk, Int. J. Hydrogen Energy, 26, pag. 185,2001.

Emilio Santoro
La storia geologica dell’Antartide
A cura di Emilio Santoro
Fino a 180 milioni di anni fa, l’Antartide faceva parte di un supercontinente chiamatoGondwana, che riuniva anche l’Australia, l’Africa, il Sudamerica, l’India e la Nuova Zelan-da. Ciò deriva dal fatto che in rocce antartiche sono stati trovati fossili di specie animali evegetali che vivevano inizialmente sul Gondwana: conifere (Glossopteris indica), felci (Di-croidium) e rettili terrestri (Lystrosaurus murray). I primi fossili di Glossopteris furono trova-ti da Edward Wilson, zoologo e responsabile scientifico dell’ultima spedizione di RobertScott nel 1911-1912. Wilson fu uno dei quattro uomini che accompagnarono Scott al Polo eche morirono con lui sulla via del ritorno. 140 milioni di anni fa, inizia lo smembramentodel Gondwana. L’Antartide, formata da due parti (una più grande, l’Antartide orientale e unapiù piccola l’Antartide occidentale), si sposta verso sud. Si apre il Passaggio di Drake, chesepara il Sudamerica dalla Penisola antartica. Cento milioni di anni fa, l’Antartide si trovagià in posizione polare. Sessanta milioni di anni fa, essa si separa dall’Australia, dando origi-ne al mare di Tasmania. Da 40 milioni di anni l’Antartide si trova nella posizione attuale. Lacalotta dell’Antartide orientale si sarebbe formata intorno a 14 milioni di anni fa; quelladell’Antartide occidentale 9 milioni di anni fa.L’isolamento provoca la genesi di una corrente circumpolare antartica, che viene alimenta-ta dai moti convettivi tra le masse d’acqua di diversa temperatura, sostenuta dalla circolazio-ne atmosferica di tipo ciclonico e influenzata dalla rotazione terrestre. Tale corrente ostaco-la la miscelazione diretta delle acque provenienti da zone più temperate con quelle fred-de continentali. In seguito a questi eventi è iniziato il progressivo raffreddamento del con-tinente anche in concomitanza di altri fattori: la posizione geografica polare; la grandeestensione continentale e l’altitudine media elevata; la forte riflessione dei raggi solari da par-te della superficie innevata. Queste condizioni hanno portato nel tempo al lento accumulodella coltre di ghiaccio che si è formata a spese dell’umidità atmosferica proveniente daisettori più temperati degli oceani circostanti. l nome : “Antarktos”, Antartide, è l’opposto di “arktos”, Artide (da “orso”, poiché la stellache indica il nord si trova nella costellazione dell’Orsa minore). Poiché solo il 2% del continen-te non è coperto dal ghiaccio, molti aspetti della geologia antartica sono tuttora poco no-ti, come, per esempio, la connessione geologica e strutturale tra la parte orientale e quellaoccidentale del continente. Di particolare interesse sono le perforazioni del ghiaccio, per-
Appunti d
i
ENERGIA, AMBIENTE E INNOVAZIONE 6/2007 80
Figura 1Supercontinente
Figura 2Spostamento delle parti del supercon-tinente nell’attuale configurazione

La storia geologica dell’Antartide
Appunti d
i
ENERGIA, AMBIENTE E INNOVAZIONE 6/2007
ché nei diversi strati si ritrovano intrappolati campioni delle antiche atmosfere terrestri. At-traverso il loro esame, è possibile ricostruire le condizioni climatiche del passato, i cambiamen-ti della composizione atmosferica e verificare le variazioni di spessore delle calotte antarti-che. Con queste tecniche, sono stati finora studiati i mutamenti avvenuti nel corso degli ul-timi 160 mila anni, evidenziando la stretta interdipendenza tra variazioni di temperaturae variazioni dell’anidride carbonica e della circolazione atmosferica (a sua volta connessacon la circolazione oceanica). Nei ghiacci sono conservate inoltre polveri di eruzioni vulcani-che vicine e lontane, particelle di origine terrestre ed extra-terrestre, meteoriti, pollini e so-stanze inquinanti. Tutti questi dati, assieme a quelli forniti dagli altri settori di ricerca, permet-tono di procedere nella comprensione dei meccanismi delle glaciazioni e dei cambiamenticlimatici che hanno caratterizzato la storia recente del pianeta. Il Programma Nazionale di Ricerche in Antartide (PNRA) avviato nel 1985, ha già prodottoun rilevante numero di spedizioni scientifiche e la sua attuazione è realizzata da un Con-sorzio costituito da ENEA, CNR, OGS, INGV. L’Antartide, da circa 15 milioni di anni, contri-buisce al bilancio termico della Terra, è la principale riserva di acqua dolce del pianeta (ne con-serva il 68%) e di ghiacci (91%). Vi vivono sette specie di foche e otto di pinguini. La pre-senza umana è limitata al personale delle spedizioni. Ma questo continente, studiato e pro-tetto grazie al Trattato Antartico cui hanno aderito 45 Paesi, sta diventando negli ultimitempi anche meta di turismo: 20.000 presenze l’anno, con navi provenienti dall’Argentina,dalla Tasmania e dalla Nuova Zelanda. L’attività di ricerca si svolge nel rispetto di accordiinternazionali che prevedono di “utilizzare” l’Antartide come un grande laboratorio sen-za interessi di tipo economico o militare seguendo progetti scientifici nazionali ed interna-zionali. Giuridicamente, infatti, tale continente è regolato da un patto internazionale dineutralità, il “Trattato Antartico”, che sospende qualsiasi rivendicazione territoriale a suddel 60° parallelo, vieta ogni tipo di esperimento di natura bellica e nucleare, favorisce losviluppo della cooperazione scientifica internazionale e assicura la conservazione e la prote-zione della flora e della fauna sull’intero territorio. Il trattato fu firmato a Washington il 1°dicembre 1959 da dodici dei quaranta paesi partecipanti all’Anno Geofisico Internazionaledel 1957-1958 ed entrò in vigore nel 1961. Nel 1991 è stato siglato, ad integrazione del Trat-tato Antartico, un accordo di particolare rilievo: il Protocollo sulla Protezione Ambientale. Taleaccordo, noto anche come Protocollo di Madrid, ha dichiarato la messa al bando per i pros-simi 50 anni di ogni sfruttamento minerario dell’Antartide e ha imposto la valutazione del-l’impatto ambientale per qualsiasi attività in programma. Al Trattato Antartico aderisconooggi 45 Paesi che rappresentano più dell’80% della popolazione globale. Nel 1991, il Tratta-to ha compiuto 30 anni; da questa data ogni Parte Consultiva può chiedere che il Trattatovenga ridiscusso. Importanti Organizzazioni mondiali, con interessi anche nell’area antar-tica, partecipano alle riunioni del Trattato, come la World Meteorological Organization(WMO) e l’Intergovernmental Oceanographic Commission (IOC).
81

dal Mondo
ENERGIA, AMBIENTE E INNOVAZIONE 6/2007 82
WEC 2007: unastrategia comune
per preparare ildopo 2012
Il problematico rapporto fraenergia e ambiente è “la piùgrande sfida della nostra gene-razione” per assicurare lo svilup-po e la sicurezza del Pianeta: conqueste parole il presidente del-la Commissione Europea JoséManuel Barroso ha aperto WEC2007, il Congresso mondiale del-l’energia, che si è svolto a Romadal 12 al 15 novembre. Barrosoha definito la situazione ener-getica “difficoltosa e insosteni-bile” e per l’ Unione Europea è
cro
nache
dal Mondo
WEC 2007: una strategia comune
per preparare il dopo 2012
ITER: un futuro per la fusione
essenziale che i leader mondia-li si impegnino in un serio ne-goziato su un accordo percombattere i cambiamenti cli-matici dopo il 2012. Gli ele-menti chiave su cui dovrà ba-sarsi l’accordo sono: dimezza-re le emissioni di gas serra ri-spetto ai livelli del 1990 entroil 2050 per limitare il riscalda-mento globale a un aumentodel solo 2%; riduzione più in-cisiva da parte dei Paesi più svi-luppati, con un calo delle emis-sioni del 30% entro il 2020;cooperazione rafforzata con iPaesi in via di sviluppo, per ri-durre gli effetti sul clima dellaloro crescita; ampliamento delmercato delle emissioni di ani-dride carbonica con meccani-smi nuovi e più flessibili, comegià delineato dal lancio dell’In-ternational Carbon Action Part-nership avvenuto a Lisbona ainizio novembre; più coopera-zione e più scambio di tecno-logie energetiche fra paesi; mi-sure più adeguate per affron-tare i cambiamenti climatici chein una certa misura sono inevi-tabili; rinnovata attenzione altrasporto marittimo ed aereo,le cui emissioni sono in rapidacrescita; infine una strategiaper affrontare i problemi del-la deforestazione. Il Presiden-te dell’ENEA, Luigi Paganetto,ha evidenziato la necessità diaffrontare i temi dell’energiafacendo riferimento all’oriz-zonte temporale delle diversepolitiche che si possono realiz-zare. Nel breve periodo sonopiù importanti le politiche diefficienza energetica che pos-sono essere realizzate con l’in-novazione tecnologica: inter-venti nei diversi settori da cuiproviene la domanda energeti-ca e cioè nel residenziale, nel-l’industria, nei servizi e nei tra-sporti. Nel medio periodo, in-vece, occorre investire sulle in-frastrutture energetiche in Ita-
lia ed in Europa per garantirecondizioni adeguate di approv-vigionamento e sicurezza; l’a-pertura del mercato e l’unifi-cazione delle regole a livelloeuropeo sono i due punti dimaggiore importanza. Ma è al-trettanto fondamentale inve-stire su nuove tecnologie com-prese quelle per le rinnovabilie quelle che perseguono gliobiettivi “zero emission”.Efficienza energetica, unifica-zione del mercato, abbatti-mento delle emissioni e inte-grazione verticale: sono que-ste le condizioni riaffermate daFulvio Conti, amministratoredelegato dell’ENEL, per rende-re il mercato europeo dell’e-nergia realmente liberalizzato.Rispetto ad altri paesi europeil’Italia ha però un mix energe-tico troppo sbilanciato verso ilgas; una maggior parte di rin-novabili e di carbone pulito, co-me in Germania, dovrebbe es-sere la chiave per avere la sicu-rezza degli approvvigionamen-ti ad un prezzo ragionevole ri-spettando l’ambiente.Per questo una politica post-Kyoto, per avere risultati, de-ve essere globale ed equa; de-ve incoraggiare lo scambio ditecnologie con i Paesi emer-genti e basarsi sulla sicurezzae sulla diversificazione dellefonti. Come è stato evidenzia-to in una sessione della Confe-renza il consumo di combusti-bili fossili crescerà almeno finoal 2030 e le fonti rinnovabilinon basteranno. Per questotecnologia e ricerca avrannoun ruolo chiave sul fronte del-l’efficienza dei sistemi di gene-razione tradizionale, su quel-lo della riduzione di costi, sullaquarta generazione del nuclea-re e sulla cattura e lo stoccag-gio di CO2. L’efficienza energe-tica risulta di estrema impor-tanza per tenere insieme ga-ranzia degli approvvigiona-

dal Mondo
cro
nache
ENERGIA, AMBIENTE E INNOVAZIONE 6/2007 83
zionali perché se si resta bloc-cati alle politiche nazionali nonci sarà possibilità di riuscita.Allargando il concetto, il Mini-stro degli Esteri D’Alema haammonito che tutte le iniziati-ve dei Paesi industrializzati, perquanto animate dalle miglioriintenzioni, sono destinate a re-stare lettera morta se non riu-sciranno a coinvolgere e a cor-responsabilizzare – in modo ra-gionevole e flessibile– le eco-nomie dei Paesi emergenti. Eper questo ha auspicato unariforma dello stesso G8 che pas-si innanzitutto attraverso unaprogressiva espansione dellacomposizione del Gruppo, inmodo da accrescerne non solola rappresentatività ma soprat-tutto la capacità di portare acompimento con successo lesue core mission. Il WEC orga-nizza ogni tre anni il Congressomondiale dell’energia; le pre-cedenti due edizioni si sonosvolte a Sidney (2004) e BuenosAires (2001) e, dopo quella diRoma, la prossima sarà a Mon-treal nel 2010.
ITER: un futuro per la fusione
ITER, il reattore sperimentalea fusione che sarà costruito en-tro il 2017 da un consorzio in-ternazionale (UE, Russia, Cina,Giappone, USA, India e Coreadel Sud) a Cadarache, vicinoMarsiglia, è un progetto da 10miliardi di euro per il quale sistimano ricadute economicheper l’industria italiana di alcu-ne centinaia di milioni di eu-ro. Rappresenta, quindi ungrande impegno non soltan-to da parte dei laboratori di ri-cerca ma anche da parte del-l’industria, sia nei settori con-venzionali che in quelli piùspecialistici, ad alto contenu-
menti, competitività e sosteni-bilità ambientale.La conclusione da trarre dallosvolgimento del 20° WEC è per-ciò che, per garantire un futurosostenibile dell’energia, occor-rerà un livello straordinario dicollaborazione globale tra indu-stria e governi ed una maggio-re integrazione dei mercati re-gionali ed internazionali dell’e-nergia. I tre anni che ci separa-no dal prossimo Congresso mon-diale saranno determinanti perdefinire l’assetto energetico deiprossimi trent’anni. Per promuo-vere la massima collaborazionein questo periodo cruciale, ilWEC ha deciso di estendere ilproprio mandato globale per af-frontare le tre sfide principalidella sostenibilità energetica: eli-minare la povertà energetica, fis-sare il valore globale del carbo-nio e stabilire standard globaliper lo scambio di energia e pergli investimenti a fronte di unacrescente ondata di nazionaliz-zazioni nel settore.Questo necessariamente com-porterà, ha affermato Pierre Ga-donneix, Presidente del Consi-glio mondiale dell’energia, il pas-saggio ad uno sviluppo econo-mico responsabile, la tutela delclima e la riduzione delle disu-guaglianze a livello globale; ilWEC, che ha aderenti in tutto ilmondo, rappresenta l’organiz-zazione perfetta in cui far incon-trare tutti i soggetti interessati.La necessità di trovare regole co-muni per garantire lo svilupposostenibile anche delle varie op-zioni praticabili deve però pas-sare in una visione globale chepermetta, ad esempio, nel cam-po delle bioenergie di evitareconflitti tra la sicurezza alimenta-re e quella ambientale. Lo hadetto Corrado Clini, presentan-do il rapporto della Global Bioe-nergy Partnership, di cui è Presi-dente, ma è necessario elabora-re un quadro di norme interna-
to tecnologico. È quanto è sta-to messo in risalto il 26 otto-bre a Genova con il workshopsu “ITER, dalla fusione l’ener-gia per il nostro futuro. Un’op-portunità per le aziende ita-liane”, che ha visto la parteci-pazione di oltre 100 aziende.Come ha messo in risalto ilpresidente della Camera diCommercio di Genova PaoloOdone, le commesse avrannouna dimensione media diqualche milione di euro, quin-di le nostre piccole e medieimprese saranno costrette adaggregarsi per partecipare al-le gare. Inoltre, come ha ricordato ilpresidente dell’ENEA Luigi Pa-ganetto, l’Italia punta ad acqui-sire circa il 20% delle commes-se europee, naturalmente con-centrate sulle tecnologie mol-to avanzate. Una cospicua par-te delle attività del progetto,però, vedrà coinvolti anche isettori più tradizionali, comeedilizia e relativa impiantistica.L’ENEA, che ha una tradizionedi eccellenza a livello interna-zionale nella ricerca sulla fusio-ne nucleare e dispone di im-pianti ad altissima tecnologianei suoi laboratori di Frascati eBrasimone, sta già attivandosiper trasferire al sistema indu-striale italiano il suo know howper promuovere nel modo mi-gliore la partecipazione dell’in-dustria italiana alla realizzazio-ne di ITER, fornendo supportoanche per attività collateraliconvenzionali connesse al pro-getto. Se fondamentale e de-cisiva è la partnership conENEA, la Camera di Commer-cio, da parte sua, offrirà servi-zi di informazione, formazio-ne e accompagnamento sia perle aziende che intendono par-tecipare alle gare per la costru-zione del reattore sia per leaziende che vogliono concor-rere all’allestimento del sito.

dall’Unione Europea
ENERGIA, AMBIENTE E INNOVAZIONE 6/2007 84
cro
nache
Mobilità intelligente
Il 17 settembre scorso la Com-missione Europea ha emessouna Comunicazione (2007/541)che costituisce la prima relazio-ne sull’iniziativa “automobileintelligente”. Avviata dal 2006,l’iniziativa ha l’obiettivo di inte-grare nel trasporto le tecnolo-gie dell’informazione e delle co-municazioni per migliorare lasicurezza e ridurre gli ingorghi,i tempi di trasporto e il consu-mo di carburante. I costi am-bientali del trasporto (dovuti aemissioni inquinanti e gas ser-ra) ammontano all’1,1% del PILeuropeo. Gli ingorghi stradali
provocano un ulteriore 1% diperdita del PIL. Infine i costi so-ciali, in particolare il numerodi decessi, troppo elevati: l’o-biettivo è quello di dimezzarlial 2010 rispetto al 2001. Tre so-no i pilastri dell’iniziativa peruna mobilità intelligente. 1.Veicoli più sicuri. Un obietti-vo è la piena diffusione entroil 2010 del sistema eCall (lachiamata di emergenza pan-europea a bordo dei veicoli).In caso di incidente eCall chia-ma automaticamente i servizidi soccorso e, grazie ai sistemidi navigazione satellitare, for-nisce posizione del veicolo ealtre informazioni sull’accadu-to; installato su tutte le autoeCall permettebbe di salvareogni anno in Europa fino a2.500 vite umane. Altro obiet-tivo è il controllo elettronicodella stabilità (ESC) sulle nuoveautomobili che riduce il peri-colo di slittamento, causa di al-meno il 40% degli incidentimortali sulle strade. Inoltre vaaccelerata l’adozione di siste-mi che combinano la frenatadi emergenza e la prevenzio-ne delle collisioni, così come isistemi di miglioramento del-la visione (fari adattivi ecc.).2.Veicoli più puliti. L’obiettivosono i 120 g/km per le emis-sioni di CO2: riduzioni obbliga-torie ad un massimo di 130g/km per mezzo di migliora-menti dei motori, e riduzionedi altri 10 g/km tramite pneu-matici a bassa resistenza, veri-fica automatica della loro pres-sione, climatizzazione, indica-tori del cambio di rapporto,rendimento energetico dei vei-coli commerciali leggeri emaggiore ricorso ai biocarbu-ranti. Parallelamente l’atten-zione va posta al sistema ditrasporto su strada nel suo in-sieme: diffusione del sistemadi adattamento della velocitàdi crociera (ACC), che compor-
ta una riduzione complessivanel consumo di carburante;oppure moderni sistemi dicontrollo del traffico urbano,già sperimentati in progettieuropei, per ridurre i ritardi fi-no al 30% e aumentare finoal 13% la velocità media deiveicoli, con riduzione dei con-sumi e delle emissioni.3.Veicoli più intelligenti. Mi-glioramento dell’interazioneuomo-macchina, e interfaccestandardizzate dei dispositiviportatili di navigazione, assi-stenza, comunicazione, intrat-tenimento. Inoltre, adozionedi “sistemi cooperativi” basa-ti sulle comunicazioni da vei-colo a veicolo e da veicolo ainfrastruttura per il trasferi-mento delle informazioni intempo reale.
Favorire le nanotecnologie
La Comunicazione (2007/505)della Commissione Europea del16 settembre, che costituisce laprima relazione sull’attuazio-ne del Piano di azione 2005-2009 per l’Europa su nanoscien-ze e nanotecnologie (N&N),riassume in otto punti le azio-ni intraprese e i progressi rea-lizzati nei primi due anni.1.Ricerca, sviluppo e innova-zione. I finanziamenti direttia favore delle N&N sono pas-sati da 120 milioni di euro delIVPQ (1994-1998) a 220 milionidel VPQ, a 1,4 miliardi nelVIPQ (2002-2006), circa un ter-zo della spesa pubblica in Eu-ropa. Nel periodo 2004-2006la spesa mondiale pubblica eprivata a favore delle N&N haraggiunto quasi 24 miliardi dieuro e l’Europa ha fornito pi˘di un quarto del totale mon-diale. Nel VIIPQ si prevede cheil finanziamento della Com-
dall’UnioneEuropea
Mobilità intelligente
Favorire le nanotecnologie
Ricerca & industria per il fotovoltaico

dall’Unione Europea
cro
nache
ENERGIA, AMBIENTE E INNOVAZIONE 6/2007 85
missione alle N&N dovrebberaddoppiare rispetto al VIPQ.2.Infrastrutture e poli di eccel-lenza europei. I progressi futuridelle attività di R&S e dell’inno-vazione dipendono dalla dispo-nibilità di infrastrutture di ec-cellenza di carattere interdisci-plinare aventi una massa criti-ca. Il sostegno della Commissio-ne mira a favorire l’accesso alleinfrastrutture esistenti e lo svi-luppo delle infrastrutture futu-re, ma non riguarda la loro co-struzione, di competenza degliStati membri.3. Risorse umane interdiscipli-nari. Le N&N beneficiano spessodell’interdisciplinarità, ma i si-stemi di istruzione e di forma-zione tradizionali non sonosempre all’altezza. La Commis-sione ha operato con i pro-grammi educativi (gestiti dallaDG Istruzione e cultura) e congli strumenti per la mobilità ela formazione dei ricercatori(gestiti dalla DG Ricerca).4.Innovazione industriale. LaCommissione ha incoraggiatole imprese, in particolare le PMI,a partecipare ai progetti colla-borativi di R&S sia al VIPQ cheal VIIPQ. Sono state introdottedelle misure per favorire l’inno-vazione industriale: il finanzia-mento con condivisione dei ri-schi, gestito dalla Banca Euro-pea per gli Investimenti con ilsostegno del VIIPQ; il fondo digaranzia del VIIPQ; il “Program-ma per la competitività e l’in-novazione 2007-2013”.5.Dimensione sociale. L’accetta-zione da parte della società è unfattore essenziale dello sviluppodelle nanotecnologie. È necessa-rio non solo che le nanotecnolo-gie vengano applicate in modosicuro e producano prodotti eservizi utili, ma occorre ancheche vi sia un consenso pubblicosul loro impatto generale.6.Salute, sicurezza e ambiente.L’impatto potenziale di alcuni
nanomateriali e nanoprodottisull’ambiente e sulla saluteumana non è ancora piena-mente conosciuto. L’obiettivodella Commissione È assicura-re lo sviluppo e l’uso sicuri del-le N&N.7.Cooperazione internaziona-le. La Commissione ha inten-sificato il dialogo internazio-nale sulle nanotecnologie.8. Strategia coerente a livelloeuropeo. Assicurare la miglio-re governance possibile dellosviluppo e dell’utilizzo dellenanotecnologie, evitando po-tenziali duplicazioni, richiedeuna struttura ed un coordina-mento efficienti. Il sito http://ec.europa.eu/na-notechnology illustra le misu-re di attuazione realizzate dal-la Commissione.
Ricerca & industria
per il fotovoltaicoLa strategia dell’UE nello svi-luppo delle fonti rinnovabili haavuto un nuovo impulso conl’adozione da parte del Consi-glio Europeo del Piano d’Azio-ne Una politica energetica perl’Europa: i nuovi obiettivi al2020 di riduzione delle emis-sioni di CO2 (meno 20% rispet-to al 1990) potranno essereconseguiti con azioni diversifi-cate tra cui un maggiore ricor-so alle fonti rinnovabili per unaquota pari al 20% del fabbiso-gno energetico europeo. Perpoter rispondere alle nuove in-dicazioni della Comunità, latecnologia fotovoltaica assu-me un’elevata valenza strate-gica soprattutto nel medio-lun-go termine. Il Position Paperdel Governo italiano, in corsodi approvazione, fissa il poten-ziale massimo teorico per lerinnovabili al 2020. Per il foto-
voltaico è stato stimato al 2020un potenziale di 8.500 MW, dicui 7.500 del tipo integrato ne-gli edifici e 1000 di centrali fo-tovoltaiche. In questa ottica,“ENEA incontra l’industria: laR&S nel settore fotovoltaico”, ilWorkshop organizzato dall’E-NEA il 22 ottobre è stata un’oc-casione di incontro fra tutti isoggetti interessati alla nasci-ta di una filiera fotovoltaica inItalia, al fine di creare le con-dizioni più favorevoli per unamigliore sinergia e per una va-lorizzazione degli sforzi in at-to. Per far scendere l’attualecosto del fotovoltaico di 6 europer watt al costo competitivodi 2 €/W è necessario un forteimpulso nel settore R&S. Perquesto si sta puntando su duetecnologie, quella a film sotti-le e l’altra più innovativa delfotovoltaico a concentrazione,in alternativa alla tecnologiadel silicio cristallino. Nel CRENEA di Portici è presenteun’importante concentrazio-ne di competenze su questetecnologie. C’è la necessità diintegrare i saperi e le speri-mentazioni, ha ribadito inapertura dei lavori il Presiden-te dell’ENEA Luigi Paganetto,affinché la ricerca esca dai la-boratori e si trasformi in inno-vazioni utili allo sviluppo delPaese e con questo incontro,ha seguitato Paganetto, l’En-te si propone di creare un ta-volo di lavoro che sia un pun-to di riferimento per questatecnologia e per le applicazio-ni sia nel civile che nella gene-razione distribuita dell’ener-gia. Al Workshop introdottodal Presidente dell’ENEA LuigiPaganetto, erano presenti leistituzioni che, a livello nazio-nale e locale, definiscono imeccanismi e gli strumenti di“governance”, nonché espo-nenti del mondo imprendito-riale e di quello della ricerca.

dall’Italia
ENERGIA, AMBIENTE E INNOVAZIONE 6/2007 86
Approvata la Finanziaria 2008La manovra Finanziaria, giàlicenziata dalla Camera il 15dicembre, è stata definitiva-mente approvata dal Senatoil 21 dicembre ed è diventa-ta legge.L’approccio complessivo cheguida la manovra è quello diutilizzare al meglio le risorsegià stanziate nel Bilancio del-lo Stato, realizzare accordicon le forze sociali ed econo-miche su specifici temi checoniughino equità, risana-mento e sviluppo, e ricapita-lizzare il Paese.Sviluppata a partire daglic
ronache
dall’Italia
Approvata la Finanziaria 2008
Censis: puntare sulle minoranze attive
Il progetto CRESCO nella TOP500
Quote emissioni 2008-2012
obiettivi impostati già conla Finanziaria per il 2007, lamanovra orienta le risorsepubbliche verso alcuni pun-ti essenziali: avvio della ri-duzione della pressione fi-scale; riutilizzo delle risorsederivanti dalla lotta all’eva-sione fiscale per la casa e lefasce deboli; semplificazio-ne e riduzione dei costi fi-scali per le imprese; pienaapplicazione del Protocollosul welfare; forte impulsoalle infrastrutture, all’uni-versità e alla ricerca; razio-nalizzazione e risorse ag-giuntive per la sicurezza; so-stegno alla cooperazione; ri-qualificazione della spesapubblica e riduzione dei co-sti della politica. Fra le misure contenute, inparticolare per le tematichedi interesse ENEA, ci sono laproroga al 31 dicembre2010 delle agevolazioni perla riqualificazione energeti-ca degli edifici e l’istituzio-ne del fondo di sviluppodelle isole minori per inter-venti specifici anche nei set-tori dell’energia, dei tra-sporti e della concorrenza.Ci sono, poi, gli incentivi al-le fonti energetiche rinno-vabili con i finanziamentiper gli impianti autorizzatie non ancora in eserciziononché per quelli in costru-zione; ma, anche medianterilascio di certificati verdiper un periodo di 15 anni,attraverso una tariffa di en-tità variabile a seconda del-la fonte utilizzata tra eoli-co, solare fotovoltaico,idraulica, biomassa e gas didiscarica. In aggiunta unanorma prevede che il gesto-re di rete connetta priorita-riamente alla rete gli im-pianti che generano ener-gia elettrica da fonti rinno-vabili, mentre con decreto
del Ministro dello Sviluppoeconomico si stabilisce la ri-partizione fra le regioni e leprovince autonome dellaquota minima di incremen-to dell’energia elettrica pro-dotta con fonti rinnovabilinecessaria per raggiungerel’obbiettivo del 25% delconsumo interno entro il2012. Al fine di garantire lo svi-luppo e la continuità dellaricerca italiana sull’idroge-no e sulle tecnologie ad es-so collegate, come le celle acombustibile, quali compo-nenti ideali di un sistemaenergetico sostenibile, ingrado di soddisfare la do-manda crescente di energiariducendo gli effetti danno-si per l’ambiente, a livellolocale e globale, viene isti-tuito il Fondo per la Piat-taforma italiana per lo svi-luppo di tali tecnologie. IlFondo (10 milioni di europer il 2008) incentiva lo svi-luppo delle diverse fasi del-la filiera che consente ciclienergetici chiusi, ossia basa-ti sull’idrogeno prodottocon l’impiego di fonti ener-getiche nuove e rinnovabi-li, il suo accumulo e traspor-to e la sua utilizzazione. Al fine di favorire il dialogotra scienza e società e dipromuovere lo sviluppo del-la ricerca e della formazio-ne avanzata, nel rispetto delprincipio di precauzione ap-plicato al campo delle bio-tecnologie, è istituito unFondo (3 milioni di euro peril 2008) che può essere ge-stito anche in convenzionecon fondazioni e istituti in-dipendenti.Le Disposizioni in favore deigiovani ricercatori. prevedeche, dall’anno 2008, unaquota non inferiore al 10%dello stanziamento com-

dall’Italia
cro
nache
ENERGIA, AMBIENTE E INNOVAZIONE 6/2007 87
plessivo del Fondo per gli in-vestimenti nella ricerca scien-tifica e tecnologica (FIRST) siadestinata ai progetti di ricer-ca presentati da ricercatori dietà inferiore ai quaranta an-ni operanti a qualunque tito-lo in attività di ricerca e pre-viamente valutati, secondo ilmetodo della valutazione trapari, sulla base di indici bi-bliometrici (quali impact fac-tor e citation index), e ope-ranti presso istituzioni ed en-ti di ricerca scientifica e tec-nologica. almeno per la metànon italiani.Le Università e gli enti di ri-cerca possono avvalersi dicontratti di lavoro flessibileper lo svolgimento di proget-ti di ricerca e innovazionetecnologica i cui oneri non ri-sultino a carico dei bilanci difunzionamento degli Enti odel Fondi di finanziamentodegli Enti o del Fondo di fi-nanziamento ordinario delleuniversità.Tra le misure per sostenere igiovani laureati e le nuoveimprese innovatrici del Mez-zogiorno nonché per la ge-stione delle quote di emissio-ne di gas serra sono previsti,tra l’altro, un Fondo da desti-nare alla “riserva nuovi en-tranti” dei Piani nazionali diassegnazione delle quote,nonché interventi a sostegnodell’attività di ricerca nel si-stema energetico e di riutiliz-zo di aeree industriali in par-ticolare nel Mezzogiorno.In tema di tutela dell’ambien-te e cambiamenti climatici,per le finalità di difesa delsuolo e per gli interventi nel-le aeree a rischio idrogeolo-gico saranno adottati PianiStrategici nazionali e di inter-vento (265.milioni d euro perciascuno degli anni 2008 e2009). Di tali risorse, un fon-do di 40 milioni è destinato
alla promozione delle ener-gie rinnovabili e dell’effi-cienza energetica attraver-so il controllo e la riduzio-ne delle emissioni inquinan-ti e climalteranti, nonchéper la promozione dellaproduzione di energia elet-trica da solare termodina-mico, una tecnologia chel’ENEA ha sviluppato e in-novato negli ultimi anni.
Censis:puntare sulle
minoranze attiveLe analisi e le interpretazionedei fenomeni, dei processi, del-le tensioni e dei bisogni socialiemergenti nel nostro Paese,che vengono riportati dall’ul-timo Rapporto CENSIS, parla-no ancora di quegli elementipositivi dell’andamento socio-economico del Paese negli ul-timi anni, che vanno dalla ri-nuncia alla retorica del decli-no, alla patrimonializzazione,dalle schegge di vitalità econo-mica fino all’indicazione di unpiccolo silenzioso boom delloscorso anno. Ma, conferman-do un’interpretazione positivaanche dell’anno in corso, vie-ne messa bene in risalto la for-ma minoritaria dei processi disviluppo attuali. Nell’evidenziare i nuovi equili-bri di mantenimento dello svi-luppo economico raggiunto, illento formarsi di nuove leader-ship e il persistere di alcuni li-miti nel sociale, e nell’analizza-re puntigliosamente i singolisettori (formazione, lavoro,welfare, sanità, territorio, reti,soggetti economici, sicurezza,cittadinanza, innovazione, me-dia e comunicazione), il Rap-porto dà una chiave di letturadell’evoluzione della realtà ita-
liana per il 2007 che può essereriassunta nell’indicazione: peruscire dall’attuale stato di ‘pol-tiglia’ sociale dobbiamo pun-tare sulle tante minoranze atti-ve nell’economia, nella societàe nelle scienze. Cresce nelle im-prese la qualità delle strategiecompetitive (di nicchia, di of-ferta sul mercato del lusso, dilavoro su commessa ecc.), si vaallargando la base territorialedello sviluppo e abbiamo alcu-ni importanti grandi attori sianel tradizionale campo indu-striale e finanziario sia in cam-po energetico. Ed è una visio-ne positiva che sembra potersuperare anche le turbolenzefinanziarie addensatesi negliultimi mesi. Ma rimangono, tuttavia, dina-miche che non riescono a rag-giungere gli strati più ampi del-la società. Una società dove laframmentazione progressivadi tutte le forme di apparte-nenza collettiva dà forza di svi-luppo, come è stato nel passa-to, sta creando ora dei ‘corian-doli’ caratterizzati da dispersio-ne del sé, nello spazio e neltempo collettivo. Pertanto inuna società così inconcludenteappare difficile attendersi l’e-mergere di una qualsivoglia ca-pacità o ripresa di sviluppo dimassa, e le offerte innovativepossono venire solo dalle nuo-ve minoranze attive. La mino-ranza che fa ricerca scientifica einnovazione tecnica, è quelladei giovani che studiano o la-vorano all’estero, dei profes-sionisti orientati ad esplorarenuovi mercati, degli operatorituristici di ogni tipo; la mino-ranza che vive in realtà localiad alta qualità della vita, equella che vive il rapporto conl’immigrazione in termini di in-tegrazione e coesione sociale;la minoranza che crede in unaesperienza religiosa attenta al-la persona e alla complessità

dall’Italia
ENERGIA, AMBIENTE E INNOVAZIONE 6/2007 88
dello sviluppo ai vari livelli, e letante minoranze che hanno scel-to l’appartenenza a gruppi, mo-vimenti, associazioni e sindacaticome forma di nuova coesionesociale e di ricerca di senso del-la vita. Si tratta, sottolinea il Rapporto,di una sfida faticosa che questeminoranze dovranno gestire dasole per continuare a crescere;ma sfida necessaria e realistica,perché non si tratta di inventa-re nulla di nuovo ma di metter-si nel solco di modernità chepervade tutti i paesi avanzati.
Il progetto CRESCO
nella TOP500
Nell’ultima lista pubblicata anovembre dei primi 500 siti conla maggior potenza di calcoloinstallata al mondo, denomi-nata TOP500 SupercomputerSites, compare per la prima vol-ta un’installazione ENEA: sitratta del sistema HPC CRESCO,con circa 2560 cpu di ultima ge-nerazione, che sta per essereinstallato presso il Centro Ri-cerche ENEA di Portici e che,sulla base delle misurazioni ef-fettuate in fabbrica prima del-l’installazione in sito, si è piaz-zato nella posizione n.180. TOP500 è una lista (www.top500.org) che, a partire dal 1993e con cadenza semestrale, illu-stra la classifica dei sistemi dicalcolo ad alte prestazioni(HPC) installati in tutti i paesidel mondo misurandone laperformance mediante unbenchmark denominato Lim-pak, accettato dalla comunitàHPC come standard di valuta-zione dei sistemi ad alte pre-stazioni. L’ENEA, unico ente di ricercaitaliano, è presente insieme a
cro
nache un Consorzio interuniversita-
rio (il CINECA con le posizio-ni n. 48, 71 e 264) e a ENEL(con le posizioni n. 247 e 248). Nella TOP500 il 58% dei sitisono negli USA, il 12% si tro-vano in Asia (principalmenteGiappone), mentre l’Europaha solo il 30% di presenze. Lerealtà italiane rappresentanol’1,2% del totale, contro il9,6% del Regno Unito, il6,2% della Germania e il3,4% della Francia. Ma CRESCO (www.cresco.enea.it) è di gran lunga l’infra-struttura HPC più importantedel Meridione d’Italia, e ciò dàmodo all’ENEA di candidarsi astruttura pubblica d’avanguar-dia nell’ambito delle realtà delcalcolo scientifico italiano. Apartire dal 1996, attraverso losviluppo di originali architet-ture GRID, l’ENEA ha saputovalorizzare le risorse di mac-chine e competenze distribui-te nei propri centri, fino a rag-giungere una maturità che og-gi consente non soltanto difornire servizi avanzati di cal-colo all’insieme dei ricercatoriENEA su una varietà di temati-che applicative, ma anche disviluppare attività e progetticon altre realtà nazionali edinternazionali, scientifiche eindustriali. Va, infine, segnalata la parteci-pazione dell’ENEA ad una se-rie di azioni che, sotto l’egidadel Ministero dell’Università eRicerca, intendono armoniz-zare le quattro realtà HPC in-sediate nel Meridione d’Italiacon i fondi del PON Ricerca,con l’obiettivo di aumentarela competitività del sistemadella ricerca italiano in [email protected]@casaccia.enea.it [email protected]
Quote emissioni2008-2012
È stata lanciata il 12 dicembredal Ministero dell’Ambiente laconsultazione pubblica sulloSchema di decisione di asse-gnazione delle quote di CO2per le industrie, nel periodo2008-2012, che porta il tettodi emissioni a 201,57 milioni ditonnellate annue, in accordocon i piani comunitari.Lo Schema è stato elaboratosulla base del Piano Naziona-le di assegnazione per il perio-do 2008-2012, approvato condecreto nel dicembre 2006, etiene conto del parere dellaCommissione europea, invia-to all’Italia il 15 maggio 2007. Rispetto alla versione prece-dente, il nuovo Piano prevedeun taglio delle emissioni di13,64 milioni di tonnellate diCO2 equivalente. Rispettatoanche il tetto di 195 milioni ditonnellate di CO2 annue a cuisono state aggiunte, sempresu indicazioni dalla Comunitàeuropea, le quote (6 milionicirca) dei nuovi settori assog-gettati alla direttiva EmissionTrading, tra cui cracking e ne-ro fumo. A tutti i settori indu-striali è stato chiesto un parti-colare sforzo per consentire alPaese di rispettare gli obiettivieuropei e di Kyoto ed in que-sta ottica il taglio operato si èmaggiormente concentratosui settori e sulle fonti ad alteemissioni di CO2. “Abbiamoavviato – ha dichiarato il mini-stro Pecoraro - una strategiacomplessiva che vede anchesegnali positivi in finanziaria.Si tratta ora di rendere più for-te questa politica e per questoè necessario un apporto positi-vo da parte del mondo delleimprese, del Governo e degliEnti Locali”.

cro
nache
ENERGIA, AMBIENTE E INNOVAZIONE 6/2007
dall’ENEA
89
compito di coordinare e fi-nanziare le attività che l’I-stituto Nazionale di FisicaNucleare (INFN) e il CentroInformazioni Studi Espe-rienze (CISE) stavano por-tando avanti nel solco del-la grande tradizione dellafisica italiana: la costruzio-ne di un grande accelera-tore di particelle e di ungrande reattore nucleare. L’azione congiunta di que-sti tre istituti portò l’Italiain pochissimo tempo aglieccezionali risultati deglianni seguenti: la realizza-zione dei Laboratori Na-zionali di Frascati e il Cen-tro Nazionale di RicercheNucleari di Ispra.L’acceleratore, entrato de-finitivamente in funzionenel 1959, venne utilizzatodue anni più tardi periniettare elettroni nella ri-voluzionaria macchinaAdA (Anello di Accumula-zione), la prima al mondoad aprire una nuova viaalla sperimentazione sulleparticelle elementari.Nel 1960, in collaborazio-ne con Euratom, ha iniziola realizzazione della pri-ma grande macchina perla fusione termonuclearea confinamento magneti-co, a geometria toroidale,denominata FT (FrascatiTorus), un tokamak ad al-to campo per lo studio deiplasmi ad alta densità, en-trato in funzione nel 1977;nel 1989, venne poi messain funzione la macchina ditipo avanzato FTU (Frasca-ti Tokamak Upgrade).Con la recente decisione dicostruire ITER, il program-ma di sviluppo della fusio-ne ha avuto un ulterioreimpulso. Per il futuro sipunta a realizzare un nuo-va macchina tokamak che
I 50 anni del Sincrotrone
di Frascati
Il 7 dicembre 2007, nella Sa-la Consiliare del Comune diFrascati sono stati ricordaticon un convegno i 50 annidei “Laboratori Nazionalidel Sincrotrone di Frascati”.Negli anni di ricostruzionedopo la guerra, l’Italia de-cise di dotarsi di un pro-gramma di sviluppo dell’e-nergia nucleare. Nel 1952 venne istituito ilCNRN, Comitato Nazionaleper le Ricerche Nucleari(che poi diverrà CNEN e suc-cessivamente ENEA) con il
rappresenti una facilityper tutta la ricerca euro-pea. L’ENEA fornirà componen-ti tecnologici di rilevanteimportanza, quali la dia-gnostica neutronica e il di-spositivo laser per la me-trologia e la visione. Uncontributo rilevante verràfornito dall’Ente anche al-la costruzione di una mac-china tokamak da installa-re in Giappone. A partire dai Laboratoridel Sincrotrone, l’area diFrascati si è andata arric-chendo di un patrimoniosempre più consistente dirisorse e istituzioni di ri-cerca e del polo universi-tario di Tor Vergata, conuna concentrazione unicaa livello nazionale e condimensioni tra le più gran-di a livello europeo, cheha conferito a questo ter-ritorio la connotazione diuna vera e propria Cittàdella Scienza.Il Presidente ENEA LuigiPaganetto ha sottolineatocome la celebrazione ab-bia voluto costituire unatappa di un percorsoproiettato in avanti, chevede in questo distrettodelle conoscenze scientifi-che e tecnologiche, unodei fattori strategici per losviluppo di quest’area,mettendo a sistema il suopatrimonio di risorse, perfavorire sinergie e integra-zioni che permettano al si-stema produttivo del ter-ritorio di conseguire unamaggiore capacità compe-titiva sui mercati, di attrar-re un maggior numero diricercatori stranieri, di ac-quisire una leadership cul-turale, di favorire lo spin-off di imprese dalle atti-vità di ricerca.
dall’ENEA
I 50 anni del Sincrotronedi Frascati
A consulto per l’ambiente marino
SICENEA: “Pura energiadi Sicilia”
Igiene e sicurezza ambientale
Banca Mondiale
Carbone: obiettivo zeroemission

A consulto per l’ambiente
marinoCon il patrocinio dell’ENEA, ea cura di Carla Micheli del Di-partimento Biotecnologie,Agroindustria e Protezione del-la Salute, si è svolta al CR dellaCasaccia, il 9 e 10 novembre laRiunione scientifica annuale delGruppo di lavoro “Algologiadella Società Botanica Italiana”.Oltre 40 ricercatori italiani han-no illustrato le loro attività sumicroalghe, cianobatteri, ma-croalghe e fanerogame mari-ne, nei rispettivi campi di ricer-ca: monitoraggio satellitare,tassonomia, biologia moleco-lare, ecologia, fisiologia e tos-sicologia (per il fitoplanctontossico). Queste ricerche sonodi estremo interesse per gli in-terventi degli specialisti del ma-nagement costiero, le agenzieregionali che si occupano delmare e delle sue risorse, e ipubblici ufficiali della salute, vi-sta la frequenza di indesidera-te ‘fioriture algali’ che ricorro-no, ultimamente, nell’ambien-te acquatico marino con rica-dute negative sulla salute uma-na, le industrie e l’economiadell’ambiente legata al turi-smo.Sono state illustrate le risultan-ze del confronto tra cianobat-teri antartici e i ceppi mediter-ranei utili per ricercare i ceppiproduttori di nuovi compostibioattivi, che trovano applica-zione in campo farmaceutico ebiotecnologico. I programmi dilavoro sull’identificazione dellespecie isolate, e attualmente incoltura, hanno fatto ricorso siaall’analisi molecolare sia allatassonomia classica, attraversola microscopia elettronica: una
dall’ENEA
ENERGIA, AMBIENTE E INNOVAZIONE 6/2007 90
cro
nache disciplina indispensabile per
la valutazione della qualitàambientale e che, nello spe-cifico, ha fatto uso di meto-dologie innovative come il te-lerilevamento (Satellitare, insitu LIDAR ENEA).Tra le varie attività riguardan-ti la vegetazione dei nostrimari, sono state presentate lericerche sulle fanerogamemarine approfondite non so-lo su direttive del Magistratoalle Acque di Venezia (Proget-to Mose), ma sviluppate an-che in relazione ai fenomenidovuti all’erosione delle co-ste e alla riforestazione in zo-ne degradate come la prate-ria di S. Marinella, in prossi-mità del porto di Civitavec-chia: uno degli interventi piùrecenti adottato non solo infunzione della conservazionedell’ambiente marino, ma an-che della pesca che rappre-senta un’importante fonteeconomica del nostro Paese.
SICENEA: “Puraenergia di Sicilia”
Il programma pluriennale SI-CENEA, www.sicenea.it, fi-nanziato dall’Assessorato al-l’Industria della Regione Si-ciliana e realizzato dall’E-NEA, promuove in Sicilia losviluppo di un modello ener-getico ed economico orien-tato all’impiego diffuso del-le fonti rinnovabili e all’uti-lizzo ottimale dell’energia. Destinatari delle diverse ini-ziative che confluiscono inSICENEA sono gli Enti Localidella Regione Siciliana, im-prese, progettisti, installato-ri, energy manager e profes-sionisti.
A Palermo il 19 novembre, ilDG ENEA Giovanni Lelli el’Assessore all’industria del-la Regione Sicilia GiovannaCandura hanno lanciato lacampagna di sensibilizzazio-ne del programma che haper slogan Stiamo lavoran-do per voi, mettendo incampo tutta la nostra ener-gia.Una campagna rivolta adoperatori economici, ammi-nistrazioni locali, famiglieper far percepire come ilprogramma energetico co-stituisca un’opportunità persviluppare e favorire impren-ditorialità innovativa.Fra gli strumenti della cam-pagna sono previsti annun-ci stampa su quotidiani loca-li e nazionali e verranno di-stribuiti anche prodotti edi-toriali e multimediali sullefonti rinnovabili, sull’uso ra-zionale dell’energia, sullosviluppo sostenibile, con par-ticolare riferimento alla si-tuazione e alle prospettivein Sicilia.SICENEA si avvale della col-laborazione del Dipartimen-to di Ricerche Energeticheed Ambientali dell’Universitàdi Palermo, del Dipartimentodi Scienza e Tecnologie del-l’Ambiente Costruito del Po-litecnico di Milano e dellaFederazione Italiana degliEnergy Manager.
Igiene e sicurezzaambientale
Anche quest’anno l’ENEAcontribuirà al corso di lau-rea triennale in “Tecnichedella Prevenzione nell’Am-biente e nei Luoghi di Lavo-ro” dell’Università degli Stu-di di Roma Tor Vergata, nel-l’ambito di una convenzio-

cro
nache
ENERGIA, AMBIENTE E INNOVAZIONE 6/2007
dall’ENEA
91
ne stipulata lo scorso annotra l’ENEA e la Facoltà di Me-dicina e Chirurgia dell’Univer-sità stessa. Secondo le fina-lità stabilite, i tecnici che siformeranno da tale corso dilaurea dovranno svolgere,con autonomia tecnico-pro-fessionale, attività di preven-zione, verifica e controllo inmateria di igiene e sicurezzaambientale nei luoghi di vitae di lavoro, di igiene deglialimenti e delle bevande, diigiene e sanità pubblica e ve-terinaria. Numerosi ricercatori del Di-partimento Biotecnologie,Agroindustria e Protezionedella Salute, già a partiredallo scorso anno accademi-co (2006-2007), sono stati no-minati docenti di svariati cor-si rivolti agli studenti del pri-mo e secondo anno, per untotale di oltre 200 ore. Ad essi, quest’anno, si ag-giungeranno i corsi tenutiagli studenti del terzo annodai colleghi dell’Istituto diRadioprotezione. Le tematiche trattate sonosoprattutto quelle di tipobiologico, sanitario e am-bientale utili al percorso for-mativo. I corsi sono suddivisi tra ma-terie di base e altre più spe-cialistiche: le prime compren-dono la biologia molecolaree cellulare, la genetica, lamutagenesi, l’immunologia,la radiobiologia; quelle piùspecialistiche spaziano dal-l’epidemiologia alla certifi-cazione ambientale, dallebiotecnologie vegetali allaqualità e sicurezza alimenta-re, dallo studio dei campielettromagnetici e dell’inqui-namento atmosferico alla ra-dioprotezione, dall’educazio-ne al corretto utilizzo e ge-stione dei laboratori di ricer-ca biomedica alle metodolo-
gie di valutazione dei rischi.Il direttore didattico delcorso è la Prof.ssa MarinaCauletti dell’Università diTor Vergata; il responsabiledel Corso per l’ENEA è laDott.ssa Donatella Tirindel-li (Direttore della Sezionedi Tossicologia e ScienzeBiomediche). La sede delCorso di Laurea è la Facoltàdi Medicina dell’Universitàdi Roma Tor Vergata, ma icorsi tenuti dai docentiENEA si svolgono presso ilCentro Ricerche della Casac-cia. In tal modo, per moltiinsegnamenti, è stato pos-sibile affiancare alle lezio-ni teoriche visite ai labora-tori e dimostrazioni prati-che che hanno ulteriormen-te valorizzato la qualità del-la didattica, offrendo lestrutture, l’esperienza e lacompetenza dei laboratoridell’ENEA per la formazio-ne di figure professionalimeglio preparate ad un in-gresso qualificato nel mer-cato del lavoro.Al termine dei corsi delloscorso anno accademico, ledispense e le diapositive ela-borate dai docenti ENEA so-no state consegnate in for-mato elettronico alla Facoltàdi Medicina dell’Università diTor Vergata che ha provve-duto ad inserirle nel propriosito Internet, rendendole co-sì facilmente accessibili aglistudenti interessati. Tra gli obiettivi futuri c’èquello di elaborare materia-le didattico utile per pro-grammi di insegnamento adistanza da integrare con lelezioni frontali.L’indirizzo del sito internetdel corso, al quale ci si puòcollegare per ulteriori infor-mazioni, èhttp://www.medlav.uniro-
ma2.it/corso/index.php
[email protected]@casaccia.enea.it
Banca MondialeUna delegazione ENEA,composta da Marina Leo-nardi e da Giorgio Simbo-lotti, guidata dal Presiden-te Prof. Luigi Paganetto siè recata il 14 novembre aWashington presso laWorld Bank (WB) per pre-sentare le attività di ricer-ca svolte dall’Ente nel set-tore delle energie rinnova-bili e della sostenibilitàambientale.La presentazione è avve-nuta alla presenza del Di-rettore Esecutivo per l’Ita-lia (nonché Portogallo,Grecia, Albania, Malta, SanMarino e Timor-Leste) Gio-vanni Majnoni e di rappre-sentanti di alto livello del-la WB, che operano neisettori potenzialmente in-teressati alle tecnologiesviluppate dall’Ente e inaree geografiche dovel’applicazione di soluzionitecnologiche potrebbe as-sumere uno specifico inte-resse per la risoluzione diproblematiche di rilievo,quali l’approvvigionamen-to idrico e la produzione edistribuzione di energiaelettrica a livello locale.La presentazione include-va l’illustrazione quantita-tiva dei risultati ENEA indiversi campi di attività(includendo il numero dibrevetti, i programmi diformazione e le borse in-ternazionali per stranieri,la partecipazione dell’En-te ai PQ di RS&T dell’Unio-ne Europea), per fornireun’idea della proiezioneinternazionale e della for-

dall’ENEA
ENERGIA, AMBIENTE E INNOVAZIONE 6/2007 92
cro
nache za tecnico-scientifica del-
l’Ente.Sono stati poi illustrate dalpunto di vista tecnico le at-tività relative allo sfrutta-mento delle biomasse a finienergetici e, più nel detta-glio, le potenzialità dellatecnologia del solare termo-dinamico, con la possibilitàdi applicazione della produ-zione di energia elettricaottenuta dal sole alla dissa-lazione dell’acqua marina,che offrirebbe un contribu-to importante alla soluzio-ne di uno dei problemi dimaggiore importanza per iPaesi del MENA (Middle Ea-st and North Africa Region).Obiettivo della visita erainoltre quello di esplorarela possibilità di realizzareeventuali progetti nella cor-nice offerta dai programmidi cooperazione e finanzia-mento che la World Bank ri-serva ai Pae si in via di svi-luppo e di individuare even-tuali opportunità di busi-ness, con particolare riferi-mento alle fonti rinnovabili,nel campo della produzionedi energia da biomasse (in-clusi i biocarburanti), delletecnologie legate al solare,dell’efficienza energetica,nonché in progetti volti al-l’adattamento ai cambia-menti climatici. A questo fine, al seminarioiniziale sono seguiti deimeeting bilaterali più ri-stretti, nel corso dei quali sisono approfonditi temi tec-nico-scientifici più speciali-stici, con esponenti sia deipaesi MENA che del Dipar-timento dello Sviluppo So-stenibile della WB (MNSSD).A completamento di questoprimo incontro potrebbe se-guire, come auspicato daentrambe le parti, la visitadi una delegazione della
World Bank ai laboratori eagli impianti ENEA di mag-giore interesse per poten-ziali progetti futuri.Un’analoga discussioneinformale, in forma di se-minario ristretto, ha avutoluogo lo stesso giornopresso gli uffici dell’Inter-American DevelopmentBank (IDB), alla presenzadell’Alternate Executive Di-rector Francesca Manno edi due alti funzionari inrappresentanza dei Paesilatino-americani, potenzia-li beneficiari di progettisulle fonti energetiche rin-novabili.A entrambi gli incontri èstata presente anche unarappresentanza dell’Amba-sciata italiana a Washing-ton, che ha confermato ilsupporto alle iniziativecongiunte su temi di im-portanza strategica per ipotenziali paesi beneficia-ri, quali lo sviluppo soste-nibile, le energie rinnova-bili, la disponibilità di ac-qua dissalata per l’agricol-tura e gli usi civili.
Carbone: obiettivo zero
emissionIl crescente ricorso alle fon-ti rinnovabili di energia eil forte impegno di rispar-mio energetico nei vari set-tori non eviteranno la ne-cessità, per i prossimi anni,di utilizzare i combustibilifossili, incluso il carbone.L’utilizzo del carbone ri-chiede però ingenti investi-menti in tecnologie in gra-do di limitare le emissioniin atmosfera, specialmen-
te di anidride carbonicaprincipale responsabile del-le alterazioni climatiche incorso. Una di queste tecnologie èquella relativa alla catturae confinamento totale oparziale della CO2 (o CCS,Carbon Capture and Stora-ge) prodotta da impiantialimentati a carbone.Le tecnologie CCS sono og-getto di attività di ricercain tutto il mondo ed è or-mai considerata matura eindispensabile la fase delladimostrazione degli im-pianti a emissioni zero o"near zero emission" conl’obiettivo di dimostrare lafattibilità tecnico-economi-ca ed allo stesso tempo lasicurezza dello stoccaggioe la sua stabilità nel tempo.Questo è quanto emergechiaramente dai lavori delCSLF (Carbon SequestrationLeadership Forum) e dellapiattaforma europea ZEP(Zero Emission Powerplants).L’ENEA, impegnato nelle ri-cerche su cattura e stoccag-gio della CO2 per ridurre azero le emissioni nel casodell’impiego di carbone, haorganizzato a Roma il 12dicembre 2007 un Work-shop come occasione diconfronto tra i diversi pro-tagonisti del mondo dell’In-dustria e della Ricerca ope-ranti nel campo delle tec-nologie CCS in Italia. L’incontro ha voluto favo-rire la definizione di un’a-zione comune a livello na-zionale, ritenuta un’oppor-tunità irrinunciabile, sia inrelazione ai futuri indirizzidi politica energetica siaper consentire al nostro si-stema industriale di compe-tere sul mercato globaledegli impianti a carbone.

Eventi
cro
nache
ENERGIA, AMBIENTE E INNOVAZIONE 6/2007 93
nostra società, è necessariocostruire un ponte anche tra lacultura di laboratorio del ricer-catore e di bottega dell’artista.Il lavoro non è poi così diverso:in entrambi i luoghi si verifica-no ipotesi sulla realtà circostan-te, sperimentando tecnichespesso molto sofisticate.In Artenergendo uno spazioENEA era dedicato alle ener-gie rinnovabili con i prototipirealizzati per il solare termo-dinamico a concentrazione, ilfotovoltaico e le celle a com-bustibile.Un secondo spazio espositivomostrava l’applicazione allostudio di sculture e opere d’ar-te del Radar Topologico adImmagine a colori, ITR, capa-ce di riprodurre immagini adaltissima risoluzione. L’ITR, uti-lizzando le onde elettroma-gnetiche, è la soluzione idea-le e tecnologicamente piùavanzata per studiare le ope-re d’arte, consentendone lariproduzione con estrema pre-cisione senza alterarne lo sta-to e la bellezza.Le due facce della mostra sonostate, da un lato un confrontosull’energia, studiata dal ricer-catore e osservata dall’artista,dall’altro un dialogo su comee quando le moderne tecno-logie possano contribuire allostudio ed alla salvaguardia deicapolavori artistici.
Il colore perdutodi Giotto
I restauri e le verifiche effet-tuate nella Basilica di San Fran-cesco ad Assisi, a seguito delterremoto del 1997, hannocostituito l’occasione per lostudio delle tecniche esecuti-ve e delle alterazioni cromati-che delle superfici pittoriche.
A dieci anni dal tragico even-to, i risultati delle indagini, rac-colti nel libro Giotto com’era(edito da De Luca), sono statipresentati il 28 novembre aRoma nella ex Chiesa di SantaMarta. Malgrado la grande impor-tanza di questo ciclo di affre-schi sulle Storie di San Fran-cesco realizzati da Giotto -hanno messo in risalto gliautori - gli ultimi dati anali-tici sull’opera risalivano aoltre sessanta anni fa. L’inda-gine, effettuate in stretta col-laborazione tra l’Istituto Cen-trale per il Restauro e l’ENEAnella navata della BasilicaSuperiore di Assisi, è riuscitaa individuare residui minimidell’originaria coloritura asecco e di decorazioni confoglie metalliche, altrimentinon apprezzabili. Ricorrendoa tecniche di diagnosticaavanzata e non invasiva, lafluorescenza X, è emersa unaricchezza di colori e materia-li: dietro a quelli che sembra-no dei rossi si scopronoazzurri, dietro molti neri ibianchi e ancora verdi e ros-si cinabro. Il riconoscimentoe la stima di quanto purtrop-po non sopravvissuto dellecromie originali di questociclo pittorico hanno sugge-rito delle ipotesi ricostrutti-ve, per la prima volta presen-tate e discusse.Quest’esperienza ha confer-mato l’importanza dell’utiliz-zo di tecnologie sofisticatenella salvaguardia del patri-monio artistico italiano, harilevato il presidente ENEALuigi Paganetto, ed è “l’illu-strazione della capacità del-le moderne tecnologie dicreare, in maniera virtuale,ipotesi di ricostruzione diopere pittoriche gravemen-te danneggiate, come le 28tavole del cielo”.
Dialogo tra arte e scienza
Dal 4 al 9 ottobre scorso a Roma,presso il Complesso Monumen-tale San Michele a Ripa, ha avu-to luogo Artenergendo, una ras-segna trasversale di arte escienza sui temi dell’energia edell’ambiente, realizzata dall’Ac-cademia di Belle Arti in collabo-razione con l’ENEA.Per l’ENEA, in uno spazio aper-to tra il laboratorio dello scien-ziato e la bottega dell’artista, l’e-vento ha rappresentato un’altromodo per parlare e incuriosire ilpubblico su questioni importan-ti, quali l’energia e il cambia-mento climatico. Oggi, di fron-te ai problemi complessi della
Eventi
Dialogo tra arte e scienza
Il colore perduto di Giotto
La comunicazione tra reale e virtuale
Intelligenza Artificiale10° Congresso AI*IA

Eventi
ENERGIA, AMBIENTE E INNOVAZIONE 6/2007 94
cro
nache
La comunicazione tra reale
e virtuale
Promosso dal Master inEconomia e Gestione dellaComunicazione e dei Media,della Facoltà di Economiadell’ Università Tor Vergatadi Roma, si è svolto il 13dicembre in collaborazionecon ENEL e FERPI il convegnoHigh Tech High Touch:lacomunicazione oggi tra realee virtuale.La comunicazione proseguen-do il suo percorso evolutivo esperimentando nuove appli-cazioni, nuove metodologie,nuovi strumenti si è da qual-che tempo fortemente foca-lizzata sulle opportunità of-ferte dalle nuove tecnologie(high tech).L’affermarsi di queste poten-zialità tecnologiche porta,però, ad una possibile indi-vidualizzazione e spersona-lizzazione del contatto che,per taluni aspetti, può sem-brare una logica evoluzionema che, da un altro lato, sa-crifica una componente im-portante dell‘uomo tesa afavorire la socializzazione ela relazione umana (hightouch).Torna, dunque, di attualitàun vecchio slogan che reci-tava ”High tech, high touch”evidenziando come fosse ne-cessario bilanciare l’accen-tuarsi della dimensione tec-nologica con una altrettan-to importante attenzione al-la dimensione del contattoumano. L’integrazione fra ledue dimensioni, tecnologi-che (tech) e umane (touch),rappresenta per la comuni-cazione una sfida perché ri-
chiede un allargamentodelle competenze fra i pro-fessionisti.L’obiettivo dell’evento, nelquale si sono avvicendatetestimonianze d’eccellen-za sull’evoluzione della co-municazione tra virtuale ereale, è stata l’occasioneper riflettere, su questa di-mensione integrata al li-vello tecnologico ed uma-no, per definire le oppor-tunità e le minacce chequesta tendenza può pre-sentare nell’ambito dellacomunicazione e, in termi-ni più generali, del marke-ting e del managementdelle imprese e delle isti-tuzioni.
Intelligenza Artificiale
10° CongressoAI*IA
Dal 10 al 13 settembre 2007si è tenuto presso VillaMondragone (Centro Con-gressi dell’Università diRoma Tor Vergata) il 10°Congresso dell’Associazio-ne Italiana per l’Intelligen-za Artificiale (AI*IA) orga-nizzato dal gruppo diricerca in Intelligenza Arti-ficiale dell’Università diRoma Tor Vergata(http://aiia.info.uniroma2.it).L’evento ha visto la parte-cipazione di più di 150ricercatori, studiosi e pro-fessionisti interessati allosviluppo di tecnologie emetodologie del settore.Numerose le iniziative rivol-te al mondo industriale fracui un ciclo di Tutorial orga-nizzati da esperti dell’AI*IAche hanno riguardato leseguenti tematiche:
• Modelli della Conoscenzae Web Semantico (Knowled-ge Modeling and SemanticWeb);• Applicazioni per il Trat-tamento e la Valorizzazio-ne dei Dati Testuali (Text-Processing Applications);• Tecnologie della Roboti-ca Cognitiva (CognitiveRobotics);• Accesso, Estrazione eTrattamento della Infor-mazione nel Web (WebMining).Stimolante la presenza diesperti internazionali inqualità di relatori invitati:1. Khurshid Ahmad, TrinitàCollege Dublin, “Artificial Ontologies andReal Thoughts: Populatingthe Semantic Web?”2. Michael Mateas, Univer-sity of California, SantaCruz,“Expressive Intelligence: Arti-ficial Intelligence, Games andNew Media”3. Manuela Veloso, Carne-gie Mellon University,“ Learning to Select TeamStrategies in Finite-TimedZero-Sum Games”e delle Special Tracks: • Artifical Intelligence andRobotics; • Artificial Intelligence andExpressive Media; • Intelligent Access to Mul-timedia Information.Sono stati organizzati treworkshop da ENEA, IBMItalia e Fondazione BrunoKessler.Il Workshop “AI for Cultu-ral Heritage” organizzatoda ENEA-FIM ha costituitoancora una volta, in quan-to alla sua quarta edizio-ne, un’occasione preziosae generosa d’incontro pertutti i [email protected]

Letture
cro
nache
ENERGIA, AMBIENTE E INNOVAZIONE 6/2007 95
Catastrofi climati-che e disastri socialiPascal AcotDonzelli, 2007, pagine 168, euro 15,50
Quali relazioni esistono tra le ca-tastrofi (canicole e inondazioniin Europa), gli uragani nel Golfodel Messico, gli incendi ripetuti-si in estate in Europa e il riscal-damento climatico? Catastroficlimatiche simili si ripeterannoin futuro? Le cause delle glacia-zioni e delle fasi di riscaldamen-to climatico del passato sono sol-tanto dovute a fattori climatici(ossia atmosferici) o sono lega-te anche ad altri fattori (astro-nomici, geologici)? Sono i que-siti che Pascal Acot, ricercatore
di Storia delle Scienze presso ilCnrs di Parigi, pone all’atten-zione del lettore e che fannosorgere altri quesiti più com-plessi. Perché i climi cambiano?Come funzionano i meccani-smi climatici? Abbiamo com-preso a pieno la circolazionegenerale dell’atmosfera e quel-la degli oceani? Lo stesso temadell’influenza delle attivitàumane sull’attuale riscalda-mento climatico pone impor-tanti problemi scientifici e su-scita numerose controversie.Contrariamente a un’idea dif-fusa da molti climatologi, af-ferma Acot, “non è stata rag-giunta una piena unanimitàscientifica sull’argomento”. Èuna difficoltà, questa, da noneludere facendo il punto sul-l’eventuale ruolo delle societàumane sull’intensificazione delriscaldamento climatico duran-te l’ultimo secolo. Ha sensodunque, parlare di “catastro-fe climatica”, oppure bisognaparlare prima di tutto di cata-strofe sociale e politica? Acotlo dichiara esplicitamente:”Scopo del libro è capire per-ché le catastrofi climatiche so-no prima di tutto disastri socia-li e per quale ragioni esse so-no anche - come tutte le cata-strofi naturali - spietati indicidell’indifferenza di quelle chei giornalisti chiamano ironica-mente le élites.” L’espressione“catastrofe climatica” non hasenso di per sé, ma soltanto serapportata alle società umane.Un cambiamento climatico,lento o improvviso, può diven-tare una catastrofe in presen-za di determinate condizionisociali: un’inondazione non halo stesso valore se avviene inuna zona della Francia o inBangladesh, pur trattandosi co-munque di una tragedia per levittime. Allo stesso modo, rife-rendosi alla calda estate del2003 Acot afferma “che la ca-
nicola ha colpito più duramen-te le popolazioni più svantag-giate, che la Francia avrebbepotuto contare un numero dimorti eccedenti di gran lungainferiore se il suo sistema sani-tario avesse funzionato ade-guatamente e che questa di-sfunzione fu il frutto di delibe-rate scelte politiche ed econo-miche”. È proprio per questoche quando si parla di effettoserra “aggiuntivo” – quello do-vuto alle attività umane, indu-striali, agricole e private - se-condo Acot si fa spesso del “ca-tastrofismo” e qualche respon-sabilità in questo senso vieneattribuita anche all’IPCC. Que-sta Agenzia, ci ricorda l’auto-re, è espressione di un disposi-tivo politico (il G7), e su questitemi fa “il bello e il cattivotempo” basandosi su modelliche “sono molto difettosi, il ri-scaldamento attuale sembramolto trascurabile se parago-nato alle fluttuazioni climati-che del passato, i dati di cui di-sponiamo sono insufficien-ti…”. Ma resta il fatto che l’ap-plicazione del principio di pre-cauzione è comunque neces-sario per non dovercene poipentire, afferma con realismol’autore, perché, “Il passato eil buon senso insegnano che èsempre più efficace agire senzasperare piuttosto che speraresenza agire!”. Ed è perciò chebisogna essere critici, come fanei confronti dell’OCSE – un al-tro Organismo di parte (il Norddel Mondo) - che, pur giudi-cando ormai tardivo l’interven-to per contrastare i cambia-menti climatici provocati dalleattività umane, finanzia taskforce per valutare, paese perpaese, le emissioni di gas ser-ra, per indurre questi paesi aridurle. Per Acot, invece, le di-rettrici di uno sviluppo soste-nibile sono la solidarietà tra ipopoli, in particolare fra quel-
Letture
Catastrofi climatiche e disastri sociali
La Governance dello sviluppo – esperienze
di politica industriale

Letture
ENERGIA, AMBIENTE E INNOVAZIONE 6/2007 96
cro
nache li del Nord e quelli del Sud, nel
senso di porre fine ai saccheggidegli uni su gli altri; una gestio-ne razionale dell’ambiente; unarazionalità economica “agli an-tipodi del liberalismo attualmen-te alla moda”. Occorre, insom-ma, pensare al futuro ecologicodel mondo in termini di eman-cipazione umana, e come affer-ma chiudendo il suo libro “lalotta per la realizzazione di un’e-cologia della liberazione uma-na è più che mai necessaria”. [email protected]
La Governancedello sviluppo –
esperienze di politica industrialeRoberto Pasca di MaglianoIl Sole 24 Ore, 2007, pagine175, euro 19
Le sfide che economie in conti-nuo mutamento e in progressi-va integrazione riversano sul si-stema delle imprese impongo-no un radicale ripensamento del-le politiche industriali come trai-no dello sviluppo. È ancor più ne-cessario che non siano distorsivedel mercato e non diffondanomessaggi assistenziali. Ma ciònon basta. Si va affermando l’e-sigenza di interventi mirati alrafforzamento della struttura fi-nanziaria delle imprese, speciedelle medio-piccole, per argina-re le ricorrenti crisi finanziarie el’invadenza degli Stati. La sceltadi come, dove investire, dellemodalità di delocalizzazione par-ziale o totale deve restare all’im-presa, senza interferenze né age-volazioni pubbliche. Gli ingre-dienti di una moderna politicaindustriale vanno ricercati, da unlato negli elementi influenzantila competitività delle imprese e,dall’altro in una governance chesappia coniugare appropriate
misure di intervento con pro-cedure snelle, trasparenti e ca-paci di indurre comportamentivirtuosi da parte degli investi-tori e delle imprese. Il libro diPasca di Magliano mette in lu-ce le tante sfide che le impreseitaliane devono superare perpartecipare al mercato globa-le, le difficoltà strutturali, gliostacoli all’innovazione e l’im-pegno di ristrutturazione rea-lizzato in questi anni. Il sensibi-le ammodernamento della po-litica industriale nazionale rea-lizzato tra il 2002 e il 2005 haaiutato le imprese a superarequeste difficoltà. L’autore hacontribuito direttamente alleriforme nella sua veste di diret-tore generale degli aiuti alleimprese al Ministero delle At-tività Produttive in quel perio-do. In sintesi si è agito:1. sulla giungla di interventipubblici esistenti, selezionan-do poche e precise misure ri-volte al sostegno degli investi-menti innovativi, al potenzia-mento della ricerca applicatae del capitale di rischio delleimprese più deboli. Nel 2003c’erano 44 leggi nazionali diaiuto, oggi non più 10 riferitea tre obiettivi;2. riformando le misure di aiu-to senza ricorrere a nuove leg-gi ma con modifiche di proce-dure farraginose per introdur-re regole fluide e responsabi-li, dimostrando che anche nel-la civil law possono introdursiregole “virtuose”. Pochi esem-pi per tutti: - gli aiuti non più concessi afondo perduto ma in un mixcomprendente crediti agevo-lati e ordinari così da respon-sabilizzare sia le imprese bene-ficiarie obbligate alla restitu-zione di parte dell’aiuto che lebanche incaricate della valuta-zione del merito creditizio;- l’introduzione di tempi certie inderogabili per l’utilizzo de-
gli aiuti a fronte di investimen-ti programmati, pena l’auto-matica decadenza della deli-bera (Cipe) di concessione;- la definizione di uno schemadi fideiussione assicurativastandard a buon fine, così dagarantire lo Stato sul buon esi-sto degli aiuti anticipati.Ma il mondo cambia rapida-mente e la governance deve es-sere capace di guidare lo svilup-po con misure ancora più selet-tive e mirate a consolidare le“spalle” delle piccole e medieimprese, evitando di interferi-re con la necessaria esposizio-ne al rischio. Il patrimonio delleriforme attuate resta comun-que valido, ma andrà applica-to a nuove azioni di politica in-dustriale che, ad avviso dell’au-tore, dovrebbero agevolare ilcoordinamento di fondi pubbli-ci e privati per la partecipazio-ne temporanea al capitale di ri-schio e per il finanziamento diinfrastrutture funzionali, la dif-fusione della finanza di proget-to agevolata e delle forme digaranzia ai crediti concessi allePmi. Anche per affrontare conmaggiore efficacia le ricorrenticrisi finanziarie e l’invadenza fi-nanziaria di nuovi paesi emer-genti (Cina, in primis) le nuovepolitiche andrebbero coordina-te o meglio realizzate a livelloeuropeo. Il libro affronta temicomplessi in modo fluido ecomprensibile senza perciò ri-nunciare ai necessari approfon-dimenti e si presta ad offrire uti-li suggerimenti ad operatoridella pubblica amministrazio-ne, banche e consulenti interes-sati al rilancio degli aiuti alle im-prese. L’autore è ordinario diEconomia politica alla Sapien-za, Università di Roma ove èpresidente dell’area didattica“Scienze della Cooperazione edello Svilppo”.