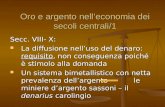L IMPRESA ITALIANA NELLECONOMIA GLOBALE 7 · tiche nel commercio internazionale, la rivoluzione...
Transcript of L IMPRESA ITALIANA NELLECONOMIA GLOBALE 7 · tiche nel commercio internazionale, la rivoluzione...
7
L’IMPRESA ITALIANA NELL’ECONOMIA GLOBALE
Capitalismo e sviluppo
Pierluigi CioccaIl capitalismo italiano:
una prospettiva storica
Guido M. ReyCreare nuovi rapporti
fra industria e finanza
Riccardo VaraldoRifondazione dei Distretti
via obbligata per il rilancio
BIMESTRALE DI POLITICA ECONOMICA
DDIICCEEMMBBRREE 22000066
Comitato scientifico
Paolo Gnes
PRESIDENTE
Boris Biancheri
Patrizio Bianchi
Innocenzo Cipolletta
Mario Deaglio
Sergio Luciano
Alberto Majocchi
Giorgio Mulè
Marco Onado
Guido M. Rey
Salvatore Rossi
Franco Varetto
Direttore Responsabile
Alberto MucciSegreteria di redazione Priscilla Bigioni
RedazioneGlobal CompetitionL’impresa italiana nell’economia globale Via G. B. Morgagni, 30/h - 00161 Roma tel. 06-44110735 - fax 06-44110775 email: [email protected]: www.cerved.com
Proprietario ed EditoreCerved Business Information SpA Via G. B. Morgagni, 30/h - 00161 Roma
Stampa Mondadori Printing SpA - Stabilimento grafico VeronaVia Mondadori,15 - Verona
DistribuzioneMondadori in abbinamento a Panorama Economyil 1° giovedì dei mesi pari
Progetto grafico e impaginazione G&Z - Comunicazione integrata - Roma
Le opinioni e i giudizi espressi negli articoli non impegnano la responsabilità di Cerved B.I. SpA
Bimestrale di politica economican. 7 - Dicembre 2006
Copyright 2005 Cerved B.I. SpA. Tutti i diritti di proprietà letteraria e artistica riservati Testata registrata al Tribunale di Roma al n. 409 del 19 ottobre 2005
L’ IMPRESA ITALIANA NELL’ECONOMIA GLOBALE
‹ editoriale ›
‹ editoriale ›Il ruolo del managerdi Paolo Gnes
Abbiamo dedicato i precedenti numeri di Global Competition all’analisi dei principali fattori che condizionanodall’esterno la competitività delle imprese italiane: la globalizzazione dei mercati, l’irrompere delle economie asia-tiche nel commercio internazionale, la rivoluzione tecnologica, lo squilibrio energetico, la dotazione di infrastrut-ture e reti, la formazione del capitale umano. Alcuni di questi fattori comportano limiti e oneri che solo le auto-rità di governo possono rimuovere; altri costituiscono sfide con cui le imprese possono e devono cimentarsi.
La principale sfida che l’industria italiana deve affrontare, nel più generale contesto del suo rafforzamento nel-l’economia globale, è il riposizionamento competitivo verso settori e produzioni a maggior valore aggiunto e, inparticolare, a più elevato contenuto tecnologico. Ma ciò richiede strutture organizzative e manageriali difficilmen-te compatibili con la frammentazione del nostro tessuto produttivo. Dobbiamo quindi chiederci, spostando l’a-nalisi all’interno dell’impresa, se e come il nostro sistema capitalistico saprà rispondere a questa esigenza di cre-scita dimensionale, organizzativa e manageriale.
Nella piccola e media impresa il capitalismo familiare ha dato nel complesso buona prova, portando al suc-cesso il made in Italy e dimostrando, in pochi ma qualificati casi, anche eccellenti capacità di crescità. La figura
dell’imprenditore capitalista, che opera in coincidenza di interesse con la propria aziendagarantendo continuità di gestione, potrebbe prestarsi quindi a governare anche la transizioneverso più adeguate dimensioni e assetti organizzativi, purché ne avverta l’esigenza, acquisiscale necessarie competenze manageriali e professionali e ottenga i finanziamenti necessari anchericorrendo, ove necessario, al private equity e al mercato azionario.
Non occorre – né sarebbe ipotizzabile – una crescita generalizzata. E’ sufficiente una cresci-ta selettiva delle imprese più dotate e dinamiche, che faccia da traino al resto del sistema. Ciòè tanto più vero considerando la realtà dei distretti industriali, così importante per il nostro siste-ma produttivo, che non resisterebbe restando com’è, ma facilita il riassetto. Come rilevaRiccardo Varaldo nell’articolo pubblicato in questo numero, occorre “far emergere dalla forestagli alberi dotati di un maggiore potenziale di cambiamento e di crescita, con la prospettiva di
costituire forze di traino anche per la rifondazione e il rilancio dei distretti industriali”. Bisognerebbe realizzare, inaltri termini, una sorta di “via italiana alla globalizzazione” per non disperdere il vasto e qualificato know-howmanifatturiero radicato nei distretti industriali riorganizzandolo attorno a più solide imprese orientate al mercatonelle sue nuove dimensioni. Operazione necessaria ma non facile, considerando la scarsa percezione del problema.
Se non sarà facile far emergere gli alberi con cui sorreggere il riassetto dei distretti, ben più arduo sarà costrui-re i pilastri su cui fondare il rilancio della grande impresa tecnologicamente avanzata. Accanto al problema dellapiccola impresa che non cresce abbastanza, si pone il problema – ben più grave – della grande impresa chescompare. Negli ultimi trent’anni, come rileva Luciano Gallino (La scomparsa dell’Italia industriale, 2003), unaserie di insuccessi – per lo più derivanti da errori di strategia aziendale o di politica industriale – ha portato allascomparsa di interi settori produttivi ad alta tecnologia in cui detenevamo posizioni di rilievo o le avremmo potu-te acquisire poiché disponevamo delle risorse umane e tecnologiche per farlo. Privo del supporto della grandeindustria tecnologicamente avanzata, il nostro paese rischia di diventare una “colonia industriale”. Solo la gran-de impresa infatti può effettuare gli enormi investimenti in ricerca e sviluppo necessari per entrare o per consoli-darsi nei settori di punta e può disporre della struttura organizzativa e della forza contrattuale indispensabili perpenetrare nei mercati esteri e inserirsi nell’oligopolio internazionale.
La crisi della grande industria chiama direttamente in causa l’efficienza del nostro sistema capitalistico, i cuilimiti sono evidenziati da Guido Rey nell’articolo qui pubblicato, al quale rinvio.
Allo sviluppo dell’economia italiana negli anni Cinquanta e Sessanta contribuirono sia le imprese pubblicheche quelle private. Le prime, e in particolare le imprese a partecipazione statale, assicurarono la crescita delle
‹ editoriale ›infrastrutture e delle industrie di base o comunque strategiche, esprimendo nell’insieme un management di altaqualità, dotato di ampia autonomia sul modello della public company americana. Anche le imprese private sep-pero crescere notevolmente, mantenendo in buona parte carattere familiare grazie all’ampio autofinanziamentoe al credito bancario. Entrambi i modelli capitalistici della grande impresa entrarono in crisi negli anni Settantaper il rallentamento economico, il mutato clima sociale e i condizionamenti politici, particolarmente nefasti perle imprese pubbliche, oltre che per gli errori sopra ricordati.
Oggi il rilancio della grande impresa, nella dimensione effettivamente congeniale agli spazi occupabili nei set-tori a media e alta tecnologia, non può fondarsi né su un diffuso capitalismo di stato, che è escluso dalla costitu-zione economica europea, né sul capitalismo familiare che – con le dovute eccezioni – ha dimostrato, anche in occa-sione delle privatizzazioni, scarsa propensione all’impegno nella grande impresa manifatturiera. Del resto l’identifi-cazione dell’imprenditore con il capitalista trova piena legittimazione quando quest’ultimo apporta buona parte delcapitale, mentre è molto meno giustificata quando, grazie a un sistema di partecipazioni a cascata e patti paraso-ciali, il controllo è conservato o acquisito disponendo magari solo dell’1% del capitale. In questo caso la coinciden-za degli interessi tra l’imprenditore/azionista di controllo e l’impresa è tutta da dimostrare, soprattutto quando ilprimo deve far fronte ai debiti contratti per l’acquisto della partecipazione o per altri investimenti a monte.
In tale situazione - rinviando a Silvano Andriani (L’ascesa della finanza, 2006, di seguito presentato) per unalucida analisi dell’evoluzione dalla pubblic company alla active ownership - la soluzione più razionale potrebbeessere l’affermarsi di un moderno capitalismo finanziario-manageriale in cui il ruolo di imprenditore sarebbe svol-to dal management dell’impresa con il supporto/controllo degli intermediari finanziari e degli investitori istituzio-nali, a condizione che si formi all’interno di entrambe le strutture una classe manageriale in grado di svolgereefficientemente i rispettivi ruoli. Il top management dell’impresa industriale dovrebbe essere in grado – per pro-fessionalità, capacità e vocazione – non solo di gestire l’azienda, ma anche di promuoverne l’internazionalizza-zione e la crescita. Analogamente il management dell’investitore istituzionale dovrebbe essere in grado, per capa-cità e competenza, di valutare professionalmente le iniziative proposte e controllarne lo svolgimento. Il capitaleda acquisire dovrebbe avere caratteristiche compatibili con la rischiosità/maturità dell’iniziativa da finanziare: ven-ture capital, private equity (fondi chiusi), fondi aperti, fondi pensione, pubblico. Gli investitori istituzionali dovreb-bero comunque destinare parte dei capitali raccolti a impieghi più stabili in una logica di maggiore attenzionealla redditività reale dell’impresa nel medio-lungo periodo, anziché applicare il paradigma dello shareholder valuein una esasperata ricerca di rapidi aumenti delle quotazioni comunque conseguiti.
Perché il capitalismo finanziario-manageriale possa colmare il vuoto lasciato nella grande impresa dal ridimen-sionamento del capitalismo privato e pubblico, occorre non solo che sappia far affluire all’impresa il necessariocapitale di rischio, ma soprattutto che riesca a promuovere la formazione, nella banca e nell’impresa, di un mana-gement all’altezza del compito da svolgere. Successi anche recenti dimostrano quanto i risultati delle aziendedipendano dalla qualità del top management. Una grande sfida per i grandi gruppi bancari e assicurativi: vor-ranno raccoglierla?
Sarebbe peraltro illusorio pensare che la formazione o la crescita delle grandi imprese tecnologicamente avan-zate, cioè dei pilastri sui cui potrà fondarsi il riposizionamento e il rilancio della nostra industria manifatturiera,possa avvenire solo per effetto del mercato. La concorrenza è certamente necessaria – come ricorda PierluigiCiocca nell’articolo qui pubblicato affermando che “il problema italiano non risiede nella capacità dei produttoridi progredire, bensì nell’attivare stimoli che li inducano a farlo” – ma non può supplire al ruolo di impulso che,in questo caso, deve essere svolto dalla politica industriale e dal mantenimento della presenza pubblica nellegrandi imprese strategiche per la difesa e lo sviluppo del paese.
Paolo Gnes
‹ editoriale ›
sommario N. 7 - DICEMBRE 2006
Capitalismo e sviluppo
Pierluigi CioccaIl capitalismo italiano: pag. 4una prospettiva storica
Guido M. ReyCreare nuovi rapporti pag. 12fra industria e finanza
Riccardo VaraldoRifondazione dei Distretti pag. 22via obbligata per il rilancio
I N T E R V E N T I
Silvano AndrianiL’ascesa della finanza. Risparmio, pag. 18banche, assicurazioni: i nuovi assetti dell’economia mondiale
Libri in vetrina pag. 30
I L P R O S S I M O N U M E R O
G I O V E D Ì 1 ° F E B B R A I O 2 0 0 7
Europa, riparti!
articoli di Boris Biancheri, Alberto Majocchi, Luigi Caligaris
IL CAPITALISMO ITALIANO:UNA PROSPETTIVA STORICA
L’Autore ripercorre le fasi dell’economia italiana (sinistra storica, guerre e fascismo,
tempi più recenti), ricorda che i produttori italiani vivono da sempre,
storicamente e strutturalmente, uno svantaggio nelle risorse primarie del territorio
e nelle fonti di energia e delinea i campi dove agire per il ritorno alla crescita dell’economia
(finanza pubblica e pubbliche amministrazioni; infrastrutture fisiche e giuridiche;
dimensione e dinamica d’impresa, promozione della concorrenza).
La conclusione: è cruciale che i produttori non deviino dalla ricerca incessante
dell’innovazione, della qualità, dell’aggiunta di valore agli inputs importati,
della capacità di esportare, ecc.
Di lunga durata, preoccupante, è lo smottamentodella crescita economica italiana. Avviatosi negli
anni Sessanta, si accentuò negli anni Settanta. Allora, fuin media di 1,5 punti nel PIL e nelPIL pro capite, di 2,5 punti nella pro-duttività del lavoro, di poco menodi 3 punti nella produttività totaledei fattori. Negli anni Settanta, tut-tavia, il rallentamento nel PIL e nelPIL pro capite fu inferiore a quellimedi dell’Unione europea edell’OCSE e i ritmi di sviluppo dell’e-conomia italiana restarono piùsostenuti. Dagli anni Ottanta, inve-ce, il décalage nella crescita prose-guì in Italia mentre si arrestò o quasinelle due grandi aree. Ne è seguitol’annullamento prima, il rovescia-mento poi, nel divario di sviluppo afavore dell’economia italiana.Soprattutto, la dinamica della pro-duttività totale dei fattori in Italia si èridotta drammaticamente nellaseconda metà degli anni Novanta. Èdiventata addirittura negativa nel2001-2005, fenomeno rarissimonella storia delle economie di merca-to capitalistiche. Nello stesso quin-quennio si è azzerata la crescita del
reddito pro capite (Tab. 1).Sono state ampiamente analizzate le concause del rista-gno in cui l’economia è ricaduta, dopo decenni postbelli-
ci di vivace ancorché non di radosquilibrato dinamismo. Lo sonostate con particolare riferimentoagli anni successivi alla crisi, valu-taria e “reale”, del 1992-1993,che segna uno spartiacque cru-ciale e inaugura la fase tuttora incorso, in cui i risultati dell’econo-mia sono stati massimamentedeludenti.
È prospettabile una interpreta-zione di estrema sintesi del déca-lage1. Si è fatto intenso il mutaredelle tecniche (la ICT è solo l’e-sempio più noto) e dei vantaggicomparati (primazia di alcunipaesi industriali nell’accesso allanuova tecnologia, irruzione sullascena commerciale internazionaledi paesi come Cina e India capacisia di qualità e d’efficienza sia dibassi costi del lavoro nelle stessetradizionali produzioni dell’Italia).Al tempo stesso la prontezza delsistema produttivo italiano nelcogliere queste opportunità, far
PIERLUIGI CIOCCA
Vice Direttore Generale della Banca d'Italia esuo rappresentante presso vari organismi nazio-nali e internazionali (G7, Financial StabilityForum, Economic and Financial Committee,BCE). È Direttore della Rivista di StoriaEconomica. È autore di numerose pubblicazioniin materia di economia, finanza, storia economi-ca fra le quali più di recente: Economia per ildiritto. Saggi introduttivi, Bollati Boringhieri,Torino, 2006 (con I. Musu); The Italian FinancialSystem Remodelled, Macmillan, London, 2005(Bollati Boringhieri, Torino 2000); Il tempo del-l’economia. Strutture, fatti, interpreti delNovecento, Bollati Boringhieri, Torino, 2004;L’economia mondiale nel Novecento. Una sinte-si, un dibattito, il Mulino, Bologna, 1998.
4
‹ Capitalismo e sviluppo ›G
LO
BA
LC
OM
PE
TIT
ION
7 -
20
06
1P. Ciocca, Il tempo dell’economia. Strutture, fatti, interpreti del Novecento, Bollati Boringhieri, Torino, 2004.
fronte alla sfida che pure in esse è insita, riallocare le risor-se è stata ostacolata dal concorso di almeno tre ordini difattori: diseconomie gravanti sulle imprese dall’esterno;carenze interne al mondo delle imprese; soprattutto,insufficienti stimoli lato sensu concorrenziali sui produttori.
Queste forze hanno interagito, interagiscono. Le dise-conomie esterne dissuadono dall’affrontare i costi e i rischiinsiti nel tentativo di colmare, per vie interne, le carenzedel sistema produttivo. Si ricercano modalità collusive eprotezionistiche nella difesa del profitto, preservando lostatus quo. La minor crescita dell’economia perpetua igravami nascenti dalla finanza pubblica. Le carenze inter-ne si accentuano. Un circolo vizioso impedisce di rispon-dere alle sfide internazionali che si fanno più serrate.Impedisce di cogliere appieno le potenzialità dischiuse dalprogresso tecnico e dall’atteggiarsi diverso dei vantaggicomparati. La minor pressione concorrenziale non inducead accumulare di più e ad accrescere la dimensione del-l’impresa.
Per il ritorno alla crescita dell’economia almeno quattroinsiemi di attori – lo Stato, le imprese, i sindacati, la finan-za – sono chiamati all’azione in altrettanti campi:
a) finanza pubblica e pubbliche amministrazionib) infrastrutture, fisiche e giuridichec) dimensione e dinamica d’impresad) promozione della concorrenza.
Le azioni positive su ciascuno dei quattro fronti sonopotenzialmente sinergiche. Nessuna fra esse è bastevole.Le interazioni fra le variabili in giuoco configurano effettinon additivi, ma fortemente moltiplicativi.
a) Il risanamento della finanza pubblica si misura sullacapacità del settore pubblico di contribuire all’innalza-mento del tasso di crescita dell’economia. Si deve risana-re per crescere. Al tempo stesso, senza crescita il risana-mento non sarà definitivo. Vanno congiuntamente coltitre obiettivi: saldi di bilancio coerenti con i vincoli europeie con una sicura discesa del debito pubblico; riduzionedella spesa primaria corrente, e quindi della imposizionefiscale e contributiva più onerosa e distorsiva, per supera-re disincentivi agli investimenti privati, rimuovere remore e
distorsioni, accrescere il risparmio nazionale; potenzia-mento e manutenzione delle infrastrutture fisiche e dellereti, da tempo inadeguate.
Il raggiungimento degli obiettivi postula uno sforzo dicontenimento della spesa senza precedenti. Si richiedeuna diminuzione dell’incidenza della spesa primaria cor-rente di oltre 5-6 punti percentuali del prodotto in unquinquennio. Della difficoltà di tale impegno le partisociali, e il Paese devono acquisire piena contezza, affin-ché ne condividano le finalità.
Una finanza pubblica e una pubblica amministrazioneopportunamente riorientate contribuirebbero allo svilup-po dell’economia per più vie: più alta propensione dei pri-vati a investire; risparmio con cui sostenere l’accumulazio-ne di capitale; minori diseconomie esterne alle imprese;minori distorsioni allocative.
b) Le economie, o diseconomie, esterne all’impresasono in larga misura connesse con le infrastrutture.Assumono rilievo speciale, fra le infrastrutture fisiche, stra-de, ferrovie, porti, aeroporti; fra le reti, energia, acquedot-ti, telecomunicazioni; fra le infrastrutture immateriali, istru-zione e sanità, ma anche il quadro giuridico che diretta-mente presiede all’operare dell’impresa. Particolarmentecarenti al Sud, le infrastrutture materiali – che è moltocostoso manutenere e ammodernare – dai primi anniNovanta non sono state rafforzate. Non hanno corrispo-sto alle esigenze crescenti dell’economia. Sono inferioriper quantità/qualità a quelle di altri paesi europei.
Anche l’ordinamento giuridico dell’economia si è dimo-strato sempre meno acconcio, nelle norme e nella loroapplicazione. Urgono riforme giuridiche che in coerenzacon il diritto societario vigente dall’inizio del 2004 valoriz-zino l’imprenditorialità, semplifichino gli adempimenti,amplino la gamma delle soluzioni organizzative e favori-scano la dinamica delle dimensioni aziendali. Deve confi-gurarsi un nuovo ordinamento dell’economia nella dire-zione di “una economia di mercato con regole”: coerentecon i dettami comunitari, ma capace di corrispondere alleesigenze specifiche del sistema economico italiano.Vanno assicurate le coerenze, valorizzate le potenzialisinergie positive, fra le principali componenti del “dirittodell’impresa”: commerciale, societario, fallimentare, dellavoro, della concorrenza, del processo civile, di cognizio-ne e soprattutto esecutivo. Occorre vincere le resistenzedegli interessi costituiti, corporativi, settoriali, di fronte ariforme che di per sé non costano e configurano rilevan-ti benefici generali. La dimensione giuridico-istituzionaleinfluisce notevolmente e pur essa, come la finanza pubbli-ca, per più vie – accumulazione di capitale, migliore utiliz-zo delle risorse, certezza dei contratti, riallocazione deirischi – sulla crescita dell’economia.
c) La frammentazione del sistema delle imprese e l’inca-pacità della piccola impresa di accrescere la propria
5
GLO
BA
LC
OM
PE
TIT
ION
7 -
20
06
‹ Capitalismo e sviluppo ›
Tabella 1- Analisi del 1961-2005 - Reddito
PIL PIL pro PIL per Produttivitàcapite unità di totale
lavoro dei fattori standard
1961-1970 5,5 4,8 5,4 4,4
1971-1980 3,8 3,3 2,8 1,7
1981-1990 2,4 2,4 1,8 0,8
1991-2000 1,6 1,5 1,6 1,0
2001-2005 0,6 0,1 0,0 -0,5
Fonte: elaborazione banca d’Italia su dati Istat, Prometeia,Commissione europea
6
‹ Capitalismo e sviluppo ›G
LO
BA
LC
OM
PE
TIT
ION
7 -
20
06
dimensione si sono accentuate. Ricchezza accumulatanegli anni, volontà di conservare il controllo in seno allafamiglia del proprietario-imprenditore, ragioni giuridiche,burocratiche, fiscali inducono l’impresa italiana a restarepiccola. Ciò ha coinciso con l’era della tecnologia digita-le, della cosiddetta ICT, dell’elettronica. La condizione dipiccole entità che non crescono, tipica delle imprese ita-liane, lungi dall’essere imposta dal modello di specializza-zione, congela quel modello, restringe l’investimento all’e-stero, limita le esportazioni. Ne risultano impedimenti allaformazione dei lavoratori, alla spesa per ricerca, al pro-gresso tecnico, alla produttività. Nel rapporto fra il pulvi-scolo delle aziende in miniatura – 4 addetti in media – ele poche corporations che rimangono, sono carenti lacomplementarità nella ricerca e l’osmosi nell’applicazionedelle innovazioni. In assenza di una leadership nella tec-nologia e nella posizione di mercato da parte delle gran-di imprese, anche le piccole e medieaziende sono in difficoltà. Manca loroun punto di riferimento, sia come for-nitori sia come produttori, per nicchiedi mercato considerate antieconomi-che dalle grandi imprese.
Tre elementi concomitanti identifica-no un'impresa moderna: dimensionecorrelata alla tecnologia e al mercatopotenziale, governance, gestione delrischio. Le banche devono averli pre-senti. Le banche, per la propria speci-fica e naturale funzione nell’econo-mia, sono chiamate a scegliere gli affi-dati anche sulla base delle prospettivedi crescita delle aziende nel medio-lungo periodo, attraverso fusioni eacquisizioni o attraverso aumento della capacità produtti-va. Dal realizzarsi di questa prospettiva dipende in ultimaanalisi lo sviluppo reddituale di lungo periodo delle ban-che medesime. Tra le 1.300 aziende italiane con più di500 addetti non mancano quelle con effettive potenzia-lità di crescita. Spetta alle banche selezionarle e sostener-le, con i finanziamenti e con la consulenza, nella separa-tezza in materia di partecipazioni di controllo.
d) La possibilità di aumentare l’efficienza, statica e dinami-ca, del sistema produttivo italiano è infine affidata a unaconcorrenza più intensa, a più forti pressioni sui produttori.
Nonostante l’apertura verso l’estero, all’interno dell’eco-nomia italiana le sollecitazioni concorrenziali – nella loropiù vasta accezione – sono complessivamente diminuite.Sono diminuite a livello tanto di macrodeterminanti (cam-bio lasco, salario reale moderato, spesa pubblica larga),quanto di microdeterminanti (nei mercati dei prodotti enei mercati della proprietà e del controllo delle imprese).
Nei pochi casi in cui la concorrenza è aumentata – comenel settore bancario e finanziario, dove in passato eramolto bassa – i risultati positivi si sono avuti2.
Nei mercati delle merci gli indici del grado di oligopolio(indici di Lerner) in media sono saliti di circa un quartorispetto agli anni Settanta e Ottanta. Il calo della concor-renza è concentrato nei servizi (il cui peso, escludendoquelli finanziari e assicurativi, è salito dal 61 al 65 percento del PIL dopo il 1993). Nei mercati della proprietà edel controllo dell’impresa la contendibilità degli assetti esi-stenti è attutita dall’alta frequenza con cui il primo proprie-tario detiene quote di maggioranza nelle aziende, in par-ticolare al diminuire della loro dimensione.
La promozione della concorrenza deve mirare ai minimicosti e ai minimi prezzi, per data struttura dell’economia.Deve anche, forse soprattutto, mirare alla rimozione degliostacoli che frenano la riallocazione dinamica dei fattori
produttivi, il rilascio delle risorse di capi-tale e di lavoro dalle produzioni, impre-se, settori che sono divenuti inefficientiverso quelli in prospettiva più redditizi.
L’azione del primo tipo deve principal-mente orientarsi alle forme di mercato eai comportamenti dei produttori. Devecontrastare posizioni dominanti, abusodi esse, intese anti-acquirenti. Nella legi-slazione antitrust del 1990 questadimensione è contemplata. I modi spe-cifici e i mezzi per questo tipo di azioneantitrust dovrebbero essere potenziati.Informazione, comunicazione, cono-scenza sono i pilastri su cui si costruiscequesto aspetto della concorrenza. Ilconsumatore deve poter compiere le
sue scelte sulla base delle informazioni strettamente rile-vanti. Dal lato dell’offerta è indispensabile un giusto equi-librio fra asimmetria informativa, indispensabile per incen-tivare la crescita, e corretta informazione sui costi. Non vipuò essere dirigismo nella fissazione dei prezzi, ma vatutelata la rendita del consumatore nei confronti di aggres-sive politiche di prezzo non giustificate da miglioramentiqualitativi.
Carente, nell’antitrust italiano, nei suoi stessi principifondanti e quindi nell’azione, è la dimensione dinamicadella concorrenza: la cura per i presupposti della rapidaed efficace riallocazione delle risorse, attraverso la tenden-za al livellamento dei tassi di profitto fra prodotti, imprese,settori. È su questo fronte che occorre soprattutto agire,minando ogni forma di difesa del capitale “vecchio”rispetto al “nuovo”: monopoli, sussidi pubblici, collusionifra capitale e lavoro, norme giuridiche, opportunismi, irre-sponsabilità. Al di là degli economicismi, il valore dellaconcorrenza così intesa allude in ultima analisi a un
2 P. Ciocca, La nuova finanza in Italia. Una difficile metamorfosi (1980-2000), Bollati Boringhieri, Torino, 2000, cap. 6.
“Le diseconomie esterne all’im-presa sono in larga misuraconnesse con le infrastrutture.Assumono rilievo speciale, frale infrastrutture fisiche, strade,ferrovie, porti, aeroporti; fra lereti, energia, acquedotti, tele-comunicazioni; fra le infra-strutture immateriali, istruzio-ne e sanità, ma anche il qua-dro giuridico che direttamentepresiede all’operare dell’impresa.”
7
GLO
BA
LC
OM
PE
TIT
ION
7 -
20
06
‹ Capitalismo e sviluppo ›
mondo di produttori che facciano conto in primo luogosu se stessi, con assunzione diretta di responsabilità.
Concorrenza e paradigmi allocativi
È su quest’ultimo aspetto che concentreremo l’attenzionenelle pagine che seguono. Decisivi nella vicenda di ognieconomia sono l’intensità e i modi con cui la concorren-za e le forze ad essa assimilabili hanno stimolato, discipli-nato, controllato i produttori. La concorrenza può mani-festarsi nei mercati dei beni e dei servizi offerti. Può altre-sì riguardare la proprietà e il controllo delle imprese. Lesue determinanti, settore per settore e nell’intero sistemaproduttivo, sono di natura micro e macro-economica. Leprime qualificano le forme di mercato, variamente situatefra la competizione pura e perfetta, a un estremo, e ilmonopolio all’altro estremo: numerodei produttori, libertà d’entrata, omoge-neità del prodotto, innovazione e suodiffondersi, rivalità o collusione fra i pro-duttori, informazione di cui il mercatodispone. Le seconde qualificano il con-testo più generale in cui i produttori,nell’insieme dei settori e dei mercati,sono attivi: grado di apertura dell’eco-nomia, regime e gestione dei cambicon l’estero, sostegni dello Stato alleimprese, dimensione e struttura dellaspesa e delle entrate pubbliche, quadrogiuridico, relazioni industriali.
Nella storia economica Italiana leforme di mercato e più in generale lepressioni competitive sui produttori si sono configurate ehanno agito in varia guisa nel volgere del tempo. Il gradomedio di concorrenza nell’intera economia ha avutoandamenti di segno opposto. Onde pluridecennali e illoro riflusso nelle sollecitazioni competitive hanno influitoin modo determinante, con segno alterno, sull’innovazio-ne e sulla produttività. Possono distinguersi alcune gran-di fasi, sebbene dai contorni sfumati.
Nonostante una maglia relativamente fitta di fiere emercati, nell’Ottocento l’economia restò a lungo fraziona-ta in occasioni organizzate di scambio locali, discontinue,non sempre accessibili, con limitata mobilità di merci e fat-tori produttivi. Tuttavia, sia la flessibilità di prezzi e costi siala competizione nell’offerta – di beni, se non di servizi –erano favorite da fattori strutturali già evocati: l’economiaaperta e price-taker nei mercati internazionali, l’abbon-danza di forza-lavoro, la modesta dimensione media delleimprese, il basso grado di concentrazione. Trovarono par-ziali ostacoli nel “colbertismo” dell’Italia francese, prima,della maggioranza degli Stati pre-unitari, poi. Col Regnod’Italia, sotto i governi della Destra storica fino al 1876,anche questi impedimenti vennero in larga misura rimos-
si, favorendo la concorrenza. Il quadro mutò nella direzione di minori pressioni sui
produttori nell’ultimo quarto dell’Ottocento, dopo la vitto-ria politica della Sinistra storica. Nonostante l’opposizionedella migliore cultura economica liberista, protezionismo,collusione fra Stato e maggiori imprese, cedimenti deltasso di cambio, repressione anche violenta delle rivendi-cazioni contadine e operaie concorsero a determinare ilmoto anticoncorrenziale. Esso lascerà sedimenti perma-nenti nel modus operandi del sistema economico.
L’età giolittiana registrò una tendenza almeno parzial-mente opposta, con l’intensificarsi di sollecitazioni insenso lato competitive. All’attenuarsi o al venir meno dellespinte anticoncorrenziali che erano emerse nell’età dellaSinistra si unì un’azione decisa dello Stato contro le posi-zioni dominanti in settori cruciali dell’economia. Sebbene
questa azione non fosse sempre coro-nata da successo, la pressione sui pro-duttori a ricercare il profitto rischiandoe innovando si fece più intensa.
Nel prosieguo del Novecento, inspecie durante la prima guerra mon-diale e nel periodo fascista, la concor-renza è stata su più fronti contrastata,limitata.Nell’attenuare presso le imprese laspinta alla produttività, al progressotecnico, all’innovazione e al suodiffondersi, il favor per aziende o set-tori insito nella spesa pubblica e nellatassazione, il ricorso a dazi e contin-genti, la debolezza dei sindacati si
sono uniti alla concentrazione e alle intese fra produttoriin settori industriali, alla commistione tra banca e indu-stria, dal 1936 alla debolezza del cambio.L’appannamento della concorrenza è avvenuto sia neimercati dei prodotti sia in quelli della proprietà e del con-trollo delle imprese. Vi hanno concorso la struttura indivi-duale o familiare dell’impresa piccolo-media, alcuni istitutie usi giuridici ovvero l’assenza di altri, il rapporto con lafinanza, la scarsa disponibilità di capitale proprio, la ritro-sia a quotarsi in Borsa.
Così come nella prima, anche nella seconda metà delNovecento la tendenza di fondo verso un più basso gradodi concorrenza ha visto una fase – sino ai primi anniSessanta – in cui le forze e le sollecitazioni competitive sisono accentuate, seguita da una più lunga fase in cui essesi sono attenuate. Quest’ultima fase è tuttora in atto, sebbe-ne nel 1990 sia stata introdotta una legislazione antitrust.
Al tempo stesso nell’economia italiana, nei due secoli,sono stati sperimentati vari paradigmi allocativi. Sono sca-turiti dal mutevole combinarsi di istituzioni, norme, formedi mercato, strutture economiche, rapporti fra Stato eMercato. Il loro succedersi è strettamente connesso,
“La frammentazione del siste-ma delle imprese e l’incapacitàdella piccola impresa di accre-scere la propria dimensione sisono accentuate. Ricchezzaaccumulata negli anni,volontà di conservare il con-trollo in seno alla famiglia delproprietario-imprenditore,ragioni giuridiche, burocrati-che, fiscali inducono l’impresaitaliana a restare piccola.”
8
‹ Capitalismo e sviluppo ›G
LO
BA
LC
OM
PE
TIT
ION
7 -
20
06
ancorché non coincidente, con le già richiamate oscilla-zioni nel grado medio di concorrenza e più in generalenell’intensità delle spinte all’efficienza, alla dinamicadimensionale, all’innovazione, esercitate sui produttori.Interessi, ideologie, rapporti internazionali hanno fatto sìche si avvicendassero più criteri a cui il modus operandidel sistema economico è stato chiamato a ispirarsi. Si può,schematizzando, delineare una sequenza:
- dirigismo e protezionismo pre-unitari (pre-Cavour inPiemonte), limitativi della concorrenza;
- laisser faire, con poche regole, liberismo commerciale,concorrenza accentuata nell’età della Destra (1861-76);
- protezionismo, collusione pubblico/privato, repressio-ne del movimento dei lavoratori, attenuarsi delle sollecita-zioni competitive con la Sinistra, sino alla crisi politico-sociale di fine Ottocento;
- più Stato (politica economica) ma al tempo stesso piùMercato e concorrenza (impresa in dialettica col sindaca-to dei lavoratori, governo neutrale rispetto alle parti socia-li, azione anti-monopoli) nell’età giolittiana;
- salario ridotto a variabile strumentale, economia chiusa,connivenza corporativa fra Stato, grande impresa e ban-che, cartelli e concentrazioni nell’industria, concorrenzaridotta al minimo nel periodo tra le due guerre;
- economia aperta e “mista”, con larga presenza dell’im-presa pubblica anche in competizione con l’impresa priva-ta, dal dopoguerra ai primi anni Sessanta;
- conati di programmazione, sindacati aggressivi, impre-se sostenute dallo Stato, concorrenza meno spinta sino aiprimi anni Novanta;
- verso una economia di mercato con regole, privatizza-zioni, politiche dei redditi consensuali nel periodo piùrecente.
Concorrenza e crescita: l’età giolittiana e il“miracolo economico”
L’età di Giolitti – 1900-1913 – segnò una svolta rispettoa quella di Depretis e soprattutto di Crispi. Pressioni com-petitive e stimoli alla ricerca di produttività e innovazioneper i produttori nazionali scaturirono da tre fonti macroe-conomiche: la tenuta del cambio, la minor protezionedoganale, la neutralità dello Stato di fronte alla dialetticaprofitto-salario.
Il tasso di cambio nominale effettivo della lira si eradeprezzato, in precedenza, a più riprese: da ultimo, nel1889-94, del 10 per cento. Tra il 1902 e il 1913 il cambiorestò sostanzialmente invariato, su valori medi dell’8 percento, più elevati di quelli del quinquennio 1897-1901.Venne meno la cedevolezza della valuta, che avrebbeattenuato la pressione sulle imprese produttrici di benicommerciabili internazionalmente ad aumentare la pro-duttività, contenere costi e prezzi, investire. “La lira faaggio sull’oro” fu lo slogan del momento. Nel medesimotempo la competitività di prezzo – il cambio “reale” della
lira – non subì variazioni significative.In un quadro di crescente apertura dell’economia agli
scambi con l’estero, tra il 1897 e il 1913 il rapporto fra leentrate doganali e il valore delle importazioni scese netta-mente, dal 19 al 10 per cento. Il minor grado di protezio-ne scaturì principalmente dalla riduzione delle tariffe uni-tarie. Concorsero gli aumenti dei prezzi internazionali inpresenza di dazi specifici riferiti alle quantità importate,mentre i mutamenti di composizione dell’interscambioagirono in senso contrario.
Le relazioni conflittuali tra capitale e lavoro per la primavolta non videro lo Stato e le forze dell’ordine schierarsicon i datori di lavoro. Le richieste di aumenti di salario epiù in generale di miglioramenti nella condizione dei lavo-ratori vennero sostenute dalle organizzazioni sindacali,dai partiti non governativi, da scioperi molto più frequen-ti e sistematici. Entro il limite del mantenimento dell’ordi-ne pubblico e della libertà di lavoro, nonostante gli inci-denti anche gravi che ebbero luogo, lo Stato non presepartito né per i capitalisti né per i lavoratori. L’offerta dimanodopera era contenuta dalla massiccia emigrazione,la domanda alimentata dalla dinamica dell’economia. Allamaniera di uno stimolo concorrenziale esercitato dal latodei costi, il rialzo dei salari reali sollecitò nelle imprese laricerca della produttività mentre era a propria volta daquest’ultima giustificato. La profittabilità, corrente e attesa,giustificò e sostenne l’intensificarsi dell’accumulazione dicapitale. La dinamica dei salari reali non debordò rispettoa quella della produttività del lavoro.
Ma la concorrenza venne su più d’un fronte favorita, oquanto meno non più contrastata, anche sul pianomicroeconomico. Giolitti ereditò il sistema che si era con-solidato nei periodi di Depretis e Crispi, nel quale era dive-nuto decisivo l’intervento dello Stato con protezionismo,commesse, premi, così come era divenuto stretto il con-nubio tra banca e industria. E tuttavia ai monopoli privatida lui giudicati istituzioni illiberali, egli oppose la forzadello Stato, in alcuni casi la soluzione del monopolio pub-blico, ovvero quella della contendibilità da parte di altrigruppi privati. Vi riuscì con le ferrovie e con la telefonia,nazionalizzate nel 1905 e nel 1907; vi riuscì nel 1912 conla fondazione dell’INA e con l’esclusiva di Stato delle assi-curazioni sulla vita, sebbene rinviata nell’attuazione; nonriuscì, nel 1909, a opporre con successo un altro gruppo– il gruppo Piaggio – e il metodo della pubblica asta allaSocietà di navigazione generale, alla Comit e a giornalicome “Il Corriere della Sera” e “La Tribuna” che ne difen-devano gli interessi sulla questione dei servizi marittimi;contrastò la speculazione edilizia sulle aree fabbricabili.Treni, telefoni, assicurazioni e trasporti marittimi nell’insie-me funzionarono meglio, essendo i produttori privati epubblici in varia guisa sollecitati all’efficienza.
Giolitti non nutrì mai soverchie simpatie per il latifondo.Mantenne, è vero, a 7,5 lire per quintale il dazio sulgrano. Lo fece per la ragion politica di non intaccare “la
9
GLO
BA
LC
OM
PE
TIT
ION
7 -
20
06
‹ Capitalismo e sviluppo ›
principale base economica della deputazione parlamen-tare meridionale”, sostenitrice dei suoi governi. E tutta-via tra il 1900 e il 1913 le importazioni di grano crebbe-ro, dell’80 per cento in quantità. Il prezzo, attestato sulle18 lire dal 1899 al 1908, salì a 21-22 lire negli anni suc-cessivi. Tra il 1897 e il 1913 la protezione nominale sulgrano diminuì dal 40 al 33-35 per cento. Nell’interocomparto dei prodotti primari la protezione nominale(ponderata con la struttura corrente del commercio)scese dal 22 al 10 per cento (pressoché interamenteattraverso tagli di tariffe), ben più di quella relativa aimanufatti (dal 13 al 9) e ai semimanufatti (dal 10 all’8).Ricardianamente, ne fu favorita la crescita.
Nel 1900-1913 l’espansione economica dell’Italia siinscrisse in quella dell’economia mondiale, da cuidesunse sostegno. E tuttavia rispetto al 1887-1900 l’ac-celerazione italiana fu notevole anche nel confronto conl’andamento dell’economia mondiale. Si trattò di una“primavera economica” dell’Italia, che andò ben al di làdella belle époque che l’intero mondo sviluppato venivasperimentando. Il tasso di crescita del PIL italiano balzòdallo 0,9 al 2,6 per cento l’anno, quello del PIL mondia-le salì alquanto, dall’1,9 al 2,6 per cento. Nel confrontocon l’età di Crispi e della crisi di fine secolo l’accelerazio-ne appare ancor più netta in termini di prodotto procapite, il cui ritmo di sviluppo si innalzò dallo 0,3 all’1,9per cento l’anno. Nello stesso periodo 1900-1913 la cre-scita del reddito pro capite mondiale fu dell’1,6 percento, rispetto all’1,2 del 1887-1900.
Un balzo di mezzo secolo collega l’accelerazione gio-littiana con quella, ancor più intensa, che l’economiavisse nel 1951-63.
Il miracolo post bellico è certo da collegare ad alcunecondizioni iniziali: ricostruzione; disinflazione del 1947;apertura verso l’estero; favor per l’industrializzazione.Dipese altresì da alcuni fattori macroeconomici, attivi nel1951-63: investimenti; innovazioni; caratteristiche deiproduttori; integrazione in un’economia europea emondiale in progresso; stabilità complessiva3.Tuttavia la spinta fondamentale che avviò e alimentò inquegli anni il meccanismo di sviluppo economicodell’Italia – così come era avvenuto al tempo di Giolitti –provenne dalla concorrenza, e più in generale dalla pro-pensione a innovare che una congerie di forze richieseai produttori italiani.Prima di elencare queste forze, va sottolineato che la sol-lecitazione – la “minaccia” sui produttori (Pantaleoni) –fu particolarmente avvertita in un sistema di imprese chedalla fine dell’età giolittiana – con la prima guerra, conil fascismo dopo de’ Stefani, con la seconda guerra –avevano per oltre un trentennio agito in un contestomolto poco concorrenziale. In particolare vale ribadire
che negli anni Trenta il paradigma allocativo prevalentenell’economia italiana era stato contrassegnato da chiu-sura internazionale; salario ridotto a variabile strumenta-le; acquiescenza sindacale; concentrazione finanziaria,cartelli, intese, abuso di posizioni dominanti; spesa pub-blica ampia e disponibile; collusione fra Stato e Mercato;socializzazione delle perdite e privatizzazione dei profitti.Mai come in quegli anni il capitalismo italiano avevagoduto – e mai più avrebbe in seguito goduto – di unasiffatta garanzia, implicita ma anche esplicita, di fronte alrischio d’impresa da parte della politica, delle pubblicheamministrazioni, delle istituzioni.
Questo quadro cambia negli anni Cinquanta, su piùdi un fronte. Concorrenza e spinta all’efficienza e all’in-novazione si sprigionano con forza inusitata nei mercatidei prodotti e dei fattori. Le pressioni a cui i produttorivengono sottoposti si estendono ai mercati, ufficiali einformali, della proprietà e del controllo delle imprese.
La principale rottura col passato non concorrenziale èda ravvisare nella riapertura dell’economia agli scambiinternazionali. Contingenti e dazi protettivi vengonoridotti, sia pure in varia misura e in tempi diversi. Il capi-tale straniero torna a investire in Italia. Il cambio è fisso,percepito come tale. La sollecitazione più vistosa e per-cepibile rivolta agli animal spirits degli imprenditori italia-ni, non solo nei settori produttivi di beni commerciabiliinternazionalmente, scaturisce dalla prospettiva delMercato comune in Europa. La firma del Trattato diRoma nel marzo del 1957 rende irreversibile l’aperturaverso l’estero. Annulla ogni velleità di ritorno al protezio-nismo da parte dei produttori di beni commerciabiliinternazionalmente.
Se il salario è frenato nella sua dinamica da un ecces-so strutturale di manodopera, movimento dei lavoratorie sindacati tornano a essere attivi, ideologicamentemotivati. Trovano sostegno in forti partiti politici, diopposizione ma anche di governo. I partiti – compresoil principale partito moderato, perno dei governi di coa-lizione – sono disponibili alle istanze delle classi lavoratri-ci. Lo sono anche perché portatori di una cultura invaria guisa e in varia misura critica del capitalismo, quan-to meno conscia dei suoi limiti ed eccessi. La dialetticafra capitale e lavoro, che il fascismo aveva spento, tornaa configurarsi, almeno potenzialmente, come conflittua-le. Ciò avviene sebbene per tutti gli anni Cinquanta lasinistra politica e sindacale venga repressa nelle fabbri-che con metodi anche antidemocratici e i suoi aderentisiano nel paese sistematicamente esclusi dai gangli dellapubblica amministrazione. Una conflittualità allo statolatente e potenziale, piuttosto che apertamente e dura-mente manifesta, esercita un effetto di sollecitazione e didisciplina sulle imprese senza minare le loro aspettative
3 P. Ciocca, L’instabilità dell’economia. Prospettive di analisi storica, Einaudi, Torino, 1987, e G. Nardozzi, Miracolo e declino. L’Italia tra concorrenzae protezione, Laterza, Bari, 2004.
10
‹ Capitalismo e sviluppo ›G
LO
BA
LC
OM
PE
TIT
ION
7 -
20
06
di profitto nel lungo periodo.L’ordinamento giuridico manca di dotarsi di una legisla-zione e di un apparato a tutela e promozione delle formedi mercato concorrenziali. Tuttavia, prima e indipendente-mente dall’indagine parlamentare sulla concorrenza varifattori interagirono nel configurare un contesto più com-petitivo: l’avversione ai monopoli, il favor per la piccolaimpresa e per le sue rappresentanze, l’articolazionedimensionale, istituzionale e territoriale del sistema banca-rio. L’ultimo aspetto è di particolare rilievo. La separatezzafra “banca” e “industria” diviene il presupposto di una rela-zione di tipo nuovo, dialettica e concorrenziale, fra richie-sta e offerta di credito. Le banche – anche perché pubbli-che in una misura pari al 70 per cento dell’attivo di bilan-cio dell’intero settore bancario – solo in rari casi sono sog-gette all’influenza di imprese non finanziarie, e viceversa.La commistione fra banca e industria aveva fino ad alloraesaltato sia i connotati di inefficienza sia il potenziale diinstabilità di un sistema economico che fra la prima e laseconda guerra mondiale si era fortemente connotatocome oligopolistico. Nel nuovo contesto, presidiato dallalegge bancaria del 1936, la disciplina esercitata da ban-che indipendenti anche sulle imprese di maggiore dimen-sione agisce nel senso di comprimere i costi e i rapportiprezzi-costi, stimola le imprese alla ricerca della produtti-vità e del progresso tecnico. Alla concorrenza nell’econo-mia “reale”, attraverso l’articolazione e l’autonomia delsistema bancario spinte sino alla protezione delle banchemeno efficienti, la Banca d'Italia del governatoreMenichella arriva a sacrificare, in una certa misura e con-sapevolmente, la concorrenza e l’efficienza all’internodello stesso sistema bancario.
Non solo nel sistema bancario, l’impresa a controllopubblico viene vista, oltre che come sostituto della priva-ta là dove questa si era dimostrata incapace di produrre edi rischiare, come un agente antimonopolistico nei setto-ri in cui coesiste con l’impresa privata. L’impresa pubblicaè affidata a tecnici che – almeno fino al radicarsi nelMinistero delle partecipazioni statali (istituito nel 1956)delle istanze politiche e programmatorie – la governanocon margini di autonomia anche più ampi di quelli di unapublic company. La concorrenza dell’impresa pubblicaappare particolarmente temibile agli occhi dei produttoriprivati operanti nelle stesse industrie presenti negli stessimercati.
Le forme di mercato divengono più concorrenzialianche indipendentemente dal ruolo dell’impresa pubbli-ca. Per le imprese private le barriere all’entrata si attenua-no, in ragione dello stesso minor rilievo della quantità dicapitale rispetto ad altri fattori qualitativi fra le determinan-ti della produzione e della produttività. Il grado di concen-trazione, industriale e finanziaria, si riduce. Sono più fre-quenti i casi di imprese dinamiche che dalla piccoladimensione assurgono alla media e alla grande scala pro-duttiva, anche in competizione con i maggiori gruppi.
Nella demografia d’impresa il tasso di natalità si accresce,in assoluto e rispetto a quello di mortalità.
Una conferma delle pressioni sui profitti che scaturironodall’insieme di questi sviluppi è offerta dal profilo e dallivello dei rapporti fra prezzi da un lato, costi medi e costimarginali di produzione dall’altro. Nell’intera economia ilrapporto tra prezzo e costo medio crollò da valori compre-si fra 2 e 1,3 nel 1938-49 a valori compresi fra 1,2 e 1,1nel 1950-63. Livelli più bassi si registreranno (fino al 1990)soltanto dopo i primi anni Ottanta. La compressione deimargini di profitto fu anche il riflesso di un attenuarsi delpotere di mercato delle imprese. Il rapporto fra prezzo ecosto marginale similmente crollò da valori compresi fra1,75 e 1,65 nel 1938-49 a valori compresi fra 1,65 e 1,60nel 1950-63. Di nuovo, livelli più bassi – lievemente infe-riori a 1,60 – si registreranno (sempre fino al 1990) solonel breve periodo 1964-66.
In un ambiente divenuto per molteplici vie maggior-mente competitivo i profitti non erano più ex ante assicu-rati come era avvenuto nel periodo fascista. Questo radi-cale mutamento non contrasta, è coerente, con il fattoche la crescita della produttività del lavoro – consentitaprincipalmente da accumulazione di capitale, economiedi scala, progresso tecnico – risultasse, ex post, superiorea quella dei salari reali. Va sottolineato che le pressionicompetitive non si espressero soltanto attraverso i prezzi,ma anche attraverso l’accumulazione di capitale, il pro-gresso tecnico, la diffusione delle innovazioni.Espandendosi rapidamente l’economia, il volume dei pro-fitti aumentava.
Dal 1951 al 1963 la società italiana realizzò la piùprofonda trasformazione della sua storia, non solo econo-mica, in età contemporanea. Il ritmo di sviluppo annualesi situa sui massimi storici: 5,8 per cento il PIL e ben 5,1per cento il PIL pro capite, avendo la popolazione conti-nuato ad aumentare al tasso medio dello 0,7 per cento.Anno per anno non solo non vi furono contrazioni, mafino al 1964 la progressione dell’attività economica nonscese al disotto del 4,5 per cento (1956), con punte del 7per cento e oltre. Il progresso del reddito pro capite èscomponibile per 4/5 in aumento della produttività dellavoro (4,6 per cento l’anno) e solo per meno di 1/5 in unpiù alto tasso di occupazione (rapporto fra occupati epopolazione in età di lavoro, fra i 15 e i 64 anni).
L’avanzamento della produttività del lavoro si estese atutti i grandi comparti del settore privato dell’economia.Fu soprattutto rapido nella manifattura (6,1 per centol’anno) e nell’agricoltura (5,3 per cento, grazie allacopiosa uscita di lavoratori “eccedenti”), non irrilevantenell’edilizia (3,6 per cento) e nel terziario (3,3 per cento).La produttività, invece, ristagnò nelle pubbliche ammini-strazioni, dove il numero dei dipendenti passò da 1,8 a2,4 milioni.
Alla base della crescita della produttività è da porre,nella manifattura ma non solo, l’intensificata accumulazio-
ne di capitale, primario veicolo di progresso tecnico. Ilrapporto fra investimenti fissi e PIL (a prezzi costanti) salì inciascun anno, senza soluzione di continuità, dal 16 percento del 1951 al 28 per cento del 1963, il livello più altodall’Unità a oggi.
Una conclusione
Quello dello sviluppo, o della crescita, resta il più miste-rioso e complesso dei fenomeni economici. L’analisi, teo-rica ed empirica, è in grado di identificare le variabili chevi concorrono, di decomporre, ex post, il loro contributorispettivo. E tuttavia le determinanti ultime, la “causa dellecause”, anche sul piano storico tendono a sfuggire, comeè spesso il caso di fronte a eventi, sì economici, ma intrisidi interrelazioni con i molteplici profili non economici delsociale.
In una economia di mercato le imprese e i loro dirigen-ti sono il luogo cruciale, oltre che dell’accumulazione dicapitale, dell’avanzamento di produttività, del progressotecnico, dell’innovazione, con cui la crescita modernasoprattutto si identifica. La capacità dei produttori è…quella che è, in ogni momento, storicamente determina-ta. Decisivo è il contesto, da cui scaturisce l’insieme degliincentivi che inducono i produttori a investire, cercare l’ef-ficienza, innovare. L’aspettativa – la ragionevole probabi-lità – di ottenere profitto è la condizione senza la quale ilmeccanismo dello sviluppo non si avvia. Soddisfatta que-sta condizione, sono essenziali le sollecitazioni competiti-ve a produrre di più e meglio.
Queste sollecitazioni sono particolarmente preziose inun contesto come quello italiano, la cui economia haattraversato lunghe fasi – Sinistra storica (1876-1900),guerre e fascismo (1915-1945), tempi più recenti – in cuigli elementi oligopolistici, problematici, collusivi hannoassunto notevole rilievo. Le fasi in cui hanno prevalsoimpulsi di segno opposto, positivi, sono – come abbiamointeso rapidamente ricordare – quelle in cui la performan-ce di crescita dell’economia italiana è stata nettamentesuperiore, formidabile.
I produttori italiani vivono da sempre, storicamente estrutturalmente, uno svantaggio nelle risorse primarie delterritorio e nelle fonti d’energia che essi stessi non menodei loro governanti sono chiamati a compensare. Occorreun’azione, una pressione continua, contro monopoli,moral hazard, collusioni, apparenti scorciatoie. Occorreanche contrastare la ricorrente, diffusa, provinciale pre-sunzione di aver raggiunto nazioni più dotate di risorse,di aver definitivamente risolto il problema economico, diessere ormai – gli italiani – “ricchi per sempre”. È crucialeche i produttori non deviino dalla via obbligata: la ricercaincessante di innovazione, qualità, aggiunta di valore agliinputs importati, capacità di esportare.
La storia non impartisce lezioni. Consente di… inventareerrori sempre nuovi. Sufficiente evidenza si è accumulata,ed è disponibile, per evitare di ripetere l’errore – più voltecommesso in un passato anche recente – di sottrarre i pro-duttori italiani alla concorrenza. Il problema economico ita-liano non risiede nella capacità dei produttori di progredi-re, bensì nell’attivare stimoli che li inducano a farlo.
11
GLO
BA
LC
OM
PE
TIT
ION
7 -
20
06
‹ Capitalismo e sviluppo ›
12
GLO
BA
LC
OM
PE
TIT
ION
7 -
20
06
‹ Capitalismo e sviluppo ›
Èopinione diffusa che l’Italia soffra di un problema dicrescita la cui soluzione può essere trovata solo
affrontando i nodi strutturali e fra questi la carenza diinnovazione, la mancanza di infrastrutture materiali edimmateriali, la revisione del ruolo dello Stato nell’econo-mia e la crescita dimensionale delle imprese italiane1.
Finita la rincorsa per entrare nel primo gruppo dei paesipartecipanti all’UEM e osservato il progressivo rallenta-mento registrato dal tasso di cresci-ta del prodotto interno lordo, è ini-ziato il dibattito sulle cause delristagno.
Venuti meno i luoghi comunisulle difficoltà di crescita dell’eco-nomia (costo del lavoro, costo delcapitale, attese inflazionistiche,incertezza sull’andamento del cam-bio, eccessivo disavanzo pubblico,elevato rapporto debito/Pil, ecc.) siè costatato, finalmente, che moltedi esse erano solo strumentali enon andavano alle radici dellenostre difficoltà strutturali.
Si è data attuazione all’UEM el’euro è subentrato alla lira comemoneta legale, ma non meno
importante è stata la privatizzazione del sistema bancario,la sua concentrazione nonché il prudente ritorno allabanca universale e la crescente importanza dei mercatiesteri come veicoli legali di allocazione del risparmio.
Altri cambiamenti sono stati imposti dal Trattato diMaastricht e dall’UE: la riduzione del disavanzo pubblico,specie della spesa per interessi, la riduzione del debitopubblico accompagnata dalla fine dell’economia mista e
dalla privatizzazione delle impresepubbliche privatizzabili.
A cavallo fra aspetti finanziari ereali vi sono state: la liberalizzazio-ne del mercato degli affitti, le suc-cessive leggi di riforma del sistemapensionistico e del mercato dellavoro, la fine del controllo deiprezzi, l’istituzione di autorità atutela della concorrenza e del cor-retto funzionamento dei mercati.
Effetti di queste riforme istituzio-nali sono stati: la stabilità dei prez-zi, la fine del dumping valutariocon i suoi effetti negativi sull'effi-cienza industriale, la maggioreofferta di servizi bancari e la cre-scente presenza delle banche d’af-fari estere. Nello stesso periodo sisono anche osservate delle situa-zioni negative come la lenta diffu-
CREARE NUOVI RAPPORTIFRA INDUSTRIA E FINANZA
L’Autore analizza il difficile rapporto in Italia tra capitale industriale e capitale finanziario
e si sofferma sulle debolezze del nostro capitalismo, dimostrate ancora una volta
dalle recenti esperienze di privatizzazione delle imprese pubbliche:
i grandi gruppi finanziari non sono stati in grado di acquisire il controllo
delle grandi imprese pubbliche senza l’aiuto essenziale del capitale di debito…
Il tema della crescita dimensionale delle imprese non può essere risolto senza una strategia
di ampio respiro, basata sull’informazione e la conoscenza, indispensabili per gestire
il rischio. Gli interventi di politica economica devono creare le condizioni
per superare le attuali carenze di produttività, infrastrutture, managerialità,
assistenza tecnica e finanzia nel processo di innovazione e nella crescita
della dimensione media dell’impresa.
GUIDO M. REY
È professore ordinario di economia politicapresso la Scuola Superiore S. Anna di Pisa. Èstato presidente dell’ISTAT e dell’AIPA. Nato aBologna l’8 dicembre 1936, si è laureato inEconomia e Commercio presso l’Universitàdegli Studi di Genova nel 1959. Nel 1968 haconseguito la libera docenza in politica econo-mica e finanziaria; nel 1995 l'Università degliStudi di Padova gli ha conferito la laurea hono-ris causa in Scienze Statistiche ed Economiche.
1 P. Ciocca, G. M. Rey, “Per la crescita dell’economia italiana”, in Economia italia- na, n. 2/ 2004.
sione delle TIC presso le imprese, il netto rallentamentonella dinamica della produttività, la lenta trasformazionedel nostro sistema industriale nonostante la pressionedelle economie emergenti nei mercati delle tradizionaliproduzioni italiane.
Questa introduzione può aiutarci a capire tre cause cherallentano la crescita dell'economia italiana: a) la correttavalutazione del tempo necessario perché riforme cosìprofonde possano modificare comportamenti ed istituzio-ni, b) se e quanto la crescita delle imprese sia condiziona-ta da fattori finanziari e monetari ed in particolare quantosia rilevante l’intermediazione fra risparmio ed investimen-to operata dalle banche oppure dai mercati finanziari, c) la più o meno consapevole resistenza al cambiamentoche permane nell’imprenditoria italiana ma anche nei sin-dacati ed in generale nel nostro sistema politico, econo-mico e sociale.
Un tema ricorrente: alla ricerca del capitalismoitaliano
L’economia italiana si caratterizza per il numero mode-sto di grandi gruppi industriali e soprattutto per la lorocontinua diminuzione. In compenso vi è una diffusa pre-senza di piccolissime, piccole, medie imprese e di lavora-tori autonomi. Non sempre queste scelte sono tali, a voltesi tratta di soluzioni di ripiego in assenza di alternativemigliori.
Il richiamo alla crisi industriale e bancaria degli anniVenti e Trenta e la riaffermazione del ruolo dello Stato pro-duttore nella Costituzione del 1948 suggeriscono unavisione del capitale privato debole di fronte agli eventiesogeni ma soprattutto dotato di fragili radici e pronto aricorrere all'intervento pubblico reclamando il ruolo socia-le dell'impresa. Sono solo pochi spunti che consentono diricordare gli anni dell'economia mista durante i quali loStato ha assegnato alle imprese pubbliche e a quelle apartecipazione statale il compito di investire nei settori adalta intensità di capitale, nei settori dell'industria di base enei settori ad elevata componente di rischio. In seguito,questa strategia ha cominciato ad offuscarsi e sono emer-si i punti deboli. La selezione dei managers pubblici nonsempre è stata attenta a valutazioni di professionalità, nonsempre l'azionista occulto ha favorito l'efficienza e l'inno-vazione né ha saputo resistere alla tentazione di piegarel'interesse dell'impresa ai propri interessi di bottega.
Il giudizio finale è ambiguo perché anche in questeimprese pubbliche, così come nelle private, si sono regi-strate situazioni di successo accanto a risultati fallimentaritalvolta accompagnati da indecenti situazioni di arricchi-mento personale. In ogni caso si tratta di eventi superatidalla nuova costituzione economica elaborata nell'ambitodell’Unione europea e accettata, più o meno consapevol-
mente dalla classe politica e dirigente del Paese.La recente esperienza di privatizzazione delle imprese
pubbliche ha fatto emergere nuovamente la debolezzadel nostro capitalismo ossia l'insufficienza del capitale adisposizione dei grandi gruppi finanziari italiani, in preva-lenza a carattere familiare. Questi non sono stati in gradodi acquisire il controllo delle grandi imprese pubblichesenza l’aiuto essenziale del capitale di debito. Il disegnoprevedeva di accollare i debiti contratti a questo fine sul-l’impresa acquisita, di superare l’iniziale crisi di liquiditàricorrendo ai fondi esistenti nell'impresa acquisita e diridurre, nel tempo, l'indebitamento con la vendita delleimprese non rientranti nel core business. Una strategiapiù confacente al capitale finanziario piuttosto che al capi-tale industriale. La conseguenza è stata l’incertezza sullescelte strategiche, l‘eccessiva distribuzione di dividendi edi finanza straordinaria per potere consentire al gruppo dicontrollo di pagare gli interessi sui debiti contratti, un’ap-parente sopravvalutazione delle prospettive di profittononostante la conclamata accresciuta concorrenza segui-ta alle privatizzazioni.
Questa distorsione nel finanziamento delle acquisizioniha avuto la conseguenza di ridurre il tasso di accumula-zione reale delle grandi imprese industriali e di coinvolge-re in questo rallentamento anche le medie e piccoleimprese con riflessi negativi sui processi di innovazione.Questo, come si è accennato nell'introduzione, è uno dei quat-tro nodi che impediscono la crescita della nostra economia.
Incerte aspettative di profitto nell'industria, mancanzad’innovazione diffusa e scarsa propensione alla concor-renza hanno spinto i grandi gruppi finanziari a vederecon favore la possibilità di subentrare allo Stato nei settorioligopolistici ed a volte monopolistici dei servizi, privati,pubblici e di pubblica utilità, purtroppo senza avere unastrategia d’incremento delle infrastrutture materiali edimmateriali. A questo secondo nodo ho accennato in pre-cedenza quando ho richiamato la mancanza di infrastrut-ture materiali ed immateriali fra gli ostacoli alla crescitadell'economia italiana anche se la responsabilità maggio-re ricade, certamente, sulle scelte politiche e sulle ammi-nistrazioni pubbliche.
Quale struttura del sistema produttivo italiano
Prima di approfondire lo studio del capitalismo italianoper capire se anche in questo ambito siano necessarieriforme strutturali per favorire l'aumento della dimensionemedia dell'impresa italiana (4 addetti nel 2001), è oppor-tuno ricordare che l’Italia si caratterizza per un’eccessivaframmentazione del tessuto produttivo e questa situazio-ne ci differenzia nettamente dalla struttura prevalentenegli altri paesi dell'UE a parità di sviluppo raggiunto (fra6 e 10 addetti in media)2.
13
GLO
BA
LC
OM
PE
TIT
ION
7 -
20
06
‹ Capitalismo e sviluppo ›
2 M. D'Antonio, “La piccola impresa italiana: una formazione ancora vincente?”, Economia italiana, n.3/2002.
14
‹ Capitalismo e sviluppo ›G
LO
BA
LC
OM
PE
TIT
ION
7 -
20
06
Il processo di riduzione della dimensione media delleimprese in termini di addetti si osserva ininterrottamentedal censimento del 1971. Le imprese italiane superano i 4milioni di unità e sono aumentate fra il 1991ed il 2001 del23 per cento mentre l’occupazione è aumentata solo del 13per cento, e in prevalenza nelle imprese dei servizi vari (Tab. 1).
La quota dell'occupazione delle imprese da 1-9 addettiè cresciuta di un punto ed è il 46,4 del totale, in compen-so il peso dell'ultima classe (oltre 250 addetti) è passato da21,6 a 20,2. In effetti, se si esclude la classe di addettidelle microimprese, fra il 1991 ed il 2001, si è verificato unmodesto spostamento verso l'alto per le tre classi superio-ri ai 50 addetti anche in questo caso verso i servizi, inparte dovuto all’aumento del numero delle cosiddettegrandi imprese nei settori interessati dalla privatizzazionedelle imprese pubbliche (energia, trasporti, TIC e banche).
Premesso che la struttura produttiva di un paese nondipende solo da decisioni autonome imprenditoriali ma èindispensabile considerare anche la tecnologia, il merca-to, le relazioni industriali, per non parlare di localizzazio-ne, infrastrutture, ecc., può essere utile richiamare alcunidati caratteristici per capire se sia conveniente crescere inuna visione di medio periodo.
Da un punto di vista aggregato i dati forniti dalle inda-gini ISTAT3 (Tab. 2) mostrano che la produttività del lavorocresce con la dimensione e quella della grande impresaindustriale è quasi 3 volte quella della microimpresa men-tre per il costo del lavoro il rapporto è solo il doppio e per-ciò nella grande impresa la quota del profitto è pari al42,6 per cento del valore aggiunto contro il 18,3 percento della microimpresa. Analoghi rapporti fra la grandeimpresa e la media impresa, ossia la classe immediata-mente precedente, mostrano che la produttività del lavo-ro della grande impresa è superiore del 40 per cento aquella della media impresa mentre il costo del lavoro èsuperiore del 20 per cento e la quota di profitto dellemedie imprese è pari a 34,5 per cento. Ne deriva che lagiustificazione del nanismo delle imprese industriali italia-
ne, se si esclude il vantaggio differenziale dell’evasione,non risiede nel costo del lavoro per unità di prodotto,mentre le difficoltà della grande impresa vanno trovatenella ripartizione del profitto fra imprenditori, azionisti,finanziatori, fisco. Poiché il tasso di accumulazione dellegrandi imprese industriali è pari al 19,5 per cento delvalore aggiunto mentre per le microimprese è il 17,0 percento e per le medie è il 15,6 per cento, se ne deduceche le difficoltà di innovazione delle grandi imprese indu-striali hanno coinvolto anche le altre imprese.
Nel caso dei servizi, la situazione si presenta meno chia-ra perché il settore è molto diversificato e, infatti, fra laprima e l’ultima classe dimensionale il differenziale di pro-duttività è 2,0 volte quello delle microimprese mentre peril costo del lavoro il differenziale è 1,65 volte. Rispetto alleimprese medie il differenziale delle grandi imprese è del14 per cento ed è dell’ 8 per cento per il costo del lavo-ro. La quota dei profitti per le imprese maggiori si commi-sura a 35,7 per cento contro 18,9 per le microimprese e32,1 per le medie. Il tasso di accumulazione della classeoltre 250 addetti è il 23,8 per cento del valore aggiuntocontro il 17,6 delle microimprese, ed il 20,6 per centodelle imprese medie ma in questo settore hanno un pesorilevante gli investimenti in tecnologia delle imprese di tra-sporto e di telecomunicazioni (Figg. 1-2).
In sintesi, questi dati mostrano che la diffusione dellapiccola e piccolissima impresa contribuisce ad abbassarenon solo la produttività del lavoro ed il tasso di accumula-zione ma anche il tasso di profitto con conseguenzenegative sull'innovazione e sulla competitività della nostraeconomia.
In compenso quasi il 60 per cento dell'occupazioneaggiuntiva intercensuaria si è avuta nella prima classe edun ulteriore contributo positivo del 23 per cento vienedalla classe 50-99 addetti, mentre nelle altre classi l'occu-pazione varia poco.
La demografia delle imprese dimostra che i tassi di nata-lità e di mortalità continuano ad essere elevati ma un'ana-
Tabella 1 - Imprese e addetti per classe di addetti e settore di attività economica - 1991 e 2001 - Totale ITALIA
CLASSI DI ADDETTIATTIVITÀECONOMICHE
IMPRESEIndustria in senso strettoCostruzioni 308,7 490,2 16,2 18,9 6,3 5,4 1,6 1,2 0,2 0,1 333,0 515,8Servizi 2309,0 2902,4 46,8 53,3 16,4 19,7 5,4 8,2 1,0 1,6 2378,6 2985,2TOTALE 3106,7 3877,8 121,7 129,4 51,2 52,9 17,8 20,6 2,9 3,3 3300,3 4084,0ADDETTIIndustria in senso strettoCostruzioni 704,0 981,3 212,9 246,3 180,7 152,6 146,1 104,9 94,0 44,0 1337,7 1529,1Servizi 4556,1 5056,8 608,9 696,1 476,1 582,8 516,4 793,7 1501,1 1896,2 7658,6 9025,6TOTALE 6621,7 7296,2 1617,1 1714,9 1481,8 1557,0 1708,2 1972,4 3145,5 3172,4 14574,3 15712,9
1 -9 10 - 19 20 - 49 50 - 249 250 e più Totale
1991 2001 1991 2001 1991 2001 1991 2001 1991 2001 1991 2001
3 ISTAT, Rapporto annuale 2004 ISTAT, Roma, 2005, pag. 114.
458,6 452,2 58,1 56,4 28,1 27,5 10,7 11,0 1,7 1,6 557,2 548,7
1298,81 195,2 787,5 762,7 816,5 812,1 1031,5 1060,1 1547,0 1229,1 5481,3 5059,2
lisi compiuta dall'ISTAT ci mostra che dopo quattro annisopravvive il 60 per cento delle imprese e che l'occupazio-ne nelle imprese sopravvissute consente solo di compen-sare, con un lieve aumento, la perdita di occupazionedelle imprese cessate, ossia le imprese sopravvissute nonhanno una strategia di crescita dimensionale ma si limita-no a consolidare il decollo.
Perché le piccole e medie imprese non cresconoe preferiscono il sommerso4
Dalla metà degli anni Settanta, gli economisti, i sociolo-gi ma anche i politologi s’interrogano sulle dinamiche delcapitalismo italiano mentre imprenditori e sindacalisti sirimbalzano la responsabilità delle difficoltà di crescita. Incompenso vi è accordo nell'attribuire allo Stato, all'ineffi-cienza delle amministrazioni pubbliche e all'eccesso dinormativa, comunitaria, nazionale, locale, la creazione diostacoli quasi insuperabili per la crescita di una piccola emedia impresa.
Discende da queste osservazioni che i fattori esogenipossono descrivere l’evoluzione del nostro sistema pro-duttivo ma non chiariscono la riluttanza degli imprendito-ri, piccoli e medi, a crescere anche se, come si è visto, lecondizioni esterne all’impresa potrebbero giustificare ilsalto dimensionale.
I distretti e le loro esternalità di aggregazione, a lorovolta, rappresentano un elemento di tenuta industriale edi flessibilità dinamica, ma molti dubitano che possanosopravvivere se non emergono nuove occasioni di svilup-po. Sebbene si registrino perdite di quote di mercato inalcuni settori strategici per lo sviluppo dell’Italia, le resi-stenze al cambiamento riscontrate per la grande impresasi ritrovano nei distretti, seppure con tensioni sociali diverse.
È lenta la ristrutturazione produttiva per uscire dai set-tori a bassa dotazione tecnologica, bassa qualità, bassicosti. Sta emergendo l'idea che la rete di esternalità pre-senti in un distretto non sia più in grado di fornire quel dif-ferenziale di benefici che li rendeva competitivi e, nono-stante vi siano state esperienze di ricollocazione interna-zionale delle imprese leader in alcuni distretti, non sonoemerse occasioni alternative di sviluppo.
Altra condizione per aumentare la dimensione mediadell’impresa italiana è l'emersione delle piccole impreseche operano nel sommerso, specie nei settori delle costru-zioni e dei servizi. L’ISTAT stima che questa parte dell’eco-nomia italiana si commisuri ad oltre il 13 per cento dellavoro occupato con punte di oltre il 20 per cento nelMezzogiorno e presenti percentuali del valore aggiuntosuperiori al 16 per cento se si tiene anche conto della sot-todichiarazione del valore aggiunto da parte delle impre-se regolari. Per ridurre il sommerso, Il saldo netto fra i van-
15
‹ Capitalismo e sviluppo ›
GLO
BA
LC
OM
PE
TIT
ION
7 -
20
06
Tabella 2 - Imprese e addetti per classe di addetti e settore di attività economica - 2004 - Totale ITALIA
ATTIVITÀ ECONOMICHEE CLASSI DI ADDETTI
(comp. %) (migliaia €) (migliaia €) (%)
Industria in senso stretto 100,0 47,7 32,8 34,91-9 10,9 25,5 21,1 18,310-19 9,4 36,8 24,7 32,820-49 13,4 44,8 29,8 33,550-249 23,7 54,3 35,6 34,5250 e oltre 42,6 74,3 42,7 42,6Costruzioni 100,0 30,2 26,0 20,81-9 50,0 24,6 21,0 15,310-19 16,5 33,6 24,2 27,920-49 14,6 42,4 31,2 26,450-249 11,6 45,3 34,3 24,3250 e oltre 7,3 59,1 42,6 27,9Servizi 100,0 34,3 27,3 28,31-9 39,0 25,1 20,0 18,910-19 11,1 39,6 25,0 36,820-49 11,0 43,3 28,3 34,650-249 14,7 44,8 30,5 32,1250 e oltre 24,2 51,3 33,0 35,7TOTALE 100,0 37,9 29,3 30,21-9 28,5 25,1 20,4 18,310-19 10,8 37,5 24,8 34,020-49 12,3 43,9 29,4 33,250-249 18,1 49,6 33,3 33,0250 e oltre 30,4 60,3 36,9 38,8
Fatturato Valore aggiunto Costo del lavoro Quota dei profittiper addetto per dipendente sul V.A.
4 A questo argomento è dedicato Economia italiana n.3/2002.
16
‹ Capitalismo e sviluppo ›G
LO
BA
LC
OM
PE
TIT
ION
7 -
20
06
taggi e gli svantaggi del sommerso deve essere modifica-to rendendo meno conveniente la scelta dell’opacità edell’evasione e deve migliorare il rapportorendimento/rischio dell’impresa legale rispetto a quellodell’impresa “sommersa”. Queste indicazioni strategichesulla dimensione delle imprese restano ininfluenti se nonsi traducono in decisioni imprenditoriali a loro voltainfluenzate anche da valutazioni di efficienza, dalla cono-scenza dei mercati, dall’accesso al finanziamento, dallacrescita della componente dei servizi e dalla scelta framake or buy nella definizione del valore dell’impresa.Questo cambiamento di strategia che impone la crescitadimensionale, l’innovazione e l'utilizzo di manodoperacon elevata professionalità impone, anche, la reingegne-rizzazione dei processi produttivi ed amministrativi e nonsempre il piccolo imprenditore è in grado di valutare cor-rettamente i vantaggi ed i rischi di questo cambiamentoin assenza di un processo condiviso dalla maggioranzadei suoi fornitori/clienti oppure dagli altri imprenditori deldistretto e finanziato dal sistema bancario.
A questo punto la domanda torna ad essere se il capi-talismo familiare italiano sia in grado di compiere questocambiamento di strategia e inoltre quali iniziative (norma-tive, tecnologiche, finanziarie, relazionali) sia opportunoprendere per agevolare il cambiamento.
Il ruolo dell'informazione e della governance puòspiegare la preferenza per il piccolo e le difficoltàdelle grandi imprese
Nonostante l’indubbio richiamo politico, economico esociale del “piccolo” e la sua presunta flessibilità, è indub-bio che in un sistema economico deve esistere un equili-brato rapporto fra dimensione dell’impresa, mercato eaccesso alle tecnologie.
È compito dell’imprenditore selezionare la tecnologia ele risorse compatibili con il mercato di riferimento e con laconcorrenza, ma in questo processo egli deve essere assi-
stito da un sistema informativo che diffonda all’interno eall’esterno dell’impresa informazioni e conoscenza in rela-zioni agli obiettivi di profitto e alla dimensione dell’impre-sa. Informazione e conoscenza devono aiutare l’imprendi-tore ed i managers a gestire il rischio e a stimare tempe-stivamente sia le potenziali occasioni di profitto e sia lefonti di perdita nonché la probabilità del verificarsi deglieventi. È, anche, indispensabile che l’impresa si doti di unsistema di regole, relazioni ed informazioni fra proprietari,managers, finanziatori e stakeholders in grado di tenereconto delle strategie dei singoli operatori e trovare unasoluzione di equilibrio dei conflitti potenziali (in sintesi unagovernance adeguata).
Questi elementi si coniugano in modo differente in rela-zione alla dimensione dell’impresa, alla rischiosità del mer-cato, alla propensione al rischio dell’imprenditore, deimanagers e dei finanziatori ed infine al livello professiona-le della forza lavoro occupata.
È indispensabile un consapevole e mirato investimentoin conoscenza e comunicazione per la gestione di sistemicomplessi e integrati, ma proprio in questo campo siriscontrano mancanze anche nelle grandi imprese.Purtroppo, se è insufficiente la domanda di conoscenza,le cose non vanno molto meglio dal lato dell’offerta poi-ché essa è poco diffusa ed è costosa. Anche il ricorso allegrandi società di consulenza, di solito estere, non sempreha portato i vantaggi attesi, nonostante le risorse impie-gate, poiché è spesso mancata un’adeguata trasmissionedi conoscenza fra consulenti, managers e proprietà.
Se questo è il modello teorico di riferimento, forse èopportuno valutare la distanza del modello dalla prassi ecapire se non vi siano soluzioni alternative, com’è soven-te possibile in questo campo. Sia la piccola sia la mediaimpresa familiare hanno una governance incentrata sul-l’opacità nell'informativa aziendale all’interno e all’esternodell’impresa. Con la dimensione aumentano la visibilità eil mercato potenziale e l’accesso a tecnologie innovative,ma crescono anche i costi amministrativi, organizzativi edel personale qualificato. La decisione è, quindi, legataanche ad uno stretto rapporto incrementale tra profitto efatturato da un lato e fra costo del personale tecnico eamministrativo, ed accrescimento della produttività e dellacapacità di gestione dei conflitti, dall’altro.
L’esigenza di un aumento della dimensione media delleimprese riguarda pochi settori, decisivi per la competitivitàdell’economia: i settori esportatori, ma anche la distribu-zione commerciale, per ridurre i costi d’intermediazione itrasporti, per gli elevati costi diretti ed indiretti che si sca-ricano sulle transazioni; i servizi delle TIC ed i servizi avan-zati per le imprese, per assistere le imprese nella reinge-gnerizzazione dei processi.
La dimensione ridotta aumenta la flessibilità, riduce ilrischio operativo e obbliga ad operare in un mercato con-correnziale, mentre il salto dimensionale, con i suoi mag-giori costi fissi e variabili e con i pericoli derivanti da un
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
01 - 9 10 - 19 20 - 49 50 - 249 250 e oltre
Figura 1 - Fatturato (quota percentuale delle classi diaddetti sul totale di macrobranca)
industria in s.s. costruzioni
servizi totale
ampliamento delle occasioni di conflitto, interno ed ester-no all’impresa, può indurre l’imprenditore a restare nelsuo ambito dimensionale qualndo non abbia la ragione-vole attesa di non essere coinvolto in un conflitto qualoradecida di operare in un mercato oligopolistico ed amministrato.
Modificare le caratteristiche del nostro capitalismo fami-liare è difficile e non sempre opportuno, ma, in alcuni set-tori, è inevitabile. Accanto ai fattori di natura economicae tecnologica richiamati in precedenza, troviamo i fattorisocio-culturali. Tra i fattori socio-culturali abbiamo la diffu-sa preferenza da parte dell’imprenditore per una gestionedei diritti di proprietà all’interno della famiglia, semmai allargata, e un elemento di disturbo può essere il proble-ma della successione. Inoltre, gli interessi e i collegamen-ti che legano l’imprenditore al territorio nel quale operasuperano i meri aspetti economici e anch’essi esercitanouna resistenza al cambiamento.
I difficili rapporti fra capitale industriale e capitalefinanziario
Un altro aspetto che sovente ostacola il salto dimensio-nale deriva dai difficili rapporti fra industria e finanza.
Il tema dell’interazione fra accumulazione, dimensionedi impresa e finanziamento dello sviluppo è al centro dellaricerca teorica e politica poiché, secondo Schumpeter,non può esservi innovazione senza una rottura con il pas-sato 5. Inoltre se manca l’assistenza alla crescita da partedelle istituzioni finanziarie, si creano le condizioni per unasclerotizzazione dell’apparato produttivo a cui viene amancare la spinta per un rinnovamento 6.
Per compiere il salto dimensionale si richiede l’acquisi-zione dei mezzi finanziari che, se appartenenti all’impren-ditore, gli garantiscono il pieno controllo dell’impresa mane condizionano la crescita, mentre se si ricorre al finan-
ziamento esterno si condivide il rischio con il finanziatorema si introduce, anche, una perdita, seppure parziale, delcontrollo.
È noto, ma non da tutti condiviso, che il finanziamen-to delle nuove iniziative interagisce con la capacità del-l’impresa di generare autofinanziamento, specie per lepiccole e medie imprese, e con l’aspettativa di potereaccrescere quest’ultimo grazie agli investimenti e all’inno-vazione. Se questa aspettativa di profitto non c’è perché sibasa sulla difficile situazione esistente, allora con fatica sipotrà convincere il finanziatore ad investire nell’impresa;se, invece, l’impresa genera profitto allora è l’imprendito-re che si porrà l’alternativa fra capitale di rischio e capita-le di debito. Questi argomenti si riferiscono al finanzia-mento dell’innovazione sia nella piccola e media impresae sia nella grande impresa ed in questo caso si valutaanche la probabilità di take over magari sollecitato propriodai finanziatori, qualora emergessero difficoltà anche tem-poranee.
In sintesi bisogna tornare ad analizzare la struttura delnostro sistema produttivo e domandarsi se il modestotasso di accumulazione e l’insistenza sulla piccola dimen-sione non siano una conseguenza della mancanza di pro-fitto e la preferenza per il sommerso non dipenda dal van-taggio che deriva dall’evasione fiscale e contributiva. Inqueste condizioni è impensabile che si possa assistere adun salto dimensionale delle imprese senza una palesecompartecipazione al finanziamento ed anche al rischiodi emersione da parte dei finanziatori. Ossia, quella cheda molti era considerata solo l’ennesima dimostrazionedella slealtà e dello scarso senso civico degli italiani sidimostra per quello che è in molti casi, specie nell’indu-stria: una strategia di sopravvivenza in una nicchia di mer-cato ad alta concorrenza, a bassa qualità senza effettiveoccasioni di crescita.
Se, inoltre, il finanziatore aggiunge la richiesta di garan-zie, reali e/o personali, per la copertura del rischio, l’im-prenditore ha la netta sensazione, ma non è solo tale, cheil suo potere ed il suo ruolo siano sotto tutela. Questasituazione mette in moto reazioni del tipo rischio moralee la conseguenza sarà una rincorsa alla riduzione delfinanziamento e all’aumento del suo costo; questo con-vincerà l'imprenditore a restare nel suo habitat tecnologi-co, lavorativo, produttivo, commerciale, ecc. soprattuttoad insistere nell’opacità informativa.
Nella grande impresa esiste una diversità per quantoattiene il finanziamento delle nuove iniziative, a secondache vi sia un padrone (persona fisica, giuridica e/o grup-po) oppure vi sia una tale diffusione dei diritti di proprietàda giustificare normativamente lo scambio di informazio-ni fra management e proprietà, in questo ultimo casosovente rappresentata da amministratori definiti indipen-
17
GLO
BA
LC
OM
PE
TIT
ION
7 -
20
06
‹ Capitalismo e sviluppo ›
80
70
60
50
40
30
20
10
0250 e oltre50 - 24920 - 4910 - 191 - 9250 e oltre50 - 24920 - 4910 - 191 - 9
Figura 2 - V.A. per addetto e Costo del Lavoro per dipendente(migliaia di euro)
industria in senso stretto costruzioni
servizi totale
5 F. Vicarelli, “Il capitale industriale e capitale finanziario”, in “La questione economica nella società italiana”, il Mulino, Bologna, 1987, pp. 271 - 293.6 G. M. Rey, “Sistema finanziario e sistema industriale in Italia”, in “Politica industriale e piani di settore”, F. Angeli, Milano, 1979.
Valore aggiunto per addetto Costo del lavoro per addetto
18
‹ Capitalismo e sviluppo ›G
LO
BA
LC
OM
PE
TIT
ION
7 -
20
06
denti. È il tema della governance che ha modificato inmodo sostanziale i rapporti fra mercato, proprietà emanagement e tuttavia non ha portato ad un aumentodel peso reale della grande impresa, anch’essa in conflit-to fra trasparenza, condivisione del rischio e orizzontetemporale medio lungo per le scelte strategiche.
I potenziali finanziatori sono di solito più numerosi maanche più invasivi e con strategie di finanziamento chenon necessariamente coincidono con quelle del manageroppure del gruppo familiare di controllo.
Questo argomento va completato con il ruolo svolto daifinanziatori qualora partecipino ai gruppi di controllo,impliciti o espliciti, delle grandi imprese ed in questo casoil pericolo di collusione fra capitale industriale e capitalefinanziario non è solo potenziale, specie se contempora-neamente assistiamo ad un processo di aggregazione nel-l’ambito della finanza.
Finora, non è stato definito cosa s’intende per finanzia-tori ma le figure riferibili a questa nozione sono moltepli-ci, perché si va dal finanziatore che trasferisce direttamen-te all’imprenditore la sua disponibilità finanziaria ad inter-mediari che aiutano gli operatori ad avvalersi del mercatoper collegare le decisioni di allocazione del risparmio conle decisioni d’investimento reale, alle banche, agli istitutifinanziari ed infine alle holding che detengono posizionidi controllo oppure solo posizioni di minoranza per pote-re avere accesso alle informazioni sulle imprese interessan-ti per il loro core business.
Alcune di queste operazioni di finanziamento sono pre-cluse ai piccoli e medi imprenditori, altre non sono daquesti ultimi accettate perché in conflitto di interesse, peraltre, infine, l’intermediario non avrebbe il vantaggioinformativo e quindi sarebbero costose. Un ruolo fonda-mentale compete alle banche presenti sul territorio poi-ché esse conoscono i flussi monetari e finanziari attivatidall’impresa7, ma il razionamento del credito nei confron-ti delle piccole e medie imprese è una caratteristica dellapolitica bancaria assillata dall’asimmetria informativa edincapace di farvi fronte aumentando gli investimenti inconoscenza. Queste distorsioni nell’allocazione delle risor-se sono state sovente sottostimate anche da molti econo-misti che giudicano concorrenziali i mercati dei capitalisolo perché globalizzati e hanno un’eccessiva fiducia nellacapacità di allocativa dei mercati finanziari e delle banche.Certo, le piccole e medie imprese non potranno maiavere accesso a quei mercati e forse neanche molte gran-di imprese italiane a condizioni favorevoli.
Il finanziamento esterno costringe l’imprenditore a con-dividere le sue informazioni e parte delle sue conoscenzecon il finanziatore, il passo successivo porta all’inserimen-to di finanziatori-azionisti fra i proprietari dell’impresa equesto può creare contrasti fra proprietà e manager e fra
gruppo di comando e azionisti e soprattutto la redistribu-zione dei diritti di proprietà farà aumentare i costi d’infor-mazione e di controllo e quindi la trasparenza ma ancheil rischio di disclosure d’informazioni strategiche.
Questi conflitti potenziali hanno convinto molti impren-ditori a restare piccoli e medi perché i costi informativi e laperdita di potere sono considerati molto superiori ai van-taggi attesi in termini di profitti e di costo del capitale.
La concorrenza e i mercati amministrati
Prima di esaurire l’indagine sulle difficoltà delle impreseitaliane, e di concludere in modo semplicistico che lapatologica diffusione delle piccole e medie imprese è lacausa della resistenza al cambiamento del sistema Italia, èopportuno considerare l’indubbia interazione fra regole,mercato e operatori in un’economia aperta e con ungrado di sviluppo avanzato. Si tratta di capire se la resi-stenza al cambiamento da parte degli imprenditori, di cuisi sono delineate le cause e le responsabilità, non siaanche una conseguenza della forte resistenza al cambia-mento nel mercato interno, e questo vale soprattutto peri mercati protetti del terziario e dei servizi di pubblica uti-lità. Di solito si sente attribuire la mancanza di concorren-za alle norme e alla forza politica delle lobby ma forse valela pena domandarsi se non vi siano anche altre forze,questa volta di mercato, le quali, sfruttando la loro posi-zione dominante, impediscono la contendibilità del mer-cato visto che già la tecnologia non renderebbe economi-co un eccessivo frazionamento dell’offerta. In sintesi, accan-to al tema della tipologia dell’impresa e alla natura del capi-talismo è indispensabile trattare il tema della struttura delmercato e delle sue regole e capire le possibili interazioni framercato, tecnologia, operatori e dimensione d’impresa.
Si tratta di valutare le conseguenze di un mercato oligo-polistico per quanto riguarda i rapporti fra grandi impre-se e piccole e medie imprese ma anche il ruolo che pos-sono svolgere le grandi imprese per favorire la crescitadelle PMI. Ossia dobbiamo domandarci se le condizioniesterne al mercato impediscano la crescita delle impreseoppure se non siano i residui corporativi esistenti nellanostra economia a disincentivare la crescita interna.
In queste condizioni, si presenta difficile il ruolo dellediverse autorità poiché vi sono strette relazioni fra il pote-re delle imprese, il potere politico ed il potere delle buro-crazie nazionali ed internazionali e soprattutto è alta laresistenza alla trasparenza dei nostri imprenditori, nono-stante le norme ed i costi amministrativi imposti dalle strut-ture di controllo interne ed esterne.
Le vicende della privatizzazione delle imprese pubblicheconfermano la continuità del conflitto antico fra settoriper i quali il profitto scaturisce dalla capacità imprendito-
7 Purtroppo, nella ricerca della dimensione ottimale delle banche, non sempre è stato adeguatamente valorizzato il loro ruolo a livello locale, forse per la scarsa attenzione prestata alle piccole e medie imprese e per la preferenza accordata al finanziamento delle grandi imprese nonostante le esperienze negative del passato.
19
GLO
BA
LC
OM
PE
TIT
ION
7 -
20
06
‹ Capitalismo e sviluppo ›
riale di essere efficiente e di selezionare investimenti inno-vativi ad elevata redditività perché glielo impone la con-correnza ed, invece, settori – di “rendita” – che ottengo-no margini elevati da vantaggi di posizione, dalla prote-zione, da accordi con i potenziali concorrenti. Il pericolodella “rendita” come obiettivo dell’impresa è rilevante nelcaso di spostamento delle risorse nel settore dei servizi,per favorire l’efficienza del settore industriale ma, in effet-ti, al solo scopo di garantire maggiore redditività allacapogruppo.
La stessa innovazione, se non è affiancata da adeguatatutela della concorrenza, può tradursi nello sfruttamentodella posizione dominante acquisita dall’impresa innova-trice, con modesti ritorni d’efficienza econ strategie di difesa della posizione.Un altro pericolo per la concorrenzia-lità del settore risiede negli effetti dilock in che si possono riscontrare inmolti servizi in rete, dall'informaticaalle telecomunicazioni ed in tutti i casinei quali la strategia di vendita deibeni privilegi il servizio e l’assistenzarispetto ai ricavi del prodotto, come staavvenendo anche nei settori maturi.Questo pericolo non discende solo dal comportamentodelle grandi imprese di servizi ma sovente si riscontraanche nei mercati locali ritenuti poco redditizi dalle gran-di imprese e dominati da piccole realtà locali (es. commer-cialisti, consulenti, ecc.).
Questo breve richiamo ai possibili ostacoli che incontrala crescita dimensionale delle imprese non sarebbe com-pleto se non includesse l’interrogativo, apparentementeparadossale, di un ostacolo alla crescita delle piccole masoprattutto delle medie imprese messo in atto dalle gran-di imprese che vedrebbero con disfavore l’entrata di unnuovo concorrente agguerrito e magari innovatore.
Questi pochi esempi, necessariamente non esaustivi,volevano solo dimostrare che la scarsa propensione a cre-scere da parte delle piccole e medie imprese può esseredovuta ai fattori socio-economici e culturali richiamati inprecedenza oppure ad ostacoli normativi, ma per comple-tezza di analisi andavano esposti anche gli ostacoli gene-rati dal mercato.
Conclusioni
Al termine di questa breve rassegna dei problemi checoinvolgono l’imprenditoria italiana emerge che il temadella crescita dimensionale delle imprese italiane non puòessere risolto con incentivi fiscali oppure confidando sul-
l’invecchiamento degli imprenditori. L’interazione fra cre-scita dell’impresa e suo finanziamento, fra innovazione eprofessionalità del lavoro, infine la complessità delle rela-zioni e dei poteri all’interno dell’impresa richiedono unastrategia che non può limitarsi all’enunciazione dei princi-pi e alla dimostrazione dei vantaggi dell’accresciutadimensione dell’impresa oppure al richiamo della situazio-ne prevalente negli altri paesi.
Un elemento centrale è l’analisi del ruolo svolto dal-l’informazione e dalla conoscenza, perché non è più iltempo nel quale all’imprenditore bastava produrre unbene in fabbrica adesso l’offerta interna ed estera superala domanda potenziale e quindi bisogna conoscere i mer-
cati e fornire assistenza ai clienti. Un elemento ulteriore è l’interazione
fra le imprese ed il ruolo guida chedeve avere la grande impresa se adottauna strategia di riduzione dei costiricorrendo all’outsourcing. In assenzadi una leadership nella tecnologia e diattenzione al trasferimento delle inno-vazioni, anche le piccole e medieimprese sono in difficoltà poichémanca loro un punto di riferimento, sia
come fornitori sia come produttori di beni finali. Il sistema bancario, a sua volta, deve affiancare gli
imprenditori nel processo di crescita dimensionale delleloro imprese perché le piccole e medie imprese nonhanno accesso ai mercati dei capitali e hanno bisogno diassistenza nell’innovazione organizzativa.
Infine, i costi informativi, diretti ed indiretti, che gravanosulle imprese al crescere della dimensione, dovuti alle pro-cedure di controllo e di governance, stanno generando uninesorabile spostamento del potere in mano ai controllori eagli avvocati. Di questi aspetti bisogna tenere conto se sivuole convincere gli imprenditori piccoli e medi ma anchequelli cosiddetti grandi a compiere il salto dimensionale.
Riprendendo quanto richiamato nell’introduzione persegnalare le difficoltà dell’economia italiana, si può con-cludere che le forze di mercato non possono compiereautonomamente questi cambiamenti perché le resistenzesono molte e sovente giustificate, ma vanno superate.
Gli interventi di politica economica, quindi, non posso-no porsi come obiettivo solo qualche decimale aggiunti-vo di prodotto interno lordo, ma devono creare le condi-zioni per superare le attuali carenze di produttività, infra-strutture, managerialità e servizi alle imprese per favorirel’innovazione, e fra gli obiettivi di queste politiche è indi-spensabile includere anche la crescita della dimensionemedia delle imprese.
“L’Italia si caratterizza perun’eccessiva frammentazionedel tessuto produttivo e que-sta situazione ci differenzianettamente dalla struttura pre-valente negli altri paesi dell'UEa parità di sviluppo raggiunto(fra 6 e 10 addetti in media).”
20
‹ Capitalismo e sviluppo ›G
LO
BA
LC
OM
PE
TIT
ION
7 -
20
06
Nel libro dal titolo L’ascesa della finanza,da me pubblicato con l’Editore
Donzelli, l’analisi del modello di capitali-smo affermatosi in seguito alla svolta neo-liberista degli anni Ottanta è condotta dalpunto di vista di uno dei suoi aspetti piùtipici: la finanziarizzazione dei sistemi eco-nomici. Di fronte alla crescita del peso edel potere della finanza vi sono coloro cheesaltano il crescente ruolo dei mercatifinanziari, in quanto garanzia di maggiorelibertà e di più efficiente allocazione dellerisorse, e coloro che considerano la cresci-ta della finanza una sorta escrescenzaparassitaria sul corpo sano dell’economiareale. Questa, tuttavia, deriva proprio daalcune tendenze dell’economia reale:accelerazione del processo di globalizza-zione; raddoppio del debito pubblico inrapporto al prodotto lordo a livello mon-diale; creazione di sistemi pensionistici acapitalizzazione; privatizzazione di impresepubbliche; disintermediazione delle atti-vità finanziarie attraverso un massiccio tra-sferimento ai mercati di rischi in preceden-za mantenuti nei bilanci di banche ed assi-curazioni. La finanziarizzazione a sua voltaretroagisce sull’economia reale influenzan-done i diversi aspetti: stabilità dei sistemieconomici, distribuzione del reddito, con-trollo e direzione delle imprese, politicamonetaria.Fenomeno analogo si verificò nell’Ottocento. Anche allora vi fu un’accelera-zione del processo di globalizzazione,anche allora crebbero il livello di finanzia-
rizzazione dei sistemi economici e l’inter-nazionalizzazione dei flussi di capitale, ilche dette luogo ad lungo periodo di cre-scita trainata dal capitale finanziario cherealizzava progetti nelle varie parti del pia-neta. Quella fase della globalizzazione finìcon una serie di crisi finanziarie culminatanel 1929 con quella che dette origine alla“Grande depressione”. La conclusione fu iltrionfo del nazionalismo e del protezioni-smo, un cambiamento radicale dei model-li di sviluppo, uno sconvolgimento degliassetti politici di un gran numero di paesi. La fase attuale presenta importanti analo-gie con quanto avvenne allora, ma anchenotevoli differenze. La base del risparmiosi è molto allargata, gli strumenti finanzia-ri sono diventati più complessi e sonorivolti, oltre che a mobilitare risorse per gliinvestimenti, a coprire i crescenti rischidelle persone ed a distribuire su una pla-tea molto più vasta i rischi, soprattuttoattraverso i derivative. Per tutti sono cre-sciute le possibilità di indebitamento. Unadelle differenze più evidenti è data dalladirezione dei flussi finanziari a livello mon-diale. Nell’Ottocento i flussi netti muove-vano essenzialmente dai paesi avanzativersi i paesi in via di sviluppo, ora gli Usaassorbono i due terzi dei flussi netti mon-diali e l’insieme dei paesi a modello anglo-sassone – Usa, Uk, Australia, NuovaZelanda, Irlanda – ne assorbe la quasitotalità. Oggi i paesi anglosassoni hannoassunto il ruolo di consumatori e di debi-tori di ultima istanza, mentre i paesi asiati-
ci vanno assumendo il ruolo di produttoridi manufatti. Il paradosso è che i paesipoveri stanno finanziando i consumi deipaesi ricchi.Per quanto riguarda l’impatto che la finan-ziarizzazione ha sulla stabilità dei sistemieconomici, assistiamo al ritorno delle crisifinanziarie. La prima grande crisi, verifica-tasi all’inizio degli anni Ottanta, fu crisi deldebito pubblico generata dalla svolta dellapolitica monetaria e dal drammaticoaumento dei tassi di interesse. A partiredalla crollo di Wall Street del 1987, segui-to poi dalle crisi giapponese, messicana,del sud-est asiatico, russa, brasiliana, e dalnuovo crollo di Wall Street nel 2000, si èripresentato un tipo di crisi, frequentenell’Ottocento, consistente nell’esplosionedi bolle speculative mobiliari ed immobilia-ri. Qui il debito pubblico non c’entra, sem-mai c’entra un eccesso di indebitamentoprivato. Le istituzioni economiche interna-zionali hanno stentato a realizzare lanovità ed hanno sbagliato i primi interven-ti, dopo si sono concentrate sull’impegnodi rendere più stabili i sistemi finanziarisoprattutto nei paesi in via di sviluppo.Tutto ciò non ha impedito il ripetersi dellecrisi che, tra l’altro, hanno origine soprat-tutto dal modo in cui grandi masse finan-ziarie sono gestite nei paesi avanzati. Oggiè importante chiedersi in quale misura ilpersistere di squilibri strutturali nell’econo-mia mondiale stressa i mercati finanziari efavorisce il prodursi delle crisi finanziarie.In fondo gli accordi di Bretton Woods
L’ascesa della finanza. Risparmio, banche,assicurazioni: i nuovi assetti dell’economiamondiale di Silvano Andriani
Silvano Andriani, economista e studioso di politica finanziaria, senatore per due legislature, è attualmentepresidente del Cespi (Centro Studi di politica internazionale) e presidente della compagnia di assicurazio-ne del Gruppo Montepaschi di Siena, Ha trasfuso le sue esperienze di analista e di manager in un volume(Donzelli editore) dal titolo L’ascesa della finanza. Risparmio, banche, assicurazioni: i nuovi assetti dell’eco-nomia mondiale, un’analisi attenta e documentata della crescita nel corso degli anni del peso della finan-za e dei mercati nella vita economica anche sotto il pungolo delle innovazioni tecnologiche. L’Autore ponel’accento sulla necessità di valutare il modo in cui i processi di finanziarizzazione vengono posti in atto e illivello di controlli a cui sono effettivamente sottoposti. Abbiamo chiesto a Silvano Andriani di riassumere in questo scritto le principali conclusioni delle sue anali-si sull’ascesa della finanziarizzazione dell’economia e sulle sue ricadute sullo sviluppo.
21
GLO
BA
LC
OM
PE
TIT
ION
7 -
20
06
‹ Capitalismo e sviluppo ›
erano focalizzati proprio sulla necessità diimpedire il perdurare di squilibri strutturalinella consapevolezza, tratta dall’esperien-za precedente, del rischio di crisi che ciòcomporta. Questo pilastro è andato smar-rito con la liquidazione del sistema diregolazione creato a Bretton Woods. Ilfatto che l’instabilità dei sistemi economicitenda a non manifestarsi più attraversol’inflazione, come accadeva negli anniSettanta, ma attraverso la formazione dibolle speculative e conseguenti crisi finan-ziarie ha riaperto il dibattito sulla politicamonetaria, che nel tempo è stata focaliz-zata sull’obiettivo di controllare l’inflazio-ne. Il formarsi di bolle speculative, tuttavia,mette in evidenza un tipo di inflazione cheriguarda beni patrimoniali non compresinegli indici esistenti. Alcuni si chiedono sela politica monetaria non debba contrasta-re anche questo tipo di inflazione. Su que-sta questione le due principali banchecentrali si sono divise in quanto la FederalReserve ritiene che non sia compito dellebanche centrali influenzare i mercati mobi-liari ed immobiliari, mentre la BancaCentrale Europea tende ad assumere unatteggiamento più attivo, anche se inten-de intervenire solo indirettamente sullabase di alcuni indicatori che possonoavvertire circa il formarsi di bolle speculati-ve, a cominciare dalla misurazione deglieventuali eccessi di indebitamento priva-to. Un tale atteggiamento può rafforzarela tendenza a non dare peso adeguatoalle esigenze di sviluppo, ma l’esperienzaci dice che la creazione di un ambientemacroeconomico favorevole allo svilupponella stabilità non può essere ottenutocon la sola politica monetaria, dipendedall’orientamento complessivo della distri-buzione del reddito.Nel libro, infatti, il tema dell’impatto della
finanziarizzazione sulla distribuzione delreddito viene affrontato soprattutto consi-derando la funzionalità dei modelli distri-butivi rispetto alle esigenze di sviluppo. Ilmodello distributivo di tipo socialdemocra-tico, politica dei redditi e politiche fiscalimolto progressive esplicitamente direttead impedire un eccesso di concentrazionedel reddito e della ricchezza, era moltofunzionale allo sviluppo. Ora il dato princi-pale è la generalizzata crescita delle disu-guaglianze soprattutto all’interno di cia-scun paese. La causa principale del feno-meno è lo spostamento dei rapporti diforza tra capitale e lavoro che ha compor-tato quasi dappertutto una sostanziale
riduzione della quota di reddito nazionaleassegnata al lavoro ed è alla base dellaforte crescita del rapporto tra valore dellaricchezza patrimoniale e prodotto lordo.Ad essa si aggiunge il fatto che il prevale-re, soprattutto nei paesi emergenti, dimodelli di sviluppo trainati dalle esporta-zioni genera un distacco tra le aree delpaese più favorevolmente collocate rispet-to a questo tipo di sviluppo e le altre.Queste tendenze di mercato sono statein molti paesi rafforzate da indirizzi dipolitica economica rivolti a ridurre lapressione fiscale e la progressività deisistemi fiscali. I paesi scandinavi, tuttavia,che realizzano le performance economi-che migliori d’Europa ed hanno i livelli dibenessere più alti al mondo, dimostranoche è possibile mantenere un forte con-trollo politico sulla distribuzione del reddi-to ed inserirsi efficacemente nel processodi globalizzazione.La crescita delle disuguaglianze comportauna perdita di funzionalità del modellodistributivo in quanto la concentrazionedel reddito e della ricchezza fa sì che unaparte crescente della popolazione restipriva dei mezzi per realizzare le propriecapacità. Qualcuno ha parlato di scom-parsa dei ceti medi. Inoltre, coloro che sivedono distaccati nel livello di reddito siindebitano per non aumentare il distacconei livelli di consumo e coloro nelle cuimani si concentra la ricchezza si indebita-no per acquisire nuovi beni patrimoniali,tutti usano il maggiore valore della ric-chezza patrimoniale come leva per l’inde-bitamento. La crescita sistematica del livel-lo di indebitamento degli Stati e dei privaticui si aggiunge l’indebitamento dei paesianglosassoni verso il resto del mondo, è lamanifestazione più evidente della scarsafunzionalità dell’attuale modello distributi-vo che non genera un adeguato livellodella domanda mondiale senza un siste-matico aumento dell’indebitamento. E cisono seri dubbi sulla sostenibilità di talemodello distributivo.Quanto all’impatto della finanziarizzazio-ne sul controllo delle imprese, si è passatida una fase, quella fordista, nella quale la governance delle imprese era determina-ta dall’equilibrio di potere fra chi gestival’impresa ed i sindacati dei lavoratori adun’alleanza tra chi gestisce ed il capitalefinanziario.Nei fatti si è verificato una carenza di bilan-ciamento del potere all’interno delleimprese che è alla base degli scandali
societari verificatisi in molti paesi. Il capita-le, finanziario opera invece attraverso imercati promuovendo take over ostili oacquisizioni e fusioni di imprese e modifi-cando così la conformazione stessa delsistema delle imprese. Le grandi imprese, in seguito alla crescitadei profitti, si conglomerano assumendo esse stesse funzioni di allocazione finanzia-ria. Anche il confine tra banche ed assicu-razioni diventa più labile in seguito allaconvergenza delle rispettive attività. Iltutto è dominato da un approccio dibreve periodo alimentato anche dallemodalità di funzionamento dei sistemifinanziari, Questi, mentre hanno creatoprodotti innovativi per coprire nuovi rischie per distribuirli su una platea molto piùampia, hanno d’altro canto accentuatoalcune attitudini speculative ed il distaccodall’economia reale, e possono trovarsi inconflitto di interesse nei confronti dellaclientela.Rispetto ai problemi individuati il libroavanza qualche proposta di discussione edi ulteriore ricerca nella consapevolezzaderivante dal passato che la globalizzazio-ne, contrariamente a quanto spesso siafferma, non è un processo irreversibile eche per assicurarne la prosecuzione biso-gna conoscere le contraddizioni dell’attua-le modello di sviluppo.
Idistretti industriali, quali agglomerazioni spaziali diimprese specializzate in determinati settori produttivi,
sono un fenomeno da tempo conosciuto, ma in nessunpaese hanno assunto una diffusione ed una rilevanzacome in Italia, dove costituiscono il cuore dell’industriamanifatturiera e l’asse portante del cosiddetto made inItaly.
La possibilità di fare industria con piccole imprese,facendo leva sulle economie ester-ne territoriali per ottenere alti livellidi efficienza e flessibilità produttiva,superando i limiti delle dimensioniridotte dei singoli operatori, è la viaattraverso cui l’Italia è riuscita, a par-tire dal secondo dopoguerra, a tra-sformare la propria struttura econo-mica da paese agricolo a paeseindustriale, dando vita nelle regionidel Centro-Nord-Est ad una formadi industrializzazione del tutto origi-nale. Ne è scaturito un modello diistituzionalizzazione e organizzazio-ne del sistema economico, produtti-vo e finanziario, quello del capitali-smo distrettuale o del terzo capitali-smo, che si è affiancato con succes-so al capitalismo privato e al capita-lismo pubblico delle grandi imprese,che con alterne vicende hannosegnato la storia industriale italiana.
Le virtù ed i meriti del capitalismo distrettuale sonoampiamente noti e gli studiosi e gli analisti ne hanno trat-teggiato con dovizia tutte le sue diverse componenti esfaccettature economiche, sociali, ambientali. Questosforzo di evidenziazione è stato particolarmente fruttiferoa partire dagli anni Settanta allorché, a fronte di una con-tinua crescita e affermazione dei sistemi distrettuali, haavuto inizio in Italia un progressivo declino della grande
industria, che non ha saputosostenere l’impatto di valori spintial cambiamento ed al consolida-mento strutturale, quali il progres-so tecnologico e organizzativo, laconcentrazione industriale efinanziaria, la liberalizzazione deimercati e l’internazionalizzazionedell’economia. Così, accumulan-dosi un progressivo divario dalleeconomie più avanzate, in fatto dimodello del sistema industriale, ilcapitalismo distrettuale è venutoalla ribalta, oltre che per i proprimeriti, anche per i demeriti dellagrande industria, diventando lacomponente prospera e vitale del-l’economia italiana, l’asset a cuiaffidare per gran parte le sue sorti.
L’impalcatura distrettuale delsistema economico e produttivoitaliano da qualche tempo sta
22
‹ Capitalismo e sviluppo ›G
LO
BA
LC
OM
PE
TIT
ION
7 -
20
06
Dopo un’attenta analisi della realtà odierna dei distretti industriali,
sviluppata in un’ottica da economista d’impresa piuttosto che da economista industriale,
l’Autore formula una serie di specifiche proposte per dare vita a quella che chiama
la “via italiana alla globalizzazione”. Occorre oggi una vera e propria rifondazione
dei sistemi distrettuali in piccole imprese. E per conseguire l’obiettivo è necessaria
l’introduzione di provvedimenti di liberalizzazione e di meccanismi di mobilità dei capiali,
degli interventi e delle risorse umane, tali da consentire a livello di impresa e di sistema
paese una diversa, più efficiente allocazione generale delle risorse,
tenuto conto delle nuove condizioni dell’economia e della finanza a livello globale.
RICCARDO VARALDO
Presidente della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa; Consigliere di AmministrazioneFinmeccanica, Piaggio e Banca CRFirenze.Docente di Economia e Managementdell’Impresa, Direttore della rivista Mercati eCompetitività e Co-direttore della rivistaEconomia e Politica Industriale. È membro delboard dell’Italy-Japan Business Group. Si è inte-ressato ed è autore di libri, articoli e contributidi economia industriale, delle strategie compe-titive, di management dell’innovazione e deidistretti industriali.
RIFONDAZIONE DEI DISTRETTIVIA OBBLIGATA PER IL RILANCIO
23
GLO
BA
LC
OM
PE
TIT
ION
7 -
20
06
‹ Capitalismo e sviluppo ›
vacillando, con tutte le conseguenze negative ben notesotto il profilo della competitività e della crescita.L’entusiasmo [nei] e per i distretti industriali è progressiva-mente calato, mentre ci si interroga sul loro futuro e sucosa fare in concreto per il loro rilancio.
In questa sede ci si ricollega a questo dibattito per offri-re spunti di analisi e di riflessione che guardano al distret-to da un’ottica da economista d’impresa piuttosto che daeconomista industriale, nell’intento di individuare i nodicritici e le debolezze strutturali dell’organizzazione distret-tuale. La globalizzazione dell’economia e dei mercati, conla progressiva digitalizzazione dei sistemi operativi e del-l’organizzazione aziendale, ha introdotto elementi didiscontinuità nel modo di fare industria e di fare impresa,che sembrano difficilmente assimilabili nelle realtà distret-tuali, così strutturalmente dipendenti da tipologie diimprese che per dimensione, assetto proprietario, struttu-ra finanziaria, competenze possedute non sembranoattrezzate per affrontare le sfide del nuovo secolo.
Nel compiere questo tipo di analisi si cerca di evidenzia-re perché e come occorra guardare oltre il tradizionaleassetto dell’organizzazione distrettuale, dove la sua forzaera assicurata dalla presenza di una folla di piccole e pic-colissime unità operative, perchè l’attuale momento stori-co impone di operare selettivamente nel far emergeredalla “foresta” gli “alberi” dotati di un maggiore potenzia-le di cambiamento e di crescita, con la prospettiva di costi-tuire forze di traino anche per la rifondazione e il rilanciodei distretti industriali.
Da un modello distretto-centrico a un modelloimpresa-centrico: un passaggio obbligato madifficile da concretizzare
I distretti industriali hanno fatto le fortune non solo del-l’economia italiana ma anche di molti ricercatori e studio-si. La prima ne ha tratto una spinta importante per l’indu-strializzazione diffusa, la crescita e l’internazionalizzazione.I secondi vi hanno trovato un campo assai fertile di inve-stigazione e di analisi teorica, portando alla ribalta incampo internazionale l’immagine dell’Italia come “paesedei distretti industriali”.
Nelle altre economie avanzate, ed in specie negli StatiUniti, l’economia industriale è una disciplina che è nata esi è sviluppata in funzione e attorno al fenomeno dellegrandi imprese, ed ai relativi problemi di governance, diregolazione, di management e di finanziamento. In Italia,a parte alcuni meritevoli studi con questo tipo di impron-ta, attorno agli anni Settanta, quando le grandi impreseavevano raggiunto un certo peso e creato aspettative, ladisciplina dell’industrial organization non ha avuto un taltipo di impostazione. Si è invece avuta una abbondanteed eccezionale produzione di studi e ricerche riguardantiil mondo dei distretti industriali e dei sistemi produttivi dipiccole imprese. E questo ha portato a privilegiare negli
studi la dimensione macro, di sistema, piuttosto che ladimensione micro, di impresa, ovvero il lato del comples-so piuttosto che il lato fattuale, strategico e funzionaledelle unità che lo compongono.
La visione del distretto come unità indistinta è propria diuna fase storica in cui il sistema paese ed a cascata i varisistemi distrettuali godevano di fattori naturali di competi-tività che assicuravano condizioni di vantaggio ai nostriprodotti sui mercati internazionali, tali da poter far con-centrare l’attenzione delle unità distrettuali sul produrrepiuttosto che sul vendere e sull’inserimento diretto neipaesi esteri.
In tale contesto, il distretto industriale come “macchinaproduttiva” poteva esprimere al meglio le sue capacità ele sue virtù come aggregato di tante piccole imprese ope-ranti in sinergia nell’ambito di una data filiera produttiva,ciascuna dedita a svolgere una particolare operazione,produrre un certo componente od assemblare un insiemedi parti per realizzare un prodotto. Questo tipo di organiz-zazione distretto-centrica, che vedeva nel distretto comeunità un protagonista egemone, denuncia oggi evidentilimiti e difficoltà. Di fronte al ridimensionamento dellacompetitività del sistema paese e alle profonde trasforma-zioni in atto nell’economia mondiale, sono evidenti i pro-blemi di tenuta competitiva per la “macchina distrettuale”.Nel contesto sono le economie interne e le strategie diimpresa che diventano un fattore chiave nel competeresu mercati complessi, sempre più affollati e concorrenziali.
L’impatto del cambiamento sulla tenuta complessiva delsistema distrettuale è particolarmente duro.
Oggi nei distretti sono venuti per gran parte meno i fat-tori di armonia e coesione che a lungo hanno costituito illoro punto di forza, assicurando benefici diffusi per tutti glioperatori e per l’intera comunità. Sono in atto al loro inte-no forze e meccanismi di selezione spinta delle imprese,trainati della nuova concorrenza internazionale dei gran-di paesi, come la Cina e l’India, che si sono affermaticome imponenti piattaforme manifatturiere. In questocontesto, molti ritengono che possibilità di recupero erilancio ci siano a livello delle imprese che riescono ademergere dal collettivo distrettuale con proprie competen-ze, capacità e distintività, piuttosto che a livello dei distret-ti come grande macchina produttiva.
La fase critica che sta vivendo il capitalismo distrettuale,con il passaggio da un modello distretto-centrico a unmodello impresa-centrico, sta preoccupando non solo gliimprenditori, ma anche i ricercatori e gli studiosi. Gli uniperché sono disorientati dal passaggio e non sanno indi-vidualmente “cosa fare“ per uscire dalla crisi, mentre sten-ta a concretizzarsi una capacità evoluta di “fare squadra”.Gli altri perché non sanno “come studiare” i distretti nellenuove condizioni in cui si trovano e nelle nuove configu-razioni a cui tendono o dovrebbero conformarsi.
Gli studiosi di economia e sociologia industriale in gran-de maggioranza si sono impegnati soprattutto a capire e
spiegare perché il “calabrone potesse volare”. Il loro inte-resse è stato così rivolto ad indagare le ragioni economi-che e sociali della sostenibilità e del successo di una orga-nizzazione industriale peculiare, tutta centrata su piccoleimprese, sostanzialmente atipica rispetto ai modelli piùconosciuti e diffusi negli altri paesi avanzati, fondati sumedie e grandi imprese.
Oggi non c’è più tempo per fermarsi a gioire del fattoche, a dispetto delle leggi della aerodinamica, il “calabro-ne vola” o addirittura per cercare di dimostrare che idistretti sanno volare meglio delle nostre poche grandiimprese.
I molti, entusiasmanti risultati che i distretti industrialisono riusciti a conquistare, ad esempio sul piano occupa-zionale e nell’export, nel particolare mondo industriale ita-liano, per meriti propri o per demerito di altri (le grandiimprese), sono noti e riconosciuti. Purtroppo sono meritiche oggi non fanno più notizia. Il motivo è chiaro: la for-mula distrettuale, nella sua concezione canonica di stam-po marshalliano, manifesta chiari sintomi di crisi. E si trat-ta di una crisi profonda che, per evitare di renderla irrever-sibile, deve essere innanzitutto percepita e riconosciutanella sua effettiva portata e gravità. Il che non è purtrop-po sempre vero. Di fronte al concreto pericolo di un decli-no rovinoso non c’è una visione comune per la rifonda-zione e la rinascita del capitalismo distrettuale, né daparte degli operatori e dei policy makers, né da partedegli studiosi “distrettologi”. Sono invece presenti e sten-tano a morire visioni e interpretazioni del fenomeno dellacrisi che non lasciano a ben sperare.
La permanenza di concezioni e visioni superate:una pericolosa deriva
Volendo schematicamente rappresentare il pericolo diabbandonarsi al corso degli eventi è utile entrare nel meri-to di alcune interpretazioni dei fenomeni di cambiamentoin corso nell’ambiente economico su scala internazionaleche evidenziano in modo eloquente il ritardo culturalecon cui il mondo imprenditoriale dei distretti affronta lenuove sfide. Una prima visione distorta della realtà è quel-la di impronta congiunturale, propria di piccole impresepoco strutturate, con orizzonti temporali ristretti, che pri-vilegiano i costi variabili e che rifuggono dal compiereinvestimenti di lungo periodo. I loro guadagni sono rite-nuti abbastanza confortanti nei periodi di alta congiuntu-ra, mentre le perdite possono essere contenute nelle fasicalanti del mercato data la loro struttura snella, poco gra-vata da costi fissi. Così facendo tendono a “galleggiaresulla congiuntura”, nella speranza che a fasi negative sialternino fasi favorevoli. Questo tipo di ottica congiuntu-rale continua a persistere nei distretti, per la tendenza aconferire alla crisi in atto una interpretazione riduttiva,senza capire che le cose sono sostanzialmente e irrimedia-bilmente cambiate.
I trends di mercato continuano a manifestare ovviamen-te fasi alterne di natura congiunturale, per cause connes-se al ciclo dell’economia internazionale e dei vari suoi set-tori, ma ciò che conta per noi è il fatto che da circa unventennio le quote di mercato dei distretti sul businessmondiale dei settori manifatturieri di loro specializzazionesono sistematicamente e progressivamente calanti. Il chedenota una perdita di competitività relativa. Una percezio-ne di regresso strutturale, anche se è presente nei distret-ti, non è comunque tale da far scattare reazioni e inter-venti adeguati, lasciando così le cose in balia degli eventi.
Un secondo modo di rinviare i problemi deriva da unavisione attendista di fronte al successo dei nuovi paesi,apparsi prepotentemente sulla scena mondiale comegrandi produttori ed esportatori di prodotti low-cost. Lo siritiene troppo di frequente un fenomeno temporaneo elimitato ad una fascia di mercato diversa e lontana daquella dove sono o si ritiene che siamo posizionati i pro-dotti del made in Italy.
La conseguenza è dannosa: si pensa di essere nel giu-sto nell’affidarsi alla speranza che possa ridursi la forzacompetitiva dei nuovi players a mano a mano che i lorocosti del lavoro aumenteranno, che verranno introdottenormative per la tutela dell’ambiente e il miglioramentodei salari e delle condizioni di lavoro, e così via. In sostan-za, nell’attesa che anche gli altri vengano frenati e pena-lizzati dai nostri lacci e lacciuoli, con un conseguente pos-sibile riallineamento delle posizioni competitive, ci sonoimprenditori che resistono, nella speranza di un dopomeno sfidante, anziché cercare di uscire dal tunnel oggi.
Auspicare e chiedere una riduzione dei differenziali dicosto del lavoro e del dumping sociale e ambientale neinuovi paesi è giusto e doveroso, nel tentativo di contribui-
24
‹ Capitalismo e sviluppo ›G
LO
BA
LC
OM
PE
TIT
ION
7 -
20
06
Figura 1 - Distretti industriali per ripartizione geograficaal 2001
42
39
NORDOVEST
NORDEST
49CENTRO
MEZZOGIORNO
26
Fonte: Elaborazione su dati ISTAT
25
GLO
BA
LC
OM
PE
TIT
ION
7 -
20
06
‹ Capitalismo e sviluppo ›
re alla formazione nel loro ambito di una legislazione ecultura di impresa più avanzata, più attenta ai dirittiumani, alla tutela ambientale ed all’etica degli affari edella concorrenza. È questo un problema all’attenzionenon solo dei paesi europei, pressati dalla concorrenzasenza limiti e senza vincoli delle importazioni low-cost dainuovi paesi, ma anche delle grandi multinazionali ameri-cane che più si riforniscono in tali paesi. La Wall-MartStores/Inc., la grande catena di distribuzione degli StatiUniti, ha denunciato recentemente un livello di violazionedegli standard per il lavoro e l’ambiente in più di sessantapaesi dove acquista articoli di abbigliamento, giocattoli,calzature ed altri prodotti. L’introduzione di nuove regoledi auditing delle fabbriche dei fornitori ha inoltre portatoad un aumento dei casi accertati di violazione ad altorischio: nel 2005 hanno riguardato il 52 per cento dellerilevazioni, mentre nel 2004 incidevano per il 36 percento dei casi.
Se è opportuno muoversi nella direzione indicata,richiedendo interventi e provvedimenti adeguati, a tutti ilivelli, non è peraltro saggio attendere questo tipo di nor-malizzazione legislativa e regolamentare come via di usci-ta dalla caduta di competitività, che è causata dalla crisistrutturale che i nostri sistemi distrettuali hanno di fronte.
C’è infine una terza visione, quella minimalista, di chiritiene di potersi ritagliare nicchie e sub-nicchie di produ-zione e di mercato, accontentandosi di ordini molto ridot-ti e spezzetati, da soddisfare in tempi estremamente ridot-ti. È il “regno dell’immaginario delle nicchie” come mezzodi sopravvivenza, con la consapevolezza di doversi accon-tentare di volumi sempre più ridotti. Si tratta di un atteg-giamento comune negli ambienti in cui è rimasta radica-ta una cultura dell’artigianato che ritorna in auge dopo
aver vissuto tentativi di sviluppo e organizzazione delleattività in modo industriale, che non sono mai stati realiz-zati in senso proprio. Puntare su nicchie senza avere lacapacità di coltivarle e sfruttarle a livello globale, con ade-guate competenze e capacità, significa cercare vie persopravvivere, rischiando l’emarginazione nel mercatosenza prospettive di crescita. È questa a ben vedere unadelle cause per cui l’economia italiana langue e soffre diuna cronica incapacità di crescita, essendo troppo dipen-dente da miriadi di piccole e piccolissime unità che hannovisto ulteriormente ridursi le loro già contenute capacitàdi crescita.
Queste tre diverse visioni sono figlie di una culturaimprenditoriale che stenta ad abituarsi all’idea che occor-ra “cambiare il modo di fare impresa” perché i tempi loimpongono. Sono impostazioni limitate alla pura soprav-vivenza e al galleggiamento, che si collocano al di fuoridelle esigenze di crescita che assillano il paese e di undisegno di rilancio della sua economia che passa ancheda una rifondazione del capitalismo distrettuale.
Le tre direttrici di marcia per la rifondazionedistrettuale
Non condivido le profezie che annunciano la scompar-sa dei distretti. Ritengo invece che essi costituiscano unacomponente non solo insostituibile del panorama indu-striale italiano ma anche fondamentale, ai fini del rilanciodell’economia italiana. Non abbiamo, come paese, tradi-zioni manifatturiere solide e di eccellenza al di fuori diquelle radicate nei sistemi locali di piccole imprese ed inspecie nei distretti. E si tratta di un asset sul quale è gio-coforza far leva se vogliamo mantenere un posto nellagraduatoria mondiale dei grandi paesi industriali.
I distretti industriali sono 156 nel 2001 ed occupano1.928.602 addetti, pari al 70,2 per cento dell’intera occu-pazione nell’industria manifatturiera italiana.
Il Centro Italia è la ripartizione geografica dove il model-lo distrettuale è più presente (Fig. 1), ma è il Nord-Ovestche conta il maggior numero di addetti manifatturieri neidistretti industriali (Fig. 2), per una maggiore presenza dimedie e grandi imprese.
Le industrie principali dei distretti industriali (Fig. 3) sonoquelle tipiche del made in Italy: la meccanica; il tessile eabbigliamento; i beni per la casa; le pelletterie e calzatu-re; l’oreficeria. I distretti così caratterizzati sono 148 (il 94,8per cento del totale), con 1.810.717 addetti manifatturie-ri (il 94 per cento del totale).
Per guardare in avanti in modo serio e fondato occorresuperare il ritardo accumulato nel capire fino in fondo ilcambiamento di scenario e le cause profonde della crisidistrettuale. Solo così è possibile darsi un quadro di riferi-mento coerente e sistemico, allo scopo di delineare pro-poste che non siano dei semplici palliativi, ma che cerchi-no di affrontare taluni nodi critici dell’attuale assetto strut-
Figura 2 - Addetti manufatturieri nei distretti industrialiper ripartizione geografica al 2001
799.420
NORDOVEST
NORDEST
CENTRO
MEZZOGIORNO
Fonte: Elaborazione su dati ISTAT
654.846
382.857
90.479
turale e funzionale dei distretti.Ci sono a ben vedere da prendere in considerazione le
discontinuità che si sono formate, nel corso degli ultimianni, rispetto al periodo della golden age, per quantoconcerne:
- il modello di crescita proprio dei distretti, per quantoriguarda l’ampliamento e l’organizzazione dell’offerta,rispetto alla dinamica della domanda;
- il modello competitivo tipico delle realtà distrettuali,oggi messo a dura prova dai nuovi trends dell’economiamondiale e dall’entrata sulla scena di nuovi grandiplayers, come la Cina e l’India, dotati di grandi capacità eforze propulsive;
- il business model prevalente nei distretti, fortementecentrato su fattori hard e poco su fattori soft, in quantoancorato alla “fabbrica” e poco orientato all’innovazionedi valore ed al presidio dei mercati di sbocco.
Su queste tre aree problematiche merita soffermarci,facendo rinvio ad altre fonti per eventuali approfondi-menti in materia (R. Varaldo, 2005 e 2006).
i. La crescita dei distretti, trainata da una forte dinamicadella domanda internazionale dei prodotti del made inItaly, si è realizzata attraverso un progressivo ampliamen-to della capacità produttiva, ottenuto tramite la prolifera-zione delle unità operative, piuttosto che con una cresci-ta dimensionale delle imprese.
Questo ha portato ad una estrema polverizzazione deltessuto imprenditoriale, indotta e facilitata dall’ambienteproprio dei distretti, mentre non sono state attivate le poli-tiche e le capacità per far nascere e crescere imprese piùstrutturate e più dotate in fatto di competenze e risorse.
Questa carenza oggi costituisce uno dei più gravi limiti aifini di una strategia di rilancio del capitalismo distrettuale.D’altro canto, la presenza di resistenze irriducibili alla cre-scita dimensionale, alle aggregazioni ed alle fusioni fraimprese, nonché alle alleanze strategiche cross-border,non lascia ben sperare.
I nostri distretti, tanto forti in apparenza, se visti comeentità unitarie, hanno da sempre covato in seno i germidi una intrinseca debolezza strutturale, che solo ora staemergendo in tutta la sua portata e gravità.
Rendersi conto di questo vincolo ed operare per ridur-lo con politiche di sostegno e di incentivazione della cre-scita dimensionale, per vie interne e soprattutto per vieesterne, è una pre-condizione di una strategia di rilanciodei distretti industriali capace di far loro riprendere unnuovo sentiero di crescita, nel quadro dell’economiamondiale.
Le realtà distrettuali più vitali sono oggi quelle dovesono in atto processi evolutivi di questo tipo, atti a faremergere dall’anonimato distrettuale imprese di mediedimensioni, con una propria identità, capaci di avvalersi edi valorizzare competenze manageriali di alto profilo, edotate dei mezzi e delle risorse per inserirsi e competerenel mercato globale.
Sono imprese che in genere non nascono dal nulla, aprato verde, bensì attraverso mirate operazioni di aggre-gazione e consolidamento strutturale, estese di frequentea reti di fornitori e sub-fornitori, capaci di assicurare van-taggi di flessibilità, apporti creativi ed alti livelli di capacitàmanifatturiere. È questo, a ben vedere, il modo in cui gliasset distrettuali possono trovare un nuovo posiziona-mento nel sistema industriale italiano, attraverso il loroinserimento nelle strutture a rete di imprese che sannoadottare questo tipo di “strategie di assemblaggio strategico”.
Le “nuove imprese distretto”, mentre sanno valorizzareal meglio le economie dei sistemi distrettuali di piccoleunità produttive, hanno nelle economie di integrazioneinteraziendale e nelle esternalità di rete, frutto della con-divisione di dati, informazioni e servizi, una nuova fontedi vantaggi competitivi. Naturalmente, per raggiungereobiettivi di questa portata è indispensabile fare affidamen-to sulla forza di Internet e dei software gestionali più avan-zati, come leva di aggregazione e di integrazione, pun-tando a conseguire vantaggi per l’impresa capofila (directnetwork effect) e per le altre imprese inserite nella suacatena del valore (cross network effect). Il che implica unosforzo complessivo di ridisegno delle filiere e delle reti perfavorire un impiego intelligente delle nuove tecnologiedell’informazione e delle comunicazioni.
D’altro canto, le banche e le istituzioni finanziarie sonochiamate a svolgere un ruolo particolare nell’asseconda-re, promuovere e supportare strategie di assemblaggiostrategico nel nostro sistema industriale. Data la situazio-ne di estrema frammentazione del tessuto imprenditoria-le, con diffuse situazioni di sottocapitalizzazione, ciò che
26
‹ Capitalismo e sviluppo ›G
LO
BA
LC
OM
PE
TIT
ION
7 -
20
06
Figura 3 - Addetti manifatturieri nei distretti industrialisecondo l’industria principale al 2001
Fonte: Elaborazione su dati ISTAT
587.320Meccanica
537.435Tessile e abbigliamento
382.332Beni per la casa
186.680Pelli, cuoio e calzature
116.950Oreficeria e strumenti musicali
48.585Prodotti in gomma e plastica
35.996Cartotecniche e poligrafiche
33.304Alimentari
27
GLO
BA
LC
OM
PE
TIT
ION
7 -
20
06
‹ Capitalismo e sviluppo ›
occorre sono forme e operazioni di private equity, appro-priate per il particolare contesto, capaci di incidere nell’e-voluzione della struttura finanziaria, del controllo proprie-tario e della condotta delle imprese, in una prospettivatemporale più estesa di quella adottata dalle istituzioni giàoperanti nel campo. È attraverso la riconfigurazione degliassetti proprietari e l’allargamento giudizioso della basesocietaria che passa la modernizzazione e il consolida-mento del nostro sistema industriale tradizionale, qualepre-condizione per l’attivazione di processi di crescita del-l’economia reale.
ii. L’esigenza di avere imprese con una loro identità edautonoma capacità di crescita emerge in termini evidentiguardando alla seconda direttrice di intervento cheriguarda il modello competitivo dei distretti industriali.
In presenza della digitalizzazione dell’economia, dell’ac-cresciuta pressione competitiva e della globalizzazione deimercati sono sempre più determinanti le capacità di inno-vazione, di relazione e di internazionalizzazione che siaccumulano nelle imprese e che vengono alimentate concontinui investimenti.
In questo quadro, la performance competitiva delleimprese diventa un fattore chiave mentre le imprese piùdotate sono destinate a giocare un ruolo chiave nellacompetitività delle economie distrettuali, tramite nuovimodi di relazionarsi e integrarsi con i tessuti imprenditoria-li locali. Stiamo in sostanza assistendo al passaggio da unasituazione in cui i fondamenti della competitività stavanonella macchina produttiva distrettuale ad un'altra in cuisono le imprese leader a giocare una parte fondamenta-le nel ricostruire le basi della nuova competitività, in fun-zione di maggiori capacità di investimento in risorseumane e finanziarie, nell’innovazione e nell’internaziona-lizzazione.
L’accesso alle nuove leve della competitività risulta quin-di selettivamente consentito solo alle imprese con unmodello di catena del valore più centrato sulle risorseimmateriali e sui servizi innovativi, che non sulla fabbrica.
Il passaggio ad un nuovo modello competitivo richiedeun generalizzato upgrading del capitale umano, a tutti ilivelli e in tutti gli ambiti del distretto e delle singole impre-se, per l’essenzialità dell’apporto di nuove e più elevatecompetenze tecnologiche e manageriali, da sviluppare inambienti imprenditoriali ed organizzativi dinamici e apertialla professionalità, al talento e al cambiamento. La com-petitività viene di conseguenza ad essere una componen-te strategica delle imprese che attivano investimenti nellaformazione e nel training delle proprie risorse umane, eche adottano politiche di reclutamento di talenti, da valo-rizzare con adeguati percorsi di inserimento, di fidelizza-zione e di crescita professionale e retributiva. Sono quin-di premiate le imprese capaci di formulare e attuare stra-tegie del personale avanzate, supportandole con unmodello organizzativo appropriato, più aperto e sfidante.
Su questi fronti si gioca per larga parte la capacità direcupero e di rilancio dell’industria italiana, ancora troppocondizionata da schemi e prassi che premiano la fedeltàpiuttosto che il merito dei collaboratori, dando spazio allaconservazione delle organizzazioni piuttosto che al lorocambiamento, in un’epoca in cui tutto si gioca invecesulla capacità e sulla velocità di innovazione della culturaimprenditoriale, delle idee, delle competenze e dei sistemioperativi.
iii. C’è in terza istanza, per dare coerenza e sostenibilitàad un nuovo disegno per la crescita e la competitività, l’e-sigenza di guardare a nuovi business models per le imprese.
La creazione di una autonoma e sistematica capacità diinnovazione di prodotto e di crescita sul mercato implicadi guardare oltre la tipica struttura tangible-intensive,come sbocco di un preciso e sistematico percorso strate-gico di riorganizzazione del business model, integrandola manifattura con investimenti intangibili (ricerca, innova-zione, branding, marketing, servizi, ecc.). Occorre insostanza passare da un modello tradizionale di impresa,fabbrico-centrico, ad un modello di impresa a più altaintensità di intangible assets.
Tutto ciò trova ragione nel fatto che le fonti del valoresono cambiate e tendono sempre più ad essere connesse a:
- investimenti sistematici e prolungati nel campo dellaricerca, del disegno e dell’innovazione, necessari per spo-stare in avanti ed elevare il tasso di creatività, originalità,perfezione tecnica e prestazionale dei prodotti; e questoper esercitare una difesa attiva nei confronti dei prodottidei paesi emergenti;
- idonee forme di tutela della proprietà intellettuale delleinvenzioni, delle idee e dei disegni, da concretizzarsi inbrevetti, marchi di fabbrica, copyright , o quant’altro utile;di fronte al diffondersi di pratiche di imitazione e contraf-fazione queste sono misure legali necessarie, ancorchénon sufficienti, per le imprese che fanno degli investimen-ti in ricerca e innovazione uno dei loro punti di forza;
- investimenti nella comunicazione e nel marketing perassicurare e promuovere l’identificazione, la valorizzazio-ne e la difesa attiva dei prodotti sul mercato, nei confron-ti dei consumatori, a livello di immagine e di brand;
- investimenti per la penetrazione e la presenza nelle reticommerciali e sui punti di vendita, cioè laddove si riesco-no a gestire le leve per ottenere maggiori e più forti fatto-ri attrattivi e legami con i consumatori.
Promuovere e realizzare la formazione di imprese capa-ci di adottare un business model di tipo diverso, fondatosu questi “pilastri” (innovazione, difesa della proprietàintellettuale, investimenti di marketing e sui punti di ven-dita) costituisce un passaggio obbligato per non disperde-re un patrimonio manifatturiero di eccellenza qual è quel-lo presente nei nostri distretti industriali.
La globalizzazione è una potente leva per una generaleriorganizzazione del business model distrettuale. Sempre
più i prodotti finali sono il risultato di una articolata e com-plessa integrazione delle filiere produttive su scala interna-zionale che supera il perimetro della tradizionale “fabbricadistrettuale”. D’altro lato, la perdita di competitività dal latodei costi nella realizzazione di certi tipi di prodotti, nell’ese-cuzione di fasi di lavorazione e componenti più labor inten-sive o standardizzate è ormai un dato acquisito. Il modo incui nei nostri distretti industriali si cerca di rispondere a que-ste sfide ci lascia purtroppo molto perplessi e preoccupati.Sono troppe le situazioni in cui ci si avventura in un decen-tramento di lavorazioni, fabbricazioni e forniture verso inuovi paesi a più bassi costi, isolatamente da una strategiadi innovazione del business model. E questo comporta evi-denti rischi a livello delle imprese che pongono in essere ildecentramento, dei distretti a cui esse appartengono e piùin generale del sistema paese.
Si tratta di modi improvvidi di trasferimento di cono-scenze, tecnologiche e know-how, nei nuovi paesi, favo-rendo e accelerando il loro processo di apprendimento, senza poter avere ritorni adeguati in termini di mezzi dainvestire nel consolidamento strutturale e strategico del proprio assetto.L’incapacità delle piccole imprese ad allinearsi ai nuoviparadigmi della globalizzazione emerge in termini chiariosservando ciò che hanno saputo fare le grandi impresee che in parte cercano di fare le nostre medie imprese.
Di fatto le grandi multinazionali, che da tempo hannomesso in atto decentramenti produttivi verso i nuovipaesi, hanno usato queste opportunità con l’intento diimpiegare i maggiori profitti realizzati, con i notevolirisparmi realizzati nei costi di produzione, per incrementa-re gli investimenti nella ricerca e nell’innovazione, nellapenetrazione e nel radicamento sui mercati esteri, nelrafforzamento della propria reputazione e della propriaidentità di marca, con mirate politiche di comunicazione.Di fatto queste imprese hanno disinvestito nel ramo mani-fatturiero per rafforzarsi nel ramo terziario, e quindi sfrut-tare le opportunità offerte dalla globalizzazione, senzaperdere il controllo delle parti strategiche della catena delvalore. E di conseguenza hanno modificato il proprioorganico riducendo drasticamente la base operaia a favo-re dell’inserimento di un maggiore e crescente numero diknowledge-workers con più alto livello di scolarizzazione.
Con la nascita di medie imprese che adottano businessmodel più centrati sull’innovazione e sul marketing chenon sulla manifattura si può come paese adottare percor-si di globalizzazione, nonché arginare la deriva della delo-calizzazione incontrollata, e nel contempo acquisire capa-cità di inserimento, presenza diretta e crescita sui nuovimercati. Il fatto distintivo di queste imprese nell’agoneinternazionale è la possibilità di avvalersi di capacità mani-fatturiere di eccellenza, quelle possedute dalle miglioripiccole imprese con peculiari attitudini e competenze nelforgiare prodotti unici, con una forte impronta e persona-lizzazione. Si vengono così a realizzare nuovi tipi di coali-
zioni tra le imprese front-desk che stanno sul mercato fina-le e le imprese bach-desk che operano nella catena mani-fatturiera, con la prospettiva di mettere in squadra e valo-rizzare in modo virtuoso le diverse competenze e specia-lizzazioni. Si tratta di una sorta di “via italiana alla globaliz-zazione” che mira a non disperdere il vasto e qualificatoknow-how manifatturiero, radicato nei distretti industriali,che sono così chiamati a rispondere alla sfida cercando diaumentare la loro efficienza produttiva per poter entraree permanere nelle reti di fornitura e sub-fornitura delleimprese medie nazionali. Per rendere possibili e favorirequesti processi di rifondazione dei sistemi distrettuali dipiccole imprese, evitando un loro irriducibile declino, ènecessaria l’introduzione di provvedimenti di liberalizza-zione e meccanismi di mobilità dei capitali, degli investi-menti e delle risorse umane, tali da consentire a livello diimpresa e di sistema paese una diversa, più efficiente allo-cazione generale delle risorse, tenuto conto delle nuovecondizioni dell’economia e della finanza a livello globale.
La presenza in Italia di limiti e vincoli alla mobilità dei fat-tori produttivi, a livello delle imprese e del sistema econo-mico nel suo insieme, costituisce un evidente freno allariorganizzazione del sistema industriale secondo gli indi-rizzi indicati. E questo è un grave danno per la competiti-vità e per la crescita economica.
Osservazione finale
L’Italia sta affrontando la sfida della nuova economiaglobale con il peso di un sistema industriale che, essendoin ritardo nel suo processo di rinnovamento e riorganizza-zione, non si presenta all’altezza della situazione. I distret-ti industriali non sfuggono a questa valutazione. Anzi, permolti aspetti, costituiscono il banco di prova della capacitàdi affrontare e possibilmente vincere la sfida.
Se, com’è ragionevole ritenere, l’economia italiananon potrà fare a meno ancora a lungo dell’apporto deidistretti, è fondamentale uscire da una logica puramen-te conservativa e dall’idea che siano sufficienti piccoliadattamenti.
Non correggere con decisione ed in profondità talunetendenze involutive, che minano alla base le fondamentadel tessuto distrettuale, significherebbe andare verso unirreversibile declino o comunque un forte ridimensiona-mento di una componente importante e insostituibile delnostro sistema industriale.
In questa sede più che ricette si è offerto uno schemadi riflessione e di analisi con spunti per interventi di policyper incidere sul modello di crescita e sul modello di com-petitività dei sistemi distrettuali e sulla riconfigurazionedelle filiere e del business model del distretto, per il trami-te delle imprese con un maggiore e più promettentepotenziale competitivo, sulle quali vanno selettivamenteconcentrate le attenzioni e le risorse, con interventi dipolitica economica e industriale ben mirati e strutturati.
‹ Capitalismo e sviluppo ›
28
GLO
BA
LC
OM
PE
TIT
ION
7 -
20
06
29
GLO
BA
LC
OM
PE
TIT
ION
7 -
20
06
‹ Capitalismo e sviluppo ›
Bibliografia
L. Bacci (a cura di), Distretti e imprese leader nel sistemamoda della Toscana, F. Angeli, Milano, 2004.
Banca d’Italia, Economie locali, modelli di agglomera-zione e apertura internazionale, Roma, 2004.
G. Becattini, Distretti industriali e made in Italy,Boringhieri, Torino, 1998.
N. Bellanca, M. Dardi, T. Raffaelli (a cura di), Economiasenza gabbie, il Mulino, Bologna, 2004.
G. Bosi, G. Scellato, Politiche distrettuali per l’innovazio-ne delle regioni italiane, Roma, Fondazione Cotec, 2005.
M. Caroli, A. Lipparini (a cura di), Piccole imprese oltreconfine, Carocci, Roma, 2002.
L. Ferrucci, R. Varaldo, “La natura e la dinamica dell’im-presa distrettuale”, in Economia e Politica Industriale, n. 80, 1993.
M. Fortis, Il made in Italy nel “nuovo modello”: protago-nisti, sfide, azioni, Ministero delle attività produttive,Roma, 2005.
G. Garofoli (a cura di), Impresa e territorio, il Mulino,Bologna, 2003.
ICE, La posizione competitiva dell’Italia nell’economiainternazionale, Roma, 2005.
G. Micucci, “Politiche di marchio e pubblicità nei distret-ti industriali: un’analisi con dati a livello di impresa”, inRivista Italiana degli Economisti, 3/2001.
G. Nardozzi, Miracolo e declino, Laterza Roma-Bari, 2004.
F. Onida, Se il piccolo non cresce, il Mulino, Bologna, 2004.
A. Quadrio Curzio, M. Fortis M., Complessità e distrettiindustriali. Dinamiche, modelli, casi reali, il Mulino,Bologna, Ottobre 2002.
B. Quintieri (a cura di), Le imprese esportatrici italiane:caratteristiche, performance e internazionalizzazione, ilMulino, Bologna, 2001.
Rapporto MET, Le politiche per la competitività delleimprese, Donzelli, Roma, 2005.
A. Sammarra, Lo sviluppo dei distretti industriali.Percorsi evolutivi fra globalizzazione e localizzazione,Carocci, Roma, 2003.
L. F. Signorini (a cura di), Lo sviluppo locale, Donzelli,Roma, 2000.
C. Trigilia, Sviluppo locale. Un progetto per l’Italia,Laterza, Roma - Bari, 2005.
Unioncamere, Rapporto 2005. L’economia reale dal puntodi osservazione delle Camere di commercio, Roma, 2005.
Unioncamere, Istituto Tagliacarne, Le piccole e medieimprese nell’economia italiana. Rapporto 2004, F. Angeli,Milano, 2005.
R. Varaldo, “Il distretto industriale oltre la fabbrica”, in B.Quintieri (a cura di), I Distretti industriali italiani dal Locale alGlobale, Rubbettino Editore, Soveria Mannelli (CZ), 2005.
R. Varaldo, “Il nuovo modello competitivo e aziendaledei distretti industriali”, in Economia e Politica Industriale,n. 1, 2006.
G. Viesti, Come nascono i distretti industriali, Laterza,Roma-Bari, 2000.
Libri in vetrina a cura di Gianfranco Fabi
“Goodbye Europa” Alberto Alesina e FrancescoGiavazzi - Ed. Rizzoli - Milano -2006 - pagg. 220 - € 18. Il titolo non ispira certamentel’ottimismo. Goodbye Europa,cronache di un declino eco-nomico e politico. AlbertoAlesina e Francesco Giavazzi(due professori universitarieditorialisti, il primo adHarvard e sul Sole-24 Ore, ilsecondo alla Bocconi e sul
“Corriere della Sera”) hanno tuttavia scritto questo librocon l’esplicita speranza che un supplemento di riflessio-ne possa aiutare l’Europa ad uscire oltre che da unasostanziale stagnazione economica anche da una peri-colosa incapacità di elaborare una coraggiosa svoltapolitica. C’è un motivo di fondo che percorre tutto illibro: è un appello alle virtù del mercato contro le mol-teplici tentazioni del nazionalismo, del protezionismo,di un welfare inefficiente e costoso, della spesa pubbli-ca come motore dello sviluppo. Ma non si tratta di uninvito all’applicazione pura e semplice delle teorie delliberismo più sfrenato: Alesina e Giavazzi danno inveceprova di un sano pragmatismo, di un’osservazioneattenta e disincantata della realtà. Gli Stati Uniti nonsono considerati un modello da seguire in tutto e pertutto anche perché, come è il caso della sanità, ci sonoelementi nell’esperienza europea che possono esserecorretti e resi più efficienti mentre l’esperienza america-na ha creato un sistema più costoso e con minorigaranzie di equità. Ma gli Stati Uniti restano un model-lo sotto molti aspetti: il mercato del lavoro, in primoluogo, un mercato che premia il merito, favorisce laproduttività, alimenta il senso di responsabilità e quindilo spirito di intraprendenza delle persone. E poi lalibertà di movimento per le imprese: libertà di nasceresenza troppi oneri burocratici, libertà di svilupparsi,senza troppi intralci fiscali, libertà di fallire senza grava-re lo Stato di oneri sociali. Un libro quindi di profondaattualità con un invito costante ai Paesi europei perchétaglino la spesa pubblica e riducano l’invadenza delloStato. Ancor più di attualità in un’Italia in cui i tagli allaspesa pubblica sono una costante nei dibattiti sulla poli-
tica economica, con tantelobby che tuttavia li rendono difatto impraticabili.
“ Il mondo è piatto” Thomas L. Friedman - I -Milano - 2006 - pagg. 580 € 22.Siamo di fronte ad una nuovarivoluzione copernicana e nonce ne siamo ancora accorti.Con Cristoforo Colombo ave-vamo avuto la prova che il
mondo era rotondo ed ora ci tocca scoprire che “ilmondo è piatto”. L’immagine di Thomas L. Friedman,editorialista di politica estera del New York Times, èindubbiamente affascinante: non vuole, ovviamente,ridare attualità al sistema tolemaico, ma informarci chela globalizzazione ha fatto grandi passi avanti rispettoalla visione tradizionale legata all’apertura dei mercatie alle grandi potenzialità dell’informatica applicata alletelecomunicazioni (che qualcuno chiama infotelematica).Siamo di fronte ad una trasformazione che sta cambian-do profondamente il modo di produrre, le strategie diinvestimento delle imprese, i parametri di una competi-zione che va oltre i fattori di prezzo, di qualità, di servi-zio. Il mondo è piatto perché ci sono sempre meno posi-zioni naturali di vantaggio competitivo: il terreno digioco si sta livellando e le potenzialità delle nuove econo-mie stanno creando le condizioni per una sfida semprepiù ampia e per crescenti opportunità di integrazione.È particolarmente significativo che l’ispirazione del tito-lo del libro sia venuta a Thomas L. Friedman dalle osser-vazioni raccolte in un viaggio a Bangalore, la SiliconValley dell’India, la zona dove si è maggiormente svilup-pata l’industria del software e dei servizi informatici edove molte imprese americane (e anche europee)hanno delocalizzato non solo i centri di ricerca e svilup-po, ma anche i servizi di assistenza e i call center perdialogare con i clienti e per cercarne di nuovi. Solo ilfuso orario rende Bangalore funzionalmente diverso daun quartiere di una città americana: ma anche questodiventa un’opportunità perché comunque alcuni callcenter devono funzionare 24 ore su 24. Siamo così difronte ad economie non solo virtualmente, ma concre-tamente integrate, un’unica, grande economia mon-diale: è questa in fondo la lezione di storia di ventune-simo secolo per ora breve, ma già capace di una rivo-luzione silenziosa molto più incisiva delle rivoluzioniroboanti.
“Voyage aux pays du coton” Erik Orsenna - Ed. Fayard - Parigi - 2006 - Pagg. 294 -€ 20.“Questa storia comincia nella notte dei tempi. Un uomoche cammina vede un arbusto i cui rami terminano condei fiocchi bianchi. Si può avvicinare che abbia avvicina-to la mano. E il genere umano ha fatto conoscenza con
la dolcezza del cotone”. Non èsolo un artificio letterario, quelloscelto da Erik Orsenna,dell’Académie française, per par-lare della globalizzazione. Il coto-ne è infatti uno dei prodotti chehanno segnato la storia dello svi-luppo di molti paesi, Stati Uniticompresi, che hanno contraddi-stinto non solo gli scambi, maanche l’organizzazione sociale edel lavoro, che hanno costituito
30
GLO
BA
LC
OM
PE
TIT
ION
7 -
20
06
la base di grandi eventi storici come la schiavitù o lacolonizzazione. Ma il cotone, insieme prodotto agricoloe industriale, materia prima e semilavorato (per esem-pio, l’olio di semi alimentare deriva in gran parte pro-prio dai semi di cotone), frutto di una tradizione mille-naria, ma con una forte dose di innovazione, è ora unesempio di una globalizzazione che cammina a passirapidi, ma che si presenta ancora con grandi differenzee profonde diversità. Ecco allora un viaggio che partedal Mali, in Africa, percorre gli Stati Uniti e il Brasile, ritor-na in Egitto per passare in Uzbekistan e terminare inCina. Tanti modi di produrre, di coltivare, ma soprattut-to di organizzare la società, l’economia, il sistema degliscambi, i rapporti produttivi e commerciali. ErikOrsenna non compie un viaggio solo nello spazio,attraverso i paesi e i continenti, ma anche nel tempo,nei cambiamenti produttivi e nel sistema degli scambi:ne esce un’immagine insolita della globalizzazione, unavisione che non dimentica la fatica dell’uomo, ma insie-me il gusto del bello, che non privilegia i fattori virtuali,come l’informatica o le telecomunicazioni (pur impor-tanti), ma che pone all’attenzione gli elementi più signi-ficativi dell’economia reale: la persona, l’organizzazio-ne, la capacità di governare i fattori dell’economia.
“Capitalismi - Asia, StatiUniti, Europa nell’econo-mia globale” Napoleone Colajanni -Sperling & Kupfer editori -Milano - 2006 - pagg. 430 - €18.Già il titolo è indicativo dellatesi di fondo. “Capitalismi” perindicare il fatto che di econo-mia di mercato non ce n’èuna sola, ma esistono tantevie diverse non solo perEuropa e Stati Uniti, ma ancheconsiderando le nuove aree
prepotentemente emerse negli ultimi anni, come laRussia e soprattutto le economie dell’Asia. Napoleone Colajanni ha consegnato alle stampe questolibro pochi giorni prima della sua morte e Marcello Villarine ha curato gli ultimi particolari per la pubblicazione.Colajanni è stato per quasi tutta la sua vita un comuni-sta, iscritto al Pci, membro del Comitato centrale. Negliultimi anni se n’era allontanato: paradossalmente,essendo lui un profondo riformista, proprio in dissensocon la linea di cambiamento che avrebbe portato alcambio della “ragione sociale”. Ed è significativo che laparabola di Colajanni si sia conclusa con un’apprezzatarubrica settimanale sul Sole-24 Ore.In questo libro c’è – come afferma Villari – “un affrescodel mondo in cui viviamo e soprattutto un insegnamen-to: sono le differenze che aiutano a capire le varie realtàche compongono il nostro mondo, non le arbitrariegeneralizzazioni di un pensiero unico diventato da
tempo la soffocante ideologia dominante”. C’è in fondoin questo saggio il cammino di un economista che haun approccio dichiaratamente marxista, ma che riesce afar prevalere il pragmatismo della ragione rispetto alleclassificazioni delle ideologie. “Pensare che il capitalismopossa crollare da solo è una sciocchezza” affermaColajanni. Ma lo stesso capitalismo dimostra che i cam-biamenti sono possibili, che una maggiore giustiziasociale può trovare le basi nella capacità di sviluppo cheè propria dell’economia di mercato, che le rituali con-traddizioni della società occidentale possono essere cor-rette da Governi efficienti e che non siano solo occupa-ti a ricercare il consenso, se non il potere.
“Le défi du monde” Claude Allègre e DenisJeambar - Le défi du monde -Ed. Fayard - Paris - 2006 -pagg. 286 - € 19.Un dialogo tra ClaudeAllègre, professore all’Istitutouniversitario di Francia eministro dell’Educazione,della ricerca e della tecnolo-gia dal ’97 al 2000, e il diret-tore dell’Express, DenisJeambar, un dialogo che è
soprattutto un cammino attraverso i grandi temi di unmondo globalizzato in cui sembrano ancora mancarele linee guida per il futuro. Con un’ottica particolare:la fiducia nella capacità dell’uomo di saper controllarelo sviluppo, un controllo possibile soprattutto se sisaprà avere un’adeguata responsabilità sulle scelte dacompiere e sulle conseguenze di queste scelte.E’ per esempio significativo che le due parole chiaveche gli autori mettono a conclusione del loro viaggiosiano: riciclaggio e complessità. Riciclaggio perché trai problemi più gravi vi è lo sfruttamento delle materieprime, con il petrolio in prima fila e la necessità dicombattere l’inquinamento e l’effetto serra. “Abbiamol’obbligo di preservare gelosamente gli equilibri natu-rali: composizione dell’atmosfera e dell’oceano, biodi-versità, equilibrio uomo-natura”. Complessità perché siamo in presenza di fattori multi-pli che reagiscono gli uni con gli altri e che non si pos-sono né analizzare né comprendere seguendo la logi-ca semplice di causa ed effetto a cui siamo stati abitua-ti ed istruiti. Ecco allora la necessità di affrontare conrisposte nuove le problematiche nuove: per questo ènecessario credere che la risposta ai problemi non stianel bloccare lo sviluppo, ma nel puntare sulla crescita,sull’innovazione, sulla scoperta, sul sapere, sulla cono-scenza. Senza i blocchi ideologici che contraddistin-guono quasi sempre, anche in Italia, i dibattiti su temicome l’energia nucleare o gli Ogm. Un invito costrut-tivo alla riflessione quindi. Tanto più utile quanto raro.
31
GLO
BA
LC
OM
PE
TIT
ION
7 -
20
06
SOMMARI
N. 1 - L’ECONOMIA ITALIANA NELLA GLOBALIZZAZIONE
N. 2 - EUROPA E ITALIA DI FRONTE AL RISVEGLIO ASIATICO
N. 3 - LA SFIDA ENERGETICA
N. 4 - DIFFICOLTÀ E PROSPETTIVE DELL’INDUSTRIA
N. 5 - INFRASTRUTTURE E RETIPER CRESCERE IN EUROPA
N. 6 - VALORIZZARE IL CAPITALE UMANO
I numeri pubblicati