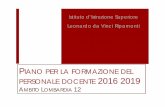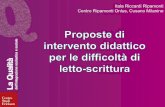L GRUPPO RIPAMONTI - shop.erickson.it · VCLA-Frasi (indicato da 11-12 a 15-16 anni) fornisce...
Transcript of L GRUPPO RIPAMONTI - shop.erickson.it · VCLA-Frasi (indicato da 11-12 a 15-16 anni) fornisce...
Le recenti ricerche nell’ambito delle dif� coltà di letto-scrittura stanno mettendo in luce l’accezione di Distur-bo della Comprensione del Testo, spesso indipenden-
te da dif� coltà di decodi� ca e de� cit fonetico-fonologici. Tale disturbo chiama in causa abilità linguistiche comples-se, de� nite anche come «sensibilità linguistica».VCLA-Frasi (indicato da 11-12 a 15-16 anni) fornisce indica-zioni speci� che rispetto a una fascia di età ancora poco esplorata, valutando le capacità sia di utilizzare strutture morfosintattiche all’interno di contesti articolati, sia di inte-grare le competenze linguistiche e logico-cognitive. L’utiliz-zo combinato di questo test e di VCLA-Parole (che indaga i prerequisiti al linguaggio alto) permette di avere un quadro signi� cativo che rileva le problematiche linguistiche dei ra-gazzi che arrivano alla valutazione in età adolescenziale. Pensato per l’ambito clinico e per scopi diagnostici e riabi-litativi, il test può essere somministrato anche da terapisti e psicopedagogisti, al � ne di individuare e predisporre trattamenti di recupero e/o elaborare progetti didattici.
Il software allegato al volume permette di automatizza-re l’elaborazione dei risultati e la loro archiviazione. Nel CD-ROM sono inoltre contenuti i protocolli stampabili per
l’esaminatore e l’alunno e la griglia in cui raccogliere i dati relativi alle singole somministrazioni.
Requisiti: • Windows 10, Windows 8, Windows 7 con Processore 1 GHz o sup. e min. 1 GB di RAM • Risoluzione minima schermo 1024x768 a 65.000 colori (16 bit) • 150 MB di spazio libero su disco � sso • Microsoft .NET Framework 3.5 • Il software richiede la con-nessione a Internet per l’attivazione e l’elaborazione dei risultati
€ 39,00Manuale + CD-ROM
indivisibili
l’esaminatore e l’alunno e la griglia in cui raccogliere i dati relativi alle singole somministrazioni.
GRU
PPO
RIP
AM
ON
TIVC
LA-F
RASI
Val
utaz
ione
del
le c
ompe
tenz
e lin
guist
iche
alte
VCLAFRASI
VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE LINGUISTICHE ALTE
GRUPPO RIPAMONTIITALA RICCARDI RIPAMONTI, VALENTINA RUSSO, BARBARA CIVIDATI,
CARLO ALBERTO ZERBINI, KATIA FEDERICO E ILARIA ROSSONI
PROVE PER LA VALUTAZIONEDELLA FLESSIBILITÀ E DELLA CAPACITÀ DI INTEGRAZIONE
TRA LE COMPETENZE LINGUISTICHE E COGNITIVE
ETÀ
CONSIGLIATA
11-16
Le recenti ricerche nell’ambito delle dif� coltà di letto-scrittura stanno mettendo in luce l’accezione di Distur-bo della Comprensione del Testo, spesso indipenden-
te da dif� coltà di decodi� ca e de� cit fonetico-fonologici. Tale disturbo chiama in causa abilità linguistiche comples-se, de� nite anche come «sensibilità linguistica».VCLA-Frasi (indicato da 11-12 a 15-16 anni) fornisce indica-zioni speci� che rispetto a una fascia di età ancora poco esplorata, valutando le capacità sia di utilizzare strutture morfosintattiche all’interno di contesti articolati, sia di inte-grare le competenze linguistiche e logico-cognitive. L’utiliz-zo combinato di questo test e di VCLA-Parole (che indaga i prerequisiti al linguaggio alto) permette di avere un quadro signi� cativo che rileva le problematiche linguistiche dei ra-gazzi che arrivano alla valutazione in età adolescenziale. Pensato per l’ambito clinico e per scopi diagnostici e riabi-litativi, il test può essere somministrato anche da terapisti e psicopedagogisti, al � ne di individuare e predisporre trattamenti di recupero e/o elaborare progetti didattici.
Il software allegato al volume permette di automatizza-re l’elaborazione dei risultati e la loro archiviazione. Nel CD-ROM sono inoltre contenuti i protocolli stampabili per
l’esaminatore e l’alunno e la griglia in cui raccogliere i dati relativi alle singole somministrazioni.
Requisiti: • Windows 10, Windows 8, Windows 7 con Processore 1 GHz o sup. e min. 1 GB di RAM • Risoluzione minima schermo 1024x768 a 65.000 colori (16 bit) • 150 MB di spazio libero su disco � sso • Microsoft .NET Framework 3.5 • Il software richiede la con-nessione a Internet per l’attivazione e l’elaborazione dei risultati
€ 39,00Manuale + CD-ROM
indivisibili
l’esaminatore e l’alunno e la griglia in cui raccogliere i dati relativi alle singole somministrazioni.
GRU
PPO
RIP
AM
ON
TIVC
LA-F
RASI
Val
utaz
ione
del
le c
ompe
tenz
e lin
guist
iche
alte
VCLAFRASI
VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE LINGUISTICHE ALTE
GRUPPO RIPAMONTIITALA RICCARDI RIPAMONTI, VALENTINA RUSSO, BARBARA CIVIDATI,
CARLO ALBERTO ZERBINI, KATIA FEDERICO E ILARIA ROSSONI
PROVE PER LA VALUTAZIONEDELLA FLESSIBILITÀ E DELLA CAPACITÀ DI INTEGRAZIONE
TRA LE COMPETENZE LINGUISTICHE E COGNITIVE
ETÀ
CONSIGLIATA
11-16
7 Premessa
9 Introduzione
17 CAP. 1 Contesto teorico
25 CAP. 2 Struttura, presentazione dei materiali, procedure di somministrazione, scoring e attribuzione del punteggio
35 CAP. 3 Presentazione di casi
39 CAP. 4 Proprietà psicometriche del test VCLA-Frasi
55 CAP. 5 Discussione e conclusioni
59 CAP. 6 Struttura del software VCLA-Frasi e modalità di somministrazione
69 Bibliografia
73 Appendice A: Approfondimenti statistici
91 Appendice B: Protocolli e griglia di correzione
115 Appendice C: Indici descrittivi del campione normativo
121 Appendice D: Indice delle tabelle e delle figure
I n d i c e
Introduzione
L’idea di elaborare un test per valutare le Competenze Linguistiche Alte si è concretizzata negli anni, in seguito all’esperienza clinica e riabilitativa con bambini e ragazzi, a partire dalla quarta/quinta classe di scuola primaria, fino ad arrivare alla scuola secondaria di secondo grado.
Infatti, diversi studenti — segnalati per difficoltà di apprendimento della letto-scrittura o/e per un deficit nella comprensione del testo scritto — spesso, evidenziano un utilizzo della lingua, orale e scritto, povero a livello sia di lessico sia di strutture.
Ciò si rileva, a volte, sia in soggetti mai segnalati per difficoltà di linguaggio, sia in ragazzi trattati per un Disturbo Specifico del Linguaggio (DSL) apparente-mente compensato (sulla base delle valutazioni fatte con i test in uso).
Diversi studi presenti in letteratura (Rispens, Roeleven e Koster, 2004; Stein, Cairns e Zurif, 1984; Byrne, 1981; Waltzman e Cairns, 2000; Joanisse et al., 2000; Cain e Nash, 2011) dimostrano l’esistenza di un ritardo nell’acquisizione delle strutture sintattiche e della morfologia flessiva sia nei bambini a rischio (primo ciclo della scuola dell’infanzia) sia nei dislessici, rispetto ai loro compagni normo-lettori.
Recenti lavori (Oakhill, 2011) stanno inoltre evidenziando accanto al profilo della dislessia, intesa come disturbo specifico della decodifica, anche l’accezione di disturbi della comprensione del testo scritto, indipendenti sia dalle difficoltà di comprensione da ascolto che dagli stessi disturbi di lettura.
Nel nostro gruppo di lavoro ha così preso consistenza l’ipotesi di una debolezza nelle predisposizioni linguistiche innate, che non sostiene l’individuo
10 VCLA-FrAsi
quando, con l’aumentare del livello scolastico, deve far fronte a richieste via via più complesse.
Questa idea trova riscontro — oltre che nelle nostre valutazioni con i singoli ragazzi segnalati per difficoltà di apprendimento e di comprensione del testo scritto — in diversi studi recenti che indicano la presenza di difficoltà linguistiche (non necessariamente e non esclusivamente fonologiche) in molti dislessici (Do-nato, Stella e Guzzo, 2010; Riccardi Ripamonti et al., 2008; Rispens, Roeleven e Koster, 2004; Stein, Cairns e Zurif, 1984; Byrne, 1981: Waltzman e Cairns, 2000; Joanisse et al., 2000). La nostra esperienza conferma l’ipotesi che — senza escludere difficoltà negli ambiti coinvolti nella comprensione di un testo, quali memoria, attenzione, capacità inferenziale, di integrazione, ecc. — alla base del disturbo di comprensione ci siano difficoltà linguistiche talvolta mai segnalate o, comunque, non completamente superate, che emergono con evidenza solo davanti a richieste elevate, come quelle che gli studenti incontrano nella scuola secondaria. Questo avviene non solo nella comprensione dei testi scritti, ma anche nell’elaborazione degli stessi e nell’espressione orale.
Le ragioni per le quali questi soggetti arrivano alla valutazione clinica in età avanzata si possono ricondurre al fatto che, fino al termine del primo ciclo della scuola primaria, né la famiglia né la scuola — solitamente — si preoccupano di segnalare bambini che si esprimono con un lessico limitato e/o con strutture mor-fosintattiche povere o carenti mentre, più facilmente, richiedono una valutazione per coloro che presentano un deficit fonetico-fonologico. In effetti, molti ragazzi, nella fascia di età dai 9 anni in su, giunti alla nostra osservazione per difficoltà di apprendimento — che pur manifestavano evidenti difficoltà di espressione e comprensione a livello di testo scritto e di oralità — sottoposti ai test linguistici tradizionali, non hanno evidenziato particolari carenze. Gli stessi studenti, invece, hanno talvolta presentato cadute significative ai test VCLA-Parole e VCLA-Frasi e al quoziente verbale del test WISC-III.
Abbiamo, infatti, più volte constatato come queste difficoltà non sempre vengano rilevate dai test in uso — rivolti, principalmente, a fasce di età più bas-se — oppure, i test che le segnalano non forniscono informazioni precise sulle caratteristiche della problematica e quindi indicazioni specifiche per il trattamento riabilitativo. Il mancato o tardivo riconoscimento di queste difficoltà determina una ricaduta negativa sulla fluidità di lettura e sulla comprensione del testo che potranno palesarsi magari solo nell’affrontare i testi delle scuole secondarie.
Competenze Linguistiche Alte e Sensibilità Linguistica
I test VCLA-Parole e VCLA-Frasi vanno a valutare le Competenze Lin-guistiche Alte interpellate soprattutto a partire dalla fine della scuola primaria
11IntroduzIone
quando le strutture linguistiche dei testi diventano più complesse, non solo a livello lessicale (inferenze, sottintesi, metafore, incisi, strutture verbali complesse implicite ed esplicite, coordinate e subordinate, con conseguente uso di avverbi, pronomi, congiunzioni, ecc.). Il raggiungimento di queste competenze prevede che il soggetto possa contare su una buona «sensibilità linguistica».
Con Sensibilità Linguistica intendiamo quella competenza del parlante nella lingua madre che gli consente di utilizzare, senza bisogno di conoscerle consapevolmente, le regole che sottendono le strutture linguistiche, in particolare quelle morfosintattiche, come avviene, ad esempio, per un bambino che, prima della scolarizzazione, spesso utilizza congiuntivi, condizionali, pronomi e frasi complesse, correttamente, in modo «intuitivo». La stessa competenza permette a un lettore esperto di fare automaticamente anticipazioni — sulla base delle aspettative indotte dal rispetto della morfosintassi — che velocizzano la lettura. La sensibilità linguistica fa quindi riferimento alle predisposizioni linguistiche innate che differiscono, a volte in maniera rilevante, da individuo a individuo e possono diventare determinanti per accedere alle strutture verbali più alte, tipiche dei testi scritti delle scuole secondarie, e per esprimere concetti e argomenti che esulano dalla quotidianità.
Rispens e Been (2007) utilizzano il concetto di «sensibilità al linguaggio» per definire i problemi linguistici che evidenziano i Disturbi Specifici di Appren-dimento (DSA).
Pinker (1994) chiama «istinto del linguaggio» quella che viene da noi definita «sensibilità linguistica». Lo stesso concetto viene ripreso da Denes (2009), nel suo testo Parlare con la testa: le basi neurologiche e la struttura del linguaggio:
Un punto fondamentale [...] è rappresentato dalla capacità che ha ogni appartenente alla specie umana di apprendere naturalmente il linguaggio, senza un’istruzione specifica, mediante un meccanismo di assimilazione genetica (effetto Baldwin): ogni individuo, data la plasticità del suo fenotipo, può adattarsi nel modo migliore all’ambiente in cui vive, rinforzando o modifi-cando alcune caratteristiche innate fisiche o comportamentali e consentendo quindi al processo di apprendimento di divenire innato. (Denes, 2009, p. 11)
Lo stesso autore, a proposito dell’evoluzione delle strutture grammaticali, scrive:
Una linea di pensiero considera la grammatica come la conseguenza dell’evoluzione di una struttura grammaticale innata attraverso un processo di selezione naturale, che ha portato allo sviluppo di un sistema che permette di codificare informazioni proposizionali di sempre maggior complessità, come quelle veicolate da parole a classe chiusa (pronomi, avverbi, ecc.). [...] Per altri, invece, l’emergere della struttura grammaticale non è considerato come il prodotto di un adattamento biologico, ma come l’effetto di una trasmis-
2Struttura, presentazione dei materiali,
procedure di somministrazione, scoring e attribuzione del punteggio
Nel definire il test abbiamo utilizzato il termine «competenze linguistiche alte» perché gli studenti, nella scuola secondaria, si trovano a far fronte a richieste elevate (vale a dire testi linguisticamente e concettualmente complessi che spesso fanno riferimento ad argomenti non conosciuti).
In effetti la nostra esperienza ha rilevato cadute al test anche in individui che non hanno mai ricevuto una diagnosi di DSL. Questo ci ha fatto pensare a una carenza nelle predisposizioni innate perché, diversamente, gli stimoli ambientali e l’integrazione con le altre competenze cognitive avrebbero consentito una compensazione. In effetti, soggetti che — a fronte di un buon bagaglio linguistico — presentano problemi attentivi o selettivi nella memoria di lavoro sembrano non cadere al test. Il quadro che emerge in tal caso permette di escludere difficoltà linguistiche e la diagnosi andrà approfondita in altre direzioni.
Come è stato costruito il test
In considerazione delle informazioni attese dalla somministrazione del test, la struttura che è sembrata più consona per la costruzione della prova VCLA-Frasi è stata quella del test CPM – Matrici di Raven, che va a misurare l’intelligenza non verbale, attraverso il completamento di una serie di figure. Nel predisporre il test è stato fatto riferimento ad alcuni parametri, propri della struttura delle prove
26 VCLA-FrAsi
Raven ad esempio: chiusura/completamento, inferenze, cogliere sfondo/signi-ficato generale, discriminazione dati rilevanti e non, sequenzialità, relazioni, ecc. La modalità di presentazione non richiede troppe spiegazioni, sollecita risposte spontanee, pressoché immediate, ed è quindi sembrata idonea per valutare il livello delle predisposizioni linguistiche e la capacità di integrarle rapidamente con le competenze cognitive e logiche più complesse (già prese in esame a livello elementare con VCLA-Parole).
VCLA-Frasi va a indagare competenze che, solitamente, vengono acquisite in modo spontaneo, solo attraverso l’esposizione agli stimoli ambientali, e le valuta attraverso la capacità di completare un gruppo di frasi, o un periodo, rispettandone l’uniformità, cogliendone la relazione, in osservanza delle regole morfosintattiche della struttura frasale e della coerenza semantica. Richiede, pertanto, di integrare le capacità linguistiche (innate e apprese) con quelle cognitive.
In quest’ottica, il test è stato suddiviso in due aree distinguibili per la struttura degli item:
– Area A: completamento di una singola frase o di un periodo– Area B: relazione tra due/quattro frasi.
Prova pilota
Una prima versione del test è stata somministrata (nel 2010) a un gruppo di 60 ragazzi della scuola secondaria di primo grado (20 per ogni classe del trien-nio) e sulla base dei riscontri avuti sono state ristrutturate alcune parti. La nuova versione è stata riproposta a 60 studenti di secondaria di primo grado (20 per classe) e a 30 studenti di secondaria di secondo grado (15 per classe di prima e seconda), il che ha permesso ancora alcune piccole correzioni:
– modifica di alcune frasi facilmente equivocabili: ad esempio, nell’item A6 la risposta «che gli aveva prescritto» è stata sostituita con «che lui aveva prescritto loro»;
– sostituzione di alcune parole all’interno degli item: ad esempio, nell’item B9 è stato inserito «grigio e nero» al posto di «bianco e nero», in modo tale che i due aggettivi non fossero opposti l’uno all’altro, il che poteva indurre in equivoco circa la scelta della risposta.
Inoltre, l’analisi statistica ha suggerito alcune modifiche strutturali:
– è stata migliorata la modalità di somministrazione del test, eliminando la risposta automatica (che si trova in diversi item della prova VCLA-Parole), in quanto non risultava statisticamente rilevante, ed è stata inserita, invece, la possibilità di correzione (modificando, così, anche l’attribuzione dei punteggi);
27Struttura, preSentazione dei materiali, procedure di SomminiStrazione, Scoring
– è stato riorganizzato l’ordine di presentazione degli item in base al grado di difficoltà degli stessi;
– sono stati eliminati alcuni item non statisticamente rilevanti;– sono stati definiti e standardizzati i tempi massimi di risposta corretta entro
cui attribuire il punto, in modo da poter meglio discriminare tra il campione normativo e quello clinico (5, 8, 15 secondi).
Infine il test, nella sua versione definitiva, è stato somministrato al campione totale di 421 normo-lettori e, successivamente, di 120 dislessici.
Composizione del test
Il test VCLA-Frasi (Valutazione delle Competenze Linguistiche Alte – Frasi) è composto da due aree (A e B) formate entrambe da 11 item, anticipati da un item di prova.
Area A
Quest’area valuta la capacità di completare il periodo cogliendone l’uniformità e rispettando sia la coesione grammaticale sia la coerenza semantica. In figura 2.1 viene riportato, a scopo esemplificativo, l’item di prova.
La maestra fa l’appello, interroga i bambini, ____________________________, corregge i compiti, dà i voti.
1) pulisce i banchi 2) ascolterà la lezione 3) spiega la lezione 4) si pettina
Fig. 2.1 Item di prova (Area A).
Area B
Quest’area valuta la capacità di cogliere le relazioni esistenti tra alcune frasi target, inserendone un’altra a scelta, che rispetti sia la coesione grammaticale, sia la coerenza semantica, presentate in forma discorsiva (figura 2.2) o con una modalità strutturata in tabella (figura 2.3).
In particolare, si indaga la capacità di individuare l’uniformità della struttura linguistica, le relazioni di opposizione, di causalità e temporalità, di inversione agente/agito, tenendo conto dei tempi verbali.
4Proprietà psicometriche
del test VCLA-Frasi
Il campione
Il test è stato somministrato a 237 soggetti normo-lettori e a un gruppo di 98 DSA, entrambi frequentanti la scuola secondaria di primo grado, e a 182 studenti della scuola secondaria di secondo grado (primo e secondo anno) e 22 DSA di pari età.
Nelle tabelle 4.1 e 4.2 è possibile osservare la numerosità del campione per classe nella scuola secondaria di primo (SSPG) e di secondo grado (SSSG).
TABELLA 4.1Numerosità del campione
per classe (SSPG)
Scuola secondaria di primo grado
Classe Campione normativo Campione clinico (DSA)
Prima 69 43
Seconda 73 34
Terza 95 21
40 VCLA-FrAsi
TABELLA 4.2Numerosità del campione
per classe (SSSG)
Scuola secondaria di secondo grado
Classe Campione normativo Campione clinico (DSA)
Prima 98 17
Seconda 84 5
Indici descrittivi del campione normativo
Nelle tabelle 4.3, 4.4 e 4.5 sono riportati gli indici descrittivi (media, de-viazioni standard, percentile) del campione normativo per ciascuna classe della scuola secondaria di primo grado. Da queste tabelle è possibile calcolare, dato un punteggio grezzo, come si pone la prestazione di un soggetto a cui è stato somministrato il test rispetto al gruppo normativo ed evidenziare così eventuali carenze.
TABELLA 4.3Media, deviazione standard, percentili per la prima classe
della scuola secondaria di primo grado
Prima classe (SSPG)
Area A Area B Totale
Media 7,17 7,32 14,49
DS 1,45 1,70 2,76
Percentile 5° 4,75 4,25 9,75
10° 5,00 5,00 10,00
25° 6,00 6,25 13,00
50° 7,00 7,00 14,00
75° 8,00 8,50 16,50
85° 8,50 9,00 18,00
90° 9,00 9,50 18,00
95° 10,00 10,00 19,25
41ProPrietà Psicometriche del test VclA-FrAsi
TABELLA 4.4Media, deviazione standard, percentili per la seconda classe
della scuola secondaria di primo grado
Seconda classe (SSPG)
Area A Area B Totale
Media 7,92 7,88 15,81
DS 1,49 1,74 2,26
Percentile 5° 5,70 4,00 12,55
10° 6,00 5,20 13,00
25° 7,00 7,00 14,00
50° 8,00 8,00 15,50
75° 9,00 9,00 17,75
85° 9,50 9,50 18,50
90° 10,00 10,00 19,00
95° 11,00 10,65 20,00
TABELLA 4.5Media, deviazione standard, percentili per la terza classe
della scuola secondaria di primo grado
Terza classe (SSPG)
Area A Area B Totale
Media 8,99 8,66 17,65
DS 1,36 1,54 2,21
Percentile 5° 6,90 6,00 13,80
10° 7,00 7,00 15,00
25° 8,00 7,00 16,00
50° 9,00 9,00 18,00
75° 10,00 10,00 20,00
85° 10,50 10,50 20,00
90° 11,00 10,50 20,50
95° 11,50 11,00 21,00
Nelle tabelle 4.6 e 4.7 sono riportati gli indici descrittivi (media, DS, per-centili) del campione normativo per le prime due classi della scuola secondaria
42 VCLA-FrAsi
TABELLA 4.6Media, deviazione standard, percentili per la prima classe
della scuola secondaria di secondo grado
Prima classe (SSSG)
Area A Area B Totale
Media 8,90 8,27 17,17
DS 1,43 1,60 2,36
Percentile 5° 6,00 5,65 12,65
10° 7,00 6,00 13,80
25° 8,00 7,00 15,75
50° 9,00 8,00 17,50
75° 10,00 9,50 19,00
85° 10,00 9,90 19,00
90° 11,00 11,00 20,00
95° 11,00 11,00 21,70
TABELLA 4.7Media, deviazione standard, percentili per la seconda classe
della scuola secondaria di secondo grado
Seconda classe (SSSG)
Area A Area B Totale
Media 9,53 8,87 18,40
DS 1,41 1,47 2,30
Percentile 5° 7,00 6,00 14,13
10° 7,75 6,50 15,25
25° 8,50 8,00 17,13
50° 9,00 8,38 17,50
75° 10,00 9,00 18,50
85° 11,00 10,00 20,00
90° 11,00 10,00 21,00
95° 11,00 10,00 21,00
6Struttura del software VCLA-Frasi
e modalità di somministrazione
Creazione del profilo dell’utente
Prima di iniziare la somministrazione del test all’alunno, è necessario crearne il profilo. Nella videata iniziale dell’applicazione (dalla quale è possibile stampare le versioni pdf dei protocolli nella versione «Alunno» e nella versione «Esaminatore»), si clicca il pulsante «Somministra e consulta test» (figura 6.1) e si accede alla videata per la creazione dei profili (figura 6.2). Quindi si clicca su «Crea nuovo utente»,
Fig. 6.1Videata iniziale dell’applicazione con i comandi di accesso al test e ai protocolli stampabili.
60 VCLa-FraSi
in alto a sinistra, e si procede con la compilazione dei dati relativi all’alunno da esaminare (figura 6.3). Il profilo può essere visualizzato, modificato (se l’utente è ancora in fase di valutazione) e, una volta conclusa la somministrazione del test, archiviato (ed eventualmente ripristinato e reso modificabile per un nuovo controllo), cliccando sugli appositi pulsanti.
Somministrazione del test VCLA-Frasi
Creata l’anagrafica dell’alunno, è possibile procedere alla somministrazione delle prove cliccando sul pulsante . Nella videata del menu (figura 6.4) sono presenti i dati riassuntivi del profilo dell’alunno selezionato e i pulsanti di accesso
Fig. 6.2Videata in cui sono raccol-ti i dati dei singoli alunni.
Fig. 6.3Videata dell’anagrafica.
61StrUttUra deL SoFtWare VCLa-FraSi e modaLitÀ di SomminiStrazione
alle due aree di cui si compone il test: Area A – Completamento di una singola frase o di un periodo, Area B – Relazione tra due/quattro frasi.
Fig. 6.4Il menu con i pulsanti di accesso alle due aree operative.
Fig. 6.5Videata del menu al com-pletamento del test.
Il test VCLA-Frasi risulta completato a conclusione di tutti gli item proposti in ciascuna area (in totale 22 item, 11 per area). Una volta terminata la sommi-nistrazione, è possibile richiedere al programma, previa connessione a internet, l’elaborazione dei risultati registrati cliccando sul pulsante «Valuta tutto». Come mostrato nelle figure 6.5 e 6.6, per ciascuna area vengono visualizzati:
– il punteggio e la deviazione standard, con evidenziati in rosso i risultati critici, in giallo quelli limite, in verde quelli positivi (nella norma e superiori);
– il l’istogramma del confronto della prestazione dell’utente con la prestazione della media del campione normativo, esportabile in pdf.