Italiano_L2_CTP (1)
-
Upload
olja-arsic-ex-perisic -
Category
Documents
-
view
24 -
download
0
description
Transcript of Italiano_L2_CTP (1)
-
ITALIANO L2 VADEMECUM PER GLI OPERATORI
DEI CENTRI TERRITORIALI
PERMANENTI
ItalianoL2 _1_36 14-12-2004 8:51 Pagina 1
-
ItalianoL2 _1_36 14-12-2004 8:51 Pagina 2
-
INDICE
Questioni relative allitaliano L2 nei CTP Pag. 7
Il Vademecum 15
Colloquio/Intervista (es. di modulo utilizzato nel CTP di Pisa) 27
Linee comuni A1 34
Unit di apprendimento Lavoro anchio.(Liv. A1 materiale per linsegnante e per lo studente) 43
Linee comuni A2 51
Unit di apprendimento Buon Appetito.(Liv. A2 materiale per linsegnante e per lo studente) 61
Linee comuni B1 72
Unit di apprendimento Emigranti.(Liv. B1 materiale per linsegnante e per lo studente) 86
Linee comuni B2 96
Unit di apprendimento Avventura(Liv. B2 materiale per linsegnante e per lo studente) 110
Linee comuni C1 123
Unit di apprendimento Genio(Liv. C1 materiale per Linsegnante e per lo studente) 134
Linee comuni C2 149
Unit di apprendimento Parcheggio(Liv. C2 materiale per linsegnante e per lo studente) 160
Tabella di osservazione degli aspetti qualitativi sulluso della lingua parlata 175
Registro per la verbalizzazione dellesame di accertamento linguistico(es. di modulo utilizzato presso il CTP di Scandicci Le Signe) 181
Certificato (es. di modulo utilizzato presso il CTP di Scandicci Le Signe) 193
POF (es. di Piano dellOfferta Formativa relativa allapprendimento insegnamento dellitaliano L2 presso il CTP di Scandicci Le Signe 194
3
ItalianoL2 _1_36 14-12-2004 8:51 Pagina 3
-
Il lavoro nasce e si sviluppa allinterno di un percorso di formazione dellIrre Toscana cheha coinvolto insegnanti di italiano seconda lingua nei Centri Territoriali Permanenti(CTP) della Toscana. Per quanto redatto da un gruppo di lavoro ristretto, essorappresenta il frutto di un impegno di cooperazione e di rete a livello regionale.Il gruppo redazionale, che si assunto limpegno di rielaborare e sviluppare i materialiraccolti, ha costantemente operato in uno spirito di condivisione e di scambio. Pur nelladifficolt di distinguere esattamente il contributo dei singoli possiamo attribuire le varieparti nel modo seguente:Maria Carla Borgogni (CTP Valdarno Montevarchi) - Vademecum, par 3.3; Unit dilavoro B2, C1e C2. Cecilia Giannini (CTP Pontassieve) - Introduzione, par. 5, Vademecum parr. 1,2,3.2,Linee comuni livello A1 e B1; Tabelle di osservazione livelli A1, A2 e B1.Pasqualina Leonardis (CTP Pisa) - Vademecum, parr. 3.1, 3.2; Linee comuni livello A2e B2; Il colloquio/intervista; Tabelle di osservazione livelli B2, C1 e C2.Sandro Piazzesi (CTP Scandicci-Le Signe) - Introduzione, parr. 1,2, 3, 4; Vademecum3.4; Linee comuni livello C1 e C2; Registro per la verbalizzazione dellesame L2;Modello di attestato; Piano Offerta Formativa del CTP di Scandicci Le Signe. Marinella Pucci (CTP Lucca) - Introduzione Riferimenti bibliografici; Unit di lavoroA1, A2, B1.
Consulenza scientifica: Elisabetta Jafrancesco (Universit di Firenze) che ha svoltoinoltre un ruolo di revisione dei materiali prodotti.Coordinamento generale del progetto: Lucia Maddii (IRRE Toscana).
Il presente lavoro sar disponibile anche sulle pagine web dellIRRE Toscana allindirizzo http://www.irre.toscana.it/italiano_2/materiali.htm
Per informazioni e chiarimenti possibile contattare direttamente il gruppo redazionalescrivendo a:Maria Carla Borgogni (CTP Valdarno Montevarchi) - [email protected];[email protected] Giannini (CTP Pontassieve) - [email protected];[email protected] Leonardis (CTP Pisa) [email protected]; [email protected] Sandro Piazzesi (CTP Scandicci-Le Signe) sandro.piazzesi_virgilio.it; [email protected] Marinella Pucci (CTP Lucca) - [email protected] [email protected] Maddii (IRRE Toscana) [email protected]
Per il contributo apportato al presente lavoro ringraziamo i seguenti colleghi: CoreviDaniela (CTP Pontedera), De Robertis Anna Rosa (CTP Pisa), Federighi Francesca(CTP Piombino), Florio Anna Maria (CTP Carrara), Francesconi Paola (CTP Lucca),Petrucci Fiorenza (CTP Pistoia), Scandurra Giovanna (CTP Carrara), Volpini Fabiola(CTP Don Milani- Firenze).
4
ItalianoL2 _1_36 14-12-2004 8:51 Pagina 4
-
5Ringraziamo inoltre tutti i colleghi che hanno partecipato al corso diformazione IRRE Toscana Apprendimento e insegnamento dellItaliano L2 ecertificazione delle competenze in et adulta, per aver contribuito nel corso dellediscussioni e degli scambi di esperienze a far nascere e sviluppare un lavorocondiviso a livello regionale.
INSEGNANTE CTP INSEGNANTE CTP
Chiarini Francesca CTP Arezzo Doretti Virgilio CTP Castelnuovo Garf.naRossi Lara CTP Arezzo Guidugli Elodia CTP Castelnuovo Garf.naCenni Carla CTP Distretto 13-Firenze Casotti Gabriella CTP Castelnuovo Garf.naDellAiuto Francesca CTP Campi Bisenzio Fontanini Piera CTP Castelnuovo Garf.naPennacchini Antonietta CTP Campi Bisenzio Ingrosso Andrea CTP PoggibonsiPanetta Giuseppe Domenico CTP Empoli Summer Luca CTP PoggibonsiTrombetti Caterina CTP Lastra a Signa Cirri Susanna CTP PoggibonsiCutigni Orietta CTP Lastra a Signa Bergamaschi Miletta CTP LuccaQuinto Angela CTP Pontassieve Federighi Barbara CTP Rosignano SolvayCaleo Stefania Scuola Carceraria Massa Stefani Mariuccia CTP VersiliaNigro Maria Scuola Carceraria Massa Pacchierini Gloria CTP PiancastagnaioMauro Mario CTP Pistoia Perna Maristella CTP PiancastagnaioNassi Alessandra CTP Portoferraio Longo Giovanna CTP ArcidossoDeni Elena CTP Portoferraio Vichi Maria CTP ArcidossoGrassi Barbara CTP Livorno Piccioni Patrizio CTP ArcidossoPietrini Clara CTP Livorno Sette Franca CTP GrossetoSottani Sabrina CTP Foiano della Chiana Florio Vincenzo CTP GrossetoCostanzo Francesca Maria CTP Foiano della Chiana Michelozzi Maria CTP FollonicaGiuliani Elisabetta CTP Foiano della Chiana Fedeli Oriana CTP FollonicaCortese Massimo CTP Prato Turini Stefania CTP FollonicaRipardelli Giovanna CTP Prato Boilini Maria Luisa CTP FollonicaZanetti Paolo CTP Piombino
ItalianoL2 _1_36 14-12-2004 8:51 Pagina 5
-
ItalianoL2 _1_36 14-12-2004 8:51 Pagina 6
-
INTRODUZIONE
QUESTIONI RELATIVE ALLITALIANO L2 NEI CTP
1. La normativa riguardante i Centri Territoriali Permanenti
Gi nel 1992, a conclusione di uno dei primi lavori sperimentali italianisulleducazione degli adulti, svolto a Scandicci, comune in provincia di Firenze,veniva individuata come esigenza peculiare dellutente straniero adultolapprendimento dellitaliano L2. Si legge infatti, nel volume Lalfabetizzazioneculturale e comunicativa. Lesperienza di educazione degli adulti nel distrettoScandicci Le Signe: risultati e proposte (De Mauro 1992), che la pi fortemotivazione per un immigrato lapprendimento della lingua italiana pipertinenti (rispetto ai corsi dalfabetizzazione per il conseguimento della licenzaelementare e media) sarebbero, pertanto, specifici corsi di lingua italiana. Ilvolume raccoglie lesperienza maturata nel corso della sperimentazione svolta aScandicci, attivata grazie alla volont dellEnte Locale e allimpegno di un gruppodi lavoro composto da insegnanti e dirigenti coordinati da Tullio De Mauro, EldaPadalino e Massimo Vedovelli. Nello stesso volume, inoltre, sono individuate,sulla base del livello di alfabetizzazione, tre tipologie di utenti:
- alfabetizzati in lingua materna e in alfabeto latino;- alfabetizzati in lingua materna ma non in alfabeto latino;- non alfabetizzati che si differenziano ulteriormente rispetto ai processi di
apprendimento spontaneo e apprendimento guidato dellitaliano L2(lingua seconda).
La Conferenza internazionale dellUNESCO sulleducazione degli adulti(EDA), tenutasi nel luglio del 1997 ad Amburgo, ha contribuito a stimolare uninteresse che in Italia ha avviato, anche attraverso le indicazioni dellOM 455/97e della Direttiva 22/01, un processo, tuttora in atto, di ridefinizione della strut-tura organizzativa dei corsi istituzionali per la licenza elementare e media, e che,al tempo della sperimentazione di Scandicci, costituivano lunica offertaformativa della scuola pubblica agli stranieri.
LOM 455 ha infatti istituito i Centri Territoriali Permanenti, indicando gliobiettivi e il coordinamento, le attivit e lorganico funzionale per la loroorganizzazione e realizzazione, nonch le modalit daccesso per gli utenti, leprocedure per negoziare il percorso e stipulare il patto formativo, le modalit divalutazione, certificazione e conduzione degli esami, la necessit di istituire illibretto personale. LOM indica anche come procedere per la formazione in
7
ItalianoL2 _1_36 14-12-2004 8:51 Pagina 7
-
servizio e laggiornamento degli insegnanti e lorgano giuridico dal quale dipendeil Centro. La stessa OM amplia poi il discorso proponendo listituzione di unComitato provinciale e di un Comitato tecnico per leducazione degli adulti.
Nucleo fondante del sistema prefigurato lattenzione posta alle esigenzedellutente adulto e alla valorizzazione della sua formazione anche extrascolastica,dunque rivolta sia a coloro che sono privi di titolo di studio sia a quanti, puressendone in possesso, vogliono riprendere la propria formazione. Con listituzionedellOM, si impone quindi ai dirigenti e agli insegnanti di ridefinirelorganizzazione e la didattica dei corsi di alfabetizzazione per il conseguimentodella licenza elementare e media e si amplia lofferta formativa (art. 5 c. 4)assegnando al Collegio dei docenti, sentito il Coordinamento degli operatori delCentro, il compito di definire i modelli organizzativi per le diverse attivit, in basealle reali esigenze dellutenza e alla effettiva possibilit di risposta legata ad unagestione efficace e responsabile delle risorse. Al punto b dello stesso comma siafferma che lofferta formativa deve essere stabilita secondo singoli percorsinegoziati, articolati per gruppi di livello, di interesse, attivit laboratoriali, stages,attivit individualizzate. Questa negoziazione del percorso formativo, in base alleesigenze e alle conoscenze delladulto, deve avvenire nella fase dellaccoglienza, chesvolge un ruolo fondamentale per la definizione del percorso.
Limportanza attribuita allaccoglienza ribadita sia nelle disposizioniorganizzative che nella definizione dei compiti del docente; infatti, allart. 6 siafferma chiaramente che la negoziazione del percorso e il patto formativoscaturiscono dai dati informativi che il docente raccoglie durante laccoglienza.
Anche se il testo non si riferiva esplicitamente ai cittadini provenienti da altripaesi, con il bisogno di apprendere la nostra lingua, appare chiaro che lordinanzaha dato ai Centri la possibilit di organizzare corsi che vengono incontro alladomanda espressa da questa fascia dutenza, pur non rientrando nel sistema for-male dellistruzione.
Unaltra fondamentale innovazione riguarda le certificazioni da rilasciare aicorsisti. I Centri, tramite lEnte giuridico del quale fanno parte (scuolaelementare o media), possono rilasciare oltre ai titoli istituzionali anche certificatio attestati che indicano i percorsi seguiti e i risultati ottenuti (art. 3, c. 6; art. 7).
A seguito della riforma del Titolo V della Costituzione, allaccordo StatoRegioni, che prevede un potenziamento delleducazione degli adulti, al passaggiodelle competenze dallex Provveditorato allUfficio regionale e allemanazione dellaDirettiva 22 del 06/02/2001 sono stati avviati ulteriori cambiamenti, ancora oggiin atto. Tuttavia, si sottolinea che la nascita delle numerose attivit svolte dai Centriha preso impulso principalmente dallOM 455. I compiti assegnati da taleordinanza ai CTP sono attuati e attuabili sia in relazione alla necessit di rispondereai bisogni dellutenza sia alla possibilit di certificarne i percorsi, pur nel complessoscenario che va costituendosi nel sistema integrato dellEDA.
8
ItalianoL2 _1_36 14-12-2004 8:51 Pagina 8
-
inoltre da osservare che la Direttiva 22 definisce i Centri per leducazionedegli adulti centri di servizio del sistema di istruzione, deputati allattuazionedellofferta formativa integrata, attraverso accordi di rete tra scuole di diversoordine e grado e, pur riconoscendo a tutte le scuole la possibilit di organizzarecorsi per adulti, evidenzia la specificit dellazione dei Centri (ribadendo buonaparte di quanto gi formulato nellOM 455), dando loro il compito dipromuovere il sistema integrato dellEDA a livello locale, che ha come strumentola rete. Nella Direttiva 22, infatti, viene riconosciuta limportanza della rete comesistema che permette di potenziare e ampliare lofferta formativa. Sono stati moltigli accordi di rete promossi dai CTP toscani, che hanno visto coinvolti pisoggetti impegnanti a vario titolo nel sistema delleducazione degli adulti. Nel2003 tutti i trentatr Centri toscani hanno raggiunto un accordo di rete cheindividua un coordinamento generale e uno specifico per aree allo scopo difacilitare lo scambio e la condivisione di progetti, esperienze e la creazione di unlinguaggio comune fra gli operatori.
2. La normativa e figura professionale del docente dei Centri Territoriali Permanenti
La normativa esistente non solo delinea i compiti dei CTP, ma definisceanche le funzioni dei docenti che vi operano. La professionalit del docente EDAsi definisce in base alla capacit di svolgere le seguenti funzioni.- Analisi dei bisogni, consulenza educativa individuale. Per il docente giungere a
un patto formativo significa essere in grado di aiutare gli allievi a valutare lecompetenze possedute, i valori e le mete finali della formazione, a confrontarele prestazioni di partenza con quelle desiderate, a individuare i requisitinecessari per ottenerle. Quindi a costruire piani per lo sviluppo dellecompetenze e, pi in generale, della persona.
- La facilitazione dellapprendimento. Il docente attiva processi di apprendimentoguidato rivolgendosi a un pubblico estremamente eterogeneo, quindi deve esserein grado di organizzare sia interventi di alfabetizzazione strumentale che attivitdi approfondimento culturale, creare e sviluppare consapevolezza cognitiva esocio-affettiva, in modo da potenziare le competenze comunicative e relazionali.
- La progettazione e la programmazione. Il docente definisce pacchetti educativi,obiettivi, finalit, progetti, in funzione delle necessit formative che emergonodal territorio in cui opera.
- La ricerca. Il docente analizza, cerca, scopre e sviluppa nuovi dati, traducendoliin modelli didattici e organizzativi; crea e produce dispositivi e materiali dausare nella formazione.
- La valutazione. Il docente deve prevedere, misurare, verificare limpiantoprogettuale, organizzativo e didattico in funzione dellefficacia dellappren-
9
ItalianoL2 _1_36 14-12-2004 8:51 Pagina 9
-
dimento, valutare in itinere e alla conclusione del percorso le prestazionidellapprendente e stimolare lautovalutazione.
- Lamministrare risorse. Il docente deve avere la capacit di partecipare adassicurare le risorse, gli strumenti e i servizi di supporto per lo svolgimentodelle attivit. Inoltre deve essere in grado di stabilire contatti, relazioni,accordi, convenzioni, contratti dopera con Enti pubblici e privati.
- Lorganizzazione. Il docente organizza la struttura dei percorsi dalla fasedellaccoglienza, alla certificazione finale delle competenze acquisite e deveessere capace di estrema flessibilit nel tener conto dei cambiamenti chepossono verificarsi in itinere.
- Lintercultura. Il docente ha il compito di documentarsi ampiamente sullemolteplici realt socioculturali che caratterizzano la societ, al fine divalorizzare le diversit per il dialogo e il confronto interculturale,relativizzando le differenze, le visioni etnocentriche per il superamento dipregiudizi e atteggiamenti xenofobi.
3. La formazione e laggiornamento per docenti di italiano L2
La ridefinizione normativa della figura professionale del docente EDA, cheopera nei CTP, ha riscontrato nel corso degli anni molto interesse da parte degliinsegnanti e dei dirigenti che hanno partecipato con entusiasmo ai corsi di ag-giornamento organizzati sia a livello locale che a livello regionale. Fra le varie ini-ziative, quella del progetto FARe, organizzato dallIRRE Toscana, ha svolto esvolge senzaltro un ruolo importante giacch ha facilitato e facilita la conoscenza,lo scambio di esperienze e la condivisione delle problematiche sulleducazionedegli adulti e delle soluzioni adottate dagli operatori.
Fra le problematiche principali sentite da tutti i CTP toscani al momentodella loro istituzione vi erano da un lato quella dellaccoglienza dei bisogni degliutenti, dallaltro quella di fornire loro risposte professionalmente adeguate, inparticolare riferendosi allutenza adulta straniera, cos come richiesto dallanormativa. Durante gli incontri fra i vari operatori dei Centri risultava chiaro chele considerazioni sulle tipologie degli apprendenti stranieri fatte nel corso dellasperimentazione di Scandicci erano estendibili a tutti i CTP toscani. Si segnalache, in base ai dati pubblicati dalla Caritas nel dossier statistico sullimmigrazione(Caritas 2003), il flusso dei nuovi ingressi in Italia, seppure non tutti a caratterestabile, ha superato le 100.000 unit nel 1991 e, stabilmente le 150.000 unit nel1997. Nel 1998 il tasso daumento stato dell8,90/o e nel 2000 del 20,3%.
Poich i docenti ritenevano inadeguati allaccoglienza della domanda i corsiistituzionali per il conseguimento della licenza elementare e media, hanno atti-vato corsi di italiano lingua seconda e, contemporaneamente, hanno chiestoallIRRE di organizzare a livello regionale un corso di ricerca e aggiornamento
10
ItalianoL2 _1_36 14-12-2004 8:51 Pagina 10
-
specifico. Tale corso avrebbe consentito uno scambio di esperienze elindividuazione di parametri di riferimento comuni, qualificando cos gliinterventi dei docenti sia sul versante dellinsegnamento linguistico eglottodidattico che su quello progettuale e organizzativo.
4. Verso lelaborazione di linee comuni di intervento
Dallaprile 2001 iniziato il corso di formazione coordinato da Lucia MaddiidellIRRE Toscana per operatori dei CTP regionali su Apprendimento einsegnamento dellitaliano come seconda lingua e certificazione del/e competenze inet adulta con lezioni teoriche a carattere frontale raccolte nel volume curato daMaddii (2004) e con gruppi di lavoro seminariali. In tale ambito si costituitoun gruppo di lavoro che aveva lobiettivo di produrre un Vademecum chepotesse essere daiuto a tutti quanti operano nel settore dellapprendimento/insegnamento dellitaliano L2: docenti, personale tecnico e amministrativo,dirigenti scolastici.
Il gruppo ha scelto di procedere attraverso il confronto delle esperienze, lesa-me dei materiali prodotti nei singoli Centri, lo studio e la riflessione sui modelliteorici e applicativi elaborati in ambito linguistico e glottodidattico,approfittando del confronto con gli esperti che, dopo le lezioni teoriche, hannoseguito specifiche attivit seminariali.
Ci che ha indirizzato e guidato la riflessione del gruppo oltre alla normativaitaliana stata la proposta del Consiglio dEuropa per lapprendimento elinsegnamento delle lingue precedentemente ricordata (Consiglio dEuropa[2001] 2002). Al gruppo hanno partecipato, nel corso degli anni, docentiprovenienti da numerosi CTP toscani, apportando importanti contributi chehanno permesso, a coloro che si sono poi presi il compito di stendere il lavoro, diavere non solo un quadro generale della situazione dei corsi ditaliano nei CTP, madi conoscere anche quello che molti insegnanti si auspicavano che potesse esserefatto per valorizzare lattivit dellinsegnamento dellitaliano L2 nei Centri. Infatti,tale insegnamento ancora troppo spesso viene identificato con unindistinta egenerica alfabetizzazione.
Le problematiche riguardanti lapprendimento/insegnamento linguistico elorganizzazione che sono state analizzate e studiate allinterno del grupporiprendono quanto la normativa definisce come punti fondamentali sui qualiinterrogarsi e impostare le azioni dei CTP che sintetizziamo qui di seguito.- Tipologia degli utenti. Il numero dei cittadini non italiani che si rivolgono ai
CTP toscani nel corso di questi anni progressivamente aumentato,determinando una crescita della domanda da parte di unutenza sempre pieterogenea per provenienza, et, estrazione sociale e culturale, con progettimigratori a carattere stanziale che con progetti a breve e a lungo termine. Ai
11
ItalianoL2 _1_36 14-12-2004 8:51 Pagina 11
-
CTP toscani si rivolgono cittadini comunitari e non, presenti nel nostroterritorio. Secondo i dati pubblicati dal MIUR (2003) la fascia det pipresente quella tra i 25 e i 40 anni, seguita da quella tra i 16 ed i 24 anni einfine quella dai 40 anni in poi. Pur variando secondo le zone, non ci sonosostanziali differenze numeriche fra la presenza degli uomini e delle donne.La popolazione straniera si caratterizza anche per unelevata mobilitterritoriale, sebbene sia sempre maggiore il numero di chi si stabilisce perperiodi prolungati in unarea, gli alloggi e il lavoro sono spesso precari eimpongono trasferimenti da zona a zona, da comune a comune. Di fronte adallievi che frammentano il proprio percorso di apprendimento tra diversicentri formativi i docenti avvertono lesigenza di comprendersi con i colleghianche lontani, accordandosi su termini in teoria ben definiti, ma nella praticaspesso ancora vaghi, come principiante o analfabeta. Si sente inoltrelesigenza di strumenti che consentano di valutare in maniera attendibile emeno soggettiva possibile quanti richiedono di accedere ai corsi dei CTP.
- Lindividuazione dei livelli di alfabetizzazione degli apprendenti presenta unarealt complessa ed eterogenea: dagli analfabeti nella lingua madre, agli alfabe-tizzati in un alfabeto diverso da quello latino, dagli alfabetizzati in alfabeto la-tino con livelli di scolarizzazione bassa a quelli con livelli di scolarizzazione uni-versitaria.
- La richiesta formativa da parte degli utenti dei CTP prevalentemente ricon-ducibile allesigenza di apprendere la lingua italiana per motivazioni legate allavoro. Ci riguarda coloro che sono appena arrivati in Italia o coloro chevogliono migliorare la propria condizione lavorativa. Tuttavia motivazioni nonmeno importanti sono a carattere culturale e riguardano da un lato la necessitdi integrarsi nella realt italiana - il caso di coloro che, avendo gi soddisfattobisogni primari vogliono sviluppare ulteriormente le proprie competenzecomunicative -, dallaltro il desiderio di conoscere e comprendere la cultura delnostro paese. Vi sono infine motivazioni di tipo strumentale connesse alconseguimento di un titolo di studio; si pensi, per esempio, agli studentiuniversitari Erasmus e a tutti quanti lavorano e studiano per un determinatoperiodo in Italia.
- Per quanto riguarda le scelte di chi opera nei CTP relativamente allaccoglienzadella domanda, lorientamento quello di accettare sia le domande provenientidalle fasce a maggior rischio demarginazione sociale, sia quelle di cittadinistranieri gi inseriti nel tessuto sociale italiano. Offrire un servizio che vengaincontro alle esigenze comunicative di profili diversi di apprendenti, ai varilivelli di competenza, permette allutente socialmente pi disagiato diintrattenere rapporti sociali con chi ha meno difficolt sul pianodellintegrazione, evitando cos forme di ghettizzazione allinterno del sistemaformativo.
12
ItalianoL2 _1_36 14-12-2004 8:51 Pagina 12
-
- Relativamente alle azioni didattiche svolte allinterno dei CTP e rivolte adapprendenti adulti stranieri, importante sottolineare che esse, per essereefficaci, devono tener conto dei modelli culturali degli apprendenti inrelazione ai sistemi formativi di provenienza e agli stili cognitivi che varianosensibilmente da cultura a cultura e da persona a persona.
- Alcuni degli interventi pi significativi realizzati nei CTP riguardano: lorganizzazione delle fasi dellaccoglienza (colloqui, iscrizioni, test dingres-
so, compilazione del libretto dello studente, patto formativo ecc.); lindividualizzazione dei percorsi didattici; le attivit di tutoraggio a studenti lavoratori che non possono frequentare i
corsi; la struttura dei corsi ditaliano L2 organizzati per moduli di livello di
competenza; il riconoscimento dei crediti culturali e leventuale modularizzazione dei
percorsi per il conseguimento della licenza elementare e media; la riorganizzazione degli obiettivi didattici e delle strategie dinsegnamento
secondo un approccio pragmatico e sociolinguistico; lanalisi dei materiali didattici in commercio e dei materiali prodotti dai
docenti; la riflessione sullinsegnamento modulare, lunit didattica, lunit di lavoro; gli esami interni ai CTP per certificare i livelli di competenza in italiano L2
(cfr. OM 455/97 del 29/07/97, Direttiva 22/01); gli esami di certificazione delle competenze in L2, come quelli del Centro
CILS dellUniversit per Stranieri di Siena con cui lIRRE Toscana, nelmaggio del 1999, ha stipulato una convenzione in base a cui tutti i CTPdella Toscana sono riconosciuti come sede di esame , dellUniversit perStranieri di Perugia e di Roma Tre;
la pianificazione dellofferta formativa del CTP e la sua presentazioneallinterno del POF della scuola da cui esso dipende.
5. Il contesto europeo
LUnione Europea, nel suo progressivo definirsi come punto di riferimentoper i singoli Stati membri, stimola e promuove notevoli cambiamenti nellepolitiche relative a vari settori della vita pubblica e sociale. Fulcro della vitacomunitaria senzaltro la possibilit di muoversi allinterno degli Stati membri,pertanto il Consiglio dEuropa sostiene progetti che favoriscono la conoscenzadelle lingue comunitarie. In questottica nel 1996-1997 nasce il Quadro comuneeuropeo di riferimento per le lingue: apprendimento insegnamento, valutazione; ildocumento europeo, fin dallinizio, rappresenta un utile quadro di riferimentoutilizzabile dagli insegnanti di lingue dei CTP per la definizione dei livelli di
13
ItalianoL2 _1_36 14-12-2004 8:51 Pagina 13
-
competenza, per tutte le questioni inerenti la didattica e per la progettazione eorganizzazione dei corsi di italiano come seconda lingua.
Per quanto riguarda specificamente i livelli di competenza linguistico-comunicativa, nel Quadro comune europeo di riferimento per le lingue:apprendimento, insegnamento, valutazione (Consiglio dEuropa [2001] 2002) siindividuano tre livelli, a loro volta suddivisi in due sottolivelli:
- Livello basico (Contatto A1, Sopravvivenza A2);- Livello indipendente (Soglia B1, Progresso B2);- Livello competente (Efficacia C1, Padronanza C2).Si riporta qui di seguito un adattamento sintetico della descrizione dei livelli
comuni di riferimento ripresa dal documento del Consiglio dEuropa.
Livello competenze (C2, C1)Sono considerati i livelli in cui lapprendere ha accesso a unampia gamma di strumentilinguistici che permettono una comunicazione sciolta e spontanea.
Il livello C2 non intende indicare la competenza del parlante nativo, ma definireil grado di precisione, appropriatezza e scioltezza linguistica che caratterizza il discorsodi apprendenti eccellenti.Il livello C1 permette di esprimersi con scioltezza, spontaneit e con una buona padronanza lessicale, per scopi sociali accademici e professionali dimostrando un sicuro controllo delle strutture discorsive e dei meccanismi di coesione.
Livello competenze (B2, B1)Sono considerati i livelli in cui lapprendente riesce ad agire pi efficacementenellinterazione sociale e a far fronte in modo autonomo e flessibile a problemi divita quotidiana.
Il livello B2 caratterizzato dalla capacit di agire in modo pi efficace nellinterazionesociale e da un nuovo grado di consapevolezza linguistica. Conversa in modo naturalemette a fuoco e argomenta adeguatamente il proprio punto di vista.Il livello B1 caratterizzato dalla capacit di interagire in modo efficace ottenendoche si desidera. Consente di comprendere i punti principali di un testo scritto e oralee di una discussione informale di intervenire e risolvere ostacoli in modo flessibilein situazioni di vario tipo, sostenendo le proprie opinioni.
Livello basico (A2, A1)Sono considerati i livelli pi bassi della competenza che permettono di generare eprodurre lingua in situazioni semplici di vita quotidiana, familiare e sociale.
Il livello A2 quello caratterizzato da descrittori relativi alle funzioni familiari esociali quali scambi comunicativi e aspetti legati ad ambiti di immediata rilevanzasociale (famiglia, lavoro, spostamenti ecc). Vi sono inoltre descrittori riguardantisemplici transazioni in negozi, uffici postali banche ecc.Il livello A1 il momento in cui lapprendente in grado di interagire in modosemplice, rispondere a domande facili su se stesso e su ci che lo circonda, formularee reagire a enunciati semplici riguardanti i bisogni pi immediati.
14
ItalianoL2 _1_36 14-12-2004 8:51 Pagina 14
-
IL VADEMECUM
1. Presentazione
Il presente lavoro rivolto a tutti coloro che, a vario livello, operano nei CentriTerritoriali Permanenti e nasce dallesigenza di formalizzare secondo parametricomuni le esperienze relative alla progettazione, organizzazione e realizzazione dicorsi di italiano L2. Pertanto utilizza come modello di competenza linguistico-comunicativa le indicazioni che il Consiglio dEuropa ha dato in materia diapprendimento/insegnamento delle lingue moderne nel Quadro comune europeo(Consiglio dEuropa [2001] 2002). Per questa ragione si ritenuto opportuno, neldescrivere le competente linguistiche degli apprendenti, attenerci il pi fedelmentepossibile alla proposta del documento europeo, anche se con alcuni adattamenti.
2. Obiettivi e finalit
Gli obiettivi principali e le finalit del presente lavoro sono i seguenti:- promuovere la conoscenza e la fruizione del Quadro comune europeo come
punto di riferimento per la progettazione di percorsi formativi, attraverso lacreazione e la condivisione di un linguaggio comune;
- utilizzare livelli comuni di competenza comunicativa che consentano anchela mobilit degli apprendenti da un Centro a un altro, attraverso ilriconoscimento dei crediti formativi;
- stabilire paramentri di riferimento comuni per la certificazione dellecompetenze linguistiche;
- facilitare la progettazione di moduli flessibili in base alle esigenze degliutenti, sia per quanto riguarda lorganizzazione dellorario e della tipologiadel corso (intensivo, breve, estensivo) sia per quanto concerne la scelta degliambiti comunicativi e delle competenze da sviluppare;
- favorire la progettazione di percorsi didattici programmati per competenzecertificabili;
- individuare modelli organizzativi e didattici comuni che consentano latrasmissione delle esperienze, agevolando il lavoro degli operatori e quellodella rete dei CTP;
- promuovere lo scambio e la diffusione di strumenti comuni e di buonepratiche.
15
ItalianoL2 _1_36 14-12-2004 8:51 Pagina 15
-
3. Articolazione interna del Vademecum
Per quanto riguarda larticolazione interna del presente lavoro, il Vademecumsi compone delle seguenti sezioni:
- accoglienza/accompagnamento/orientamento;- linee comuni di riferimento;- unit di lavoro;- verifica e valutazione;- colloquio-intervista;- linee comuni di riferimento e unit di apprendimento per i livelli A1/A2;- linee comuni di riferimento e unit di apprendimento per i livelli B1/B2;- linee comuni di riferimento e unit di apprendimento per i livelli C1/C2;- tabella di osservazione degli aspetti qualitativi sulluso della lingua parlata;- registro per la verbalizzazione dellesame di accertamento linguistico;- modello di certificato delle competenze acquisite,- modello di POF.
3.1. Accoglienza, accompagnamento, orientamento
Laccoglienza pu essere considerata come un processo pedagogico attraversocui sono garantite, a quanti si rivolgono ai CTP, lopportunit e la fruibilit distrutture, di insegnamenti, di procedure che rispondono ai principi del diritto al-listruzione e alla formazione. Tale processo diventa parte integrante dellattivitdidattica e dovrebbe essere affidato a personale qualificato.
Gli adulti, i giovani e gli stranieri che affluiscono ai CTP sono, comeprecedentemente evidenziato, un pubblico assai eterogeneo, che portaesperienze, esigenze e competenze a loro volta assai differenziate. Riconoscerle,per predisporre percorsi didattici adeguati, fa parte dellaccoglienza edellorientamento.
Inoltre, sempre a proposito di eterogeneit, utile ricordare che ogni adultoha un proprio stile di apprendimento, relativo anche alle esperienze formativepregresse, e che il contesto socioculturale in cui inserito stimola bisogni di rin-novamento, di continua messa a prova di ci che si divenuti.
Gli adulti, per quanto autonomi nelle diverse sfere della loro vita, hanno bi-sogno di rinforzo alla motivazione, di sostegno allapprendimento e di guida alnuovo percorso di formazione; da qui limportanza del colloquio individualecome primo e fondamentale passo per la costruzione di un percorso formativoche non privilegi lacquisizione di strumenti spendibili solo nella realt produttiva,ma anche nella sfera relazionale e individuale.
A questo proposito si sottolinea che laccoglienza, allinterno dei CTP, diver-samente da quanto avviene presso altre istituzioni scolastiche, non un momen-
16
ItalianoL2 _1_36 14-12-2004 8:51 Pagina 16
-
to limitato allinizio delle attivit didattiche, ma una pratica continua, poich iflussi di utenza interessano lintero anno. Sarebbe quindi utile unattivit di spor-tello per conoscere le esigenze dei singoli e orientarli allinterno dei percorsiformativi disponibili nei Centri.
A questo punto si propone uno schema di riferimento flessibile per larealizzazione delle fasi di accoglienza. Si sottolinea che tale schema non pu essereconsiderato un modello rigido; esso, infatti, potr essere adattato in accordo alcontesto socioculturale e alle risorse in cui opera listituzione scolastica. Si ricordache il presente paragrafo stato confrontato con il documento stilato durante gliincontri Adultit e formazione dei docenti, nellambito del Progetto regionale FARe (Scaglioso 2002) dellIRRE Toscana.
3.1.1 Le Fasi
Prima fase: pubblicizzazione. Il primo contatto delladulto con il Centro iniziacon la conoscenza delle attivit attraverso una capillare opera di informazione epubblicizzazione. Saper diffondere le informazioni in luoghi adeguati con azioni,strumenti e linguaggi chiari importante per orientare il potenziale utente e perfavorire la conoscenza dei servizi offerti dal Centro.
Per la promozione e la pubblicizzazione possono essere utilizzati vari mezzi:manifesti, locandine, volantini, TV radio e web. I manifesti, le locandine e i
volantini dovrebbero essere distribuiti a Istituti scolastici, Enti locali, ufficipubblici, agenzie e centri per limpiego, Informagiovani, parrocchie, centri diaccoglienza, associazioni di categoria, ospedali, ambulatori medici, carceri,supermercati, esercizi pubblici.
Seconda fase: contatto. Nella fase del contatto lutente riceve informazioni suicorsi e sulle modalit di iscrizione. Il primo contatto pu avvenire sia con gliaddetti della segreteria che con i docenti del Centro. In questa fase possono esserecompilati i moduli per liscrizione con i dati del corsista e pu essere fissato uncolloquio con il docente o con il tutor (precedentemente formato) che accoglierlutente.
Terza fase: informazione. Il colloquio con il docente o con il tutor finalizzatoa una prima ricognizione sui bisogni formativi del corsista e alla formalizzazionedelliscrizione. Nel corso del colloquio il docente illustra in maniera sinteticalofferta formativa del CTP, lorganizzazione didattica delle attivit e gli orari deicorsi. Il colloquio iniziale pu avvenire alla presenza di un mediatore linguistico.
Quarta fase: conoscenza-accertamento. Il colloquio, ispirato ai principi dellapsicologia umanistica (Rogers 1999), ha come primo obiettivo quello di creareuna situazione empatica con la persona che si rivolge al CTP ed un momentomolto importante della fase dellaccoglienza. Il docente ha come obiettivo fon-
17
ItalianoL2 _1_36 14-12-2004 8:51 Pagina 17
-
damentale quello di accogliere la persona, stimolarla a parlare di s e delle ragioniche lhanno portata a iscriversi al corso. In tale occasione, per valutare il livello dicompetenza in italiano, viene somministrato allapprendente un test dingressoe/o gli viene chiesto, dal livello B1 in poi, di scrivere la propria Biografialinguistica e di autovalutare le proprie competenze (cfr. Portfolio Europeo delleLingue, vd. http://www.istruzione.it).
Qualora la richieste di iscrizioni ai corsi siano superiori alle possibilitorganizzative del CTP, possibile formare liste di attesa per evitare linserimentoselvaggio nei gruppi di livello e prevedere eventuali nuovi moduli diinserimento.
Quinta fase: percorso formativo. Il percorso formativo, elaborato dal team deidocenti in base alle informazioni acquisite, ai risultati delle prove e agli attestatie titoli presentati, concordato con lutente e sottoscritto. In questa fase assumeparticolare importanza lesplicitazione e la condivisione del percorso formativoche lutente dovr seguire, in quanto fondamentale che egli prendaconsapevolezza del percorso da affrontare, sia motivato e assuma responsabilit.
Nellelaborazione del percorso formativo vanno individuati gli spazi dinegoziazione possibili relativi a contenuti, tempi e modalit di apprendimento.
Il patto formativo che ne consegue permette allutente di verificareautonomamente il proprio percorso di apprendimento, le eventuali difficolt, ipossibili imprevisti nel mantenere limpegno ed esplicitare ulteriori bisogni (vd.http//www.irre.liguria.it/patto.doc). Lapprendente, infatti, pu richiedere econcordare momenti di recupero individuale o facilitazioni disciplinari, maanche accelerazioni e approfondimenti del percorso stesso in unottica diflessibilit oraria e didattica.
3.2. Linee comuni di riferimento
Dato che leducazione degli adulti un settore in cui spesso il ricambio del-lorganico docente molto rapido, sono poche le strutture che possono contaresu un gruppo stabile di docenti. Le proposte presentate possono dunquecostituire uno strumento di condivisione delle esperienze, di continuit e dicrescita professionale. Tuttavia, si sottolinea che tali proposte non pretendono diavere carattere definitivo, ma vogliono essere un punto di partenza perleleborazione di nuove proposte e per la creazione di occasioni di confronto edi scambio.
Nellelaborazione delle Linee comuni stato assunto come documento di ri-ferimento il Quadro comune europeo (Consiglio dEuropa [2001] 2002). Nella ta-bella successiva riportata la scala globale dei livelli comuni di riferimento chedefiniscono il grado di competenza degli apprendenti di una lingua straniera.
18
ItalianoL2 _1_36 14-12-2004 8:51 Pagina 18
-
Tabella. Livelli comuni di riferimento: scala globale (Consiglio dEuropa [2001] 2002 p. 32).
in grado di comprendere senza sforzo praticamente tutto ci cheascolta o legge. Sa riassumere, informazioni tratte da diverse fonti, oralie scritte, ristrutturando in un testo coerente argomentazioni e leinformative. Si esprime spontaneamente, in modo molto scorrevole epreciso e rende distintamente sottili sfumature di significato anche insituazioni piuttosto complesse.
in grado di comprendere unampia gamma di testi complessi epiuttosto lunghi e ne sa ricavare anche il significato implicito. Si esprimein modo scorrevole e spontaneo, senza un eccessivo sforzo per cercare leparole. Usa la lingua in modo flessibile ed efficace per scopi sociali, ac-cademici e professionali. Sa produrre testi chiari, ben strutturati earticolati su argomenti complessi, mostrando di saper controllare lestrutture discorsive, i connettivi e i meccanismi di coesione.
in grado di comprendere le idee fondamentali di testi complessi suargomenti sia concreti sia astratti, comprese le discussioni tecniche nelproprio settore di specializzazione. in grado di interagire con relativascioltezza e spontaneit, tanto che linterazione con un parlante nativosi sviluppa senza eccessiva fatica e tensione. Sa produrre testi chiari earticolati su unampia gamma di argomenti ed esprimere una opinionesu un argomento dattualit, esponendo i pro e i contro delle diverseopzioni.
in grado di comprendere i punti essenziali di messaggi chiari in linguastandard su argomenti familiari che affronta normalmente al lavoro, ascuola, nel tempo libera ecc. Se la cava in molte situazioni che si possonopresentare viaggiando in una regione dove si parla la lingua in questione.Sa produrre testi semplici e coerenti su argomenti che gli siano familiario siano di suo interesse. in grado di descrivere esperienze eavvenimenti, sogni, speranze, ambizioni, di esporre brevemente ragionie dare spiegazioni su opinioni e progetti.
Riesce a comprendere frasi isolate ed espressioni di uso frequenterelative ad ambienti di immediata rilevanza (ad es. informazioni di basesulla persona e sulla famiglia, acquisti, geografia locale, lavoro). Riesce acomunicare in attivit semplici e di routine che richiedono solo unoscambio di informazioni semplice e diretto su argomenti familiari eabituali. Riesce a descrivere in termini semplici aspetti del propriovissuto e del proprio ambiente ed elementi che si riferiscono a bisogniimmediati.
Riesce a comprendere e utilizzare espressioni familiari di uso quotidianoe formule molto comuni per soddisfare bisogni di tipo concreto. Sapresentare se stesso/a e altri ed in grado di porre domande su datipersonali e rispondere a domande analoghe (il luogo dove abita, lepersone che conosce, le cose che possiede). in grado di interagire inmodo semplice purch linterlocutore parli lentamente e chiaramente esia disposto a collaborare.
C2
C1
B2
B1
A2
A1LIV
ELL
O B
ASI
CO
LIV
ELL
O I
ND
IPE
ND
EN
TE
LIV
ELL
O C
OM
PE
TE
NT
E
19
ItalianoL2 _1_36 14-12-2004 8:51 Pagina 19
-
Le Linee comuni sono articolate in sei sezioni di livello che hanno tutte lastessa struttura. Nella prima pagina sono raccolte indicazioni concernenti leseguenti voci:
- livello;- destinatari;- prerequisiti;- risultato atteso;- durata del corso;- tipologia del corso.Nella seconda pagina c la tabella che riporta i contesti situazionali duso
della lingua, ripresa dal Quadro comune europeo (Consiglio dEuropa [2001]2002). Si evidenzia che nel documento europeo i contesti duso individuati sonoi seguenti: privato, pubblico, occupazionale ed educativo, a loro volta descritti at-traverso luoghi, istituzioni, persone, oggetti, avvenimenti, azioni e testi. Per unapprofondimento delle tematiche riguardanti la definizione di possibili profili diapprendenti di italiano L2, si rimanda al testo di Vedovelli, Guida allitaliano perstranieri, in particolare al capitolo Percorsi didattici: modelli diprogrammazione (Vedovelli 2002, pp. 143-193).
utile specificare che, in relazione allapproccio pragmatico e sociolinguisticoadottato nel Quadro comune europeo, chi usa e apprende una lingua consideratoun agente sociale che deve portare a termine determinati compiti linguistici incircostanze date, in ambiente specifico e allinterno di un determinato campo diazione, attraverso attivit linguistiche (Consiglio dEuropa [20011 2002, p.11) di ricezione, interazione e produzione di testi.
Nella sezione dedicata alle abili/attivit linguistiche, la ricezione, lintera-zione e la produzione sono presentate con descrittori sia generali sia specifici eriguardano lorale e lo scritto. Per esempio, i descrittori di competenza specificiriguardanti la ricezione, per lorale, sono: comprendere una conversazione fraparlanti nativi, ascoltare come componente di un pubblico, ascoltare annuncie istruzioni, ascoltare mezzi comunicazione audio e registrazioni, ricezioneaudiovisiva di programmi televisivi e film.
Passando alla descrizione della sezione dedicata alla competenza linguistica, utile premettere che, sebbene nel documento europeo si faccia riferimento sia allecompetenze generali che riguardano la persona nella sua globalir (dimensionecognitiva ed emotivo-affettiva) , sia alle competenze linguistico-comunicative,nellelaborare le Linee comuni dei sei moduli di livello, si fa riferimentoesclusivamente alle seconde.
La competenza linguistico-comunicativa articolata in tre sottocompetenze:- la competenza linguistica;- la competenza pragmatica;- la competenza sociolinguistica.
20
ItalianoL2 _1_36 14-12-2004 8:51 Pagina 20
-
La competenza linguistica si riferisce alla conoscenza della lingua in quantosistema di regole formali e riguarda la competenza fonologica, ortografica,lessicale, morfosintattica e semantica.
La competenza pragmatica riguarda la competenza discorsiva, relativa allagestione della coerenza e della coesione del testo, cio tutto quanto coinvoltonei processi discorsivi. La competenza discorsiva viene descritta attraverso laflessibilit, il prendere la parola, lo sviluppo tematico, la coerenza e la coesione.La competenza funzionale si riferisce alluso funzionale delle risorse linguisticheper il raggiungimento di determinati scopi. La competenza funzionale riguardale macro e le micro funzioni, gli schemi interazionali e viene descritta attraversofattori qualitativi di fluenza nel parlato e di precisione dasserzioni.
La competenza sociolinguistica, relativa a tutti quei comportamenti lingui-stici propri dei parlanti, che variano in relazione alle situazioni comunicative, ri-guarda gli elementi linguistici che segnalano i rapporti sociali, le regole dicortesia, le espressioni di saggezza popolare, le differenze di registro, le varietlinguistica e laccento. Tali conoscenze e abilit sono state descritte in termini diappropriarezza sociolinguistica.
Si ricorda che i descrittori delle abilit/attivit linguistiche e delle competenzelinguistico-comunicative presentati nelle Linee comuni sono stati ripresi dalQuadro comune europeo (Consiglio dEuropa [2001] 2002), e dal testo Valutare ecertificare litaliano di stranieri (Barki et al. 2002), per i livelli A1 A2. Tuttavia, inparticolare per la competenza morfosintattica, sono stati adottati come punto diriferimento gli indicatori specifici ripresi dalle Linee guida CILS (Vedovelli 1998).Infine, per quanto concerne la competenza lessicale, non vengono riportate indi-cazioni particolari e si affida al docente il compito di scegliere il lessico relativo aicontesti duso specifici significativi per un determinato gruppo di apprendenti.
Concludendo, si ribadisce che il presente lavoro non ha la pretesa di essereesaustivo, anzi necessita di essere arricchito con il contributo di chi opera in que-sto settore.
3.3. Le unit di lavoro
Le Linee comuni sono seguite da unit di lavoro esemplificative per ognilivello. Le unit sono suddivise in due parti: la prima rivolta al docente econtiene indicazioni sullarticolazione del lavoro allinterno dellunit e su ognisingola attivit presentata; la seconda rivolta, invece, allo studente e pu esserefacilmente utilizzata dal docente, fotocopiandola, qualora la ritenga adatta alproprio gruppo classe.
opportuno sottolineare che i corsi di italiano L2 rispondono a unaconcezione di apprendimento/insegnamento della lingua attraverso i testi, in
21
ItalianoL2 _1_36 14-12-2004 8:51 Pagina 21
-
quanto non solo elemento fondante della comunicazione, ma anche veicolo dielementi culturali e sociali. Insegnare una lingua seconda, a ogni livello diapprendimento, non pu prescindere n dagli aspetti strumentali, n da quelliculturali.
Ed ormai noto che parlare di metodo didattico in riferimentoallapprendimento/insegnamento della L2 e della lingua in generale vuol direricondurre il discorso a un lungo e complesso itinerario che ha visto spesso scuoledi pensiero confrontarsi, quando non scontrarsi apertamente.
Alla luce di dinamiche ormai ampiamente conosciute, allinterno delle qualila pratica didattica in generale ha mostrato di riferirsi ora alluno ora allaltrometodo, si giunti, grazie al contributo di numerosi studiosi italiani e stranieri,alla nascita degli approcci comunicarivi. Proprio a questi ultimi riconducibilelazione degli insegnanti che si trovano a operare nei CTP, per il fatto che taliapprocci vedono lapprendimento/insegnamento linguistico come sistemaoperativo non rigido e predeterminato, bens altamente sensibile a tutte levariabili di apprendimento linguistico (a fattori biologici, cognitivi e sociali, afattori contestuali di apprendimento e di insegnamento, a fattori culturali eaffettivi, a fattori motivazionali, e cos via) (Danesi 1998, p. 13).
A partire dagli anni Settanta, nella didattica delle lingue la competenzalinguistica in senso stretto, cio la correttezza formale degli enunciati, non pilunico obiettivo glottodidattico da perseguire, in quanto si ritiene fondamentalela capacit dellapprendente di comunicare in modo appropriato in relazione aivari contesti duso della lingua. Di conseguenza, importante sviluppare lecompetenze linguistico-comunicarive allinterno di ambiti che siano rilevanti perlapprendente. In tal modo si mira in primo luogo a soddisfarne i bisognicomunicativi, sociali e culturali.
Ecco dunque il senso di un approccio che ha come centro focalelapprendente e come sviluppo operativo lunit di lavoro.
La scansione dellattivit in classe in unit di lavoro ormai un modellooperativo in uso negli interventi formativi rivolti agli utenti stranieri adulti deiCTP. importante ricordare che la scelta metodologica di sviluppare la didassi inunit di lavoro, dalla durata variabile, ha lontane radici nellattivismo americanodegli anni Trenta. In seguito, negli anni Settanta, ha trovato applicazione nelladidattica delle lingue con Freddi ed stata poi confermata, anche attraversosuccessive rielaborazioni, sia dalla glottodidattica e dagli studi neurolinguisticidegli anni Novanta sia dagli odierni orientamenti in questo ambito.
Linteresse tutto da rivolgere a unazione didattica che non trova necessitnella ragione spazio-temporale e cronologica, ma nellessere un vero e proprioprocesso che, in quanto tale, fa dellunitariet il proprio criterio e dellar-
22
ItalianoL2 _1_36 14-12-2004 8:51 Pagina 22
-
ticolazione il proprio metodo. Tutto ci nellottica di una progressione che, comenoto, non si svolge nella direzione lineare dal semplice al complesso, ma piuttostoprende le mosse dai bisogni linguistico-comunicativi degli apprendenti, secondouno sviluppo a spirale che muove dagli elementi linguistici e culturali che via viasi intendono presentare.
Si parla dunque di unit, perch azione caratterizzata dallunit delloggettodi insegnamento, in quanto propone la lingua nella sua pienezza comunicativa,partendo sempre dalla presentazione di una tranche completa e autosufficiente dilingua. Ma anche perch propone il concetto di unit del soggetto apprendente,come indicato dalla psicologia della Gestalt. Tali ipotesi sostengono che vi sia, nelprocesso di percezione dellevento linguistico, innanzi tutto una percezioneglobale che attiverebbe principalmente lemisfero destro per poi passare adattivit pi a carattere analitico, prevalentemente riferibili allemisfero sinistro. Ilprocesso sostenuto dallinsegnante nella sua qualit di faciliratore.
Le unit di lavoro presentate si sviluppano nelle fasi riportate qui di seguito(nella parte per lo studente tali fasi sono denominate con un linguaggio piamichevole e meno tecnico).
Motivazione. Fase in cui, fornendo input visivi e/o uditivi, si invita lo studentead accostarsi al testo, facilitandone la comprensione globale, attraverso ilrecupero delle conoscenze, che egli possiede sullargomento, la formulazione diipotesi e la loro elicitazione.
Globalit. Fase in cui gli studenti, individualmente oppure divisi a coppie oin piccoli gruppi, vengono esposti al testo, accompagnato da compiti assegnatisecondo tecniche che motivano alla comprensione globale, quali griglie dicomprensione, domande a scelta multipla, attivit di transcodificazione ecc.
Lavoro sul testo. Fase in cui gli studenti sono invitati ad analizzare il testo, ascomporlo e ricomporlo, con lobiettivo di individuarne i meccanismifondamentali e i legami che ne fissano e mantengono la coesione e la coerenza,comprese anche la riflessione morfosintartica, lessicale, culturale e il reimpiegodelle forme presentate.
Controllo. Fase in cui gli studenti con linsegnante possono verificare le ipotesisul funzionamento della lingua emerse, in genere attraverso la creazionepersonale di un testo su imitazione del modello dato.
3.4. Verifica e valutazione
Una prima considerazione da fare in relazione alla valutazione dellecompetenze in italiano L2 riguarda il fatto che le attivit di testing si riferisconoai contenuti e agli obiettivi parziali o globali del corso e sono correlati ai livelli dicompetenza specificati nel Quadro comune europeo (A1, A2, B1, B2, C1, C2). Nel
23
ItalianoL2 _1_36 14-12-2004 8:51 Pagina 23
-
presente documento tali contenuti e obiettivi si ritrovano allinterno dei singolimoduli di livello delle Linee comuni.
Per quanto riguarda la verifica delle competenze in italiano L2, si vuolericordare ora la funzione delle seguenti attivit: il test dingresso, il test in itineree il test finale.
Il test dingresso, che si svolge secondo pi modalit, a seconda delle diverseesigenze dei CTP, serve a collocare lapprendente nel gruppo di livello adeguatoed inoltre utile per individualizzare il percorso formativo, soprattutto nelleattivit di tutoraggio. Il test dingresso normalmente costituito da prove sia oraliche scritte e non somministrato a studenti di livello principiante assoluto.
Il test in itinere, che somministrato una o pi volte durante il percorsoformativo, ha il duplice scopo di verificare le conoscenze apprese e di accertare lavalidit delle scelte operate dal docente in sede di programmazione didattica.
Il test finale serve a misurare il livello di competenza raggiunto e ha comeoggetto i contenuti e gli obiettivi globali del corso. Il test finale, inoltre, funzionale al rilascio da parte del CTP del Certificato di conoscenza relativo alpercorso effettuato.
In accordo con lapproccio di tipo pragmatico e sociolinguistico adottato e inriferimento ai materiali prodotti dal Centro CILS dellUniversit per Stranieri diSiena, la strutturazione interna dei test potrebbe essere articolata in sezioni, in cuisono presenti prove di ascolto, comprensione alla lettura, analisi delle strutture dicomunicazione, produzione scritta e produzione orale.
Allinterno della verifica il peso dato a ogni abilit, in termini di punteggio,dovrebbe essere equivalente a quello dato alle altre, in considerazione del fattoche i corsi presso i CTP sono in prevalenza rivolti a un pubblico eterogeneo ehanno pertanto lobiettivo didattico di sviluppare armonicamente tutte le abilit.A titolo esemplificativo, nelle prove desame la ripartizione dei punteggi puessere analoga a quella adottata nelle prove di certificazione CILS, in cui ogniabilit vale 20 punti per un totale di 100 (cfr. Registro per la verbalizzazionedellesame di accertamento linguistico, pp. 181 ss).
Tuttavia, in sede di valutazione sommativa oltre ai risultati relativi al testfinale si pu decidere di prendere in considerazione altri criteri valutarivi, come,per esempio, la partecipazione in classe e il lavoro autonomo dellapprendente. Siveda lo schema seguente.
Criteri per la valutazione sommativa dellapprendenteEsame finale 70%Partecipazione in classe 15%Lavoro autonomo 15%
24
ItalianoL2 _1_36 14-12-2004 8:51 Pagina 24
-
Per quanto riguarda i tipi di test utile ricordare che essi si distinguono inoggettivi e soggettivi a seconda del tipo di prova utilizzata. Le prove oggettive sonoquelle in cui lattribuzione del punteggio non richiede alcun giudizio da parte delvalutatore, le prove soggettive, invece, sono quelle in cui tale giudizio richiesto(cfr. Barni 2002). Le prove oggettive o strutturare (vero\falso, scelta multipla,completamento, cloze, abbinamento, riordino ecc.) sono utilizzate in genere perla verifica delle abilit ricettive, mentre le prove soggettive (produzione scritta,comunicazione unidirezionale, interazione orale e scritta ecc.) sono usate princi-palmente per verificare le abilit produttive. Vi sono infine le cosiddette provesemistrutturate, come per esempio le risposte brevi, i riassunti, la costruzionedi frasi a partire da parole date ecc., la cui valutazione implica una minor sogget-tivit di giudizio da parte del valutatore.
Riferimenti bibliografici
Balboni, P. (a cura di) 1995, Curricolo di italiano per stranieri, Roma, Bonacci.Balboni, P. 1985, Elementi di glottodidattica, Brescia, La Scuola.Barki, P., Gorelli, S., Machetti, S., Sergiacomo, M. P., Strambi, B. 2002, Valutare e certificare
litaliano di stranieri. I livelli iniziali, Perugia, Guerra.Barni, M. 2002, La verifica e la valutazione, in A. De Marco (a cura di), Manuale di
glottodidattica, Roma, Carocci, pp. 155-174.Council of Europe 2001, Common European framework for Language: Lerning, Teaching,
Assessment, Council for Cultural Co-operation Education Committee Modern LanguagesDivision, Strasbourg, trad. it. Quadro comune europeo di riferimento per le lingue:apprendimento. insegnamento, valutazione, Milano-Firenze, La Nuova Italia-Oxford, 2002.
Ciliberti, A. (a cura di) 1994, Manuale di glottodidattica. Per una cultura dellinsegnamentolinguistico, Firenze, La Nuova Italia.
Danesi, M., 1988, Neurolinguistica e glottodidattica, Padova, Liviana.De Marco, A. (a cura di) 2000, Manuale di glottodidattica, Roma, Carocci.De Mauro,T., Padalino E., Vedovelli M., (a cura di) 1992. Lalfabetizzazione culturale e
comunicativa. Lesperienza di educazione degli adulti nel distretto Scandicci-Le Signe: risultati eproposte, Firenze, Giunti Marzocco.
Diadori, P. 1994, Litaliano televisivo. Aspetti linguistici, extralinguistici, glottodidattici, Roma,Bonacci.
Diadori, P. 1990, Senza parole. 100 gesti degli italiani, Roma, Bonacci.Domenici, G. 1991, Gli strumenti della valutazione, Napoli, Tecnodid.Freddi, G., 1994, Glottodidattica. Fondamenti, metodi e tecniche, Torino, Utet Libreria.Galli De Paratesi, N. 1981, Livello soglia per litaliano, Strasburgo, Consiglio dEuropa.Giunchi, P. (a cura di) 1990, Grammatica esplicita e grammatica implicita, Bologna, Zanichelli.Krashen, S. D., Dulay, H., Burt, M. 1982, Language Two, New York, Oxford University Press,
trad. it La seconda lingua, Bologna, Il Mulino, 1985, a cura di A. Giacalone Ramat.Lavino, C. 1990, Teoria e didattica dei testi, Firenze, La Nuova Italia.Micheli, P. (a cura di) 1994, Test dingresso di italiano per stranieri, Roma, Bonacci.
25
ItalianoL2 _1_36 14-12-2004 8:51 Pagina 25
-
Maddii, L. (a cura di) 2004, Apprendimento e insegnamento dellitaliano L2 per adulti, Firenze-Atene, IRRE Toscana-Edilingua.
Ministero della Pubblica Istruzione 1997, OM 455 del 29 luglio.Ministero della Pubblica Istruzione 2001, DM. 22 del 6 febbraio.Ministero Istruzione Universit Ricerca 2003, Lofferta formativa dei Centri Territoriali, Roma.Pallotti, G. 1998, La seconda lingua, Milano, Bompiani.Porcelli, G. 1994, Principi di glottodidattica, Brescia, La Scuola.Rogers, C. 1999, La terapia centrata sul cliente, Firenze, La Nuova Italia.Scaglioso, C. (a cura di) 2002, Lofficina di Vulcano. F.A.Re Formazione, Firenze, MIUR-IRRE
Toscana.Sobrero, A.A. (a cura di) 1993, Introduzione allitaliano contemporaneo. Le strutture. La variazione
e gli usi, Roma-Bari, Laterza.Tosi, A. 1995, Dalla madrelingua allitaliano. Lingue e educazione linguistica nellItalia
multietnica, Firenze, La Nuova Italia.Vedovelli, M. 2002,. Guida allitaliano per stranieri. Roma, Carocci.Vedovelli, M. (a cura di) 1998. CILS. Linee Guida. Siena, Universit per Stranieri di Siena.
Vedovelli, M., Massara, 5., Giacalone Ramat A. (a cura di) 2001, Lingue e culture in contatto. Litaliano come L2 per gli arabofoni, Milano, Franco angeli.
Vertecchi, B. 1988, La valutazione, Bologna, Il Mulino.
26
ItalianoL2 _1_36 14-12-2004 8:51 Pagina 26
-
Colloquio / Intervista
parte 1
Nome . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cognome . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Data di nascita . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Et . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Citt di nascita . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Stato o Nazionalit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cittadinanza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sesso M F
Stato Civile: celibe nubile coniugato/a
Indirizzo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Luogo di residenza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Telefono 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Telefono 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Codice Fiscale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Permesso di soggiorno si no in attesa.
scadenza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
DATI ANAGRAFICI
27
ItalianoL2 _1_36 14-12-2004 8:51 Pagina 27
-
parte 2
Indica il grado di conoscenza1 2 3 4
Lingua madre . . . . . . . . . . . . . . Altre lingue . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Legenda:1 = scarsa, 2 = basilare, 3 = buona, 4 = eccellente
parte 3
A. STUDI EFFETTUATI
1. Quanti anni di scuola hai frequentato?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nel Paese dorigine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
In Italia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
In altri paesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2. Quali titoli di studio hai conseguito?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nel Paese dorigine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
In Italia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
In altri paesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3. Ultima classe o corsi frequentati e in quale anno?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ESPERIENZE SCOLASTICHE E FORMATIVE
CONOSCENZE LINGUISTICHE
28
ItalianoL2 _1_36 14-12-2004 8:51 Pagina 28
-
B. ASPETTI POSITIVI E NEGATIVI
1. Ripensando alla tua esperienza scolastica: quali aspetti positivi o negativi?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2. Quali erano le tue materie / discipline preferite a scuola?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3. Rispetto al tuo nuovo percorso intrapreso, cosa pensi che potrebbe ostacolarela tua esperienza?
Lavoro
Orario di lavoro
Situazione familiare
Ubicazione della scuola
Mezzi di trasporto
Altro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
29
ItalianoL2 _1_36 14-12-2004 8:51 Pagina 29
-
4. Cosa pensi che la scuola potrebbe fare per facilitare il tuo percorso?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hai dei suggerimenti da dare?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
C. ESPERIENZE DI FORMAZIONE
TIPO O NOME SEDE DI DURATA TITOLIDEL CORSO SVOLGIMENTO E TERMINE CERTIFICATI
ATTESTATI
TIPO O NOME SEDE DI DURATA E TERMINE TITOLI/ CERTIFICATIDEL CORSO SVOLGIMENTO ATTESTATI CONSE-Esempi: informatica, A. Scuola /Istituto dal ___ al ______ GUITIlingua straniera, teatro, Statale n. ___ mesi A. Qualifica professio-danza, musica, grafica, B. Istituto non statale anno finale nalelingua italiana, corso per C. CTP B. Attestato di fre-parrucchiere, giardinag- D. Agenzia formativa quenzagio, corso per animatore E. Ente di formazione C. Certalicato di livellodi comunit, qualifica regionale provincia- D. altroOSA, qualifica OTA, le comunalequalifica OSS, qualifica F. Azienda di lavoroassistente familiare, G. Corso a distanzameccanica, elettronica, H. Autoformazionealtro________ 1. Altro
1.
2.
3.
4.
5.
6.
30
ItalianoL2 _1_36 14-12-2004 8:51 Pagina 30
-
parte 4
A. CONDIZIONE LAVORATIVA
1. Indica se sei:
Occupato/a In attesa di lavoro In mobilit
In cerca di occupazione
2. Se sei occupato indica quale tipo di lavoro svolgi
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3. Se in attesa di occupazione indica in quale settore
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4. Se sei in mobilit indica in quale settore
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5. Se sei in attesa di inserimento lavorativo indica in quale settore, se hai effet-tuato gi colloqui, presenza in graduatoria di concorso, ecc.
B. ANALISI DELLESPERIENZA LAVORATIVA
1. Come consideri la tua esperienza lavorativa?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2. Tra le tue esperienze lavorative quali sono state le pi significative?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ESPERIENZE DI LAVORO
31
ItalianoL2 _1_36 14-12-2004 8:51 Pagina 31
-
Aspetti positivi
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Aspetti negativi
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
C. INTERESSI E ATTITUDINI
1. Possiedi competenze particolari sviluppate al di fuori della tua esperienza professionale o scolastica?Se s quali?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2. Coltivi particolari interessi nel tempo libero? Se s quali?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3. Cosa pensi di sapere fare?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
32
ItalianoL2 _1_36 14-12-2004 8:51 Pagina 32
-
parte 5
Sono tornato/a a scuola perch?a. per migliorare le mie possibilit di carriera sul posto di lavorob. per avere pi possibilit di cambiare lavoroc. per accrescere le mie conoscenze anche solo a livello personaled. per avere pi stima di me e sentirmi pi rispettato/a a casa e fuorie. perch mi annoiavo e volevo fare qualcosa di diversof. per acquisire una qualifica professionale pi richiesta nel mercato del lavorog. per ridurre la precariet del mio lavoroh. per uscire dal mercato del lavoro neroi. per rimettermi in pari con gli studenti del corso mattutino che ho
abbandonatoj. perch (risposta aperta)
* Il presente modulo nasce dal confronto dei docenti dellIstituto IPSIA Matteotti e delCTP I.C. Fibonacci di Pisa (gruppo progetto PIA) e da coloro che hanno partecipato algruppo Accoglienza del progetto FARe ed stato redatto in questa stesura da PasqualinaLeonardis
MOTIVAZIONE
33
ItalianoL2 _1_36 14-12-2004 8:51 Pagina 33
-
LINEE COMUNI
Basico - Al (contatto).
Apprendenti comunitari e non.
Competenze culturali pregresse (studenti scolarizzati nella loro lingua madre).
Essere in grado di comprendere e utilizzare espressioni familiari di uso quotidianoe formule molto comuni per soddisfare bisogni di tipo concreto. Saper presentarese stesso/a e altri ed essere in grado di porre domande su dati personali e saperrispondere a domande analoghe (il luogo dove abita, le persone che conosce lecose che possiede). Essere in grado di interagire in modo semplice purchlinterlocutore parli lentamente e chiaramente e sia disposto a collaborare.
Da 110 a 130 ore circa.
Corso intensivo: durata bimestrale, 5 giorni di lezione alla settimana per 3 oreal giorno.
Corso breve: durata quadrimestrale, 2 giorni alla settimana per 4 ore al giorno. Corso estensivo: durata annuale 2 giorni alla settimana di 2 ore al giorno.
TIPOLOGIA DEI CORSI
DURATA DEI CORSI
RISULTATO ATTESO
PREREQUISITI
DESTINATARI
LIVELLO
34
ItalianoL2 _1_36 14-12-2004 8:51 Pagina 34
-
Contesti duso della lingua
Le categorie descrittive dei contesti situazionali duso hanno lo scopo dirichiamare lattenzione sulluso della lingua in situazione reale. Nel Quadrocomune europeo i principali contesti duso individuati sono i seguenti: privato,pubblico, occupazionale ed educativo, a loro volta descritti attraverso le seguenticategorie: luoghi, istituzioni, persone, oggetti, avvenimenti, azioni e testi. In sededi programmazione didattica il docente dovr disegnare percorsi che, tenendoconto dei bisogni formativi e del livello degli apprendenti, sviluppino lacompetenza linguistico-comunicativa nei contesti duso pi opportuni.Si riporta qui di seguito la tabella presente nel Quadro comune europeo(Consiglio dEuropa [2001] 2002, pp. 60-61)
35
ItalianoL2 _1_36 14-12-2004 8:51 Pagina 35
-
36
Priv
ato
Ambito Luoghi Istituzioni Persone Oggetti Avvenimenti Azioni TestiPu
bblic
oO
ccup
azio
nale
Edu
cati
vo
Casa(appartamento,locali, giardino)propria dellafamiglia, diamici,di estraneiSpazio per s inuna pensione,in un hotelCampagna,mare
La famigliaReti sociali
GenitoriNonni e nonneFigli e nipotiFratelli e sorelleZii e zieCugini ecugine, affiniConiugi,persone con cuisi in intimitAmici,conoscenti
Mobili e arredoAbbigliamentoApparecchidomesticiGiocattoli,attrezzi, igienepersonaleOggetti darte,libriAnimali(domestici )Alberi, piante,prati, stagniBeni domesticiBagagliAttrezzatura peril tempo liberoe lo sport
Feste in famigliaIncontriIncidenti,infortuniFenomeninaturaliFeste, visitePasseggiate apiedi, inbicicletta, inmotoVacanze,escursioniEventi sportivi
Routinequotidiane:vestirsi, svestirsi,cucinare,mangiare,lavarsiBricolage,giardinaggioLettura, radio eTVDivertimentiHobbyGiochi e sport
TelexGaranzieRicetteManualiscolasticiRomanzi, rivisteGiornaliMaterialepubblicitarioOpuscoliLetterepersonaliTesti oralidiffusi via radioe registrati
Luoghipubblici:strada, piazza,parcoMezzi ditrasportoSupermercati enegoziOspedali,ambulatori,clinicheStadi, campisportivi, palestreTeatri, cinema,spettacoliRistoranti, baralberghiLuoghi di culto
Uffici stataliOrganismipoliticiOrganismigiudiziariServiziosanitarioAssociazioni divolontariatoGruppiPartiti politiciIstituzionireligiose
SemplicicittadiniRappresentantiufficialiCommessiPolizia, esercito,personale disicurezzaAutisti,controlloriPasseggeriGiocatori, fans,spettatoriAttori, pubblicoCamerieri,personale dei barPortieri,Preti, fedeli
Soldi,portamonete,portafogliDocumentiMerciArmiZaini, valigie,borsePalloniProgrammiPasti, bevande,merendePassaporti,patenti
IncidentiInfortuni,malattieIncontripubbliciProcessi,udienze intribunaleGiornatebeneficheMulte, arrestiPartite, gareSpettacoliMatrimoni,funerali
Acquistare iservizi pubblicie utilizzarliUsare il serviziosanitarioViaggi in auto,treno, nave,aereoDivertimenti eattivit deltempo liberoFunzionireligiose
Annunci eavvisiEtichette,confezioniVolantini,graffitiBiglietti, orariCartelli,regolamentiContrattiProgrammiMenTesti sacri,prediche,preghiere
UfficiFabbricheLaboratoriPorti, stazioniFattorieAeroportiMagazzini,negoziAziende diserviziAlberghiServizi pubblici
ImpreseSocietmultinazionaliIndustrienazionaliSindacati
Datori di lavoroDirettoriColleghiSubordinatiCompagni dilavoroClientiConsumatoriAddetti allaricezione,segretariPersonale dellepulizie
MacchinedufficioMacchineindustrialiAttrezziindustriali eartigianali
RiunioniIntervisteRicevimentiConvegniFierecommercialiConsultazioniVenditestagionaliIncidenti sullavoroConflitti sociali
GestionecommercialeGestioneindustriale AttivitproduttiveProcedureamministrativeTrasportiOperazioni divenditaCommercializzazioneOperazioniinformaticheManutenzione degliuffici
LetterecommercialiRelazioniAvvisiRegolamentiManualiMaterialepubblicitarioEtichette econfezioniIstruzioni dilavoroSegnalazioniBiglietti davisita
Scuole: atrio,aule, cortile,campi sportivi,corridoiCollegiUniversitSale per leconferenzeAule per iseminariAssociazionistudentescheResidenzeuniversitarieLaboratoriMense
ScuolaCollegioUniversitAssociazioniculturaliAssociazioniprofessionaliOrganismi diformazionecontinua
InsegnantiBidelliAssistentiGenitoriCompagni diclasseProfessoriuniversitari,lettoriStudentiuniversitariBibliotecari epersonale dilaboratorioPersonale dellamensaPersonale dellepuliziePortieri, segretari
Materiale perscrivereAbbigliamentoe attrezzaturesportiveCiboApparecchiAudiovisiviLavagna e gessoComputerCartelle e zaini
Inizio dannoIngresso inclasseFine annoVisite e scambiPomeriggi eserate con igenitoriGiornatesportive, partiteProblemidisciplinari
LezioniGiochiRicreazioneGruppi eassociazioniCompiti inclasseLavori inlaboratorioStudio inbibliotecaSeminari e lavoriassistitiCompiti a casaDibattiti ediscussioni
Testi autentici(v. sopra)Libri di testo, diletturaLibri diconsultazioneTesti alla lavagna(luminosa)Testi su schermo(computer e TV)EserciziArticoli digiornaleSommariDizionari
ItalianoL2 _1_36 14-12-2004 8:51 Pagina 36
-
ABILIT LINGUISTICHERICEZIONE - INTERAZIONE - PRODUZIONE
Ricezione
Ascolto
Cfr. Consiglio dEuropa [2001] 2002, pp. 83 ss.; Barki et al. 2002, p. 102.
Lettura
Cfr. Consiglio dEuropa [2001] 2002, pp. 83 ss.; Barki et al. 2002, p. 102.
Competenze specifiche
Comprensione della corrispondenzaComprende brevi, semplici messaggi su cartoline.Lettura per orientarsiRiconosce nomi, parole e frasi familiari su semplici cartel-li nelle pi comuni situazioni quotidiane. Comprende te-sti semplici e avvisi di uso quotidiano quali insegne, indi-cazioni, istruzioni e avvisi di pericolo in luoghi pubblici. Satrovare informazioni nel materiale di uso quotidiano, co-me pubblicit, prospetti, elenchi, orari ecc.Lettura per informazioneSa cogliere il senso del contenuto di materiali informativimolto semplici e di brevi e facili descrizioni specialmentese accompagnati da supporto visivo.Lettura di istruzioniSa seguire indicazioni scritte brevi e semplici. (ad es. vaida X a Y ). Comprende semplici istruzioni.
Competenza generale
Comprende testi molto bre-vi, molto semplici che con-tengono un lessico di usofrequente, cogliendo nomi,parole, frasi basilari, ancherileggendole.Comprende testi semplici ebrevi su argomenti comuniespressi in un linguaggioquotidiano di largo uso e re-lativo al contesto a lui/leimolto fmiliare.C
ompr
ensi
one
oral
e
Competenze specifiche
Ascolto di annunci e istruzioniComprende e segue istruzioni date lentamente. Compren-de semplici indicazioni relative a come andare da X a Y, apiedi o con trasporti pubblici. Coglie il punto principale inmessaggi e brevi annunci.
Competenza generale
Comprende un breve inter-vento orale, se esso accura-tamente articolato e contie-ne pause che permettono dicoglierne il senso. Capiscefrasi ed espressioni relativead aree di immediata prio-rit (ad es., informazioni elementari sulla famiglia, ac-quisti, geografia locale, lavo-ro, scuola). Comprende abbastanza per far fronte abisogni immediati di tipoconcreto, se il discorso arti-colato lentamente e chiara-mente.
Com
pren
sion
e or
ale
37
ItalianoL2 _37_95 14-12-2004 8:55 Pagina 37
-
Interazione
Cfr. Consiglio dEuropa [2001] 2002, pp. 93 ss.; Barki et al. 2002, p. 103.
Competenze specifiche
Comprendere un interlocutore parlante nativoComprende domande e istruzioni rivoltegli/le lentamente eriesce a seguire indicazioni semplici. Comprende sempliciespressioni che mirano a soddisfare bisogni quotidiani, for-mulate direttamente in modo chiaro, lento e ripetuto da uninterlocutore disponibile e comprensivo. Riesce a seguireci che gli/le viene detto lentamente e direttamente nellaconversazione quotidiana, se l'interlocutore fa lo sforzo difarsi capire. Comprende generalmente un discorso chiaro,comune, su argomenti familiari che gli/le viene fatto, pur-ch possa chiedere di riformulare la frase ogni tanto.ConversazioneComprende espressioni di vita quotidiana miranti a soddi-sfare semplici bisogni, che gli/le vengono rivolti diretta-mente in modo chiaro, lento e ripetuto da un interlocuto-re disponibile e comprensivo.Sa chiedere alle persone come stanno e reagire alle infor-mazioni che gli/le vengono date.Sa presentarsi/re e usare semplici espressioni di saluto e dicommiato.Discussione informale (fra amici )Sa esprimere il consenso o il disaccordo con gli altri.Cooperazione orientata in grado di chiedere e dare qualcosa. in grado di comprendere domande e istruzioni rivoltelentamente e di seguire brevi, semplici indicazioni.Ottenere beni e serviziSa chiedere per avere e sa dare cose alle persone. Sa ordina-re un pasto. Sa fare semplici spese indicando che cosa vuo-le e chiedendo il prezzo. sa dare e ricevere informazioni sul-la quantit, numeri, prezzi ed ore.Scambio di informazioniSa fare domande e rispondere su se stesso (dove vive, le per-sone che conosce, le cose che possiede) o su altre persone.Sa fare e sa rispondere a semplici domande. Sa fare o con-tinuare semplici affermazioni su aspetti familiari o per sod-disfare bisogni immediati. Sa scambiare informazioni ele-mentari su ambiti familiari o di routine. Sa comprendereistruzioni semplici espresse con cura e lentamente. Sa se-guire indicazioni brevi e semplici. Sa comprendere a suffi-cienza per scambiare informazioni su argomenti familiariin situazioni quotidiane e prevedibili.Intervistare ed essere intervistatiSa rispondere in un colloquio a domande semplici e diret-te su aspetti personali, espresse lentamente e chiaramentein un linguaggio diretto e non idiomatico. Sa rispondere asemplici domande e reagire a affermazioni elementari inunintervista.
Competenza generale
in grado di interagire inmodo semplice, ma la comunicazione dipende dalripetere in modo pi lento,dal ricomporre la frase e dalla correzione. Sa fare do-mande semplici e risponde-re, sa prendere l'iniziativa diparlare e rispondere a sem-plici affermazioni riguar-danti bisogni immediati oargomenti molto familiari. in grado di comunicare inattivit semplici e di routineche richiedono uno scambiodi informazioni su argomen-ti familiari o di routine cheriguardino la famiglia, lascuola o il tempo libero.
Inte
razi
one
oral
e
38
ItalianoL2 _37_95 14-12-2004 8:55 Pagina 38
-
Interazione
39
Inte
razi
one
scri
tta
Pro
duzi
one
oral
e
Competenza generale
Sa gestire frasi semplici supersone e luoghi. Sa dareuna semplice descrizione dipersone, condizioni di vita,routine quotidiane, ci chepiace e che non piace ecc.,tramite una serie di frasicoordinate.
Competenze specifiche
Monologo articolato: descrizione di esperienzeSa descrivere se stesso, che cosa fa e dove abita. Sa descri-vere gente, luoghi e cose in termini semplici. Sa descriverela propria famiglia, le condizioni di vita, le attivit del mo-mento.
Cfr. Consiglio dEuropa [2001] 2002, pp. 73 ss.; Barki et al. 2002, p. 104.
Scritto
Competenza generale
in grado di chiedere e for-nire dati personali per iscrit-to.
Competenze specifiche
CorrispondenzaSa scrivere una cartolina breve e sempliceAppunti, messaggi, moduliSa scrivere numeri, date, il suo nome, nazionalit, indiriz-zo, et, data di nascita o di arrivo nel paese ecc. Sa scrivereun modulo.
Cfr. Consiglio dEuropa [2001] 2002, pp. 102 ss.; Barki et al. 2002, p. 104.
Scritto
Competenza generale
in grado di scrivere sem-plici espressioni e frasi isola-te.
Competenze specifiche
Scrittura creativa in grado di scrivere semplici espressioni e frasi su se stes-so/stessa e su persone immaginarie, sul luogo in cui vivonoe su ci che fanno.
Cfr. Consiglio dEuropa [2001] 2002, pp. 77.
Pro
duzi
one
scri
tta
ItalianoL2 _37_95 14-12-2004 8:55 Pagina 39
-
COMPETENZE LINGUISTICHE
Cfr. Consiglio dEuropa [2001] 2002, p. 135.
Cfr. Consiglio dEuropa [2001] 2002, p. 144.
Cfr. Consiglio dEuropa [2001] 2002, p. 145.
Cfr. Consiglio dEuropa [2001] 2002, p. 136 ss.
Competenza lessicale
Ampiezza Dispone di un repertorio lessicale di base fatto di singoleparole ed espressioni riferibili a un certo numero di situa-zioni concrete.
Padronanza Dispone di un repertorio molto ristretto, funzionale adesprimere bisogni concreti della vita quotidiana.
Padronanza ortografica
in grado di copiare e/o scrivere parole e brevi espressioni conosciute, ad es. avvisi o istruzio-ni, nomi di oggetti duso quotidiano e di negozi e un certo numero di espressioni correnti. in grado di dire lettera per lettera il proprio indirizzo, la nazionalit e altri dati personali.
Padronanza fonologica
in grado di pronunciare un repertorio molto limitato di parole ed espressioni memorizzateche richiedono qualche sforzo da parte di parlanti nativi.
Repertorio linguistico generale
Dispone di un repertorio molto elementare formato da espressioni semplici relative a dati per-sonali e bisogni di tipo concreto.
40
ItalianoL2 _37_95 14-12-2004 8:55 Pagina 40
-
Competenza morfosintattica
Cfr. Consiglio dEuropa [2001] 2002, p. 140.
Competenze specifiche
Riconosce e usa pur con errori e interferenzedella lingua madre, genere e numero dei no-mi; articolo determinativo e indeterminativo;aggettivi qualificativi (anche se non in gradodi fare sempre la concordanza); coniugazioneriflessiva del presente del verbo chiamarsi, co-niugazione attiva degli ausiliari essere e averee dei verbi regolari ai seguenti modi e tempi:indicativo: presente, indicativo passato pros-simo (anche se non sempre concordato ilparticipio passato con il soggetto); infinitopresente; imperativo (forma attiva e negativaalla seconda persona singolare e plurale); ver-bi modali: potere, dovere, volere; pronomi per-sonali soggetto; aggettivi e pronomi possessi-vi, dimostrativi e interrogativi; ci pi essere; iprincipali avverbi di tempo (prima, poi, dopo,ora/adesso, sempre, mai, oggi, domani, ieri); av-verbi di luogo (qui/qua, l/l, sopra/sotto, gi,dentro, fuori, vicino, lontano, davanti, dietro, adestra, a sinistra); altri avverbi pi frequenti:cos, molto, poco, tanto, pi, meno, meglio, be-ne, male; numeri cardinali da 1a 20, le decine,le centinaia; le preposizioni semplici in espres-sioni di uso frequente.La frase semplice: proposizioni dichiarative,interrogative introdotte da chi, come, dove,quando, perch, che cosa, volitive con limpera-tivo.
Correttezza generale
Ha solo una padronanza limitata di qualchesemplice struttura grammaticale e disemplici modelli sintattici, in un repertoriomemorizzato.
41
ItalianoL2 _37_95 14-12-2004 8:55 Pagina 41
-
42
COMPETENZE PRAGMATICHE
Cfr. Consiglio dEuropa [2001] 2002, pp. 150 ss.
Cfr. Consiglio dEuropa [2001] 200


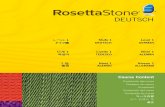


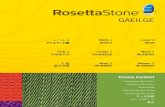
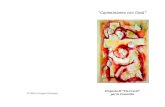


![1 1 1 1 1 - Storia del diritto medievale e moderno › uploads › 5 › 9 › 4 › 8 › 5948821 › padovani_2010.pdf1 1 ð 1 ð 1 á 1 1 4 1 1 1 1 1. 1 1 1 w w \ [ _ [ 1] 1 ^ 1](https://static.fdocumenti.com/doc/165x107/60d7d9cb6ef019434466aa8e/1-1-1-1-1-storia-del-diritto-medievale-e-a-uploads-a-5-a-9-a-4-a-8-a.jpg)









![1 £ 1 1 1 1 1 ï 1 1 1 £ 1 1 1 1 1 1 1 ... - EuroStudium · (xurvwxglxp z jhqqdlr jlxjqr 1 [ x 1) 0dlr]]l /d 5lyrox]lrqh 1 1. (xurvwxglxp z jhqqdlr jlxjqr 1 [ y 1) 0dlr]]l /d 5lyrox]lrqh](https://static.fdocumenti.com/doc/165x107/5fc60ea4d563330c12652014/1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-xurvwxglxp-z-jhqqdlr-jlxjqr-1-.jpg)
