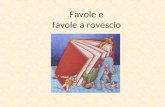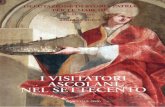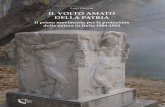Italia Patria del rovescio
-
Upload
dario-di-santo -
Category
Documents
-
view
360 -
download
0
description
Transcript of Italia Patria del rovescio

stampa | chiudi
Copyright © RIP SrlPolitica energetica nazionale venerdì 03 aprile 2009
Rinnovabili ed efficienza, l'Italia a rischio desertificazione
Politica energetica
In quest'articolo, Dario Di Santo, della Fire, fa un'analisi impietosa
delle difficoltà di superare vecchi e anacronistici vincoli amministrativi e
burocratici nonché debolezze strutturali e di portare avanti, nel settore
energetico, la modernizzazione dell'Italia, “patria del rovescio, non del
diritto”.
Il 19 marzo, Piero Ostellino concludeva il suo editoriale sul
Corriere con le parole “Italia, Patria del Rovescio; non del Diritto”.
Vediamo un po' perché anche nel settore dell'energia ha senso dire che siamo il paese del rovescio.
Il nostro lungimirante legislatore, cui non mancano certo le buone idee, aveva già introdotto la
certificazione energetica degli edifici con la Legge 10/91. Un provvedimento potenzialmente utile,
specie se associato a certificatori competenti e ad installatori in grado di tradurne in realtà le
indicazioni. Peccato che all'atto dell'emanazione della direttiva 2002/91/CE non se ne fosse fatto
ancora nulla, che nel frattempo il Titolo V della Costituzione avesse posto le basi per rivivere l'età dei
comuni rinascimentali, e che siano poi passati altri quattro anni per l'emanazione del D.Lgs.
192/2005, già più volte rimaneggiato senza che trovasse un'applicazione estesa (del resto le linee
guida sono state appena rilasciate). Il cocktail risultante ha un sapore amaro e l'applicazione della
certificazione riguarda uno sparuto numero di Regioni benemerite e coraggiose. Di fatto 18 anni sono
passati, ma la maturità è ben lungi dall'essere raggiunta. Parlando di opere edili, qualcuno si chiederà
a questo punto se completeranno in meno tempo la Salerno-Reggio Calabria, qualcun altro se
l'aumento di cubatura del 20% in auge in questo momento, non si dovrebbe applicare agli impianti di
generazione elettrica, visto che pagano l'Ici.
In altri ambiti è andata meglio. Le leggi 9/91 e 10/91 avevano previsto con largo anticipo
l'incentivazione delle fonti rinnovabili e dell'efficienza energetica negli usi finali. Temi fondamentali per
un Paese carente di risorse. Il provvedimento Cip 6/92 recepiva il primo aspetto attraverso un conto
energia, che purtroppo è stato mal gestito, per cui ha permesso di ottenere buoni risultati sul fronte
delle fonti assimilate – concedendo in molti casi contributi eccessivi – ma non è stato capace di
portare alla creazione di una filiera sulle rinnovabili, come in seguito avvenuto in Danimarca,
Germania, Spagna e Giappone, solo per citarne alcuni. A questo punto, visto che ricominciare è in
Italia più gradito che migliorare, si è deciso di provare qualcosa di più complicato, ed è iniziata la fase
dei meccanismi cap and trade.
Il primo è stato quello dei certificati verdi, dedicato alle fonti rinnovabili. Doveva essere un
meccanismo di mercato, per sfruttare il vantaggio teorico di questi dispositivi, ossia la capacità di
portare al miglior rapporto costi/benefici premiando le tecnologie più cost effective. Non è mai stato
tale, ha subito continue modifiche che l'hanno via via avvicinato ad un conto energia, ha visto
crescere la durata dell'incentivazione da 8 a 15 anni, si è visto appioppare teleriscaldamento
cogenerativo e idrogeno (poi rientrati, salvo i diritti acquisiti) ed ha premiato eccessivamente alcune
Stampa | Staffetta Quotidiana http://www.staffettaonline.com/Stampa.aspx?id=71119
1 di 4 7-04-2009 14:23

realizzazioni, nonché gli operatori dell'IPEX per l'energia non soggetta all'obbligo. Sorvoliamo
sull'assurdità del momento, ossia le aste di aprile a cui il GSE venderà certificati ad un prezzo
inferiore a quello a cui li ritirerà in seguito (non gli stessi, se non altro). I risultati ci sono comunque
stati, rallentamenti sulle autorizzazioni degli impianti a parte. Il problema vero di questo meccanismo
sta nell'assenza di certezze sui flussi di cassa, che nonostante le varie storpiature lo rendono poco
gradito agli investitori e a chi presta il denaro. In pratica i costi per la gestione del sistema e la
copertura dei rischi tolgono risorse agli impianti e quindi riducono l'effetto utile a parità di somma
prelevata in tariffa.
Il secondo, quello dei certificati bianchi, è messo anche peggio, visto che ai problemi del primo
associa la difficoltà di valutare i risparmi generati dagli interventi, con tutta una serie di aspetti
collegati. Gli esiti sono dubbi e di difficile valutazione. Tolti pochi interventi per i quali l'incentivo ha
prodotto i risultati voluti, anche se a costi sicuramente superiori al necessario, per il resto alcuni
interventi prendono soldi senza essere “stimolati” dal meccanismo (e.g. le caldaie unifamiliari a
condensazione), ci sono poche schede di valutazione semplificata, due sono bloccate da un ricorso
da quasi tre anni, la comunicazione con gli operatori da parte di chi gestisce il meccanismo non è
sufficiente, mancano dati di mercato aggiornati, il sistema di remunerazione dei soggetti obbligati
lascia qualche dubbio circa il funzionamento nel futuro. C'è da chiedersi se un meccanismo di
incentivazione che non può essere “bancato” sia realmente tale. Ed è presto d'altra parte per dire
quanto l'effetto di promozione del mercato delle ESCO stia funzionando (rappresenta il secondo
beneficio cercato dal dispositivo). Comunque si è già posto rimedio a buona parte delle
problematiche e si spera che si continui su questa via.
La sintesi è che abbiamo messo in campo due meccanismi di cap and trade (per tacer
dell'emission trading, che però è su scala extranazionale) e gli abbiamo in buona parte snaturati e
continuamente modificati. Non era meglio a questo punto un mix di conti energia e finanziamenti in
conto interesse? In ogni caso: poco diritto, qualche dubbio sull'efficacia, molta creatività (piccolo
inciso: i CV non valgono ora meno dell'avvio, in compenso gli anni sono passati da 8 a 15 e i
coefficienti introdotti dalla Finanziaria 2008 sono premianti, non penalizzanti; ma non dovrebbe
diminuire nel tempo il contributo per i nuovi impianti a parità di soluzione tecnologica? e poi: allungare
il periodo di riconoscimento dell'incentivo ha precise ripercussioni sugli oneri di sistema della bolletta
elettrica, che risultano sì più diluiti, ma che non danno spazio a nuovi interventi se non con impegni
relativi crescenti, visto che l'effetto sostituzione si verifica dopo 15 anni: siamo sicuri che sia la strada
giusta?).
Una parte importante di questi incentivi, comunque, non finanzia gli impianti, ma le nostre
inefficienze. Da questo punto di vista la riforma del Titolo V ci ha messi in mezzo ad una giungla,
senza Tarzan a darci qualche dritta. I tempi dei procedimenti autorizzativi sono rispettati quanto i limiti
di velocità sulle strade senza Tutor. I 180 giorni del D.Lgs. 387/03 fanno tenerezza, se confrontati con
quelli mediamente necessari per chiudere la conferenza dei servizi (ammesso che venga convocata
e sperando che non si invochi l'intervento di mamma TAR). Il risultato è un aggravio di costi che si
ripercuotono sui cittadini, che così finanziano ritardi, incertezze, tasse (beh, è il caso dell'ICI sul
fotovoltaico, ma non solo), tangenti (compensazioni, se preferite), fotocopie (in alcuni casi qualche
migliaio di Euro a progetto, nell'era dell'informatica...) e chi più ne ha più ne metta.
Se Regioni ed Enti Locali usano il principio di sussidiarietà con criteri non sempre chiari, il
Legislatore centrale non dà centro il buon esempio. Come si decidono i principi energetici a casa
nostra? A parte i decreti legislativi di recepimento delle direttive comunitarie, che in genere hanno una
base tecnica e soprattutto hanno per forza una parvenza di organicità, in quanto legati ai rispettivi
provvedimenti europei, per il resto le formule più usate sono: la legge finanziaria (notoriamente nata
per altri scopi), i disegni di legge minestrone (tipo il d.d.l. sviluppo) e il decreto legge. I primi due si
fondano sulla rincorsa al comma miracoloso, per cui la lobby di turno convince il parlamentare amico
a presentare un appropriato emendamento. Vuoi perché in questo processo si perdono pezzi di
informazione, vuoi perché le lobby in Italia sono spesso piccole realtà poco competenti e incapaci di
Stampa | Staffetta Quotidiana http://www.staffettaonline.com/Stampa.aspx?id=71119
2 di 4 7-04-2009 14:23

un'azione organica, il risultato cambia poco e il nostro emendamento si limita a bloccare eventuali
decreti ministeriali in emanazione e a dedicarsi a nuovi provvedimenti attuativi, facendo più danni che
altro. Gli esempi si sprecano quindi tralascio. Il decreto legge talvolta produce risultati apprezzabili
(vedi lo sblocca centrali), ma in genere non è risolutivo per temi complessi (stendiamo un velo pietoso
sul D.L. 29 novembre 2008 n. 185, che faceva scempio del diritto e del buon senso) e i vantaggi
dell'iter veloce si pagano con il rischio di impopolarità e rifiuto.
Inutile dire che tante incertezze si traducono non solo in costi diretti, ma anche in una debolezza
strutturale. Sfido chiunque a prestare denaro in queste condizioni. Non è un caso se i capitali stranieri
preferiscono altre mete (un Paese fatto di piccole aziende sottocapitalizzate ne avrebbe bisogno), le
banche adottano spread elevati o chiedono garanzie pesanti, le nostre imprese rimangono
cenerentole e non si sviluppano filiere produttive. Si parla tanto di ESCO ultimamente, ma se non
cambiano le regole del gioco è pane per pochi, vista la dimensione piccola (che in genere si traduce
in mancanza di organizzazione e di multidisciplinarità) e la recente costituzione di molti soggetti, che
li rende poco gestibili dagli istituti di credito.
Se il Paese funzionasse il criterio di base adottato nelle scelte sarebbe: conosco, quindi decido e
agisco, poi controllo e aggiusto (non per niente è alla base dei sistemi di qualità aziendale, dov'è noto
come ciclo di Deming: plan-do-check-act). Conoscenza, chiarezza, trasparenza, diritto. Nella Patria
del rovescio: non conosco, quindi decido ma il giorno dopo ci ripenso per cui le mie azioni vanno a
singhiozzo e non si concretizzano, poi non controllo e comunque ricomincio se chi aveva deciso
prima non era amico mio... No. Così non va.
Per superare queste difficoltà, vedo tre opzioni. La prima è quella di emigrare, confidando in
centri di accoglienza bioclimatici. Ma la vita insegna che fuggire in genere non è una soluzione e poi
abbiamo un bel Paese e conviene investire per migliorarlo. La seconda strada è quella di continuare
più o meno come siamo abituati. Tanto ce l'abbiamo fatta finora e dunque perché preoccuparsi?
Qualcuno risolverà i problemi per noi. Va bene finché si è bambini, ma poi in genere si capisce che
non funziona sempre. Non solo non è detto che arrivino mamma e papà a darci una mano, ma
quando si cade da grandi ci si fa più male. La terza possibilità sta nello sfruttare questo periodo
congiunturale difficile, che presumibilmente farà vedere i suoi veri effetti nei prossimi mesi, per
ristrutturare il Paese e prepararsi a ripartire più forti.
Da questo punto di vista vorrei sottolineare come molti dei mali segnalati in precedenza non
siano legati necessariamente a cattiva volontà o incompetenza. Un elemento che accomuna i
soggetti responsabili tirati in ballo è la carenza di persone (o l'utilizzo inefficiente delle stesse in alcuni
casi). Inutile dire che una struttura sotto organico non può che lavorare male, perché deve pensare a
sopravvivere e può dedicare poco tempo all'aggiornamento professionale, alla conoscenza ed
all'analisi e soluzione dei problemi. Se si prendono i casi di buone pratiche, che non sono rari, si
scopre come in genere siano legati a bravi decisori/amministratori che hanno saputo investire in
risorse e organizzazione e far parlare fra loro le varie funzioni. Basterebbe emularli e saremmo il Bel
Paese sotto tutti i punti di vista.
Per fare questo occorre superare la cultura dei vincoli di spesa e del “senza oneri aggiuntivi per
lo Stato”, che nel medio periodo rischiano di costare più dei risparmi che comportano per la scarsa
qualità dei risultati ottenuti. E occorre andare oltre le barriere linguistiche e mentali, che fanno sì che i
politici parlino con i politici, i tecnici coi tecnici, gli economisti con gli economisti e i medici coi medici,
ma pochi cercano di ascoltare e di parlare con chi è fuori dal loro giro.
Investiamo nelle persone e facciamole lavorare. Ci sono pochi soldi? Ripensiamo allora la
politica degli incarichi multipli, ma soprattutto prevediamo per ogni incentivo delle misure di
accompagnamento. Il 5% dei circa 2 miliardi di euro stanziati per l'efficienza energetica dai
programmi del MSE fra fondi strutturali, ricerca e sviluppo, ad esempio, sono 100 milioni, e
consentirebbero di metter su un'agenzia e di farle fare attività diagnostica, di pianificazione e di
Stampa | Staffetta Quotidiana http://www.staffettaonline.com/Stampa.aspx?id=71119
3 di 4 7-04-2009 14:23

monitoraggio; i benefici conseguenti varrebbero più dei soldi sottratti agli interventi.
Enti e aziende, con più risorse, funzionerebbero meglio e farebbero girare più fluidamente i
meccanismi citati in precedenza. I decreti attuativi uscirebbero con ritardi minori e le autorizzazioni
arriverebbero prima. Conosceremmo di più la realtà e le nostre decisioni sarebbero più solide e
durature. E via discorrendo. Siamo un Paese di servizi, che soffre più di altri la mancanza di lavoro, e
le risorse disponibili sono scarse: usiamole bene!
© Tutti i diritti riservatiE' vietata la diffusione e o riproduzione anche parziale in qualsiasi mezzo e formato.
Stampa | Staffetta Quotidiana http://www.staffettaonline.com/Stampa.aspx?id=71119
4 di 4 7-04-2009 14:23