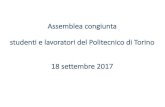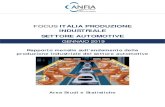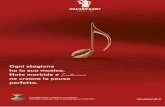In.IT 18
description
Transcript of In.IT 18
-
www.initonline.itn 18
Direttore ScientificoPaolo E. Balboni
Direttore ResponsabileDomenico Corucci
RedazioneMario CardonaMarco Mezzadri Anthony Mollica
EditoreGuerra Edizioni
Via Manna, 25 - 06132 Perugiatel +39 075 5270257 - 8
fax +39 075 5288244www.guerra-edizioni.com
e-mail: [email protected]
Grafica e impaginazioneKeen s.r.l.
CopertinaLetizia Pignani
StampaGuerra Stampa - Perugia
PubblicitGuru S.r.l.
Via Manna, 25 - 06132 Perugiatel +39 075 5270257 - 8
fax +39 075 5288244
AutorizzazioneTribunale di Perugian 12 del 04/03/2000
Tiratura12.000 copie
Le illustrazioni di questo numero riproducono personaggi
celebri del cinema italiano.
1 In.IT
Sommario 18 2006Metodologia
Una proposta di utilizzo didattico di Internet:la webquest.Marco Mezzadri
Italiano LS nel Mondo
Cosa possono fare le istituzioni per aiutare la formazione dei docentiIntervista di Fabio Caon a Fabrizio Lobasso,Console dItalia ad Atene
Una mammina in attesa di scodellare ilmostro, o come entusiasmare una classe di italiano come lingua straniera.Simona Bartoli Kucher
Apprendere l'italiano in TunisiaAbdelmonem Khelifi
Quito: una proposta bilingue dalla scuola dellinfanzia alla maturitBarbara Micheli
Italiano L2 in Italia
Linsegnamento dellitaliano ad adulti stranieri in Italia Paola Begotti
Insegnamento orientato all'azione: una proposta operativaAntonella Filippone e Andreina Scaglione
Cyberitaliano
Indirizzi e siti utili per cercare offerte di lavoro per l'insegnamento dell'italiano a stranieriRoberta Barazza
Strumenti
Universit per Stranieri di Perugia.Universit per Stranieri di Siena.Universit di Venezia.
Materiali didattici
Quaderni CilsCertificazione di italiano come lingua stranieraCollana Arte e MetodoEsercitarsi con la grammaticaCantagrammaApprendere la grammatica italiana con le canzoni
pag
pag
pag
pag
pag
pag
pag
pag
pagpagpag
pag
pag
pag
pag
2
8
12
16
17
20
24
28
303132
7
19
23
27
-
Continuiamo in questo numerola riflessione iniziata in In.it 16
altri paesi, ormai prassicomune nella scuola affidarsia Internet per realizzare atti-vit di ricerca di informazioni.Questo campo di applicazionerisulta prevalente (Petrucco,2002) anche a causa della ric-
chezza di fonti che questa nuova risorsamette a disposizione e della relativa facilitdi reperimento delle informazioni. Questotipo di impiego non riguarda una disciplinain particolare, ma in modo trasversale lamaggior parte di esse. Anche per quantoriguarda litaliano, LS o L2, per ragionididattiche e organizzative fondamentalmen-te simili nei due ambiti, la rete Internet staassurgendo a fondamentale fonte di infor-mazione.Tuttavia a fronte di una sensazione, spessoavvalorata dai fatti, dellalta probabilit ditrovare in Internet quanto ricercato, espe-rienza comune ritrovarsi ad annaspare neltentativo di comprendere le informazionireperite o di utilizzare tali informazioni perproseguire la ricerca. Alla base sta la neces-sit di interpretare lo strumento Internetquale risorsa che investe vari aspetti e nonsolo quelli che definiremmo contenutistici.Un uso didattico di Internet crediamo nonpossa prescindere da riflessioni riguardoalla metodologia da seguire per la sua appli-cazione o alla necessit di coniugare percor-si tematici ad altri di educazione allutilizzodello strumento.Dunque, lintervento cui chiamato ildocente di italiano a stranieri si sviluppa siasul piano linguistico e culturale, sia su quel-lo delleducazione alluso del NT. Questoavverr, a seconda dei contesti, con laiutodi colleghi di altre discipline o sviluppando il percorso formativo in maniera individuale.Comunque sia, il docente di italiano a stra-nieri dovr affrontare, nel momento in cuiaccoglie lopzione dellutilizzo didattico delleNT, i tre piani di intervento contemporanea-mente e cos come dovr richiamarsi alleconoscenze culturali e alle competenze lin-guistiche pregresse degli studenti, ancheper quanto riguarda le NT dovr comportar-si allo stesso modo. Dovr, cio, incentivarepercorsi educativi che approfondiscano lecompetenze duso di questi strumenti; pro-ponendo un esempio facilmente comprensi-bile, si dovr insegnare allo studente a ope-
rare in maniera efficace con Internet, promo-vendo lacquisizione di tecniche di naviga-zione, di raccolta e di elaborazione dei dati,ecc., allo stesso modo in cui si insegnava esi insegna luso del dizionario, di un enciclo-pedia, e cos via. Internet, tuttavia, non unenciclopedia.Lorganizzazione del materiale presente una non-organizzazione. come se fossimodi fronte a innumerevoli mondi, i singoli siti,strutturati con un proprio ordine, che a voltecomunicano tra loro, attraverso i collega-menti ipertestuali esterni, che si imitano lunlaltro, ma che non rispondono a unarchitet-tura generale coerente e coesa. Lo scenarioper chi naviga in questo universo diventaquello che abbiamo descritto sul numero 16di In.it: il rischio il sovraccarico cognitivo,lincapacit o quantomeno la grande diffi-colt delaborazione del materiale reperito,ammesso e non concesso che lutente sap-pia ricercare e trovare linformazione neces-saria. E questo dicasi solo per riprenderealcune delle insidie che derivano dallusodel web.Negli anni sono stati sviluppati modelli dinavigazione che cercano di affrontare il pro-blema (Petrucco 2002, 2003), cos comesono stati predisposti ambienti che accom-pagnano lo studente nellesplorazione delweb: da banche dati, quali i cataloghi di sitidi interesse per una determinata disciplina,a piattaforme per le-learning. Questo contri-buto intende presentare un ambiente che hanella coerenza e nella semplicit strutturale,crediamo, i maggiori punti di forza: la web-quest.
Una definizione Uno degli ideatori della webquest, BernieDodge (1995), fornisce questa definizione:
Una WebQuest unattivit di ricerca nellaquale una parte o la totalit delle informa-zioni con cui interagiscono gli studenti pro-vengono da risorse disponibili in Internet.(Nostra traduzione).
Il secondo ideatore della webquest, TomMarch, nel fornire una propria definizione,evidenzia la necessit di superare il livellodella ricerca e acquisizione dellinformazionedal web se si desidera cogliere il reale valo-re della webquest. March (2004) afferma chela caratteristica principale di una webquest permettere di trasformare linformazionein modo tale da creare una nuova forma
2 In.IT
IN ITALIA,COME
IN MOLTI
Una proposta di utilizzo didattico dmetodologia
Rodolfo Valentinoattore
-
testuale frutto della comprensione, della rie-laborazione critica e dellacquisizione delleinformazioni originali.Secondo lo stesso autore (March 2004) que-sto avviene nelle migliori webquest moti-vando gli studenti a ricercare relazioni tema-tiche sempre pi approfondite e a rifletteresui propri processi metacognitivi.Prima di passare a una descrizione del fun-zionamento ci pare utile presentare unaserie di caratteristiche, obiettivi e vantaggiofferti dalla webquest: insegna, affina, applica strategie di
navigazione e di ricerca nel web; sviluppa il pensiero critico e lautonomia
dello studente attraverso percorsi dicostruzione della conoscenza;
sviluppa un atteggiamento collaborativonegli studenti;
sviluppa abilit cognitive di tipo alto, qualila capacit di analisi e sintesi, e grazie alsuo carattere fortemente collaborativo lacapacit di mediazione e negoziazione disignificati sia sul piano delle competenze ditipo relazionale, sia per ci che attiene allosviluppo dei meccanismi della comprensione;
promuove un atteggiamento di tipoproblem-solving, motivando gli studentigrazie allimpostazione che prevede larealizzazione di contesti, situazioni ecompiti fortemente verosimili;
permette di strutturare attraverso unpercorso di rielaborazione linformazionereperita prevalentemente sul web, inducendolo sviluppo di abilit e strategie atte asuperare il possibile sovraccarico cognitivocui esposto lo studente oggi;
sviluppa strategie di apprendimento diqualit grazie alla sua struttura e al rigorosoprocedimento basato su chiare fasi dipianificazione, esecuzione, monitoraggioe valutazione.
Il procedimentoPotremmo definire la webquest una tecnica,rendendo con questo termine pi compren-sibile il concetto e dar forse la sensazione diuna relativa semplicit duso. Preferiamoper il termine ambiente in quanto credia-mo permetta maggiormente di inquadrarequesto strumento.La webquest dotata di una struttura che leconsente di svilupparsi creando un vero eproprio ambiente di lavoro per gli studenti.La presenza di una struttura accompagna lostudente al di l del percorso di ricerca edelaborazione finalizzato alla creazione di un
prodotto, come pu essere ad esempio larealizzazione di un breve testo della tipolo-gia che si vorr scegliere su un tema specifi-co quale il Carnevale in Italia dellesempiopresentato in conclusione di questo articolo.Il grande valore aggiunto della presenza diuna struttura rigorosa consentire allo stu-dente di promuovere in modo guidato losviluppo della consapevolezza circa i proprimeccanismi e processi metacognitivi. Ci permette di spingere lo studente versoperformance superiori alle capacit delmomento (Cho e Jonassen 2002), sostenen-do e promovendo una crescita integrata siada un punto di vista delle conoscenze, siasul piano metacognitivo. La webquest suddivisa in fasi: introduzione compito procedimento valutazione conclusione.Le attivit a cui sono chiamati gli studentirisultano predeterminate dal docente sullabase dello schema previsto dallambiente. Sitratta prevalentemente, ma non unicamente,di attivit di tipo collaborativo, da svolgerein gruppo. Un elemento pressoch fonda-mentale e immancabile lapproccio di tipoproblem-solving delle webquest. Taleapproccio fornisce agli studenti la possibilitdi esprimersi in modo creativo e di andareoltre il semplice reperimento delle informa-zioni attraverso il web, in modo da risolvereil problema postulato.
3 In.IT
o di Internet: la webquest. di Marco Mezzadri
Antonio De Curtis, in arte Totattore
-
LintroduzioneNella prima fase, quella dellintroduzione, siprocede alla motivazione dello studente ealla definizione dello scenario.Se la webquest prevede las-sunzione di ruoli specifici daparte degli studenti per megliosimulare le attivit, questo ilmomento di proporla. Ad esem-pio: sei giornalista e fai partedella redazione di un importan-te quotidiano. Hai ricevuto unatelefonata anonima che ti infor-mava di. Assieme alla defini-zione degli eventuali ruoli deglistudenti, vengono qui introdottialtri elementi utili a inquadrare ilcontesto e a preparare la fasesuccessiva, quella della defini-zione del compito. Come esem-pio si pu dare unocchiata allawebquest ospitata allindirizzo:http://www.irrepuglia.it/webquest/webfed/introduzione.htm.
Ecco come viene presentata la fase dellin-troduzione.
Il compito La fase successiva dedicata alla descrizio-ne del compito da svolgere e pone laccentoin particolare sul risultato atteso. questo ilmomento per il docente per chiarire agli stu-denti il tipo di competenze richiesto in parti-colare riguardo alle Nuove Tecnologie. Allafine del compito, la soluzione del problemaproposto porta infatti molto spesso alla rie-laborazione di informazioni e materiali repe-riti online e quindi possono venire richiesteconoscenze di strumenti di videoscrittura, dipresentazione o altro.
Eccone un esempio tratto dahttp://quarini.scuole.piemonte.it/webquest/civprec/index.htm
Il procedimento Il terzo momento caratterizzato dalladescrizione del procedimento. Per un esem-pio proponiamo una webquest sui dirittiumani: http://www.swif.uniba.it/lei/scuola/insegnanti/WQ%20Diritti/index.htm.Si tratta della fase che richiede pi prepara-zione da parte del docente. Occorre infattiindicare agli studenti quali risorse soprattut-to web, ma anche di altro genere, essi devo-no utilizzare per portare a termine il compitoassegnato. Ci significa che lo studente vie-ne guidato dallinsegnante a scoprire lerisorse web e non viene scaraventato nelvuoto di uno spazio virtuale troppo pieno diinformazioni, spesso difficili da reperire edelaborare.A monte sta la ricerca e la selezione dellerisorse da parte del docente. Questo anche il momento in cui il docentedeve scegliere le attivit possibili da farsvolgere. Linsegnante di italiano lingua stra-niera ha a disposizione le molteplici risorsefornite dalla sua conoscenza riguardo alletecniche glottodidattiche, ma pu ancheoptare per strumenti non tradizionali qualiprogrammi autore specifici per le lingue, adesempio Hot Potatoes (http://web.uvic.ca/ hrd/halfbaked) o trasver-sali per la didattica, come le cacce al tesorosul web (Mezzadri 2001).Una rapida riflessione si impone ora circa icosti in termini di tempo che la creazione diuna webquest comporta. Nel momento incui, legittimamente, linsegnante si interro-gher sul rapporto costo/beneficio che questo
4 In.IT
metodologia
Una proposta di utilizzo didattico di Internet: la webquest.
-
strumento presenta, crediamo sia importan-te non dimenticare che si tratta di strumentiche possono essere facilmente riproposti incontesti didattici diversi, in anni diversi, ecc. Inoltre le webquest permettonodi procedere non in maniera individuale,come spesso accade nel panorama dellita-liano per stranieri, ma di condividere le pro-prie realizzazioni con altri docenti, e quindiconsentono di usufruire delle proposte dialtri. Ne sono un felice esempio le innume-revoli proposte che si possono rintracciarein Internet.
La valutazioneLa valutazione la fase successiva in cui lostudente invitato a riflettere sul processomesso in atto in chiave autovalutativa attra-verso gli strumenti scelti dal docente comenella proposta a destra tratta dahttp://www.itsos.gpa.it/webquest/webquest/gruppo3/valuta.htm
La chiave autovalutativa una possibile pro-posta didattica che pu essere facilmentecombinata e integrata in modelli di tipovalutativo. Quanto risulta indispensabile nel-la filosofia della webquest affrontare que-sta fase in chiave collaborativa con lo stu-dente, al quale vanno esplicitati i parametriche si andranno ad applicare e quindi glielementi che si andranno a valutare. In rete si trovano risorse utili a creare tasso-nomie sia dei compiti (http://webquest.sdsu.edu/taskonomy.html), sia delle performancedegli studenti (http://projects.edtech.sandi.net/staffdev/tpss99/rubrics/rubrics.html,anche in italiano http://www.bibliolab.it/webquest_task/WebQuest%20Rubric.htm).
La conclusione Lultima parte della webquest riguarda unariflessione conclusiva su quanto gli studentiavranno realizzato e appreso alla fine delpercorso. possibile usare questo spazioper incoraggiare approfondimenti e indicarerisorse e percorsi integrativi.
Le pagine del docente e i ringraziamenti Queste due sezioni aggiuntive nel modellodella San Diego University (http://projects.edtech.sandi.net/staffdev/buildingblocks/p-index.htm) sono dedicate a una sorta di gui-da per il docente che potr essere daiutoallinsegnante in tutte le fasi della webquest.Nei ringraziamenti, invece, troveranno spa-zio le menzioni a persone che hanno colla-
borato alla stesura della webquest, alle fontiutilizzate e infine alle risorse web quali igeneratori disponibili o la pagina principaledella San Diego University dedicata allawebquest (http://webquest.sdsu.edu/).
5 In.IT
di Marco Mezzadri
Marcello Mastroianniattore
Anita Ekbergattrice
-
La lingua della webquestTra i diversi compiti cui si trova di fronte ildocente che intende usare la webquest vi la scelta del registro da utilizzare e il mododi interagire con gli studenti. Se la strutturadellambiente risulta fissa, se i contenutisono la parte mobile per eccellenza, credia-mo che anche il modo in cui essi vengonoproposti possa avere delle ricadute moltoprecise sulla fruizione da parte degli studen-ti, sulla loro motivazione, e quindi sulla riu-scita dellesperienza.A titolo desempio proponiamo uno stralcioda una webquest che riteniamo sia stataconcepita con una giusta attenzione agliaspetti psico-affettivi che le scelte linguisti-che possono coinvolgere
1:
A Carnevale ... ogni dolce veneziano vale!!!
INTRODUZIONE
L'epifania tutte le feste si portata via
Ma in realt la festa possiamo continuaremangiando, divertendoci e andando a ballare
iniziato infatti il Carnevalepieno di maschere, coriandoli e voglia di mangiareSe questa attivit vuoi seguirestai attento a ci che sto per dire:molti dolci italiani potrai imparare a cucinaretutti tipici del veneziano carnevale
Prepara bilancia, uova, zucchero e farinae non dimenticare una bella terrina
giunto il momento di darsi da fareclicca su COMPITO se vuoi imparareDimenticavo...
BUON DIVERIMENTO E... BUON CARNEVALE
COMPITO
L'attivit che stai per fare sar molto utile perimparare non solo il lessico italiano, ma anche per capire esattamente quali dolcisono tipici di Venezia e da dove deriva la lororicetta.
Alla fine dell'attivit, tu e il tuo gruppo potretepresentare ai vostri compagni una ricetta, inPower Point oppure in versione cartacea, e com-mentarla a voce.
Non finita.Durante la festa di Carnevale, sar allestita, ascuola, una piccola zona cucina.L'insegnante procurer gli ingredienti e dovreteprovare a preparare i dolci.
Ora clicca su PROCEDIMENTO se vuoi capirecome organizzarti.
Risorse web per lapprofondimentoIl sito principale The webquest pagedellUniversit di San Diego (in inglese)http://webquest.sdsu.edu/. in inglese. Al suo interno possibile trovare unampia banca dati con progetti diwebquest realizzati per diverse discipline e a diversi livelli.In italiano sono disponibili parecchie risorsetra cui un generatore che pu aiutare aprendere contatto e ad acquisire dimesti-chezza e fiducia nei confronti dei programmiautore:http://www.aula21.net/Wqfacil/webit.htm.Altre risorse in italiano sono disponibiliallindirizzo:http://www.bibliolab.it/webquest.htm.Tra queste la paginahttp://www.bibliolab.it/webquest_task/web-questaskonomy%20italiano_file/frame.htmfornisce una spiegazione per immagini initaliano della webquest.Per la fase di valutazione, alla pagina indica-ta si trova una griglia:http://www.bibliolab.it/webquest_task/WebQuest%20Rubric.htm.In rete sono numerosi gli esempi di web-quest, tra questi citiamo alcuni siti che elen-cano numerose proposte: nella sezione WebQuests del portale:
http://webquest.org/ BestWebQuests, sito gestito da Tom March:
http://www.bestwebquests.com/ e inoltre iwebquest.com:
http://www.iwebquest.com/.
6 In.IT
metodologia
Una proposta di utilizzo didattico di Internet: la webquest.
Dodge B., 1995, "Some Thoughts About WebQuests", inhttp://edweb.sdsu.edu/courses/edtec596/about_webquests.htmlDodge B. J., 1995, WebQuests: A structure for active learning on theWorld Wide Web, The Distance Educator, 1(2).Dodge B. J., Muoz G., 1997, Lessons Learned from the San DiegoMicroworlds Project, presentato al Sixth Annual German-AmericanDialog on Integrating Technology into Schools, Gtersloh (Germania).March T., 2000a, "Are We There Yet?: A Parable on the EducationalEffectiveness of Technology. Multimedia Schools Magazine. Vol. 7 #3.http://www.infotoday.com/MMSchools/may00/march.htmMarch T., 2000b, "The 3 R's of WebQuests: Lets keep them Real, Rich, andRelevant. Multimedia Schools Magazine. Vol. 7 #6.http://www.infotoday.com/MMSchools/nov00/march.htmMarch T., 2004, What WebQuests Are (Really)http://bestwebquests.com/what_webquests_are.aspCho K., Jonassen D., 2002, The Effects of Argumentation Scaffolds onArgumentation and Problem Solving., ETR&D, Vol. 50, No. 3.Mezzadri M., 2001, Internet nella didattica dell'italiano: la frontiera presente,Guerra-ditions SOLEIL, Perugia/Welland.Petrucco C., Costruire mappe per cercare in rete: il metodo Sewcom,in TD-Tecnologie Didattiche n. 25 - Numero 1-2002.Petrucco C., 2003, Ricercare in rete, Pensa Multimedia, Lecce.Ritchie D.; Dodge B. J., 1992, Integrating Technology Usage across theCurriculum through Educational Adventure Games, Paper presented atthe Annual Conference on Technology and Teacher Education (Houston,TX, March 12-15, 1992). ERIC Document Reproduction Service Document#ED 349 955.Stinson A.D., 2003, Encouraging the use of technology in the classroom:The WebQuest connection, in Reading Online, 6(7).
BIBLIOGRAFIA
1Tratta da una webquest creata da Anna Amadio nellambito di uno deipercorsi formativi del Master Itals di Ca Foscari.
NOTE
Federico Felliniregista
-
7 In.IT
Materiali didatticimateriali didattici
novit
Questi volumi contengono le prove somministratenelle due sessioni di esame (giugno e dicembre)negli anni 2003 e 2004 complete delle chiavi e deicriteri di valutazione utilizzati, del CD con i testi perle prove di ascolto, delle trascrizioni e delle istruzio-ni per la somministrazione. Grazie a questi stru-menti, i Quaderni CILS sono utili a tutti coloro chesono impegnati nel processo di apprendimento ooperano nel settore dellinsegnamento e valutazio-ne della competenza linguistico-comunicativa.Servono agli studenti per esercitarsi e misurarsi conle prove e controllare i risultati ottenuti. Gli inse-gnanti possono utilizzare le prove in classe persimulare lesame o parti dellesame. Per entrambirappresentano uno strumento di orientamento perla scelta del livello di esame adeguato al livello dicompetenza linguistico-comunicativa.
Il volume, contenente le prove dei Moduli A1 e A2 - adulti allestero e dei Moduli A1 e A2 - ragazziallestero, destinato a coloro che si trovano nelleprime fasi del processo di apprendimento e che siavvicinano allo studio della lingua italiana in unpaese straniero, e quindi hanno poche occasioni discambio comunicativo con italofoni, al di fuori delcontesto di apprendimento formale. Le prove sonoadatte anche a chi possiede come lingua di origineuna lingua tipologicamente distante dallitaliano(giapponese, cinese ecc.), per i quali, essendo picomplesso il raggiungimento dellautonomiacomunicativa, le difficolt incontrate nelle primefasi del processo di apprendimento, potrebberocausare un abbassamento della motivazione. I duemoduli certificatori possono rappresentare unostrumento utile per sostenerla.
Il volume, contenente le prove del ModuloA1 - adulti in Italia e del Modulo A2 - adulti inItalia, destinato a coloro che si trovano nelleprime fasi del processo di apprendimento e chesi avvicinano allo studio della lingua italiana in
Italia, e quindi possono aver appreso la linguaanche in contesti di interazione spontanea. Leprove rispecchiano i bisogni e gli usi linguisticiprimari di chi si trova in Italia, essenziali per lasopravvivenza e la convivenza in ambito socialee lavorativo. Dal momento che le difficoltincontrate nelle prime fasi del processo diapprendimento, potrebbero causare un abbassa-mento della motivazione, i due moduli certifica-tori possono rappresentare uno strumento utileper sostenerla.
Il volume, contenente le prove del LivelloUNO - B1, destinato a coloro che possiedonouna competenza di base in italiano come linguastraniera: verifica la capacit linguistico-comuni-cativa necessaria per usare la lingua italiana conautonomia e in modo adeguato nelle situazionipi frequenti della vita quotidiana. Uno stranierocon questo livello di competenza pu affrontaresenza problemi un viaggio in Italia: in grado dicomunicare in italiano nelle situazioni di tutti igiorni sia per scritto sia oralmente. La produzio-ne orale e scritta comunicativamente efficace,anche se contiene errori.
Il volume, contenente le prove del LivelloDUE - B2, destinato a coloro che possiedono unacompetenza autonoma in italiano come L2.Prevede una maggiore capacit di uso di elementidellarea fondamentale della lingua rispetto alLivello UNO - B1. Permette di gestire una maggiorevariet di situazioni, sempre tipiche della vita quoti-diana. Chi possiede questo livello in grado dicomunicare efficacemente durante un soggiorno inItalia per motivi di studio e in un contatto con lalingua e la cultura italiana anche per motivi dilavoro. La produzione orale e scritta deve esserecomunicativamente efficace, anche se contieneerrori. il livello che devono possedere gli stu-denti extra-comunitari per iscriversi nelle univer-sit italiane.
Il volume, contenente le prove del LivelloTRE - C1, destinato a coloro che possiedono unlivello di padronanza in italiano come L2: prevedela capacit di gestire unampia area di usi linguisti-ci in differenti contesti di comunicazione. Permettedi comunicare non solo in situazioni tipiche dellavita quotidiana, ma anche nei rapporti formali ditipo pubblico e nei rapporti di lavoro. Chi possiedequesto livello in grado di interagire oralmente eper scritto con Enti pubblici, aziende ecc. dimo-strando di saper assumere un ruolo adeguato allasituazione.
Il volume, contenente le prove del LivelloQUATTRO - C2, destinato a coloro che possiedo-no un livello di piena padronanza in italiano comeL2: prevede la capacit di dominare una vastagamma di situazioni comunicative. Chi lo possiede in grado di interagire non solo nelle situazioniinformali e formali di comunicazione, ma anche inquelle professionali. il livello che deve possedereuno straniero che voglia insegnare italiano; richie-de una completa formazione linguistica.
QUADERNI CILSCertificazione di italiano
come lingua straniera
-
8 In.IT
Intervista di Fabio Caon a Fabrizio Lobasso, Console dItalia ad Atene
Incontro centinaia di insegnanti di italianoogni anno nei vari corsi di formazione ingiro per il mondo. Le situazioni sono diffe-renti, i problemi sono diversi, ma una richie-sta unica a ogni latitudine: Le istituzionidovrebbero essere pi presenti nel preten-dere e permettere la formazione. Cosa pos-sono fare le istituzioni, che poi vuol diresoprattutto i consoli, cui fanno capo i diri-genti scolastici e che hanno le funzioni diquelli che fino a poco tempo fa erano deno-minati Provveditori? Lo chiediamo a Fabrizio Lobasso, ConsoledItalia ad Atene.
Lei ricopre la carica di Console in uno deiPaesi in cui litaliano gode di maggior diffu-sione, la Grecia. Cosa pu fare, e cosa fa, unConsole?Vista laltissima domanda di apprendimentodella lingua e lingente numero di connazio-nali residenti, contribuire a una maggiore emiglior diffusione della lingua italiana inGrecia rappresenta un servizio essenziale diquesto Consolato.Tra le nostre prerogative vi sono le funzionidi supporto istituzionale allIstituto ItalianoStatale Comprensivo di Atene (ancheScuola italiana, esistente in Grecia dallini-zio del secolo) e al Comitato greco dellaSociet Dante Alighieri. Con questi interlo-cutori, e con altri ancora, facciamo il massi-mo per mantenere vivo linteresse dei con-nazionali (specie le ultime generazioni pro-venienti da famiglie miste) e dei greci, nonsolo per la lingua ma anche per il nostromodo di essere e di esprimere italianitnelle varie sfere della vita sociale.Dopotutto, fare sistema significa anchepresentarsi come un soggetto attivo e inte-grato, capace di promuovere la propriaimmagine in modo efficace e competitivo, acominciare dai propri connazionali allestero.La lingua italiana il nostro biglietto da visitae rappresenta uno dei pi saldi punti di forza,perch legato a uno stile di vita che spessosuscita ammirazione e stimola emulazione.Per usare una definizione ricardiana, litaliano uno dei nostri vantaggi comparati sulquale bisogna investire ancora pi tempo edenergie per mantenere alti i livelli di qualite professionalit del suo insegnamento e i livelli di domanda internazionale.
Lei parla di altissima domanda, di chenumeri stiamo parlando? Da un recente studio fatto con lAmbasciatadItalia, si calcola che in Grecia il bacinoattuale di utenza che studia litaliano superile 20.000 unit. Tale cifra comprende i datiprovenienti dalle istituzioni italiane con spe-cifici compiti in materia (ad esempio gliIstituti di Cultura e la Scuola italiana), quellidi enti in qualche modo collegati alle istitu-zioni italiane (ad esempio la Dante Alighierio le due Scuole Materne con presa datto)e quelli provenienti dai numerosissimifrontistiria e cio le locali scuole privatedi lingue straniere. Pur nelloggettiva diffi-colt di calcolare una cifra esatta, andrebbe-ro anche considerati i numerosissimi greciche, privatamente, studiano litaliano perottenere una certificazione finale di cono-scenza dal locale Ministero dellEducazione.Il bacino potenziale, comunque, sicura-mente maggiore. La gran parte dei dati sue-sposti si riferisce alle due importanti circo-scrizioni di Atene e Salonicco, ma esiste unaforte domanda proveniente da altre cittquali Patrasso, Volos, Larissa e importantiisole come Rodi, Corf e Creta.La diffusione della lingua italiana in Greciaavviene in due modi. Quello classico,mediante scuole e istituti che insegnano lin-gua e cultura (tra questi menzioniamo tredipartimenti di italianistica presso universitle universit di Atene, Salonicco e Rodi), e quello legato alla presenza di istituzioniitaliane come la Scuola statale o le scuolematerne dove linsegnamento dellitaliano siiscrive in un contesto pi generale di sistemaeducativo italiano presente nel paese.Anche lidentikit dellutente di due tipi. Dauna parte vi sono i greci che percepisconotutto cio che proviene dallItalia come unostatus symbol. Il caso classico quello di un genitore (in genere il capo famiglia cheha effettuato studi universitari in Italia) cheproietta i suoi desideri di approfondimentodella lingua e della cultura italiana sui proprifigli. Dallaltra vi sono i connazionali che tal-volta restano legati al sistema educativo isti-tuzionale italiano, ma che spesso risultanomolto integrati al sistema educativo greco e desiderano rafforzare le proprie tradizionimediante lapprendimento della lingua attra-verso strutture para-scolastiche.
Cosa possono fare le istituzioni per aitaliano LS nel mondo
Giulietta Masinaattrice
-
Esistono modalit con le quali il Consolatopartecipa direttamente al processo di pro-mozione della lingua italiana e di formazio-ne dei docenti in Grecia?Come detto, esistono in Grecia istituzioni eorganismi italiani deputati alle attivit dipromozione culturale, linguistica e di forma-zione, raccordate con puntualit dallaRappresentanza Diplomatica ad Atene. ConlAmbasciata abbiamo organizzato nel 2005una riuscitissima Settimana della linguaitaliana nel mondo, iniziativa ideata e volu-ta dal Ministero degli Esteri, giunta oramaialla sua quinta edizione, nella quale abbia-mo fatto confluire eventi riguardanti la lin-gua italiana applicata a settori come il cine-ma e la musica, e la sua diffusione attraver-so la letteratura.Esistono poi attivit che di per s coinvolgo-no direttamente loperato del Consolato,specie quando si riverberano sulla vita deiconnazionali residenti (in Grecia, circa12.000), sulla loro interrelazione con il pae-se, o quando riguardano il funzionamentodelle istituzioni scolastiche come la Scuolastatale di Atene. Un interessante fenomeno di interrelazione,per esempio, quello associativo di tiposocio-ricreativo che vede cittadini italiani egreci (permeati dal comune sentimento da-more per la cultura e lo stile di vita italiana)unire i propri sforzi per organizzare eventiludici e culturali a beneficio dei membri del-lassociazione stessa e della comunit locale.Il sostrato su cui possibile sviluppare talefenomeno ovviamente la conoscenza dellalingua italiana, diffusamente parlata dallemigliaia di greci che negli anni passati riem-piva (e ancora riempie, anche se in misuraminore) le nostre universit.A questo fenomeno appassionante ilConsolato d un suo contributo, assicurandola sua efficacia e durevolezza nel tempo. Dauna parte, infatti, esso opera affinch le rela-zioni tra italiani e greci siano sempre pifluide e orientate al reciproco arricchimentoin chiave biculturale; dallaltra, crea le condi-zioni per cui tale fluidit sia assicurata. In tale ottica si iscrive lopera di motivazionenel percorso formativo di chi svolge la pro-fessione di insegnante di lingua italianaallestero, specie quando si tratta di cittadinistranieri: loperatore linguistico, lungi dal-lessere solo un mezzo per la diffusione del-la lingua, della letteratura e della cultura ita-liana, dovrebbe infatti poter rappresentareanche un simbolo della riuscita interazione
di due culture e un meccanismo veicolareper mantenere alti livelli dintegrazione tra i connazionali residenti e la madre patria, da una parte, e tra connazionali e paeseospite, dallaltra. Sul fronte delle attivit della Dante Alighierie della Scuola statale italiana, poi, gli esempidi partecipazione diretta del Consolato allapromozione linguistica e culturale sononumerosissimi. Mi limiter a menzionaredue casi. Il primo il recente successo con le localiAutorit per il riconoscimento in Grecia del-la certificazione linguistica della DanteAlighieri, il PLIDA, ottenuto con dedizione e costante coordinamento con il Comitatogreco dellente. Il PLIDA, oggi, ha raggiuntole certificazioni di lingua italiana gi ricono-sciute ufficialmente dalla Grecia (ad es. il CELI), e ha quindi arricchito il panoramanel paese di offerta del prodotto lingua ita-liana, in linea con il principio generale disana competitivit in un libero mercato.Un altro successo, in collaborazione con il Dirigente scolastico ad Atene, la Direzionedegli Affari culturali del Ministero degliEsteri e lAmbasciata dItalia stato il nego-ziato con le locali Autorit per la revisionedello status e del funzionamento dellaScuola italiana che ha portato per la primavolta nella storia della Scuola alla riunionedi una Commissione mista di lavoro italo-greca, peraltro gi prevista dal Protocolloculturale tra Italia e Grecia del 1956. Oltre a migliorare in chiave egalitaria la nor-mativa per laccesso e luscita dallIstitutodegli studenti, senza pi limitazioni impostedalla rispettiva nazionalit o dai differentisistemi educativi, Italia e Grecia si appresta-no oggi a negoziare alcune integrazioni cur-ricolari nelle due sezioni (greca e italiana)della Scuola in unottica bilinguistica e bicul-turale mirata ad agevolare lavvicinamento ela reciproca conoscenza dei rispettivi sistemi.Lobiettivo finale, da ottenere per gradi, lapiena integrazione delle due sezioni, purmantenendo tagli differenziati per corri-spondere alle richieste dellutenza.
Si rafforza, quindi, il famoso andante deigreci una faccia, una razza quando parla-no dei cugini italiani...Esattamente. Ho ascoltato per la prima voltaquesta frase da un collega greco mentre ter-minavo la mia missione diplomatica aSantiago del Cile, ed stata per cos dire ilmio biglietto dingresso per la Grecia.
9 In.IT
r aiutare la formazione dei docenti.
Gina Lollobrigidaattrice
-
Confermo linteressante somiglianza socio-culturale tra greci e italiani (specie quelli delsud), e aggiungo che desterebbe altrettantointeresse approfondire alcune differenzesocio-comportamentali che, una volta cono-sciute e apprezzate, avvicinerebbero ulterior-mente i due paesi. Il fatto che limmagine dellItalia e la richie-sta ditalianit siano elementi qui cos pre-senti, rende le attivit del Consolato anchepiacevoli, perch improntate alla creativit ealla ideazione di nuove forme comunicative,promozionali e, perch no, formative.
Ad esempio?Questanno, il Consolato organizzer conla preziosa collaborazione di ITALS e in lineacon le iniziative previste dallAmbasciata edalle altre istituzioni italiane in Grecia treseminari che avranno come minimo comundenominatore il miglioramento della comu-nicazione interculturale in ambito sociale,artistico e aziendale. Da una parte lattenzione sar centrata sulbilinguismo come elemento evidente di unapi profonda biculturalit da studiare inambito comportamentale, familiare e scola-stico, specie nelle famiglie miste. Dallaltraci concentreremo sulle relazioni interperso-nali in alcune aziende che rappresentano
veri e propri laboratori di sperimentazionequotidiana di convivenza di diverse perce-zioni di valori quali il concetto del tempo,della gerarchia e dello status sociale nonchdei rispettivi strumenti comunicativi, verbalie non.Tema a parte quello artistico, a me caroanche per ragioni personali essendo autoree compositore di musica. Con la collabora-zione della Scuola italiana e dellUniversitKapodistriaca di Atene, proporremo unmodulo formativo basato sui vantaggi del-linsegnamento della lingua italiana allesteroattraverso la canzone dautore, un tema delquale lITALS un indiscusso pioniere. Talesistema non ha solo il vantaggio di utilizzarela ludicit insita nellascolto musicale qualestimolo alle capacit di apprendimento del-lutente. Esso recupera laspetto pi profon-do, curativo dellascolto musicale che per-mea il sistema fisico, emotivo, mentale epersino spirituale dellascoltatore, azionandoun circolo virtuoso che moltiplica le suecapacit comunicative, cognitive, interattivee mnemoniche. Inoltre, oltre agli aspettidindubbio interesse per questa modali-teccentrica e briosa di insegnare lingua eletteratura, lidea quella di generare utilisinergie in campo musicale tra artisti di ori-gine italiana e artisti locali, entrambi ispiratinelle loro professioni dal patrimonio musi-cale nostrano. In linea con liniziativa lancia-ta qualche tempo fa dal Ministero degliItaliani nel Mondo relativa agli Artisti di ori-gine italiana, si metter quindi in moto unmeccanismo che mira a stanare eventualieccellenze italiane in loco, e comunque a farrisaltare la funzione ispiratrice della canzoneitaliana su artisti locali, anche di chiara fama.
Lo scenario di cui parla sembra idilliaco...ma ci saranno pure alcune smagliature nelsistema promozionale e formativo allesterodella lingua italiana...Da un punto di vista istituzionale, lItalia pienamente consapevole dellimportanza didifendere a livello internazionale il patrimonioculturale rappresentato dalla propria lingua. Il Governo italiano attivamente impegnatoa difendere il ruolo dell'italiano in seno alleistituzioni comunitarie e nell'agire quotidia-no di un'Europa che trova nella diversitculturale e linguistica un innegabile ele-mento di identit e di ricchezza. Sul piano tecnico lascerei sicuramente lopi-nione a chi pi di me ha esperienza nel cam-po della formazione linguistica.
Cosa possono fare le istituzioni per aiutare la formazione dei docenti.
10 In.IT
italiano LS nel mondo
Anna Magnaniattrice
-
Pure, dal mio limitato angolo di osservazio-ne, direi che maggiori sforzi potrebberoessere diretti verso lindividuazione pi pun-tuale delle competenze glottodidattiche delpersonale votato allinsegnamento dellita-liano allestero (a cominciare da quello nelleScuole italiane), per corrispondere con piefficacia alle necessit dellutenza. Unasistematica riflessione preventiva portereb-be allindividuazione di precise figure pro-fessionali per tale scopo. Per fare un esem-pio, potrebbero ridursi i casi in cui dallItaliavengono inviate figure professionali per ladidattica di tipo L1 laddove il bacino di uten-za e le motivazioni locali allapprendimentorichiedono una didattica di tipo L2 o LS.Ancora, una preventiva attivit di pre-posting(o anche il successivo aggiornamento profes-sionale) gioverebbe sicuramente allinseri-mento della figura del docente di italiano nelpaese dove presta servizio. La conoscenza dinozioni relative al sistema educativo delpaese ospite, sulla sua cultura, sui rapporticon lItalia con particolare riferimento aiconnazionali residenti, comporterebbe unapi rapida integrazione con lambiente e lapopolazione scolastica. In Grecia, ad esempio, risulta evidente che ilsistema educativo a differenza di quelloitaliano abbia forti connotazioni mnemoni-che che creano nei giovanissimi meccanismiautomatici di apprendimento. Altro esempio il fenomeno associativo menzionato inprecedenza, che sicuramente diverso inGrecia da quello di alcuni paesi del SudAmerica dove il mantenimento delle originiregionali si giustappone al sentimento diappartenenza alla patria e potrebbe ispirareanche le modalit dinsegnamento della lin-gua da parte del docente.Infine, un maggior coordinamento delle atti-vit dei vari organismi votati allinsegna-mento allestero della lingua italiana, per-metterebbe una visione dinsieme pi chiarasia dei punti di eccellenza della nostra atti-vit promozionale, sia di quelli che inveceriescono a corrispondere solo parzialmenteai bisogni e alle richieste dellutenza.Allargando il raggio di tale coordinamento,dialogando non solo con enti riconosciuti maanche con le realt private locali, si riuscireb-be forse a contrastare in modo pi efficacelingiustificato proliferare di scuole private edi pseudo-docenti che, privi di debita compe-tenza, si lanciano nelle attivit di insegna-mento dellitaliano sfruttando il trend positi-vo della domanda di apprendimento.
In Consolato a volte giungono traduzioni didocumenti originali di cui stentiamo anche acapire il senso. E infatti non raro trovareorganizzazioni locali che, in modo superficia-le, attivano servizi estemporanei di traduzio-ne e/o insegnamento linguistico, nei qualiviene inclusa anche la lingua italiana purnon avendola studiata seriamente o inassenza di certificazioni ufficiali per tale atti-vit. In questo scenario, ci capitato a voltedi dover restituire allutente il documento edi non poter procedere.Per riassumere, lo spirito promozionale allabase della diffusione e dellinsegnamentodella lingua italiana dovrebbe soggiacere asua volta allassunto che non possibileoggi abbassare la guardia, contando su diuna sorta di auto-rigenerazione del fasci-no dellitaliano per gli stranieri o per i citta-dini italiani di ultima generazione nati e vis-suti in un paese diverso dallItalia. Come un valore, una moda, anche litalianoha bisogno di energie e di tempo per rinfor-zare e sviluppare il suo carisma, specie inuno scenario dove la lingua in generale e imeccanismi che ne regolano linsegnamentoe la diffusione subiscono attacchi violentida parte della telematica e della comunica-zione informatica usa e getta che, per cor-rispondere ad apparenti necessit di imme-diatezza, stanno contaminando anche i prin-cipi linguistici pi basilari.
11 In.IT
Sofia Lorenattrice
-
Harald Weinrich rifletteva sulruolo imprescindibile dellaletteratura quale specchio siadella complessit linguisticache della complessit dellavita, invitando gli insegnantidi lingua straniera a farne usofin dalle prime lezioni
1.
Nella pi attuale discussionesu interdisciplinariet e didat-
tica delle lingue straniere, si pu registrareuna ricollocazione del ruolo della letteraturaquale elemento essenziale per confrontarein modo consapevole gli utenti con lassedialettico tra aspettative, comprensione delmondo, esperienze precedenti di lettura elaltro da s (lingua, testo, identit e cultura),quellunit tra lingua e cultura
2in cui
i testi letterari si posizionano sia come baro-metro linguistico, che come istantanee dellacultura straniera in oggetto, per il tramite di una delle sue molteplici manifestazioni.Altre posizioni nel dibattito pi recente sonoveri e propri plaidoyer a favore dei testi let-terari non solo come documenti di lingua, ma anche come veicoli privilegiati del coin-volgimento emotivo del recipiente. LotharBredella per esempio sottolinea che unamoderna didattica della letteratura non devepresentarsi come veicolo delle teorie lettera-rie pi in voga, bens contribuire a renderepossibile la competenza letteraria anche inlettori inesperti sfruttando il potenziale deitesti letterari per lo sviluppo delle facoltcognitive ed emozionali degli studenti
3. Il
presente testo vuole proprio dare testimo-nianza del fattore emotivo rappresentato daimeccanismi complessi del giallo, calato neltessuto complesso della lingua parlata di cui laletteratura contemporanea italiana si fa carico.Nellimmaginario del pubblico (tra laltroprevalentemente femminile) dei corsi uni-versitari di italiano, la rabbia e la determina-zione di una giovane donna incinta, abban-donata dal suo uomo pochi mesi prima discodellare il mostro(87) e improvvisatasidetective per far luce sulle circostanze oscuredella morte di una vicina di casa, sono infat-ti destinate a fare centro, specialmente se iltesto letterario che tutto questo racconta intessuto dalloralit. Quella dimensione del-la lingua che negli ultimi anni pervade la let-teratura e che la ricerca linguistica associaallitaliano delluso comune quotidiano, del-luso colloquiale nella sua variazione diafa-sica, definita cio dalla funzione e dallasituazione duso
4.
La vicenda della giornalista italiana a Parigi,coinvolta suo malgrado nel delitto di unacantante dal nome esotico, con la quale ha addirittura trascorso una notte damore,affascina a prima vista stimolando asprofondarsi nella lettura per terminarladun fiato. Lasciandosi piacevolmente coin-volgere anche da riflessioni sul parlato gio-vanile
5. Una strategia vincente per accorciare
le distanze tra finzione e realt, oltre che perconciliare la necessit di riempire linsegna-mento di una lingua straniera di contenutidella letteratura contemporanea senzarinunciare alle strutture della lingua viva,spendibili per capire e farsi capire. Dellacoesistenza di questi fattori, di casa nella letteratura dei nostri anni, dovrebbe farsiveicolo, secondo noi, una didattica della lin-gua e della letteratura attenta alle esigenzedei recipienti. A un lettore esperto, di casa nella letteraturaitaliana degli ultimi anni, non possono sfug-gire le somiglianze, dal punto di vista tema-tologico, tra il giallo uscito dalla penna diRossana Campo nel 1999, e quello pubblica-to cinque anni prima da Dacia Maraini
6. Una
giornalista curiosa in cerca di scoop con unocchio alla necessit di sbarcare il lunario,una vicina di casa per lungo tempo ignoratanellanonimit del condominio metropolita-no, un delitto improvviso e brutale in unasera destate, una famiglia apparentementeintegerrima nei cui meandri si infila, persmascherarne i segreti, la detective improv-visata: queste le coordinate della fabula diVoci e di Mentre la mia bella dorme. Ma laricerca dei punti comuni non va oltre questielementi strutturali di superficie: la Marainiimbastisce il suo giallo nella nota prospetti-va del narratore autobiografico, e fin dalleprime pagine cerca di dare risposta a unquesito di carattere sociologico, annosoquanto insoluto: perch tante donne vengo-no violentate e uccise? E perch nella mag-gior parte dei casi sono le donne stesse adaprire la porta ai loro assassini? Il giallo di Rossana Campo
7, nel mettere a
nudo il marciume di una societ sprofondatanella ricerca del profitto e nella predilezioneper lomert, si presenta attraverso i pensie-ri e i discorsi diretti, conditi di forme idioma-tiche del parlato giovanile
8, dellingombrante
quanto sgangherata detective che fa di pro-fessione la cronista di nera. Una sera, dopoaver finito di raccontare in trenta righe len-nesimo delitto di famiglia, trova lingressodella sua casa parigina bloccato dallambu-
12 In.IT
italiano LS nel mondo
Una mammina in attesa di scodeo come entusiasmare una classe di italianoGI
NEGLIANNI 80
Sergio Leoneregista
-
lanza, dalle auto della polizia e dai solitisguardi morbosi dei passanti che non hannonessuna voglia di spostarsi, gelosi comesono delle loro postazioni: si stannogodendo la sciagura e non vogliono mollar-la
9per niente al mondo (31).
Per terra un corpo disteso coperto da untelo grigio, da cui esce un braccio sottile di donna, la ragazza del sesto piano, lacantante:
Io ho paura di non aver capito, le dico diripetere. Poi invece ho paura di aver capito.Dico: Ma come? E cho freddo nelle ossa,una specie di aspiratore ha cominciato arisucchiarmi il sangue. arrivata Pauline, si messa a piangere conla mano davanti alla bocca, ha detto: Fruit!Si buttata di sotto.Ho continuato a dire, Cosa cazzo dici? E mela sono presa con lei per non sentire unacosa che mi sta spaccando dentro. qualcosadi non molto solido, che ero riuscita a riat-taccare insieme un po a malapena, e dapoco tempo (32).
Gi in queste poche righe, alcune dellecaratteristiche linguistiche che attraversanotutto il testo: al racconto in prima persona siintrecciano, senza le virgolette introduttivedel discorso diretto, spaccati di parlato tri-viale (Cosa cazzo dici?), seguiti da rifles-sioni interiori espresse sempre nelle formedel parlato colloquiale come i verbi prono-minali, che formano ununit lessicale conuno o due clitici
10(e cho freddo nelle
ossa), usati come variante pi espressivarispetto al relativo verbo senza pronome(avere).
Non certo il primo morto che vedo nellamia vita, per adesso di fronte alla sua fac-cia ho un senso di irrealt. Perch il viso chesto guardando lo stesso che avevo davantiieri sera ma ora non ha pi nessuna reazio-ne e non ne avr mai pi. Ha gli occhi aper-ti, ma stata portata via da un sonno defini-tivo. E c unaltra cosa, forse lultima cosache posso sentire. Questi occhi aperti mistanno parlando.Negli occhi delle persone morte ho semprevisto la conferma di qualcosa che stavanoaspettando. In quelli di Fruit invece c pau-ra e sorpresa. Sono gli occhi di chi stupitoe non capisce quello che sta succedendo,come chi non se laspetta proprio di dovermorire (33).
In questa seconda citazione la chiave din-gresso nel romanzo criminale: si tratta dav-vero di suicidio, come sostiene la polizia? Laforza di quello sguardo, gli occhi aperti diquella ragazza morta quando proprio tuttaltrosi aspettava dal futuro pi prossimo, offronola chiave di lettura del vero e proprio noircon colpi di scena e risvolti inattesi che ver-ranno scoperti dall improvvisata detectivecol pancione sempre pi ingombrante. Coordinate linguistiche e strategie narrativeper tenere ben desta lattenzione e la moti-vazione della pi esigente classe di italianocome lingua straniera. E daltronde non forse vero che negli ultimi anni il giallo, il noir, con il suo meccanismo seduttivo, hatrovato una generazione dautore conqui-stando spesso le classifiche
11dei libri pi
venduti? Perch non utilizzare la popolaritdel giallo, racconto strutturato secondocomplessi meccanismi fondanti, nel quale latrama dei rapporti di coerenza e di coesioneassume forme tali da coinvolgere in modoimpegnativo il lettore, come forse nessunaltro genere testuale
12in una prospettiva
innovativa di didattica della letteratura nel-linsegnamento delle lingue straniere? Neanche il seguito del giallo della Campodelude le aspettative. Mentre la morte dellacantante bella, ricca e intelligente - che tralaltro si scopava un modello bellissimo(35) e pur avendo tutto si stancata di cam-pare - viene presa dassalto da tutti i giornali,indignati a palate (39) per il vuoto dei gio-vani e della societ, la scalcinata detective simette alla ricerca del bandolo della matassa,guidata dal suo istinto:
Daccordo, io sono un essere tuttaltro cheperfetto. Mi faccio metter incinta da una testadi cazzo, continuo a bere birra anche se nondovrei, mi fa sangue un poliziotto polacco
13,
daccordo, per certi versi sono parecchiofuori. Per nella mia vita ho unancora. una specie di bussola che mi dice fin doveposso arrivare, fino a che punto posso scen-dere. E questa bussola la mia intuizione.Chiamiamola anche sesto senso, o istinto disopravvivenza, per si d il caso che pervia di questa bussola che sono rimasta inpiedi fino a oggi, che non sono andata a pez-zi e che posso pensare che il mondo non solo lo schifo allucinante che sembra (52).
Ce n davanzo per tenere sveglia la curiositdel lettore: quella ragazza lio narrante nonriesce a togliersela dalla testa, e la certezza
13 In.IT
di Simona Bartoli Kucherdellare il mostro,no come lingua straniera.
Vittorio De Sicaregista
-
che non si sia suicidata la riempie di speran-za. Il fatto che la stessa certezza illumini lasedicente zia di Marianne (questo il nome dibattesimo della sfortunata cantante), - unaragazza bruttina e schiva, il genere di per-sona che ti chiede scusa di essere al mondo(54) -, danno allio narrante la certezza chela sua testa non sta andando a puttane (40).Da questo punto in poi, il romanzo procedesu due piani che si intersecano: la ricercadellassassino, con landamento incalzantedegli interrogatori che la giornalista detecti-ve fa ai familiari e ai pi stretti conoscentidella vittima - meccanismo fondante delgiallo - e le riflessioni interiori della narratrice,formulate in una scrittura la cui forma domi-nante loralit, il che sarebbe gi di per srilevante nella prospettiva dellapprendi-mento dellitaliano come lingua straniera.Tanto pi che, in prospettiva didattica, vi sipu collegare la riflessione che la lingua ita-liana, liberatasi dalla secolare armatura dellatradizione letteraria, da tempo ormai si avvi-cina, anche a livello della scrittura, allusocomune, quotidiano, colloquiale. E che pro-prio nella letteratura contemporanea stannodi casa elementi e strutture del parlato. Ma torniamo al giallo. Nella sua foga dismascherare il colpevole, la narratrice detec-tive si rivolge direttamente al lettore, inquella mescolanza di tecniche narrative dicui ricca tutta la letteratura contemporanea:
Tira su la testa a carciofo (la narratrice staparlando di Janine), mi guarda coi suoiocchi gonfi e fa: Ah, b, s. Io non ci credoche Fruit si suicidata. Allunga una manoper sfiorarmi il polso. Dice: Lei neanche,vero? ()Non faccio fatica a confidarvi che in questomomento Janine si come accesa di unaluce dorata. Non mi vergogno a dire certecose, perch questo che fa la differenza frale persone che soffrono di stitichezza emotivae le altre. La vita pu cambiare vibrazioni incerti momenti, e ora so che per questo checi siamo incontrate, io e lei, per tirare fuoridalla merda qualcosa che brilla (57)
Si noti la ricchezza di discorsi diretti integra-ti nel tessuto testuale
14, cos come luso del
deittico questo, scelto dalla narratrice perrivolgersi al lettore (Non faccio fatica a con-fidarvi che in questo momento Janine)sottolinea la vicinanza dellio narrante conquanto lei stessa ricorda e racconta. Sonoproprio strutture dellinformalit delluso,
quelle di cui Rossana Campo si serve persottolineare limportanza assunta per lionarrante dallincontro fugace con quella vicinadi casa sparita troppo in fretta, che era statal l per farle scoprire una dimensione nuo-va, diversa:
Fruit mi si avvicinata e ha detto, Mon dieu,che pancione, posso toccarlo? Io ho detto faipure e quella ha incominciato a carezzarmila trippa e come sensazione non nientemale, mi piace il suo tocco. () A un certopunto ci sono le mani e la bocca di Fruit checominciano a andarmi dappertutto, e lei chemi dice, Je vais te faire lamour, cos, comese fosse la cosa pi ovvia da fare al momento.Io ho pensato, b, perch no, magari questanotte scopro una nuova dimensione (22).
Per questo la cronista detective, del pensierodi quella inspiegabile morte non pu liberarsi,e ha la precisa sensazione che su questastoria ci sto uscendo di testa (85): unadislocazione a sinistra, che risponde allesi-genza di collocare al primo posto ci di cuisi parla
15. Cos come, alcune pagine dopo,
unaltra struttura sintattica tipica del parlato- se pure meno frequente - in cui un elemen-to nominale gi noto, la felicit dellio nar-rante dopo la notte passata a casa del pulot-to, viene collocata dopo il nucleo della fra-se
16: Per cavolo non facile, perch non
ho voglia di mollarla questa stronza di feli-cit (89)
17. sempre attraverso il discorso
diretto pieno di sequenze lessicali del parlato,che la protagonista spiega la propria deci-sione esistenzial di infilarsi nel labirinto dipersonaggi e fatti di cui rimasta vittima labella cantante:
Merda Krasicki, mi piaceva quella ragazza,e sento che devo fare qualcosa per lei.Oppure solo che non so che cazzo fare, nonho da lavorare, mi sento sola, e ho una pauradella madonna a pensare che fra poco devomettere al mondo unaltra poveraccia. ()E allora voglio trovare qualche motivo perdirmi che ne vale la pena (87).
Sar un viaggio che decolla da Londra peratterrare negli anfratti del passato dellafamiglia di Fruit, a consentire alla nostraeroina al rovescio di ricostruire la verit inun incredibile quanto inaspettato mosaico:la famiglia come ricettacolo di fantasmi sco-modi, la famiglia come bandolo della matassada districare. Chi ha ucciso la povera Fruit,
14 In.IT
Una mammina in attesa di scodellare il mostro, o come entusiasmare un
italiano LS nel mondo
Michelangelo Antonioniregista
-
fatto fuori il portiere dello stabile in cui vive-va, - colpevole solo di aver visto o sentitoqualcosa di troppo -, chi ha tentato di disto-gliere col terrore prima e di uccidere poi lin-cauta giornalista, altro non che il padrenaturale di Fruit, il rispettabile monsieurMorice, padre di famiglia e uomo daffarilanciato nella carriera politica e un tempofricchettone con lhobby di violentare leragazzine (141). La ragazzina quattordicenneda lui violentata, sorella della sua amante diun tempo e attuale omertosa complice, altronon che la vera madre di Fruit, spacciatasempre invece per la sua pi anziana e sfor-tunata sorella. E chi accende i riflettori sulmarcio nascosto dietro lapparente norma-lit una donna qualunque, mossa daunautentica voglia di farsi giustizia da sola,specie se a un uomo a cui pu farla pagare
18.
Politica, sesso, violenza contro le donne,famiglia: coordinate del tutto attuali che,fino allultimo capitolo coinvolgono emoti-vamente il lettore, creando nel giallo dellaCampo quella suspence la cui esemplarit inprospettiva didattica rappresentata, comesi gi detto, dallopportunit di mirare allosviluppo della competenza linguistica inuso.Si pensi a tutti i casi di overlexikalizationcon lidea del ludico, per rendere il concettodegli avverbi molto e tanto: mi sto cal-mando alla grande(39), Pauline ha conti-nuato a spararne a raffica (21), Lui se nesta l bello, godendosela alla grande (66),Deve avere gi cominciato a bere alla gran-de (79). Quale strumento migliore, in unaprospettiva innovativa della didattica dellaletteratura, di un racconto cos strutturato,per insegnare che nella lingua contempora-nea lidea dellintensificazione si realizzaanche con parole che nello standard nonvengono usate con lo stesso significato?Ecco che la letteratura contemporanea assu-me una particolare dimensione di fruibiletestimonianza glottodidattica: testimonianzadel ruolo crescente che variet ambientatenella dimensione parlata hanno assunto nel-la realizzazione scritta. Come in ogni giallo popolare che si rispetti,in cui la conclusione promuove una visioneottimistica del mondo, anche in quello dellaCampo non manca lhappy ending. Mentrela protagonista avverte nella pioggia batten-te della turbolenta situazione finale una spe-cie di metafora della propria vita, non appe-na spunta il sole lei e la sua amica quasialcolista decidono di smetterla di fumare e
di scoppiarsi con il fumo, oltre che di corre-re dietro a questi imbecilli che non micagano (147), perch limportante capirciqualcosa, cominciare a capire che si valequalcosa nel senso che cos puoi dare unsenso alla tua vita, e smettere di considerar-ti meno di una merda, no? (149).
15 In.IT
re una classe di italiano come lingua straniera. di Simona Bartoli Kucher
1Harald Weinrich, Literatur im Fremdsprachenunterricht ja, aber mit Phantasie, in: Die neueren Sprachen 82:3 (1983), pp. 200-216.
2Lothar Bredella, Werner Delanoy, Was ist interkultureller Fremdsprachenunterricht?, in: Bredella/Delanoy, Interkultureller
Fremdsprachenunterricht, Tbingen: Narr 1999, pp. 11-31, in part. p. 27 e segg.3
Lothar Bredella/Eva Burwitz-Melzer, RezeptionssthetischeLiteraturdidaktik mit Beispielen aus dem Fremdsprachenunterricht Englisch, Tbingen: Narr 2004, p. XVII. E ancora: Jrgen Donnerstag,Kulturelle Kreolisierung und interkulturelle Kompetenz, in: Bredella/ Delanoy, cit, pp. 240-260.
4Monica Berretta, Il parlato italiano contemporaneo, in: Luca Serianni e Pietro Trifone (a cura di), Storia della lingua italiana. Scritto e parlato, II,Torino: Einaudi 1994, p. 242; Tullio De Mauro et alii, LIP-Lessico di frequenza dellitaliano parlato, Milano, Etas - IBM 1993. Per quantoriguarda la lingua parlata, si ricordi che a confronto con altre lingue europee, gli studi e le ricerche sullitaliano sono relativamente recenti. In proposito si veda la bibliografia riportata da Berretta nel testo su citato, e ancora, nello stesso volume: Michele Cortelazzo, Il parlato giovanile,pp. 291-317. Sia Berretta che Cortelazzo mettono a fuoco il problema dellapossibile identificazione dellitaliano parlato con litaliano colloquiale.
5A proposito di lingua dei giovani si veda il gi citato M. Cortelazzo. Pervariet giovanile Cortelazzo intende la variet di linguausata dagliappartenenti ai gruppi giovanili in determinate situazioni comunicative (p.294), indipendentemente dal testo, orale o scritto, in cui compare. Questa variet di lingua si ritrova in una notevole parte della letteratura contemporanea.
6Dacia Maraini, Voci, Milano: Rizzoli 1994; Rossana Campo, Mentre la miabella dorme, Milano: Feltrinelli 1999. Dal libro della Maraini nel 2001Franco Giraldi ha tratto un film con lo stesso titolo.
7Rossana Campo nata nel 1963 a Genova in una famiglia di origini napoletane. Laureata in lettere moderne, vive tra Roma e Parigi. Nel 1992ha pubblicato In principio erano le mutande, da cui il film omonimo di Anna Negri, e ancora alcuni racconti nella raccolta Narratori delle riserve,curata da Gianni Celati; poi Il pieno di super (1993), Mai sentita cos bene(1995), Lattore americano (1997), Il matrimonio di Maria (1998), il libro per bambini La gemella buona e la gemella cattiva (2000), Sono pazza di te (2001), Luomo che non ho sposato (2003).
8Per quanto riguarda un panorama delle ricerche pi recenti sul linguaggiogiovanile, si veda: Elmar Schafroth, berlegungen zur Erforschung vonJugendsprache - illustriert am Italienischen, in: Horizonte, 2000, pp. 25-48
9Le sottolineature fanno riferimento a strutture proprie dellinformalitdelluso, che le rende espressioni tipiche del parlato, ma anche dei livellimeno controllati della scrittura, presenti oltre che nella letteratura contemporanea, anche nella lingua dei giornali.
10Monica Berretta, cit, p. 268. Nel testo della Campo, ancora: Su questa storia ci sto uscendo di testa (85), e Irene caveva il pallino di andare a Parigi (107)
11Oggi si legge di pi per capire la realt, intervista ad Ernesto Franco, direttore editoriale dellEinaudi, in: La Repubblica 5.8.2003. Gli autori a cui Franco fa riferimento, oltre naturalmente a Camilleri, sono Lucarelli, Fois, Ammaniti, coi loro noir che sanno raccontare la societ, aldil della trama.
12Massimo Vedovelli, Analfabeti, criminali di guerra, sordomuti, certificazioni,in: M. Vedovelli (a cura di), Lingua in Giallo, Perugia: Guerra 2004, p. 8.
13Si tratta del pulotto polacco Krasicki che fra i primi a giungere sul luogodella tragedia, e che la protagonista conosce da tempo : le sue mani e i suoi occhi un po da matto mi fanno ricordare due cose, uno, la volta che abbiamo scopato, due che avrei voglia di farlo ancora (36)
14Luso dellindicativo al posto del congiuntivo nella secondaria oggettivaretta da una principale con un verbo di valutazione (io non ci credo che Fruit si suicidata), si trova ormai in molti livelli della scrittura. Si vedapure, nello stesso testo: ...io ho la sensazione precisa che questa donnami si sta aggrappando, e ancora: () e adesso ho paura che a guardarmela ancora mi tornano su dei ricordi ingombranti (61), e Sembra che ha appena ricevuto un diretto in piena faccia (116) , e nata Fruit e le abbiamo fatto credere che era figlia di Irene e del suo primo marito (121) ecc. Tutte le forme verbali sottolineate, allindicativo,dipendono da verbi che indicano unopinione o unimpressione (avere lasensazione, avere paura, sembrare, far credere), e che richiedono pertanto il congiuntivo.
15M. Berretta, cit., p. 255
16Idem, p. 256
17Si veda ancora: Non sono riuscita a schiodarmelo dalla testa, quel nome (133)
18Guarda che un po di tempo che ho voglia di fare qualcosa di moltocattivo a un uomo (137); Mi venuto in mente che questestate hoimmaginato diverse volte di avere per le mani una pistola, ho immaginatodi puntarla addosso al bastardo che mi ha mollata, e anche addosso a altri uomini (144).
NOTE
Luchino Viscontiregista
-
un paese molto vicinoall'Italia e mantiene uno strettorapporto di intercultura. Lasua economia basata soprat-tutto sul turismo, e gli italianisono fra i pi numerosi a visi-tare questo paese del Nord
Africa. Per questo conoscere litaliano diventauna sicura opportunit di trovare lavoro.Non mancano tuttavia persone spinte dalpuro piacere di apprendere una lingua e unacultura nuova.L'insegnamento dell'italiano in Tunisia benavviato da parecchi anni: presente nei liceitunisini fin dagli anni Sessanta, con l'istitu-zionalizzazione dell'inglese come secondalingua straniera dopo il francese, la linguaitaliana divenuta la terza lingua opzionalenei licei e viene studiata negli ultimi tre annidel liceo non prima, con un volume orariodi due ore alla settimana.
Perch litalianoLe motivazioni che spingono gli studenti delliceo a scegliere l'italiano variano. Ci sonoquelli che lo scelgono per continuare a stu-diare l'italiano nelle universit, conseguireuna laurea e andare a insegnare l'italianonei licei, dopo un concorso nazionale; ulti-mamente, sono chiamati a insegnare anchenegli istituti superiori, e ci sono quelli che loscelgono per evitare lo spagnolo, il tedesco,il russo o il cinese. La lingua italiana attiramaggiormente le studentesse.Altra motivazione che suscita l'interesse perl'italiano quella professionale (IstitutiTuristici, di Giornalismo, di Traduzione, diCommercio, d'Industria ecc).
C. Gravin Oliviero, docente alla scuola italia-na di Tunisi, in un articolo sul Corriere diTunisi del 25 giugno 2005, dopo aver esa-minato futuri insegnanti di italiano, scrive:per me si trattato di unesperienza mera-vigliosa, che mai avrei pensato di poter farein vita mia. In un paese culturalmente moltodistante da noi, gruppi compatti di giovanidei due sessi appassionati della lingua e del-la cultura italiana di null'altro desiderosi senon di approfondirne e ampliarne la cono-scenza per s e di diffonderne l'amore afrotte di scolari e di studenti: 238 docentitunisini di italiano il prossimo anno scolasti-co per circa 22.000 studenti nell'80% deilicei di tutto il paese. E non si tratta di genteil cui impegno fosse unicamente finalizzatoa ottenere un posto di lavoro, prospettivaperaltro per se sola dignitosa e legittima. Sitratta di gente che ha fatto delle scelte preci-se: una scelta culturale (scegliendo l'Italia
come oggetto di studio), una scelta di amore(privilegiando il nostro paese su molti altripossibili), una scelta di vita (disponendosi diimmergersi nell'insegnamento e dedicarsialla diffusione della nostra cultura in Tunisia).Ho potuto constatare personalmente nonsolo quanto sincero fosse il loro desiderio diapprendere, ma anche quanto profondo fos-se il loro entusiasmo di farlo incontrandosicon qualcuno venuto apposta dall'Italia adincontrarsi con loro per corrispondere, il piche si possa, alle loro esigenze. Paragoniamo le cifre, citate sopra, con altreapparse sul Corriere di Tunisi il 20 novem-bre 1993: durante l'anno scolastico 1989-90, gli allievi di italiano erano 4.000, gli inse-
16 In.IT
italiano LS nel mondo
LATUNISIA
Apprendere l'italiano in Tunisia.
Bernardo Bertolucciregista
-
gnanti 29, distribuiti in 59 licei e 11 regioni(su 23). Nel 1990-91: gli allievi erano 6.500,gli insegnanti 45, i licei 61 in 14 regioni. Nel1991-92: gli allievi erano 8.250, gli insegnan-ti 60, tra cui 10 italiani, i licei 79 distribuiti in23 regioni, cio su tutto il territorio dellaRepubblica. Si nota il continuo crescere delnumero sia degli insegnanti sia dei discenti.Da non dimenticare che la lingua italiana presente e si studia anche nei due liceiMission Franaise a Tunisi.Quali sono le motivazioni dello studio dellalingua italiana in Tunisi? A questa domandala prof.ssa R. Razgallah, docente all'I.S.L.T,risponde cos: Sono basate prima di tuttosulla prossimit dell'Italia alla Tunisia. I tuni-sini, dopo due secoli di convivenza con la
17 In.IT
di Abdelmonem Khelifi
Quito: una proposta bilingue dalla scuoladellinfanzia alla maturit
Barbara Micheli
LIstituto Luigi Galvani nasce a Quito,capitale dellEcuador, dieci anni fa, su ini-ziativa di una giovane imprenditrice ecua-doriana, Martha Alvarez de Enriquez, e dalsuo amore e interesse verso la lingua e lacultura italiana . La scuola apre le sue portea 30 bambini, alcuni dei quali sono ancoracon noi e sono ormai vicini alla licenzamedia. In un secondo tempo entra a farparte della scuola unaltra ecuadoriana,Rosa Paredes, che con grande interesse ,specialmente per i pi piccoli, aiuta, coordi-na e organizza con grande simpatia.Lunione di queste due persone e lamoreverso i bambini fanno s che la scuola pre-senti, gi al secondo anno di vita, un incre-mento superiore al 100%. Questo porta allanecessit di inserire nellquipe una perso-na di madre lingua italiana, per perfeziona-re linsegnamento della lingua. Barbara Micheli, italiana e, pi precisamente,veneta, entra allIstituto Galvani nellotto-bre del 97, con la sola idea di insegnare aibimbi ecuadoriani la lingua italiana, nellostesso modo con cui laveva fatto con isuoi figli, un po giocando, un po scherzandoe un po sul serio. Lintesa tra le tre imme-diata e il lavoro comincia a prendere dimen-sioni sempre pi grandi, gi durante lannoscolastico 1999-2000 gli alunni sono 800.I genitori hanno creduto nella nostra scuo-la e ci hanno dimostrato sempre grande
affetto e appoggio. La simpatia dimostrata verso la lingua italiana supera ogni aspet-tativa, ed per questo che nel gennaio del2000, lallora Addetto CulturaledellAmbasciata Italiana in Quito, Prof. LeoLuceri, propone di richiedere il riconosci-mento legale al Ministero degli Affari Esteriitaliano.Nellaprile del 2004, la scuola viene dichiara-ta ufficialmente scuola paritaria italiana.Oggi lIstituto Globale Luigi Galvani ha1380 alunni, la seconda scuola italianapi grande del mondo. I nostri bimbi entra-no a 4 anni ed escono, dopo il diploma dimaturit, a 18 anni. La scuola cambiatamolto, ha una sede con tre edifici, con pidi 50 aule, due piscine, laboratori di audioe video, di scienze naturali, fisica e chimi-ca, una biblioteca, due laboratori di infor-matica con 30 computer ognuno, e da que-stanno un meraviglioso teatro per 600 per-sone. Per evadere dal caos e dallo smogdella citt, gli alunni hanno a disposizioneun grande spazio verde, di oltre un ettaro,in periferia , dove possono divertirsi prati-cando gli sport preferiti, dalla pallacane-stro, al tennis, dal calcio, alla pallavolo oalla ginnastica artistica, ma possono anchegiocare a scacchi o imparare larte dellagastronomia, e per gli appassionati di agri-coltura, abbiamo dei piccoli orticelli perimparare a coltivare alcuni prodotti.Ma non sono solo rose e fiori, sono tantele piccole sfide giornaliere che ci spingonosempre e comunque ad andare avanti.Finch troveremo delle risposte nel sorrisodi un bimbo sapremo che ne vale la pena!
Claudia Cardinaleattrice
-
Apprendere l'italiano in Tunisia.
italiano LS nel mondo
comunit italiana, usano oggi le lingue deisuoi mestieri in una lingua franca in cui leparole italiane sono presenti in maggioranza.Affinit e simpatia spingono il tunisino adinteressarsi alla lingua italiana. Di pi, que-sta prossimit permette di sperare di lavora-re in e con l'Italia. I giovani tunisini credonoin un mondo migliore dove la libera circola-zione degli individui senza frontiere creaamicizia e collaborazione.
Le universitIl numero sempre crescente di studenti diitaliano nei licei ha indotto l'universit adare luogo a un nuovo percorso di laurea inLingua e letteratura italiana in parecchie uni-versit e istituti superiori. In particolare:
Universit di Manouba a Tunisi: laurea in Lingua e letteratura italiana (4 anni); laurea in Lingua italiana applicata al
commercio, turismo, affari (4 anni); laurea in Lingua italiana applicata
(LEA; 3 anni); master in Letteratura e linguistica
(3 semestri); inoltre si studia l'italiano come opzione
quando si iscritti a un altro corso di laurea.1 anno, 180 studenti; 2 anno, 140 studenti;3 anno, 100 studenti; 4 anno, 74 studenti.Totale: 494 studenti.
Istituto superiore di lingue di Tunisi(Universit 7 Novembre Carthage): laurea in Lingua e letteratura italiana,
con eventuale specializzazione inTraduzione (4 anni).
1 anno, 117 studenti; 2 anno, 107 studenti;3 anno, 48 studenti; 4 anno, 35 studenti.
Istituto superiore delle scienze umane di Tunisi (I.S.S.H.T), Universit Tunis El Manar: laurea in Lingue applicate (si studia anche
l'italiano; 4 anni).1 anno, 42 studenti; 2 anno, 35 studenti; 3 anno, 30 studenti; 4 anno, 9 studenti.Totale: 116 studenti.
Universit di Gabes (400 km a sud di Tunisi): laurea in Lingua e letteratura italiana (4 anni).1anno, 50 studenti; 2 anno, 30 studenti; 3 anno, 27 studenti; 4 anno, 19 studenti.
Universit di Moknine(regione centro orientale della Tunisia): laurea in Lingua e letteratura italiana (4 anni); laurea in Lingua applicata alla traduzione
(3 anni); laurea in Lingua applicata all'animazione
turistica (3 anni).
Universit di Kairouan(150 km a sud di Tunisi): L'italiano si studia come opzione nei
seguenti indirizzi; Laurea in lingue straniere applicate (3 anni). Laurea in lingua applicata alla traduzione
(3 anni). Laurea triennale in turismo.
Istituto delle lingue applicate di Nabeul(60 km a sud di Tunisi): laurea in Lingua applicata (3 anni).
Parallelamente si studia italiano frequentandocorsi diurni, pomeridiani e serali dedicatiagli adulti sia nellIstituto Dante Alighieri diTunisi che organizza parecchi corsi di linguaitaliana (294 studenti nel 2004-05), sia negliIstituti del Bourguiba School sparsi su tuttoil territorio (quello di Tunisi aveva 210 stu-denti nel 2004-05), sia nell'Istituto di CulturaItaliana che, a sua volta, ne organizza molti.E anche qui il numero degli studenti sem-pre crescente e ha varie motivazioni, dallostudio alla professione e agli interessi di cul-tura generale (storia dell'arte, collaborazionicon gli italiani, capire i programmi della RAI,seguire il calcio italiano che appassionamolto i giovani, ecc.)
20.
18 In.IT
Stefania Sandelliattrice
C. Gravin Oliviero, L'insegnamento dell'italiano nelle scuole secondarietunisine, Il Corriere di Tunisi, 25 giugno 2005, p. 4.F.B., L'insegnamento della lingua italiana nei licei tunisini, Il Corriere diTunisi, 20 novembre 1993, p. 3.R. Razgallah, Le prospettive dell'insegnamento della lingua italiana inTunisia, relazione dattiloscritta, s.d.I. Baldelli, Le sorti della lingua italiana all'estero, Il Veltro, 1-2 (1989), pp. 61-70.J. Chouchane, L'insegnamento della lingua italiana nei licei tunisini,relazione dattiloscritta, 2002.
BIBLIOGRAFIA
20Dati forniti dalla prof.ssa Silvia Finzi, docente all'Universit di Manouba, dalla prof.ssa Rawdha Razgallah, docente all' I.S.L.T Universit 7 Novembre Carthage, dal prof. Fethi Negga, docente all' I.S.S.H.T. Universit Tunis el Manar.
NOTE
-
19 In.IT
Materiali didatticimateriali didattici
novit
Arte e metodo una collana di testi operatividedicati allapprendimento/ insegnamento dellalingua italiana.Gli autori ritengono di aver ideato le matrici chepermettono a insegnanti e studenti di comporrepercorsi di apprendimento efficaci, rigorosi e scientifici ma di volta in volta rinnovabili, integra-bili con testi autentici e finalizzati al raggiungimen-to di un particolare obiettivo. Ogni testo mira alla presentazione di un aspettospecifico dellapprendimento e delluso della linguaitaliana, senza mai scindere la competenza lingui-stica dalle competenze comunicative generali. Gliautori hanno ripreso dal Quadro Comune Europeodi Riferimento delle Lingue lesigenza di operare inmodo puntuale sulle competenze generali, comuni-cative, linguistiche e strategiche. Lattenzione allecompetenze strategiche e agli aspetti metacognitivi la novit che gli autori colgono dalla consultazio-ne del Framework e Portfolio.In Arte e metodo gli autori sostengono studenti einsegnanti nelluso consapevole di metodo e ditecniche atte a dirigere studenti e insegnanti verso ilraggiungimento degli obiettivi intermedi di unsistema di apprendimento permanente. Risolvere un singolo problema linguistico (task),sapendolo inquadrare in uno schema aperto e piampio, significa gi avere la consapevolezza dimuoversi nellapprendimento permanente. Nel processo di apprendimento permanente il rag-giungimento degli obiettivi intermedi, la familiaritcon le tecniche e le strategie necessarie qualoraunite ad eccellenze creative consentono di operarenon pi entro il metodo ma entro larte. Da qui lascelta del titolo della collana: insegnare/imparareuna lingua una scienza, parlarla e scriverla avolte unarte.
Grammatica e comunicazioneLopera un esempio di didattica della grammati-ca italiana a livello operativo. diretta a studentiprincipianti che avranno un quadro completo epreciso dello sviluppo graduale della lingua italiana nei suoi aspetti grammaticali, lessicali,nozionale-funzionali; studenti a livello medio-avan-zato che troveranno materiali e cognizioni utili peruna razionale sistematizzazione della lingua; inse-gnanti che avranno a disposizione tavole sinotti-che di sintesi grammaticale; materiale lessicale scientificamente ordinato e tratto dalle principaliliste di frequenza; presentazione a livelloprincipiante e medio-avanzato delle funzioni enozioni del Livello Soglia; futuri insegnanti di ita-liano a cui si offre una guida completa della didatti-ca della grammatica italiana; autodidatti che neces-sitano di un percorso rigoroso e graduale nellap-prendimento dellitaliano.
Prove graduate di profittoIl volume permette di verificare in itinere i pro-gressi di uno studente e il conseguimento degliobiettivi intermedi prefissati, aiuta ad analizzarecon cura minuziosa la competenza linguisticache, assieme alla competenza comunicativa,costituisce la materia degli esami di certificazio-ne, definiti secondo i parametri tracciati dalCommon European Framework of Reference.Si accerta la padronanza di microcosmi gramma-ticali, semantici, lessicali e funzionali attraversopercorsi diversi, griglie di items con controlliincrociati preparati che la performance (esecuzio-ne) riveli anche il livello di competence (sapereconsapevole). Sono presentate 996 batterie perun totale di 3984 items (a scelta multipla a base4), raccolti in 7 livelli per un totale di 16 provegraduate.
Guida alluso delle preposizioni suddiviso in 5 sezioni:1) Completamento di 40 esercizi (ciascuno con
30 microsituazioni) elaborati nel rispetto dellalista di frequenza oltre che della gradualitgrammaticale. Lo sviluppo delle frasi per argo-menti grammaticali stato guidato dalla con-sultazione di Grammatica e comunicazione.
2) Completamento di 23 microdialoghi presentaesercitazioni chiave per la comunicazione effi-cace entro domini di maggiore frequenza, cioi settori della vita sociale. La scelta di contestiduso di maggior rilevanza facilita la decodificae luso corretto delle preposizioni.
3) Completamento di 23 Sai perch raccoglie alcu-ne curiosit linguistiche a cui si collegano eserci-tazioni di approfondimento lessicale.
4) Una sinossi in grado di fornire allo studente unquadro completo delluso delle preposizioni.
5) Chiavi degli esercizi.
CollanaARTE E METODO
-
per il 2005 ci fornisce dei datiimportanti sui soggiornantistranieri regolari: sono duemilioni e ottocentomila, corri-spondente al 4,8% dellapopolazione attuale, e nellaUnione Europea il nostro pae-se viene solo dopo Germania(7,3 milioni di immigrati) eFrancia (3,5 milioni), mentre alla pari di Spagna e GranBretagna. Per motivi di lavoroarrivano soprattutto i rumeni
(40% dei visti) e quindi, molto distanziati,albanesi, marocchini, polacchi, ciascuno conquote tra il 15% e il 10%, mentre per gli uni-versitari si verificata una lieve ripresa,come si rileva dal numero di studenti inItalia nel 2004 (12.743) e docenti (1086) affe-renti al progetto Erasmus. A questi dati dob-biamo aggiungere gli stranieri irregolari,soprattutto manodopera stagionale, gli adultiin Italia per turismo a lungo termine, perlavori altamente qualificati (dirigenti, mana-ger, professionisti e i loro familiari), oppurechi sceglie lItalia come paese delezione pervivere gli anni della pensione.Nel nostro paese questo afflusso massicciodi adulti stranieri ha determinato il fiorire diiniziative per insegnare litaliano, ma le tipo-logie dei corsi si differenziano notevolmenteed interessante notare come i diversi biso-gni di questo pubblico adulto decretinoanche una differenziazione di indirizzo a cuirivolgersi per la formazione linguistica.Infatti, gli adulti mediamente o altamentescolarizzati si rivolgono a istituzioni quali i Centri Linguistici delle Universit, le sedidella Dante Alighieri o le Scuole private,mentre gli immigrati che arrivano nel nostropaese preferiscono rivolgersi ai corsi orga-nizzati dai Centri Territoriali Permanenti(CTP) delle scuole statali, oppure ai Comunio alle associazioni di volontariato, per conte-nere i costi di iscrizione e frequenza.Ne consegue che negli ultimi decenni, linte-resse degli studiosi di psicologia dello sviluppo umano e di alcuni pedagogisti si trasferito progressivamente dallo studio della prima infanzia a quello dellet adulta o matura, dando vita a quella che statadefinita life-span theory, ossia prospettivacentrata sullarco della vita
21, che si basa su
una logica di evoluzione e di azione. Sempre pi si diffusa, quindi, lespressio-ne Lifelong Learning
22per indicare una for-
mazione permanente delladulto, che preve-
de un apprendimento costante a intervalliregolari lungo lintero arco della vita, secondo uno sviluppo diacronico che con-sente al discente di occuparsi della propriaformazione per un tempo che abbraccia unnotevole numero di anni.Si sta diffondendo ora anche il concetto diLifewide Learning
23, ossia un tipo di forma-
zione che comprende tutti gli aspetti dellavita e in cui tutto diventa occasione diapprendimento, secondo uno sviluppo ditipo sincronico che moltiplica le situazioni diacquisizione di nuovi contenuti e consentealladulto di occuparsi di pi aree formativecontemporaneamente.
Lapprendimento in et adultaGli adulti presentano dei tratti caratteristiciricorrenti che si differenziano rispetto allap-prendimento destinato ai bambini, e ci aprescindere dalla loro provenienza geografica,et, sesso e formazione iniziale.Si possono distinguere le caratteristichedellapprendimento delladulto in sei elementi distintivi
24:
il concetto di s: ladulto ha una personalit formata e desidera essere responsabile delle proprie decisioni e di autogestirsi;
la motivazione: ladulto spinto dal desiderio di autorealizzazione;
il bisogno di conoscenza: ladulto valuta bene i vantaggi che potranno trarre dallaformazione poich investe su questa unnotevole impegno
25;
la disponibilit ad apprendere: ladulto disposto ad apprendere ci di cui ha bisogno;
lorientamento verso lapprendimento:ladulto impara per un utilizzo di conoscenzenella vita reale;
linfluenza dellesperienza precedente:ci sicuramente presenta pi vantaggi che svantaggi in ambito formativo, perch lampio bagaglio interiore di conoscenze consente di metterle a confronto e di apprezzare e cogliere il valore profondo della cultura
26.
La fatica a intraprendere un percorso forma-tivo da parte di un discente adulto vienesupportata dalla motivazione, quella cheBalboni definisce lenergia che mette inmoto hardware e software
27, la quale pu
presentarsi in tre forme: il dovere, che nonporta allacquisizione perch inserisce unfiltro affettivo che fa restare nella memoriaa medio termine le informazioni, il bisogno,
che funziona fino a quando lo studente deci-
Linsegnamento dellitaliano ad a
20 In.IT
italiano L2 in Italia
IL DOSSIERSTATISTICO
DELLACARITAS
Isabella Rosselliniattrice
-
de che lo ha soddisfatto, e il piacere,motivazione essenzialmente legata allemi-sfero destro, ma che pu coinvolgere anchelemisfero sinistro divenendo in tal modopotentissima. evidente che ladulto che impara pu esserespinto da una qualsiasi delle tre motivazioni:un impiegato pu accostarsi a un corso diaggiornamento organizzato dalla sua aziendaspinto dal dovere, ma un immigrato che cercalavoro in Italia, invece, sicuramente sarspinto a frequentare un corso di italiano perbisogno, e cercher di far studiare i figli peruna sorta di riscatto socio-economico e cul-turale
28che consenta a lui e alla sua famiglia
di emergere e autorealizzarsi.Non dimentichiamo, tuttavia, che esistonoanche adulti che si accostano agli studimotivati dal piacere, ad esempio le moltepersone che arrivano in Italia e imparanolitaliano perch appassionati di lirica, oppuredi storia dellarte o perch desiderano leggere testi di letteratura italiana in linguaoriginaria, e questa motivazione senza dubbio la spinta pi potente, che conducea risultati migliori.
Fattori che influiscono sullapprendimentodelladultoTra i fattori che si possono individuare comedeterminanti, sia in senso positivo che nega-tivo, sullapprendimento dellindividuo adul-to possiamo annoverare lesperienza del suovissuto, il livello di scolarizzazione, gli stilicognitivi e le strategie messe in atto, le atti-tudini e la cultura dorigine.Determinante per la formazione lo stilecognitivo che ciascuno di noi possiede,ossia il modo in cui ciascuna persona perce-pisce, elabora e organizza gli stimoli che lepervengono dallambiente: ci non significache lindividuo utilizzi sempre e comunquelo stesso metodo per imparare, ma sicura-mente una modalit che adotta in modoprevalente, che perdura nel tempo e che siriscontra in diversi settori della formazione
29.
universalmente conosciuta la teoria delleintelligenze multiple di H. Gardner
30, il
quale afferma che ognuno di noi possiedeuna pluralit di intelligenze: ogni studentepresenta delle specifiche attitudini e abilitdi cui fondamentale tener conto in ambitoeducativo, ognuno pu avere unintelligenzapi sviluppata e preferita, ma tutti abbiamola capacit di usarle tutte indifferentemente,alternando gradi di preferenza.In didattica, di conseguenza, il docente dovr
proporre attivit variate, che prendano inconsiderazione la maggior parte dei tipi diintelligenza e di canali sensoriali preferiti, in modo da stimolare ciascun discente nellasua diversit.Ladulto, inoltre, ha anche subto uninfluen-za dal contesto culturale e dallo stile di inse-gnamento del suo vissuto: esemplificativa,ad esempio, la tipologia di apprendimentodegli studenti orientali.Generalmente nel sistema scolastico orien-tale uno studente abbina il termine appren-dere a memorizzare e questo semplice-mente perch le lingue orientali presentanomigliaia di forme diverse di ideogrammi chevanno memorizzati nel corso degli anni.Insegnare una lingua straniera a uno stu-dente orientale utilizzando una metodologiadi tipo induttivo, in particolare durante il primoapproccio alla nuova lingua, significa porloin seria difficolt e spesso rendere inefficacelinsegnamento, poich egli generalmentenon abituato a fare ipotesi e confrontarsicoi compagni per ricercare le regole dellalingua, bens richiede tabelle da memorizza-re, frasi da copiare e ricordare.Al contrario, studenti ispanofoni, spagnoli osudamericani mostrano di non temere ilconfronto con i colleghi, ma di apprezzaremolto una metodologia dinamica, centratasulla collaborazione tra partecipanti e conattivit che siano operative.Nel caso di insegnamento della lingua stra-niera, determinante per la formazione purisultare anche la distanza tra la linguamaterna e la lingua straniera o seconda: pila distanza sar accentuata, pi sar mag-giore lo sforzo cognitivo e quindi difficile ilpercorso formativo.Considerato questo punto di vista, vera-mente da apprezzare limpegno manifestatoe gli sforzi compiuti dagli studenti adulti lacui lingua madre presenta ideogrammi, adesempio cinesi, giapponesi, indiani e coreani,oppure comunque con un alfabeto nonoccidentale, ad esempio larabo o il cirillicoperch devono cimentarsi non solo con diver-sit fonologiche e sintattiche, bens anche conp