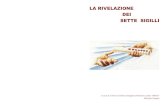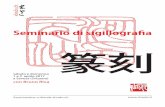Impronte di sigilli mesopotamici conservate ad Aosta
Click here to load reader
-
Upload
stefania-mazzoni -
Category
Documents
-
view
215 -
download
2
Transcript of Impronte di sigilli mesopotamici conservate ad Aosta

Impronte di sigilli mesopotamici conservate ad AostaAuthor(s): Stefania MazzoniSource: Aegyptus, Anno 58, No. 1/2 (GENNAIO-DICEMBRE 1978), pp. 209-221Published by: Vita e Pensiero – Pubblicazioni dell’Università Cattolica del Sacro CuoreStable URL: http://www.jstor.org/stable/41216974 .
Accessed: 14/06/2014 03:51
Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at .http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp
.JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range ofcontent in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new formsof scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected].
.
Vita e Pensiero – Pubblicazioni dell’Università Cattolica del Sacro Cuore is collaborating with JSTOR todigitize, preserve and extend access to Aegyptus.
http://www.jstor.org
This content downloaded from 91.229.248.111 on Sat, 14 Jun 2014 03:51:45 AMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions

Impronte di sigilli mesopotamici conservate ad Aosta
Alla Collegiata di S. Orso ad Aosta sono attualmente conservate alcune impronte realizzate da sigilli cilindrici della collezione raccolta da G. G. Boson (1) a Parigi sul mercato antiquario. Poiché non è
(1) G. G. Boson, in Aegyptus Vili (1927), pp. 272-74; dei sigilli pubbli- cati dallo studioso corrisponde alla nostra impronta n. 2 il sigillo n. 12, p. 274; il sigillo n. 3 del Boson invece non è stato da noi incluso, perché verosimil- mente falso.
Diamo qui di seguito le abbreviazioni utilizzate nel corso della trattazione: Amiet, GS = P. Amiet, Glyptique Susienne des origines à Vépoque des Perses Achéménides. I ( = MB Al XLIII), Paris 1972. Boehmer, EGA = R. M. Boehmer, Die Entwicklung der Glyptik während der Akkad-Zeit (= UAVA 4), Berlin 1965. Buchanan, CANES = B. Buchanan, Catalogue of Ancient Near Eastern Seals in the Ashmolean Museum, Oxford 1966. Delaporte, 6rmrae£ = L. Delapobte, Cylindres orientaux du Musée Guimet, Paris 1909. Delaporte, Louvre II = L. Delaporte, Musée du Louvre. Catalogue des cylindres, ca- chets et pierres gravées de style oriental, II, Paris 1923. Frankfort, CS = H. Frankfort, Cylinder Seals. A documentary Essay on the Art and Religion of the Ancient Near East, London 1939. Frankfort, SCS = H. Frankfort, Stratified Cylinder Seals from the Diyala Region (= 01 P 72), Chicago 1955. Kenna, CCSBM = V. E. G. Kenna, Catalogue of the Cypriote Seals of the Bronze Age in the British Museum (= CCA 3; SMA: XX), Göteborg 1971. Legrain, CBSCM = L. Legrain, The Culture of the Babylonians from their Seals in the Collections of the Museum (= PBS 14), Philadelphia 1925. Le- grain, Ur X = L. Legrain, Ur Excavations, X. Seal Cylinders, New York 1951. Moortgat, VR = A. Moortgat, Vorderasiatische Rollsiegel. Ein Bei- trag zur Geschichte der Steinschneidekunst, Berlin 1940. Osten, Brett = H. H. von der Osten, Ancient Oriental Seals in the Collection of Mrs. Agnes Baldwin Brett ( = OIP 37), Chicago 1936. Osten, Newell = H. H. von der Osten, Ancient Oriental Seals in the Collections of Mr. Edward T. Newell (= OIP 22), Chicago 1934. Parrot, GM = A. Parrot, Glyptique Mésopotamienne. Fouil- les de Lagash (Teïlo) et de Larsa (Senkereh) (1931-33), Paris 1954. Porada, Corpus = E. Porada, Corpus of Ancient Near Eastern Seals in North Ame- rican Collections. The Collection of the Pierpont Morgan Library (== BS 14), Washington 1948. Vollenweider, CRSCI = M. L. Vollenweider, Musée d'Art et d'Histoire de Genève. Catalogue raisonné des sceaux cylindres et intail- les I, Genève 1967.
This content downloaded from 91.229.248.111 on Sat, 14 Jun 2014 03:51:45 AMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions

210 STEFANIA MAZZONI
stato possibile procedere ad un esame diretto degli originali, dei quali non si conosce il presente luogo di conservazione, e poiché delle im- pronte conservate alcune sono attualmente illegibili ed altre appar- tengono a falsi, ci limiteremo nella presente nota ad analizzare le impronte pertinenti sicuramente, a nostro avviso, a sigilli autentici e di buona lettura.
Tengo qui ad esprimere il più vivo ringraziamento a Mons. Do- maine per avermi liberalmente messo a disposizione il materiale e per la sua cordiale ospitalità alla Collegiata.
1. Dim.: h. cm. 3,1; largh. cm. 4 (le misure si intendono riferite al partito fi-
gurativo del sigillo)
Impronta suddivisa in senso orizzontale in due scene da due incisioni orizzontali parallele. In alto: una teoria di cervidi passanti tra piante; di essi uno appare assalito da una figura leonina. In basso due figure sedute in atto di celebrare un banchetto assistite da due inservienti, al lato di un edificio sacro.
Una classe glittica unitaria ben rappresentata in età Protodina- stica è costituita da una serie di sigilli con il campo scenico suddi- viso, spesso tramite una doppia incisione, in due partiti figurativi, caratterizzata dall'associazione di una scena di banchetto, che si svolge per lo più nel registro superiore e, nel registro inferiore, una scena o un fregio del tipo « Figurenband » ovvero con un'aquila leontocefala in atto di afferrare due cervidi ovvero ancora con una semplice teoria di animali. A quest'ultima variante appartiene l'im- pronta di Aosta. L'arco di attestazione di questa tipologia all'in- terno dell'età Protodinastica sembra potersi definire con relativa si- curezza sulla base del confronto con alcuni sigilli a doppia scena di banchetto provenienti dalle tombe reali di Ur (1), tra i quali spicca un sigillo aureo rinvenuto nella tomba della regina Shubad, che si data ad età di poco precedente a Mesanepada (2). Questi sigilli, caratterizzati da una limpida disposizione spaziale e da una resa nitida delle superfici con ampie pause destinate a favorire la corn-
il) L. Woolley, The Royal Cemetery, Urt II. Philadelphia 1934, PI. 193-95. (2) Ib. n. U. 10939, PI. 193, 16; H. J. Nissen, Zur Datierung des Königs-
friedhofes von Ur (= BUFAMK 3), Bonn 1966, p. 60.
This content downloaded from 91.229.248.111 on Sat, 14 Jun 2014 03:51:45 AMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions

IMPRONTE DI SIGILLI MESOPOTAMICI 211
prensione della scena, possono in qualche modo essere serviti di ispirazione ad una serie di sigilli di stile più corrente, rinvenuti in vari luoghi e livelli dello stesso cimitero, ma che devono essere con- siderati contemporanei della serie di stile aulico (1). Fuori di Ur questa classe di cilindri è attestata a Telloh (2) e nella Diyala (3).
Tra gli elementi che distinguono, nell'ambito della serie così iden- tificata l'impronta di Aosta, notiamo che l'inversione delle due scene compare già in un sigillo da Ur (v. nota 3) ed in un sigillo conser- vato all'Ashmolean Museum (4) e che la presenza della porta con i simboli di Inanna, destinata ad identificare il luogo del banchetto, è abbastanza comune (5). Per ciò che concerne più direttamente la datazione della classe, ricordiamo che lo stesso sigillo dell'Ashmolean Museum, le cui figure si presentano vestite come la figura femminile seduta e l'inserviente di destra della nostra impronta, viene datato da B. Buchanan al Protodinastico III, sulla scorta dei dati forniti dall'abbigliamento. Allo stesso modo un sigillo della stessa classe conservato alla Bibliothèque Nationale, con figure abbigliate in modo simile, è datato all'età di Urnanse da A. Moortgat (6), ovvero al Protodinastico III b. Alla stessa data sembrano inoltre convergere i pochi dati desumibili ancora dal confronto con l'abbigliamento della statuaria (7). Infine anche la teoria di animali del registro su- periore dell'impronta di Aosta trova un parallelo evidente per modi iconografici e stile nei cervi di alternati a piante di un sigillo di Ur a due registri, per il quale H. Frankfort (8) ha avanzato una data- zione al Protodinastico III.
(1) Legrain, Ur, X, nn. 119-29, PI. 8-9; il n. 126 presenta le due scene invertite come nell'impronta di Aosta.
(2) H. de Genouillac, Fouilles de Telloh, I, Paris 1934, p. 84, PI. 70 bis le, b, nn. 1284, 1444.
(3) Frankfort, SCS, nn. 968-69, PI- 91. (4) Buchanan, CANES, n. 235, PI. 19, pp. 44, 46. (5) V. a proposito P. Amiet, La glyptique mesopotamienne archaïque, .Fans
1961, p. 123; Porada, Corpus, n. 108 E, PL XVIII, p. 16 (per altri sigilli della stessa classe v. i nn. 109-116, PI. XVIII); v. ancora i sigilli di Telloh già citati.
(6) Moortgat, VR, Taf. A 4, p. 14 = L. Delaporte, Fondation E. fiot. Catalogue des cylindres orientaux et des cachets assy r o -babyloniens, perses et syro-cappadociens de la Bibliothèque Nationale, Paris 1910, n. 51, PL VI, p. 27.
(7) E. Strommenger, in Baghdader Mitteilungen 1 (1960), pp. 41-42. (8) Frankfort, CS, PL XIII e, p. 58 = Woolley, cit., n. U 9751, PL
212, n. 298, considerato da questo autore di tipo elamita e datato ad età ac- cadica, p. 357.
This content downloaded from 91.229.248.111 on Sat, 14 Jun 2014 03:51:45 AMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions

212 STEFAKIA MAZZONI
Ancor più decisivo risulta il confronto tra questi sigilli ed alcune placche votive provenienti da Teli Asmar, Khafagia e Nippur (1) nelle quali ritroviamo l'associazione tra il banchetto e la sfilata di animali in modi pressoché identici, in specie nell'alternarsi del cervo alla pianta. Queste opere permettono anche di valutare come uni- tarie le due scene interpretando la teoria di animali come un mo- mento preparatorio del banchetto stesso secondo schemi iconografici canonizzati nelle placche a rilievo. Infine, il confronto con le placche, unitamente alla constatazione della scarsa adattabilità della divi- sione in registri al limitato campo scenico dei sigilli, permette di formulare l'ipotesi dell'origine di questa classe glittica su imitazione delle placche a rilievo, ovvero per riduzione del repertorio iconogra- fico e del gusto compositivo di quelle. Il fenomeno potrebbe essere confermato in ultima analisi dalla lieve posteriorità dei sigilli di que- sto tipo, dei quali nessuno sembra risalire oltre il Protodinastico III a, rispetto alle placche a rilievo con questa tematica che invece si da- tano fin dall'età di Mesilim.
In conclusione, per l'impronta di Aosta i dati forniti dai con- fronti permettono di formulare una datazione all'interno del Proto- dinastico III.
2. Dim.: h. cm. 2,3; largh. cm. 3,8.
Scena di adorazione: una figura divina è rappresentata stante in adorazione di fronte a Shamash, che brandisce la mazza e la sega, in atto di sorgere dalle montagne, rese a scala; alla sua destra una divinità minore regge la porta. Sul campo come riempitivi compaiono la stella e la mazza tra la porta ed il dio guardiano ed un bastone di misura (?) tra l'adorante e Shamash.
L'impronta appartiene ad una delle classi glittiche più rappre- sentative dell'età accadica, con raffigurazione di Shamash in atto di comparire sulle montagne al di là delle porte del cielo. Lo stile cor- sivo del sigillo, evidente in specie in alcuni particolari della lavora- zione come la sovrapposizione errata delle braccia del guardiano, il
(1) J. Boese, Altmesopotamische Weihplatten. Eine sumerische Denkmals- gattung des 3. Jahrtausends v.Chr. (= UAVA 6), Berlin 1971, n. AS 3, Taf. Ill, pp. 170-71; CS 1, Taf. VI, p. 174; N. 9, Taf. XVIII, p. 185; K 9, Taf. XLI, p. 212, datate dall'età di Mesilim a Ur III.
This content downloaded from 91.229.248.111 on Sat, 14 Jun 2014 03:51:45 AMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions

IMPRONTE DI SIGILLI MESOPOTAMICI 213
gesto insicuro dell'adorante, le vesti dello stesso eseguite con tratto non fermo e la rapida schematizzazione dei tratti del volto, non è raro in sigilli accadici con tale tematica (1). Nei confronti dell'ico- nografia più tradizionale di questa scena (2) l'impronta di Aosta presenta poche varianti, d'altronde già note, quali la figura dell'ado- rante, raramente rappresentato da una divinità (3), e di un solo guardiano invece dei due usuali (4); talvolta i due dati ricorrono insieme (5). Ugualmente sono bene attestati i riempitivi in campo, la stella, la mazza identica a quella brandita dal dio, il bastone di misura (6); non rara è anche la realistica resa di scorcio della gonna del dio nell'atto di ascendere sulla montagna (7). Poiché quest'ul- timo particolare non è attestato anteriormente alla fase centrale dell'età accadica e mostra di stabilizzarsi nella fase finale, la sua presenza sull'impronta di Aosta indica per essa una data tra l'Ac- cadico II e il III (8).
3. Dim.: h. cm. 2,8; largh. cm. 1,3; largh. dell'iscrizione cm. 1,2.
Scena d'introduzione: sulla sinistra è rappresentata la divinità femminile seduta, rivolta a destra verso la dea introducente e l'ado- rante. Iscrizione su tre colonne.
Il sigillo ripropone la classica scena d'introduzione ad una divi-
(1) V. p.es. due sigilli della Diyala: Frankfort, SCS, n. 589, PI. 56; n. 614, PI. 58.
(2) Frankfort, CS, pp. 105-108; Boehmer, EGA, pp. 71-76. (3) Th. Beran, in Archäologischer Anzeiger, 1968, n. 20, pp. 112-14; De-
laporte, Louvre II, nn. A 139-140, PL 71,7-8, p. 109. (4) Amiet, GS, nn. 1557-58, PL 147, p. 199; Boehmer, EGA, Abb. 404,
Taf. XXXIV; 413, Taf. XXXV; Legrain, Ur, X, nn. 239-241, PL 17; Po- rada, Corpus, nn. 185-186, PL XXIX, p. 25.
(5) Boehmer, EGA, Abb. 398, Taf. XXXIII; 423, Taf. XXXV; Bucha- nan, CANES, n. 347, PL 27, p. 65; Osten, Newell, n. 167, PL XIV, p. 29; Parrot, GM, n. 249, PL XIV, p. 53.
(6) Si veda Boehmer, EGA, Taf. XXXIII-XXXVI passim; il bastone di misura compare già in ib. n. 435, Taf. XXXVI e in Amiet, GS, n. 1556, PI. 147, p. 199.
(7) Boehmer, EGA, n. 416, Taf. XXXV; 426, Taf. XXXVI; Buchanan, CANES, n. 347, PL 27; in Osten, Newell, n. 167, PL XIV, p. 29 troviamo un dio in atto di adorazione.
(8) Boehmer, EGA, p. 74; si utilizzano qui le fasi risultanti dallo studio analitico di questo autore, v. pp. 135-37.
This content downloaded from 91.229.248.111 on Sat, 14 Jun 2014 03:51:45 AMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions

214 STEFANIA MAZZONI
nità femminile dell'età neosumerica, in uno stile lineare, con lieve accenno di modellato nei corpi, divulgato nella gran massa dei sigilli di stile non aulico di questo periodo. Infatti il trattamento stilizzato delle frange e degli orli delle vesti (1), degli arti e dei volti (2) ripete senza varianti le schematizzazioni dell'epoca con esercizio di maniera. Ricorre perfino il particolare dell'errore di valutazione dello spazio dell'iscrizione che invade il campo figurativo (3), indizio di una la- vorazione spesso sommaria ed affrettata e di un'applicazione mec- canica degli schemi iconografici. L'unica variante significativa che si può notare in questa impronta nei confronti dello schema classico è costituita dall'inversione di posizione delle figure: infatti la dea compare sempre a destra dell'adorante e mai a sinistra. Poiché tale norma nell'età accadica finale non appare ancora stabilizzata (4), il dato potrebbe indicare per l'impronta una data alta all'interno del- l'età neosumerica.
4. Dim.: h. cm. 2,8; largh. cm. 4.
Scena d'introduzione: sulla sinistra è rappresentata la divinità femminile seduta rivolta a destra verso la dea introducente e l'ado- rante. Dietro la dea compare un simbolo imprecisato.
Si tratta dello stesso soggetto del sigillo precedente, reso in uno stile altrettanto corsivo, ma meno geometrizzante, poiché si allude più realisticamente alle forme nel senso della dea seduta e nella ac- centuata sinuosità dei corpi avanzanti secondo un gusto plastico che in quello era assente e che qui si percepisce al di là del peggiore stato di conservazione dell'originale dal quale l'impronta è stata tratta. Per ciò che concerne l'elemento verticale che si distingue dietro alla figura seduta esso può essere identificato ed associato a taluni sten-
ti) V. p. es. Parrot, GH, n. 124, PI. Vili, p. 28; Delaporte, Louvre II, n. A 207, PI. 75, 16, p. 116; Catalogue of the Collection of the Antique Gems formed by James Ninth Earl of Southesk K.T., ed. by his daughter Lady He- lena Carnegie, London 1908, n. Qa 36, PL IV, pp. 56-57.
(2) V. p. es. Parrot, GM, n. 136, PL VIII, p. 31. (3) 16. n. 139, PL VIII, p. 31. (4) Delaporte, Louvre II, n. A 171, A 174, A 175, A 179, A 185, PL 74,
2, 3, 4, 8, 9, 14, pp. 113-14 con la divinità a sinistra; per la scena di presen- tazione nell'età accadica v. Boehmer, EGA, pp. 113-14.
This content downloaded from 91.229.248.111 on Sat, 14 Jun 2014 03:51:45 AMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions

IMPRONTE DI SIGILLI MESOPOTAMICI 215
dardi od emblemi che spesso accompagnano queste divinità (1). La datazione del sigillo deve, anche in questo caso, essere fissata all'età neosumericaj forse iniziale, se si tiene in considerazione quanto sopra già osservato a proposito dell'inversione della scena nei confronti dell'iconografia comune.
5. Dim.: h. cm. 3; largh. cm. 3,3; largh. dell'iscrizione cm. 1,2.
Scena d'introduzione: sulla sinistra è rappresentata la divinità femminile seduta, al di sotto della falce lunare, rivolta a destra verso la divinità introducente e l'adorante. Iscrizione su due colonne.
L'impronta ripete con stereotipa meccanicità il tema divulgato nell'età neosumerica d'introduzione alla divinità. Nei confronti dei sigilli precedenti a uguale schema ed in genere della corrispondente produzione neosumerica, si nota in questa impronta la presenza di una maniera più schematizzante, secondo un gusto lineare che evita ogni accenno plastico indulgendo, al contrario, in forme affusolate e verticali, che allungano ed assottigliano sproporzionatamente le fi- gure. In questo stile si deve riconoscere comunque una tendenza che informa gran parte della produzione glittica minore d'età neo- sumerica (2).
6. Dim.: h. cm. 2,8; largh. cm. 3,5; largh. dell'iscrizione cm. 0,9.
Scena d'introduzione: sulla sinistra è rappresentata una divinità maschile barbata con mazza e scettro (?) seduta al di sotto della falce lunare, rivolta a destra verso l'adorante seguito dalla dea in- troducente a mani levate. Nel campo tra la divinità e l'adorante compare uno struzzo. Iscrizioni su due colonne.
La solita scena d'introduzione ha come protagonista questa volta una divinità maschile che si potrebbe identificare con Nanna sulla base della falce lunare sovrastante il dio, se questo simbolo non fosse,
(1) Amiet, OS, n. 1832, PI. 166, p. 243, attribuito all'età di Isin e Larsa; Delaporte, Louvre II, n. A 203, PI. 75, 12; A 207, PI. 75, 16 ;A 223, PI. 76, 1, p. 117; A 240, PI. 76, 16, p. 118.
(2) Th. Beran, in Archäologischer Anzeiger (1968), n. 22, Abb. 9, p. 114; Legrain, CBSCM, n. 255, PL XVII, p. 22 L; U. Moortgat-Correns, in Münchner Jahrbuch der bildenden Kunst 6 (1955), n. 7, Taf. I, p. 9.
This content downloaded from 91.229.248.111 on Sat, 14 Jun 2014 03:51:45 AMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions

216 STEFANIA MAZZONI
come invece è, divulgato genericamente nella glittica neosumerica con questo tipo scenico. Tra gli elementi che distinguono questo sigillo all'interno di tale produzione, ricordiamo la presenza dello struzzo che in sigilli con scena d'introduzione ricorre frequentemente ed in particolare nella stessa posizione tra la divinità seduta e l'ado- rante (1) e forse costituisce l'offerta al dio. Anche gli atteggiamenti dell'adorante e della dea, se pure più rari rispetto allo schema del- l'introduzione per mano, come i loro abbigliamenti, non sono infre- quenti nell'età neosumerica (2).
Per ciò che concerne lo stile, è ancora dominante lo stesso gusto lineare di gran parte della produzione glittica di questa epoca, qui lievemente temperato da un debole accenno di modellato nella veste della dea e nei volti, ormai consunti, dell'adorante e del dio.
7. Dim.: h. cm. 2,8; largh. cm. 4,5.
Scena d'introduzione: sulla sinistra è rappresentata una figura maschile barbata seduta sotto una falce lunare, rivolta a destra verso la dea introducente e l'adorante. Ampio spazio vuoto certo previsto per un'iscrizione.
Nonostante che l'impronta si presenti poco chiara forse per lo scarso stato di conservazione della superficie del sigillo dal quale essa è stata realizzata, si può ancora distinguere l'accurata qualità di lavorazione di questo pezzo. Lo stile finemente miniaturistico, che accomuna infatti questa impronta ai migliori sigilli con scena d'in- troduzione al sovrano (3) appartenenti alla III dinastia di Ur (4),
(1) E. Borowski, Cylindres et cachets orientaux conservés dans les collec- tions Suisses I, Mésopotamie (= AA III), Ascona 1947, n. 39, PL VIII, pp. 145-46; Delaporte, Louvre II, n. A 237, PL 76, 13, p. 118; Legrain, CBSCM, nn. 291, 295, PL XIX, pp. 23-32; n. 246, PL XVI; Ur X, n. 367, PL 22, p. 28; Moortgat, VR, n. 272, Taf. 36, p. 108; n. 280, Taf. 37, pp. 29, 109; Porada, Corpus, n. 291, PL XLV, p. 36.
(2) Legrain, CBSCM, n. 311, PL XX, p. 236. (3) Delaporte, Louvre II, n. A 244, PL 76, 21, p. 118; Legrain, Ur, X9
nn. 385-90, PL 23, p. 29. (4) Buchanan, CANES, n. 427, PL 31, p. 77; Legrain, CBSCM, n. 291,
PL XIX, p. 231; per lo stile confronta anche con Moortgat, VR9 n. 258, Taf. 34, p. 107.
This content downloaded from 91.229.248.111 on Sat, 14 Jun 2014 03:51:45 AMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions

Tav. I
1
2
3
4
This content downloaded from 91.229.248.111 on Sat, 14 Jun 2014 03:51:45 AMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions

Tav. II
5
G
7
8
This content downloaded from 91.229.248.111 on Sat, 14 Jun 2014 03:51:45 AMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions

Tav. Ill
9
10
11
12
This content downloaded from 91.229.248.111 on Sat, 14 Jun 2014 03:51:45 AMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions

IMPRONTE DI SIGILLI MESOPOTAMICI 217
è qui impreziosito da un'accurata scansione spaziale delle figure ed in particolare da un modellato leggero e sfumato con tenui accenni di ombre che alludono con sapienza al volume dei corpi secondo il gusto caratteristico dell'epoca.
8. Dim.: h. cm.3; largh. cm. 3; largh. dell'iscrizione cm. 1,5.
Scena d'adorazione: sulla sinistra è rappresentata una divinità maschile seduta in atto di brandire il simbolo della folgore, rivolta a destra verso un offerente con situla in mano. Iscrizione su tre colonne.
L'impronta presenta una scena di adorazione con caratteri pecu- liari ed autonomi nei confronti dei sigilli con questa iconografia. In- fatti la presenza del simbolo del fulmine, che identifica come Adad la divinità seduta, indica al di là di ogni dubbio una data del sigillo ad età paleobabilonese; il simbolo in questione infatti non sembra attestato anteriormente a questo periodo (1). Il carattere generale della raffigurazione tuttavia non permette con certezza questa attri- buzione. Nella glittica paleobabilonese in effetti Adad compare se- duto in un solo caso e sul suo dragone (2); raramente è accompagnato da un offerente con situla (3), che ancora si presenta sempre vestito di un corto gonnellino, rasato e con l'aspersorio oltre la situla, se- condo un'iconografia diffusa e ben stabilizzata (4). La figura invece che accompagna Adad nell'impronta di Aosta riprende nell'atteggia- mento e nei tratti somatici gli offerenti con situla della glittica ac- cadica, raffigurati talvolta in connessione con figure non identificabili sedute (5). Anche lo stile sommario dell'incisione secondo un geome- trismo assai diffuso in classi glittiche popolari o corsive dei vari periodi non offre dati sicuri per l'attribuzione cronologica ed areale dell'impronta. In sintesi queste considerazioni pregiudicano la data- bilità del sigillo, che può essere attribuito tentativamente agli inizi del II millennio forse ad ambiente paleobabilonese.
(1) Frankfort, CS, pp. 162-164, 127. (2) Ib. PI. XXVII i, pp. 127, 163. (3) Ib., n. 1001, PL 92. (4) Ib., p. 158. (5) Delaporte, Louvre II, n. A 167, PI. 73, 11; A 174, 175, PI. 74, 3-4,
pp. 113-14; Legrain, n. 180, PI. XII, p. 196; 236, PI. XVI, p. 210; Porada, Corpus, nn. 245, 252, PI. XXXIV, pp. 30-31.
This content downloaded from 91.229.248.111 on Sat, 14 Jun 2014 03:51:45 AMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions

218 STEFANIA MAZZONI
9. Dim.: h. cm. 2,6; largh. cm. 3,2.
Scena d'introduzione: sulla sinistra è rappresentata una divinità sotto la falce lunare in atto di brandire una sega e calpestare un elemento non più leggibile, rivolta a destra verso un adorante se- guito dalla dea intercedente a mani levate. In campo come riempitivi compaiono il cane o scimmia tra il dio e l'adorante, un volatile (?) ed un bastone di misura tra la dea e l'adorante.
L'impronta propone una delle scene più diffuse della glittica pa- leobabilonese, l'adorazione a Shamash raffigurato in atto di brandire la sega, suo simbolo, e di calpestare con un piede le montagne, sche- matizzate, sulle quali sorge (1). La grande popolarità di questo schema iconografico è responsabile evidentemente di una sua diffusione quasi in serie in sigilli di lavorazione rapida e sommaria come il nostro, senza varianti né nella disposizione delle figure, né nei loro atteggiamenti, ma solo nel numero e nell' alternarsi dei vari riempitivi minori nel campo. Tuttavia anche tra questi notiamo che la scimmia o il cane è assai frequente ed occupa sempre il posto tra il dio e l'adorante (2), e che il volatile ed il bastone di misura compaiono spesso in coppia tra l'adorante e la dea intercedente (3). Il fenomeno della standar- dizzazione di questa iconografia, come d'altronde di altre símilmente popolari nell'età paleobabilonese, non solo nei caratteri generali ma nei dettagli minori della rappresentazione, quali appunto i riempitivi, fa supporre spesso una lavorazione seriale del prodotto o la circola- zione di cartoni o disegni « guida » dai quali gli artisti riprendevano senza varianti le raffigurazioni richieste.
10. Dim.: h. cm. 2,8; largh. cm. 5,2.
Scena di adorazione: sulla sinistra è raffigurata una dea interce- dente rivolta a destra verso una figura maschile barbata vestita di
(1) Per la raffigurazione del dio e dei suoi attributi v. Frankfort, CS, pp. 160-62; Moortgat, VR, p. 39; Porada, Corpus, n. 49.
(2) Delaporte, Louvre II, n. A 323, PI. 79, 10, p. 125; L. Legrain, Ca- talogue des cylindres orientaux de la Collection Louis Cugnin, Paris 1911, n. 50, PI. IV, pp. 34-35.
(3) Legrain, CBSCM, n. 429, PL XXIV, p. 265; Delaporte, Guimet, nn. 55, 57, PI. IV, pp. 42-44.
This content downloaded from 91.229.248.111 on Sat, 14 Jun 2014 03:51:45 AMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions

IMPRONTE DI SIGILLI MESOPOTAMICI 219
corto gonnellino con in mano una mazza. Nel campo senza ordine compaiono un nano a gambe ripiegate, un porcospino, due cervidi e una scimmia o un cane tra le due figure.
La scena presenta il dio della mazza (1) stante di fronte ad una divinità femminile di tipo introducente che sembra rivolta a lui in atto di adorazione. Questo schema iconografico assai povero e sem- plice ma largamente diffuso nella glittica paleobabilonese (2), forse per la sua adattabilità a lavorazioni rapide di serie in una produ- zione che si va facendo sempre più ampia e richiesta, non prevede varianti se non nella scelta e quantità dei riempitivi secondari. Pro- prio il nano, la scimmia, spesso nella stessa posizione, gli arieti (3) e perfino il porcospino (4) sono tra questi i più diffusi. Anche lo stile generale dell'impronta, caratterizzato da un plasticismo appena ac- cennato da un'esecuzione di non grande qualità che tende piuttosto a schematizzare nei punti problematici, quali le spalle o i polpacci, o di secondario interesse, quali i corpi animaleschi ed in genere i riempitivi, non si discosta dal manierismo corrente della glittica paleobabilonese minore.
11. Dim.: h. cm. 2,7; largh. cm. 2; largh. dell'iscrizione cm. 1,5.
Scena di adorazione: sulla sinistra è raffigurata una dea interce- dente rivolta a destra verso una figura maschile vestita di corto gonnellino. Nel campo tra le figure compaiono come riempitivi il sole sulla falce lunare ed un volatile (?). Iscrizione su tre colonne.
Il sigillo appartiene ad una classe glittica diffusa alla fine del- l'età paleobabilonese, caratterizzata dall'iconografia della scena di presentazione od adorazione, da una forte riduzione figurativa e sem- plicità scenica ad evidente vantaggio dell'iscrizione (5) e stilistica-
(1) Frankfort, CS, p. 168; Porada, Corpus, pp. 51-52, 54. (2) V. p. es. MooRTGAT, VR, Taf. 53-54; Porada, Corpus, PL LXII-LXIV. (3) Delaporte, Louvre II, n. A 384, A 387, PL 81, 12, 11, p. 131; Frank-
fort, CS, p. 177; Legrain, CBSCM, nn. 372-373, PL XXII; 385, P. XXIII, pp. 352-53; Osten, Brett, nn. 70, 72, PL VII, p. 11; Porada, Corpus, n. 451 E, PL LXIV; 467, PL LXV, pp. 54-55.
(4) Frankfort, CS, p. 177, PL XXVII i, XXIX a ; Kenna, CCSBM, n. 37, PL IX, p. 22.
(5) Frankfort, CS, pp. 153-54 traccia le linee di questa evoluzione.
This content downloaded from 91.229.248.111 on Sat, 14 Jun 2014 03:51:45 AMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions

220 STEFANIA MAZZONI
mente da un uso esasperato del punteruolo e del disco che incidono solo i contorni delle figure in uno stile sommario e schematizzante. Tra i motivi preferiti è proprio l'incontro tra una figura maschile gradiente, forse il dio con la mazza dei sigilli di stile migliore, ed una dea di tipo introducente, con pochi simboli in campo che tendono a standardizzarsi (1); è evidente come la quasi esclusiva predilezione in questo periodo verso questa scena deve dipendere in gran parte dalla sua adattabilità ad essere riprodotta rapidamente senza par- ticolari attenzioni stilistiche (2).
12. Dim.: h. cm. 2,2; largh. cm. 3,1; largh. dell'iscrizione cm. 1,3.
Scena di adorazione: sulla sinistra è rappresentata una divinità in atto di brandire una sega e calpestare un elemento schematizzato, rivolta a destra verso un offerente che reca un cerbiatto ed una dea ad ali spiegate. In campo compaiono un'aquila ad ali spiegate, uno scorpione ed un occhio. Iscrizione su tre colonne.
La provenienza areale di questa impronta, che presenta una scena paleobabilonese assai diffusa, l'offerta di un capride a Shamash (3), è incerta. Infatti non depongono a favore di un'origine mesopota- mica del pezzo né la particolare figura di Ishtar, che qui funge da dea introducente, né i riempitivi, né lo stile generale dell'incisione. Infatti la dea alata in genere sembra essere esclusiva della glittica paleosiriana (4) nella quale compare non raramente associata ad uno
(1) Buchanan, CANES, nn. 513-18, PI. 35-36, p. 93 presentano scene di questo tipo ma di stile plastico ed esecuzione accurata, dalle quali dipendono ovviamente le rappresentazioni più corsive del nostro tipo.
(2) Buchanan, CANES, nn. 542-43, PI. 37, pp. 97-98: vesti e tiare sono simili; Delaporte, Guimet, n. 75, PI. V, p. 58; Louvre II, n. A 431, PI. 82, 26, p. 134; A 429, PI. 82, 27, p. 134; Moortgat, VR, n. 440, Taf. 53, p. 124; U. Moortgat -Correns, in Baghdoder Mitteilungen 4 (1968), nn. 67-69, Taf. 43, pp. 260-61; H. H. von der Osten, Altorientalische Siegelsteine der Sammlung Hans Silvius von Aulock (= SEU), Uppsala 1957, n. 261, pp. 109, 148; Osten, Newell, n. 223, PL XVII, p. 38; Porada, Corpus, nn. 458, PI. LXIV, p. 54; 475, PL LXVI, p. 55; Vollenweider, CRSCI, n. 40, PL 22, 6, p. 45.
(3) Frankfort, CS, pp. 160-62; Porada, Corpus, pp. 49-50. (4) C. H. Gordon, in Iraq 6 (1939) nn. 41-42, PL VI, p. 18; Osten, Brett,
n. 94, PL IX, p. 15; E. Porada, in Journal of Near Eastern Studies 16 (1957), pp. 192-97, Fig. 1, PL XXX, 1-3; Porada, Corpus, nn. 958-63, pp. 128-29; per un'interpretazione dell'iconografìa v. M. Th. Barrelet, in Syria 32 (1955),. pp. 222-60.
This content downloaded from 91.229.248.111 on Sat, 14 Jun 2014 03:51:45 AMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions

IMPRONTE DI SIGILLI MESOPOTAMICI 221
scorpione (1). Anche la scena di offerta a Shamash in presenza di una dea alata ricorre con frequenza nella glittica dei livelli VII e IV di Alalakh (2) ed è realizzata in uno stile corsivo che schema- tizza i tratti somatici tramite un uso pronunciato del punteruolo e del disco. In questa produzione non sono pure infrequenti come riempitivi lo scorpione (3) e l'aquila (4), mentre l'occhio, stilizzato come appare nell'impronta di Aosta, trova riferimento solo nella glittica mitannica di stile elaborato (5). Infine non va sottovalutato il dato che la dea alata sia nella glittica paleosiriana, che in quella di Alalakh, d'età paleosiriana e mitannica, non presenta mai quattro ali ed è vestita sempre senza varianti con una lunga tunica su di un corto gonnellino (6) e che, quindi, la resa sull'impronta di Aosta deve essere considerata abnorme. In conclusione mentre lo stile, talune caratteristiche della raffigurazione ed in genere l'iconografia depongono a favore di un'origine occidentale di questa impronta in un'età che oscilla tra la tarda età paleosiriana e l'età mitannica, non pochi dubbi permangono sull'associazione degli elementi in campo, riempitivi ed iconografia centrale, ed in specie sull'aspetto della dea, divergente dalle rappresentazioni tradizionali occidentali.
Roma Stefania Mazzoni
(1) Renna, CCSBM, n. 38, PI. IX; Porada, Corpus, n. 960 E, PI. CXLV, p. 128. Si noti che lo scorpione è un simbolo diffuso prevalentemente nella glittica occidentale e più raramente in quella mesopotamica, v. Moortgat, VR, n. 531, Taf. 63, p. 132; Frankfort, CS, p. 177.
(2) D. Collón, The Seals Impressions from Tell AtchanaJ Alalakh (= Au AT 27), Neukirchen-Vluyn 1975, nn. 128, 129, 133, PL IX, pp. 69-72, 183-84.
(3) Ib., PI. XLII, p. 191. (4) Ib., PL XLV, p. 191. (5) Porada, Corpus, n. 1064, PL CLXI, p. 147 lo interpreta come un pesce. (6) D. Collón, cit., PL XX, pp. 182-83; Porada, Corpus, pp. 128-29.
This content downloaded from 91.229.248.111 on Sat, 14 Jun 2014 03:51:45 AMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions