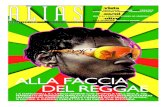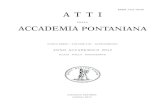IL SISTEMA SANITARIO E L’EMPOWERMENT · 2016. 3. 31. · I L S I S T E M A S A N I T A R I O E L...
Transcript of IL SISTEMA SANITARIO E L’EMPOWERMENT · 2016. 3. 31. · I L S I S T E M A S A N I T A R I O E L...

ILSI
STEM
ASA
NIT
AR
IOE
L’EM
POW
ERM
ENT
6° Supplemento al numero 25 2010
6° Supplemento al numero 25 2010 di Monitor
Trimestrale dell’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali
I QUADERNI DI
Poste Italiane SpASpedizione in Abbonamento Postale 70% - Roma
IL SISTEMA SANITARIOE L’EMPOWERMENT
Elementi di analisi e osservazione del sistema salute�

I QUADERNI DI
Elementi di analisi e osservazione del sistema salute
IL SISTEMA SANITARIOE L’EMPOWERMENT

2
IQU
AD
ERN
IDI
Quaderno di Monitor n. 6
Elementi di analisie osservazionedel sistema salute
Trimestrale dell’Agenzia nazionaleper i servizi sanitari regionali
Anno IX Numero 25 2010
DirettoreFulvio Moirano
Direttore responsabileChiara Micali Baratelli
Comitato scientificoCoordinatore: Gianfranco GensiniComponenti:AldoAncona,Anna Banchero,Antonio Battista, Norberto Cau,Francesco Di Stanislao,Nerina Dirindin,Gianluca Fiorentini, Elena Granaglia,Roberto Grilli, Elio Guzzanti, Carlo Liva,Sabina Nuti, Francesco Ripa di Meana,Federico Spandonaro, FrancescoTaroni
EditoreAgenzia nazionaleper i servizi sanitari regionaliVia Puglie, 23 - 00187 ROMATel. 06.427491www.agenas.it
Progetto grafico,editinge impaginazione
Via V. Carpaccio, 1800147 Roma
StampaCecomBracigliano (Sa)
Registrazionepresso il Tribunale di Roman. 560 del 15.10.2002
Finito di stamparenel mese di luglio 2010
L’Agenzia oggi | Presidente Renato BalduzziDirettore Fulvio MoiranoConsiglio di amministrazione Carlo Lucchina, Pier Natale Mengozzi, Filippo Palumbo, Giuseppe ZuccatelliCollegio dei revisori dei conti Emanuele Carabotta (Presidente), Nicola Begini, Bruno De CristofaroI settori di attività dell’Agenzia | Monitoraggio della spesa sanitaria • Livelli di assistenza • Organizzazione dei servizi sanitari •Qualità e accreditamento • Innovazione, sperimentazione e sviluppo • Formazione - Sistema nazionale di Educazione Continua in MedicinaECM • Documentazione, informazione e comunicazione • Affari generali e personale • Ragioneria ed economato
www.agenas.itSul sito dell’Agenzia sono disponibili tutti i numeri di
Periodico associatoall’Unione StampaPeriodica Italiana
L’Agenzia Nazionale per i servizi sanitari regionali è un ente con personalità giuridica di diritto pub-
blico che svolge un ruolo di collegamento e di supporto decisionale per il Ministero della Salute e le Regio-
ni sulle strategie di sviluppo del Servizio sanitario nazionale. Questa funzione si articola nelle seguenti
specifiche attività: la valutazione di efficacia dei livelli essenziali di assistenza; la rilevazione e l’analisi dei
costi; la formulazione di proposte per l’organizzazione dei servizi sanitari; l’analisi delle innovazioni di
sistema, della qualità e dei costi dell’assistenza; lo sviluppo e la diffusione di sistemi per la sicurezza delle
cure; il monitoraggio dei tempi di attesa; la gestione delle procedure per l’educazione continua in medicina.

PRESENTAZIONER.Balduzzi ...................................................................................................................4INTRODUZIONE - Il ruolo dell’Agenas nelle strategie di sviluppo dell’empowermentF.Moirano .....................................................................................................................7I RISULTATI DELLA RICERCA AGENAS - Definizione, modello di analisi, strumentidi rilevazione ed esperienze significative di empowerment in sanitàG.Caracci,S.Carzaniga ...................................................................................................10
LEVOCI DELLE REGIONI E PROVINCEAUTONOMEI percorsi sviluppati nell’ambito della ricercaL’ESPERIENZA DELLA REGIONE CAMPANIAG.Franco ....................................................................................................................20REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA - Presentazione del percorso sviluppato a livello regionaleS. Gagliardi,G.Simon .....................................................................................................24PERSONA, CITTADINO, PAZIENTE - Il programma di empowerment nella Regione PiemonteM.Viale, O. Bertetto .....................................................................................................28REGIONE UMBRIA - Il cittadino competente e attivo nel sistema saluteA.Perelli .....................................................................................................................34REGIONEVENETO - Il miglioramento continuo tra partecipazione e corresponsabilizzazioneP. De Polli, M.G. Cavazzin .............................................................................................41
FOCUS SU DUE ESPERIENZE SPECIFICHEPROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - La certificazione delle impresecome occasione per la promozione della salute e l’empowermentF.Plörer ......................................................................................................................48PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - Cartella clinica del cittadino-TreC:uno strumento per l’empowermentL. Pontalti, D. Conforti, E. Piras, S. Forti ............................................................................55
POLITICHE E STRATEGIE REGIONALIREGIONE ABRUZZO - Lo stile comportamentale degli operatori del sistema sanitarioper favorire l’empowerment dei cittadiniL.Tobia, F. Forgione ......................................................................................................66EMPOWERMENT DI COMUNITÀ - Gli orientamenti in Regione Emilia RomagnaM.A. Nicoli, M. Biocca,A. Brambilla, S. Capizzi, B.M. Carlozzo,A. Marcon, F.Terri ......................68REGIONE LOMBARDIA - Empowerment e sussidiarietàF.Milani .....................................................................................................................74DIRITTI E PARTECIPAZIONE NELLE POLITICHE DELLA REGIONETOSCANAM.Menchini,R.Bottai .....................................................................................................81
EMPOWERMENT EVALUTAZIONE:PROSPETTIVE E METODIA CONFRONTOEMPOWERMENT - Misurare cosa capita e perchéP. Lemma, N. De Piccoli, M. Di Pilato, C.Tortone,A. D’Alfonso ................................................90LAVALUTAZIONE DELL’EMPOWERMENT - ProspettiveP.Poletti......................................................................................................................95EMPOWER(ING)MENT EVALUATION -Valutare in promozione della salute per produrre saluteG.Pocetta ..................................................................................................................102EMPOWERMENT EVALUTAZIONEA. Marcon, M.A.Nicoli ................................................................................................111
I CITTADINI, L’EMPOWERMENT E LAVALUTAZIONEFARE EMPOWERMENT CON LE ASSOCIAZIONI DI CITTADINI E PAZIENTIL’esperienza di PartecipasaluteP. Mosconi, C. Colombo,A. Liberati, R. Satolli ....................................................................124L’AUDIT CIVICOA.Terzi.....................................................................................................................131
Sommario
3
IQU
AD
ERN
IDI
IL SISTEMA SANITARIOE L’EMPOWERMENT

4
IQU
AD
ERN
IDI I
l presente Quaderno di Monitor è dedicato al-l’empowerment del cittadino, un termine in-glese che risulta ancora impossibile, a causadella sua complessità semantica, tradurre con
una sola parola in italiano e con il quale in que-sto testo ci si riferisce alla partecipazione consa-pevole del cittadino e della comunità alla gestio-ne della sanità e della salute.Rispetto a tale tema, che negli ultimi decenniha assunto un ruolo di crescente rilevanza nel-l’ambito dei servizi sanitari, l’Agenas ha rice-vuto dalla Conferenza Unificata del 20 settem-bre 2007 un preciso mandato, in virtù del qua-le “l’Agenzia favorisce e supporta la pianificazione,la gestione e la valutazione di strategie, ricerche e per-corsi formativi finalizzati all’empowerment degli am-ministratori locali, delle comunità ed allo sviluppodelle competenze del personale dipendente degli entilocali coinvolto nelle attività di integrazione socio sa-nitaria, in linea con gli indirizzi internazionali, na-zionali e delle Regioni in tema di sviluppo di com-petenze”1. Con tale deliberazione, la Conferen-za Unificata ha inteso recepire una serie di in-dicazioni provenienti dal contesto internazio-nale e nazionale.A livello internazionale, l’Organizzazione Mon-
diale della Sanità, sin dal 1978, attraverso le di-verse Conferenze Internazionali sulla promozio-ne della salute, chiede agli Stati membri l’impe-gno ad assumersi responsabilità precise sul temadella partecipazione dei cittadini. Nella Dichia-razione di Alma Ata (1978)2 si sottolinea che l’e-quità e la partecipazione sono obiettivi della pro-mozione della salute; nella Carta di Ottawa (1986)3
e nella Dichiarazione di Jakarta (1998)4 si rico-noscono nell’azione della comunità e nell’empo-werment due pre-requisiti per il raggiungimen-to degli obiettivi di salute; nella Carta di Bang-kok (2005)5 si evidenzia il ruolo dell’empower-ment nella problematica della sostenibilità dei si-stemi sanitari.Nell’ultima Conferenza globale sul-la promozione della salute, tenutasi a Nairobi nel-l’ottobre del 2009, l’empowerment individuale edella comunità sono considerati strategie fonda-mentali per implementare concretamente ed ef-ficacemente la promozione della salute.L’istanza internazionale di occuparsi di empo-werment, tuttavia, non proviene esclusivamentedalla sanità pubblica, ma si affianca alla richiestadegli stessi cittadini, avanzata attraverso le loroassociazioni di rappresentanza.A tal proposito, ri-sultano esemplari il Manifesto dei pazienti per il
PRESENTAZIONE
di Renato BalduzziPresidente Agenas - Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali
1 Deliberazione Conferenza Unificata del 20-09-2007 Rep.Atto n.73/CU.2 WHO (1978), Declaration of Alma Ata, Geneva,World Health Organization.3 WHO (1986), Ottawa Charter for Health Promotion, Geneva,World Health Organization.4 WHO (1998), The Jakarta Declaration on Leading Health Promotion into the 21st Century, Geneva,World Health Organization.5 WHO (2005), The Bangkok Charter for Health Promotion in a GlobalizedWorld, Geneva,World Health Organization.

5
IQU
AD
ERN
IDI
Presentazione
Parlamento e la Commissione Europea 150 Mi-lioni di ragioni per agire6, con il quale lo EuropeanPatients’ Forum richiama i governi europei adimpegnarsi in tre fondamentali aree di azione alfine di migliorare la qualità dell’assistenza. Delletre aree, due riguardano “Migliore informazionee risorse affinché i pazienti siano partner nel de-terminare le proprie cure” e “Una voce dei pa-zienti che sia ascoltata a Bruxelles e attraversotutta l’Unione Europea”. L’International Allian-ce of Patients’ Organizations, nella Dichiarazionesull’assistenza sanitaria centrata sul paziente7, invitai decisori politici, i professionisti sanitari, i pro-vider e le industrie impiegate nel campo della sa-nità, a mettere al centro delle loro politiche epratiche cinque principi, tra i quali “Scelta edempowerment” e “Coinvolgimento del pazien-te nelle politiche per la salute”. La stessa Com-missione delle Comunità Europee, infine, nel-l’ambito dell’Approccio strategico dell’UE per il pe-riodo 2008-20138, individua nella partecipazionedei cittadini uno dei principi fondamentali chedebbono guidare l’azione comunitaria nel setto-re della salute.A livello nazionale, il principio della centralità dellapersona costituisce uno dei cardini dell’ordinamento co-stituzionale italiano, ed il diritto alla salute, nei suoivari risvolti, ne realizza un elemento caratterizzante9.La partecipazione del cittadino è stata ricono-sciuta quale principio fondante del nostro Servi-zio sanitario nazionale sin dalla sua istituzione(legge 23 dicembre 1978 n. 833), ed ha assuntodefinizioni sempre più specifiche attraverso testinormativi successivamente emanati.Tra questi,due risultano di particolare rilevanza: il decretolegislativo 30 dicembre 1992 n. 502 ed il decre-to del Presidente del Consiglio dei ministri 19maggio 1995. Il d.lgs 502/1992 dispone la previ-
sione di forme di partecipazione dei cittadini edegli utilizzatori dei servizi alla verifica dell’atti-vità svolta e alla formulazione di proposte rispet-to all’accessibilità dei servizi offerti, nonché l’a-dozione e l’utilizzazione sistematica della cartadei servizi per la comunicazione ai cittadini. IlDpcm 19 maggio 1995 definisce lo schema ge-nerale di riferimento per l’adozione della Cartadei servizi pubblici sanitari intesa come strumentovolto “alla tutela dei diritti degli utenti: non sitratta di una tutela intesa come mero riconosci-mento formale di garanzie al cittadino,ma di at-tribuzione allo stesso di un potere di controllo di-retto sulla qualità dei servizi”.Nell’ultimo Piano sanitario nazionale (Psn 2006-2008) si sottolinea la necessità di rivedere la strut-turazione dell’offerta a causa dell’evolversi deibisogni di salute, legati all’innalzamento dell’e-tà media della popolazione ed alla necessità dimaggiori risorse. Per garantire questo adegua-mento una delle leve sulle quali si chiede di pun-tare è la “razionalizzazione delle risorse e la lo-ro rifinalizzazione più appropriata, coinvolgen-do i cittadini e le reti di cittadinanza in opera-zioni di governance creativa nelle quali cittadi-no, associazioni di tutela e reti di cittadinanzadivengano sponsor e attori del sistema sanitarionazionale garantendo la partecipazione consa-pevole”. Il Psn 2006-2008 segna, inoltre, il pas-saggio dalle modalità “storiche” di partecipazio-ne del cittadino (umanizzazione delle cure, qua-lità percepita, carta dei servizi, consenso infor-mato) a processi più ampi e complessi di empo-werment, riconosciuti quali strumenti utili perfavorire l’erogazione di cure efficaci ed appropriatesotto il profilo clinico ed etico e, nel contempo, garanti-re il massimo livello possibile di equità nell’uso dellerisorse.
6 European Patients’ Forum (2009), 150 Million reasons to act. EPF’s Patients’ Manifesto for the European Parliament and Commission (http://www.eu-pa-tient.eu/Documents/Events/Manifesto/epf_manifesto.pdf, accessed May 2009).
7 International Alliance of Patients’ Organizations (2006), Declaration on Patient-Centred Healthcare.(http://www.patientsorganizations.org/attach.pl/712/420/IAPO%20Declaration%20on%20Patient-Centred%20Healthcare%20-%20Colour.pdf , accessed May 2009).
8 Libro Bianco. Un impegno comune per la salute. Approccio strategico dell'UE per il periodo 2008-2013, Commissione delle Comunità Europee, Bruxelles, 23.10.2007 [COM(2007)630 definitivo].
9 Ministero della Salute (2008), Libro bianco sui principi fondamentali del Servizio sanitario nazionale.

Alla luce del quadro internazionale e nazionalesopra delineato, l’empowerment si conferma unodegli elementi strategici per la gestione del Ssn:considerando che la maturazione delle capacitàdi partecipazione, della responsabilità e del sensodi appartenenza dei cittadini e degli operatori fa-voriscono la sostenibilità del sistema, si può af-fermare che l’empowerment rappresenta uno stru-mento tecnico fondamentale. In questa ottica edin virtù del mandato attribuitole, l’Agenas nel2007 ha avviato in questo campo un percorso in
stretta collaborazione con il Ministero della salu-te, le Regioni e le Province Autonome di Tren-to e di Bolzano.Il frutto di questo lavoro di ricerca (finanziata dalMinistero della salute, nell’ambito dei program-mi di Ricerca Corrente 2007, ex art. 12 del d.lgs502/92 e successive modificazioni) è raccolto nelpresente Quaderno di Monitor, che auspichiamopossa favorire la diffusione sia di una cultura con-divisa dell’empowerment, sia di esperienze con-crete realizzate dalle diverse Regioni italiane.
IL SISTEMA SANITARIO E L’EMPOWERMENT
6
IQU
AD
ERN
IDI

7
iQua
dern
idi
L’Agenas, nel corso degli ultimi tre anni,si è impegnata a promuovere nelle Re-gioni la pianificazione, gestione e valu-tazione dei processi di empowerment,
un ambito di lavoro individuato come priorita-rio tra i nuovi indirizzi di attività dell’Agenzia(Conferenza Unificata Stato-Regioni del 20 set-tembre 2007). Per realizzare tale funzione è statoutilizzato un approccio fondato su due principa-li elementi strategici:�collaborazione e consenso tra gli attori;�diffusione e trasferimento di esperienze esem-plari.Il primo elemento strategico rispecchia un me-todo di lavoro consolidato inAgenzia, volto a sti-molare il dibattito e le sinergie tra i sistemi sani-tari regionali.Con questo spirito l’Agenas ha in-vitato tutte le Regioni a costituire un Gruppo dilavoro ad hoc, impegnato a promuovere un con-fronto interregionale permanente per lo svilup-po dell’empowerment del cittadino in Italia.Dal primo incontro tra gli esperti regionali, av-venuto sul finire del 2007, si è evidenziata unaspiccata disomogeneità rispetto al significato at-tribuito al termine empowerment, alle iniziativeche vengono ricondotte a tale tematica e al livel-lo di sviluppo di questi processi nei diversi con-testi locali. Si è ritenuto, quindi, opportuno pro-
muovere la creazione di un knowledge network, in-teso come una rete di conoscenze che collegapersone e istituzioni, per offrire “strumenti, luoghi,tempi e incoraggiamento per l’interagire di saperi e lapossibilità di azione”1.Una rete che, quindi, non è da intendere in sen-so organizzativo, bensì come luogo di scambiocontinuo di conoscenze tra professionisti ed isti-tuzioni, fondamentalmente orientato ad amplia-re le possibilità di azione. Il gruppo di lavoro in-terregionale e l’Agenas, in questi anni, hanno ope-rato per tessere le prime “maglie della rete” e perfacilitare l’implementazione e l’ampliamento delknowledge network. Gli obiettivi fondamentali dellavoro sono stati i seguenti:1. individuare modelli di analisi e strumenti di ri-levazione condivisi;
2. rilevare esperienze regionali significative di em-powerment e facilitarne la diffusione a livellonazionale;
3. promuovere una rete volta a favorire la realiz-zazione di iniziative a livello regionale.
Per attuare gli obiettivi sopra elencati, l’Agenas,in collaborazione con il gruppo di lavoro inter-regionale, ha promosso, all’interno del Program-ma di Ricerca Corrente anno 2007, la ricerca“Metodi e strumenti per la partecipazione attivadei cittadini alla valutazione dei servizi ed alle de-
Introduzione
di Fulvio MoiranoDirettore Agenas - Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali
INTRODUZIONE
IL RUOLO DELL’AGENASNELLE STRATEGIE DI SVILUPPODELL’EMPOWERMENT
1 Nonaka I. and Takeuchi H. (1995), The knowledge-creating company: how Japanese companies create the dynamics of innovation, NewYork, Oxford University Press.

cisioni locali in materia di organizzazione dei ser-vizi sanitari” nel corso della quale sono stati rea-lizzati i documenti metodologici, gli strumentioperativi e le azioni che sono raccolte in questapubblicazione. Il metodo di lavoro utilizzato è sta-to improntato alla condivisione di tutte le fasioperative, al supporto reciproco ed al coinvolgi-mento più ampio possibile. Delle 14 Regioni eP.A. che attualmente costituiscono il Gruppo dilavoro sull’empowerment, 10 hanno partecipatoquali Unità Operative alla Ricerca Corrente 2007,finanziata dal Ministero della salute, ex art. 12 delD.lgs. 502/92 e modificazioni.Nel corso della ricerca si è, tuttavia, stabilito diraccogliere suggerimenti e di informare costan-temente tutte le Regioni rispetto alle attività incorso di realizzazione.Il secondo elemento strategico sul quale ha pun-tato l’Agenas è stata l’individuazione e la diffu-sione di iniziative esemplari di empowerment.Ciè sembrato opportuno, infatti, riconoscere e va-lorizzare il patrimonio di esperienze che i pro-fessionisti ed i sistemi sanitari hanno “accumula-to” negli anni, poter condividere questa ricchez-za e costruire su quanto è stato già attuato dalleRegioni. D’altro canto, scambiare le conoscenzee le migliori prassi relative alle problematiche sa-nitarie è una delle azioni raccomandate dallaCommissione e dal Consiglio Europeo nel Se-condo programma d’azione comunitaria in materia disalute (2008-2013)2.Tale raccomandazione è sta-ta pienamente recepita dall’Agenas che l’ha ap-plicata con successo anche nel campo delle buo-ne pratiche per la sicurezza del paziente.A questo riguardo, mi preme sottolineare che ladiffusione delle pratiche esemplari non mira esclu-sivamente allo scambio di conoscenze,ma è vol-ta a stimolarne e facilitarne il trasferimento.Per questi motivi, il lavoro del gruppo interre-gionale si è caratterizzato per la sua duplice va-lenza, di ricerca e di azione: oltre alla raccolta di
71 iniziative segnalate dalla Regioni come signi-ficative, sono stati organizzati una serie di eventidi diffusione locale su quanto realizzato e condi-viso a livello nazionale.Tali eventi (convegni,workshop, seminari, ecc.), ai quali hanno parteci-pato più di 800 professionisti, hanno fornito oc-casioni di incontro, di riflessione e di progetta-zione all’interno e tra le Regioni.Nel campo dell’empowerment, infatti, i due li-velli della ricerca e dell’azione sono da conside-rarsi di pari importanza e non possono essere sle-gati l’uno dall’altro. La ricerca risulta particolar-mente pregnante poiché l’empowerment, essen-do un costrutto sviluppato in diversi campi di stu-dio (dalla pedagogia, alla psicologia di comunità,alla ricerca sui servizi sanitari) ed applicato in di-versi ambiti (politico,medico,manageriale, ecc.),pone un problema di integrazione di saperi.Que-sta sua natura e la caratteristica di essere un pro-cesso che assume forme differenti in relazione al-la cultura, alla società e alla popolazione specifi-ca all’interno della quale si sviluppa, rende contodella diversità delle iniziative realizzate a livellonazionale. Proprio la caratteristica di eterogenei-tà dei percorsi regionali ha comportato un gros-so impegno da parte del gruppo di lavoro per con-dividere modelli di analisi e strumenti di rileva-zione comuni.Per tale motivo, è con soddisfazione che deside-ro presentare questo numero dei Quaderni di Mo-nitor, nel quale sono raccolti i contributi delle Re-gioni che hanno partecipato, seppure con gradidifferenti, al percorso sull’empowerment sopradescritto.Gli articoli pubblicati nel Quaderno presentanopunti di vista differenti sul tema: alcuni rivisitanoil percorso che hanno sviluppato all’interno delprogetto di ricerca (Regioni Campania, FriuliVe-nezia Giulia, Piemonte, Umbria eVeneto), altridescrivono specifiche iniziative di empowerment(Provincia Autonoma di Bolzano e Provincia Au-
IL SISTEMA SANITARIO E L’EMPOWERMENT
8
IQU
AD
ERN
IDI
2 Secondo programma d’azione comunitaria in materia di salute (2008-2013), Decisione n. 1350/2007/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007 (Gazzet-ta ufficiale dell’Unione europea, L 301/ del 20/11/2007.

tonoma diTrento), altri ancora presentano una ri-flessione sulle politiche e le strategie della propriaRegione in questo settore (Regioni Abruzzo,Emilia Romagna, Lombardia eToscana).Dalle di-verse prospettive riportate emerge l’attuale qua-dro nazionale sul costrutto in esame.La parte finale del Quaderno è dedicata ad una te-matica che, nell’arco di questi tre anni di lavoro,il gruppo interregionale ha riconosciuto comeparticolarmente rilevante e critica: empower-ment e valutazione.Sul tema della valutazione, sono stati invitati acontribuire alcuni colleghi di Fondazioni, Uni-versità, Centri di Ricerca con un’accreditata espe-rienza nel campo, per arrivare ad una necessariaintegrazione di saperi su un elemento così pre-gnante come la valutazione.La tematica risulta di particolare rilevo, anche alfine di rendicontare quanto possano impattare iprocessi di empowerment sull’efficacia e l’effi-cienza del sistema. La sostenibilità dei servizi sa-nitari è la sfida che ci troviamo ad affrontare og-gi in un sistema universalistico che si rivolge acittadini con una sempre maggiore aspettativa di
vita, una crescente cronicità, bisogni di salute sem-pre più complessi.In questo articolato panorama, dove il rapportotra medico-paziente sta evolvendo verso una mo-dalità basata sulla pariteticità, si possono già ap-prezzare alcuni sviluppi concreti dell’empower-ment nell’ambito di nuovi modelli assistenzialicome, ad esempio, il Chronic Care Model.L’Agenas continuerà a sostenere iniziative di ri-cerca e intervento fondate su strategie condivise,con un particolare focus sulla valutazione del-l’empowerment, sullo sviluppo di competenzedegli operatori sanitari e delle comunità, che so-no stati indicati dal gruppo di lavoro interregio-nale quali necessari campi di studio.I contenuti del presente Quaderno di Monitor rap-presentano, quindi, i risultati di un percorso diapprofondimento specifico sull’empowerment,sviluppato per la prima volta a livello nazionale,che oltre ad aver promosso la condivisione e dif-fusione di modelli di analisi, strumenti di rileva-zione ed esperienze esemplari, ha delineato unaserie di azioni future da intraprendere nel campodella ricerca e degli interventi.
Introduzione
9
IQU
AD
ERN
IDI

IL SISTEMA SANITARIO E L’EMPOWERMENT
10
iQua
dern
idi
Un progetto di ricerca richiede chevenga, in primo luogo, definito l’og-getto di studio per poi esplicitare gliobiettivi, i metodi, gli strumenti e i
risultati.Nel caso dell’empowerment il primo steprisulta particolarmente rilevante sia per chiarireil significato del termine inglese, sia per la diffi-coltà di rintracciare in letteratura una definizio-ne univoca. Come oramai noto, la parola empo-werment non trova un corrispettivo in italianoche possa rendere la complessità semantica: nonesiste ancora un’alternativa alla traduzione classi-ca “favorire acquisizione di poter, rendere in gra-do di”. Ciò accade perché la parola empower-
ment negli ultimi cinquanta anni è stata utilizza-ta per dare un nome ad elementi e fenomeni dinatura diversa a seconda del campo di applica-zione in cui è stato utilizzato tale concetto.Secondo Piccardo (1995)3 il costrutto dell’em-powerment appare in letteratura alla fine deglianni Sessanta, per essere ampiamente adottato conuna molteplicità di significati nel pieno degli an-ni Ottanta. Gli ambiti in cui tale concetto è sta-to particolarmente sviluppato sono quattro: po-litico, medico-psicoterapeutico, pedagogico e or-ganizzativo. Nell’ambito politico ha rappresenta-to l’obiettivo dei movimenti per i diritti civili del-le minoranze, dei programmi di sviluppo dei “pae-
“Prendendo sul serio l’empowerment,non saremo a lungo capaci di vedere le persone esclusivamente come bambini bisognosio solo come cittadini con dei diritti,ma piuttosto come esseri umani completiche hanno sia diritti che bisogni”l
“La responsabilità verso l’altronon ha tanto la funzione di determinare, quanto quella di rendere possibile”2
I RISULTATI DELLA RICERCAAGENASDefinizione, modello di analisi, strumentidi rilevazione ed esperienze significativedi empowerment in sanità
di Giovanni Caracci, Sara CarzanigaSezione Qualità e Accreditamento - Agenas - Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali
1 Rappaport J. (1981), In Praise of Paradox: A Social Policy of Empowerment Over Prevention, in American Journal of Community Psychology, 9: p.15.2 Jonas H. (1990), Il principio di responsabilità: Un'etica per la civiltà tecnologica, curato da P.P. Portinaro, Einaudi,Torino.3 Piccardo C. (1995), Empowerment. Strategie di sviluppo organizzativo centrate sulla persona, Raffaello Cortina Editore, Milano.

si svantaggiati” e dei movimenti per l’emancipa-zione femminile. Nell’ambito medico e psicote-rapeutico è stato utilizzato per favorire processiriabilitativi brevi, promuovendo capacità di auto-diagnosi e gestione della propria salute, fondatisul presupposto di emancipare il paziente dalla di-pendenza dalla figura medica. In campo pedago-gico l’empowerment ha costituito uno dei valo-ri fondamentali per lo sviluppo della pedagogiadegli adulti, nella quale l’apprendimento è con-cepito come un processo che dura tutta la vita, dicui ogni persona è responsabile e al quale parte-cipa attivamente in un rapporto di reciprocità conil “formatore”. In questo campo, inoltre,molto sideve all’opera rivoluzionaria di Paulo Freire4, pro-motore della “Pedagogia degli oppressi”, il qualeha sviluppato un metodo di alfabetizzazione ba-sato sul dialogo e l’azione, che mira all’emanci-pazione delle fasce più povere della società attra-verso la presa di coscienza e la responsabilità. Ilquarto ambito di sviluppo, quello organizzativo,a seguito della globalizzazione e flessibilità deimercati ha ricevuto un forte impulso verso la ri-cerca di nuovi assetti organizzativi orientati allavalorizzazione delle risorse umane.Attraversol’empowerment è stata promossa una maggiorepartecipazione, autonomia ed impegno da partedei lavoratori, dando vita ad organizzazioni piùorizzontali in cui è stato particolarmente sottoli-neato il valore del lavoro di gruppo e la leaders-hip partecipativa.Nonostante le diverse connotazioni date al co-strutto dell’empowerment, sembrerebbe eviden-ziarsi un “fil rouge” che lega i diversi ambiti e cheè costituito da parole come, ad esempio, emanci-pazione, responsabilità, partecipazione e reciproci-tà. Permane, tuttavia, la difficoltà ad elaborare unadefinizione univoca del concetto che, d’altronde,affonda le sue radici in numerose discipline: dalla
psicologia di comunità, all’educazione e promo-zione della salute, dallo sviluppo rurale e di co-munità, alla ricerca sui servizi sanitari.Vi è, infine,da interrogarsi su quale significato possa assumereun termine così ricco e multidisciplinare nell’am-bito della sanità pubblica e su quale ruolo possa ri-vestire nella governance dei servizi sanitari.Il gruppo di lavoro interregionale sull’em-powerment, promosso dall’Agenas, ha avviato ilprimo confronto nazionale su tali quesiti ri-uscendo, come primo risultato, a concordare unsignificato comune nel campo della sanità pub-blica. Ciò è stato possibile grazie al report sull’e-videnza dell’efficacia dell’empowerment nel mi-gliorare la salute che l’Health Evidence Network(Hen) dell’Ufficio Regionale Europeo dell’Or-ganizzazione Mondiale della Sanità (Who Regio-nal Office for Europe) ha commissionato nel 2006a NinaWallerstein – Professore e Direttore delMaster in Public Health Program dell’Università delNew Mexico (Usa). Nel documento è riportatala seguente definizione di empowerment, assun-ta a definizione condivisa a livello nazionaledal gruppo di lavoro interregionale:
L’empowerment così definito discende dalle ela-borazioni teoriche dei due principali studiosi del-la materia: Julian Rappaport e Marc A. Zim-merman. A Rappaport dobbiamo la prima defi-nizione nell’ambito della psicologia di comuni-tà, secondo la quale l’empowerment è un mecca-nismo che permette a persone, organizzazioni e co-munità di accrescere la capacità di controllare la propriavita6. Questo autore sottolinea sin dal principio
I risultati della Ricerca Agenas
11
IQU
AD
ERN
IDI
4 Freire P. (1971), La pedagogia degli oppressi, Mondadori, Milano.5 Wallerstein N. (2006),What is the evidence on effectiveness of empowerment to improve health?, Copenhagen,Who Regional Office for Europe (Health Evidence Network report;http://www.euro.who.int/Document/E88086.pdf, December 2007).
6 Rappaport J. (1981), In praise of paradox. A social policy of empowerment over prevention, in American Journal of Community Psychology,1, pp. 1-25.Rappaport J., (1984), Studies in empowerment: Introduction to the issue, in Prevention in Human Services; 3: 1-7.
L’empowerment è un processo dell’azione sociale at-traverso il quale le persone, le organizzazioni e le co-munità acquisiscono competenza sulle proprie vite,al fine di cambiare il proprio ambiente sociale e poli-tico per migliorare l’equità e la qualità di vita5.

che l’empowerment è un processo che riguardanon solo i singoli individui, ma anche organiz-zazioni e comunità: l’empowerment viene defi-nito “costrutto multilivello” proprio per la ca-ratteristica di potersi sviluppare a tre diversi li-velli. Ovviamente è impossibile tracciare una net-ta distinzione tra i livelli, poiché essi fanno par-te di un continuum, sono strettamente interdi-pendenti e sono allo stesso tempo causa e con-seguenza l’uno dell’altro.Altro rilievo importan-te, che lo stesso Rappaport ha sostenuto, è chela capacità di controllo è una condizione neces-saria ma non sufficiente per lo sviluppo dell’em-powerment. Le altre capacità che concorrono al-la definizione del costrutto sono state indicate daZimmerman7, a cui si deve la strutturazione delcorpo teorico dell’empowerment.Nei suoi scrit-ti8, in continuità con quanto delineato da Rap-paport, definisce con grande concretezza le trecomponenti fondamentali dell’empowerment,cioè quelle competenze da sviluppare affinché lepersone possano padroneggiare le proprie vite: ilcontrollo, la consapevolezza critica e la parteci-pazione. Il “controllo” si riferisce alla capacità, per-cepita o attuale, di influenzare le decisioni che riguar-dano la propria esistenza. La “consapevolezza criti-ca” consiste nella comprensione del funzionamentodelle strutture di potere e dei processi decisionali, di co-me i fattori in gioco vengono influenzati e le risorse mo-bilitate. La “partecipazione” attiene all’operare in-sieme agli altri per ottenere risultati desiderati e condi-visi. Lo sviluppo del controllo, della consapevo-lezza critica e della partecipazione può essere os-servato a livello individuale, organizzativo e dicomunità, laddove ciascuna componente assumecaratteristiche distintive a seconda del livello.Coni suoi lavori Zimmerman giunge, quindi, a defi-nire un preciso modello di analisi dei processi diempowerment, che permette di chiarire in ma-
niera decisiva che tale processo non si esauriscenella mera capacità di controllo o nella sola par-tecipazione: l’empowerment comprende in ma-niera imprescindibile sia il controllo, sia l’azionecollettiva, che la consapevolezza critica quale ca-pacità di identificare, ottenere e gestire le risor-se (personali e del contesto).Quanto appena de-scritto, costituisce il modello di analisi dei pro-cessi di empowerment condiviso a livello na-zionale dal gruppo di lavoro interregionale.Ci sembra opportuno richiamare alcune caratte-ristiche che Zimmerman9 ha considerato basila-ri nella definizione della teoria dell’empower-ment. In primo luogo, con empowerment si puòindicare sia un processo che un risultato10. I pro-cessi empowering sono quelli nei quali è fonda-mentale il tentativo di acquisire controllo, otte-nere le risorse di cui si ha bisogno e comprende-re criticamente il proprio ambiente sociale. Il pro-cesso è empowering se aiuta le persone a sviluppa-re competenze tali per cui possano diventare in-dipendenti nella risoluzione dei problemi e nel-la presa di decisioni.Alcune attività, opportunitào strutture possono essere intese come empowe-ring e l’esito di tali processi consiste nel fatto chei soggetti siano in qualche misura empowered. L’em-powerment come risultato si può riferire, quin-di, alle conseguenze dei tentativi dei cittadini diavere un maggior controllo nella comunità o aglieffetti degli interventi progettati per promuove-re l’empowerment dei partecipanti. La riflessio-ne sulla differenza tra processi ed esiti ha rappre-sentato uno snodo importante nel percorso delgruppo interregionale che ha deciso di conside-rare l’empowerment come processo ai fini dellacostruzione dello strumento di rilevazione delleesperienze regionali.L’empowerment non va visto come una variabi-le dicotomica (presente o assente),ma come una
IL SISTEMA SANITARIO E L’EMPOWERMENT
12
IQU
AD
ERN
IDI
7 Zimmerman M.A. (2000), Empowerment theory: psychological, organizational and community levels of analysis, in Rappaport J., Seidman E., eds,Handbook of community psychology,NewYork, Kluwer Academic/Plenum Publishers: 43-63.
8 Zimmerman M. (1999), Empowerment e partecipazione della comunità, in Animazione Sociale, n°2, anno XXIX, Febbraio: 10-24.9 Zimmerman M.A. (2000), op. cit.10 Swift C., Levine G. (1987), Empowerment an emerging mental health technology, in Journal of Primary Prevention, 8: 71-94.

I risultati della Ricerca Agenas
13
IQU
AD
ERN
IDI
variabile continua, ovvero presente in diversi gra-di e livelli nelle persone, organizzazioni e comu-nità. Tutte le persone hanno competenze relati-ve al controllo, alla partecipazione e alla consa-pevolezza critica che possono presentarsi con di-versi gradi di sviluppo. Promuovere empower-ment non significa, dunque, dare “potere” a chinon ne ha, ma favorire il pieno sviluppo dellecompetenze e delle risorse che sono presenti nel-le persone e nei contesti. L’empowerment, inol-tre, è una variabile che può cambiare al variaredel tempo e delle situazioni, poiché si realizza at-traverso una interazione dinamica tra l’acquisi-zione di maggiori competenze interne e il su-peramento degli ostacoli esterni per accedere al-le risorse11; in questo senso costituisce una buo-na mediazione tra dimensioni individuali e so-cio-politiche.L’empowerment, infine, si specifica in relazioneal contesto ed alla popolazione, assumendo for-me differenti per persone diverse (età, fascia so-ciale, bisogni ecc.), in contesti diversi (differenze
culturali, confini nazionali ecc.)12. Per tale moti-vo, le azioni di promozione dell’empowermentnon possono essere “calate dall’alto” o essere re-plicate con modalità standardizzate, ma devonopartire da una attenta analisi del contesto, dei vin-coli e delle risorse disponibili ed essere costruiteinsieme alla persona/organizzazione/comunità acui sono rivolte.Tale specificità rende conto del-la diversità delle esperienze rilevate nei diversicontesti regionali.Sulla base della definizione e del modello di ana-lisi condiviso, il gruppo di lavoro interregionale– nell’ambito del percorso operativo previsto dalprogetto di Ricerca Corrente “Metodi e stru-menti per la partecipazione attiva dei cittadini al-la valutazione dei servizi ed alle decisioni localiin materia di organizzazione dei servizi sanitari”(Riquadro 1) – ha messo a punto una scheda dirilevazione delle iniziative di empowerment, chesin dal principio è stata indirizzata alla raccoltadelle esperienze ritenute significative.La scheda di rilevazione non è stata concepita ai fi-
11 Speer P.W., Hughey J. (1995), Community organizing: an ecological route to empowerment and power, in American Journal of Community Psychology, 23(5): 729-748.12 Francescato D.,Tomai M. (2005), Psicologia di comunità e mondi del lavoro. Sanità, pubblica amministrazione, azienda e privato sociale, Carocci Editore, Roma.
RIQUADRO 1 - Percorso operativo della Ricerca Corrente
1. INDIVIDUAZIONE OBIETTIVI E MODALITÀ OPERATIVE
2.CONDIVISIONE DELLA DEFINIZIONE E DEL MODELLO DIANALISI DEL PROCESSO DI EMPOWERMENTINDIVIDUATI IN BASEAI RISULTATI DELL’ANALISI DELLA LETTERATURA
3.COSTRUZIONE DELLA SCHEDA ED ELABORAZIONE DELLA PROCEDURA DI RILEVAZIONEDELLE INIZIATIVE DI EMPOWERMENT
4. SPERIMENTAZIONE DELLA SCHEDA DI RILEVAZIONE
5.RICERCA E SELEZIONE DELLE ESPERIENZE DI EMPOWERMENT INAMBITO LOCALE
6.DIFFUSIONE DEL MODELLO E DELLE ESPERIENZE REGIONALIATTRAVERSO MODALITÀ DIFFERENZIATE(CARTACEA, INFORMATICA, UTILIZZO DI MATERIALE AUDIOVISIVO, PERCORSI FORMATIVI
DESTINATI A CITTADINI EDAMMINISTRATORI LOCALI)
7. PRESENTAZIONE DEI RISULTATI E DIFFUSIONE

ni di un puntuale censimento ma come strumentoutile ad avviare una riflessione nei contesti regiona-li. La scheda, scaricabile dal sito dell’Agenas(http://www.agenas.it/database_empowerment.htm),è composta da una guida alla compilazione,dalla se-zione “A” – in cui sono rappresentate le informa-zioni identificative dell’iniziativa – e dalla sezione“B”– in cui sono richiesti gli elementi informativitipici per la rappresentazione di un’esperienza pro-gettuale (contesto; problematica; obiettivi; destina-tari; percorso operativo; risultati;diffusione ed espe-rienze di trasferimento; costi e benefici; riflessionisull’iniziativa:punti di forza e punti di debolezza;al-legati). Per ciascun campo della sezione “B” sonoriportate alcune domande guida alla compilazioneed è prevista la possibilità di allegare documenti. Sirimanda al numero 24 di Monitor (http://www.agenas.it/agenas_pdf/monitor_24.pdf) per unadescrizione più puntuale delle modalità di speri-mentazione della struttura della scheda e delle pro-cedure di rilevazione (Figura 1).La rilevazione delle iniziative di empowerment, adoggi,ha portato alla raccolta di 71 esperienze esem-
plari, segnalate da 14Regioni e ProvinceAutonomeattraverso la scheda di rilevazione (Tabella 1).Tutte leschede sono state classificate secondo il modello dianalisi condiviso e pubblicate sul sito dell’Agenas(http://www.agenas.it/database_empowerment.htm),dove saranno inserite le ulteriori esperienze che leRegioni segnaleranno.La maggior parte delle iniziative attiene al livelloindividuale (40 schede), poi organizzativo (21) edinfine di comunità (10). Le esperienze esemplarisegnalate dalle Regioni rappresentano iniziativerivolte agli “attori”del sistema (dai cittadini ai pro-fessionisti, dall’organizzazione alla comunità) e so-no state ricondotte per ciascun livello (individua-le, organizzativo e di comunità) ad una serie diambiti specifici, grazie al fondamentale contribu-to metodologico offerto dalla Regione Emilia Ro-magna a tutto il gruppo di lavoro.Gli ambiti entro i quali si possono ritrovare espe-rienze di empowerment individuale sono:1. acquisire stili di vita e comportamenti più cor-retti: ad esempio,movimenti/campagne infor-
IL SISTEMA SANITARIO E L’EMPOWERMENT
14
IQU
AD
ERN
IDI
FIGURA 1 - Procedura di rilevazione e criteri di selezione delle esperienze di empowerment
segue a pag. 16
�
LA PROCEDURA DI RILEVAZIONE
REFERENTI REGIONALIDELGRUPPODI LAVOROINTERREGIONALE
ICRITERIDI SELEZIONEDELLE INIZIATIVE
• Innovatività: novità rispetto ametodi e strumenti utilizzati• Rilevanza:importanza dell’esperienza in termini epidemiologici e/o sociali• Caratteristichedel target:esperienze finalizzate all’empowerment deisoggetti fragili e/o svantaggiati per la riduzione delle disuguaglianze• Impatto:i risultati conseguiti• Trasferibilità:possibilità di implementare l’esperienza in altri contesti• Esemplarità:esperienze contenenti elementi conoscitivi utili perpromuovere apprendimento,anche nell’ottica di“impariamodagli errori
GRUPPODI LAVOROLOCALE
1
23

I risultati della Ricerca Agenas
15
IQU
AD
ERN
IDI
TABELLA 1 - Le iniziative di empowerment rilevate
SCHEDE DI RILEVAZIONE DELLE INIZIATIVE DI EMPOWERMENT INDIVIDUALESviluppare la "cultura" della prevenzione AbruzzoPercorso Salute AbruzzoFigli dell'immigrazione: la sfida dell'integrazione Emilia-RomagnaMeeting Giovani - Le mie domande non solo mie Emilia-RomagnaTeatro-Forum sulla prevenzione dell’alcol Emilia-RomagnaDei delitti delle pene Emilia-RomagnaGruppoAuto MutuoAiuto “Al di là delle voci”(di uditori di voci) Emilia-RomagnaInformazione E Consenso Emilia-RomagnaIl cuore oltre l’ostacolo- Incontro di saperi tra donne operate al seno e percorsi di cura: dall’auto mutuo aiuto al “fare insieme” Emilia-RomagnaGenitoripiù FriuliVenezia GiuliaProgetto “Diamo peso al benessere” FriuliVenezia GiuliaL’adulto diabetico insulinotrattato:Corso di educazione terapeutica strutturata nel paziente diabetico tipo 2 insulinotrattato FriuliVenezia GiuliaCentro Clinico Nemo LombardiaProgetto Moli-Sani MoliseFormazione Piani Dimissione PiemontePaziente Esperto ToscanaNon Sei Solo ToscanaAssistenza domiciliare del paziente “fragile” con scompenso cardiaco cronico ToscanaFormazione alla gestione domiciliare del paziente affetto da malattia metabolica ereditaria ToscanaApplicazione degli indirizzi indicati dalla Dgrt 402/04 e successive integrazioni, per la valutazione multidimensionale,redazione dei piani personalizzati di assistenza ed attivazione dei servizi per l'assistenza territoriale alla persona non autosufficiente ToscanaEducazione dei pazienti cronici complessi ToscanaRiguardiamoci il cuore ToscanaAmpliamento dell’attività di counseling nutrizionale per pazienti cardiologici e con patologia reumatica ToscanaAuto-Aiuto e diabete ToscanaProgetto per le persone migranti che hanno sviluppato dipendenza da alcol e sostanze stupefacenti P.A. diTrentoPersone Immigrate Extracomunitarie – La salute degli immigrati e delle persone in situazione di emarginazione P.A. diTrentoCartella clinica del cittadino -Trec P.A. diTrentoPromozione e sviluppo della partecipazione UmbriaNumero Unico Per La Salute UmbriaContact Center per tessera sanitaria on-line UmbriaCome orientarsi nel mondo degli ausili UmbriaMediazione culturale nei servizi sanitari UmbriaIntegrazione del servizio accoglienza e mediazione interculturale presso l'ospedale di Spoleto UmbriaContinuità assistenziale tra ospedale e territorio UmbriaStar meglio in ospedale Umbria"Verso Un Ospedale Senza Dolore" UmbriaProgettoAccoglienza UmbriaProgettoAccoglienza Utenti Migranti (Paum) VenetoNutrilandia (alimentazione e stili di vita) VenetoI processi di empowerment in azienda ospedaliera:un processo decisionale inclusivo per l’implementazione della carta dei servizi Veneto
SCHEDE DI RILEVAZIONE DELLE INIZIATIVE DI EMPOWERMENT ORGANIZZATIVOAudit Civico AbruzzoCollaboratori sani in imprese sane P.A. di BolzanoGruppo DiTraverso – Progetto d’intervento psicologico CalabriaIl Mio Ospedale CampaniaMediazione dei conflitti nelle aziende sanitarie Emilia-RomagnaServizio di mediazione linguistico culturale Emilia-RomagnaRealizzazione di un’esperienza diAudit Civico nelle strutture ospedaliere e territoriali del distretto di Scandiano Emilia-RomagnaLaboratorio dei cittadini per la salute Emilia-RomagnaLaboratorio Cittadino Competente Emilia-RomagnaProgetto "L'accoglienza nell'emergenza" Gaps Emilia-RomagnaL’esperienza diAudit Civico all’arcispedale S.Maria Nuova di Reggio Emilia Emilia-RomagnaInsieme per la salute mentale: Infermieri a confronto FriuliVenezia Giulia“Con gli occhi del cittadino” Programma regionale diAudit Civico FriuliVenezia GiuliaDifendiamo la salute - Progetto intersettoriale per la difesa del diritto alla salute, individuale e di comunità LazioEmpowerment dell’anziano ToscanaU.F.E (Utenti Familiari Esperti) P.A. diTrentoIl controllo condiviso dei processi assistenziali e tecnico amministrativi – Uvm eAdi P.A. diTrentoFormazione amministratori locali per la costruzione dei piani locali della salute P.A. diTrentoDefinizione linee guida regionali per bilancio sociale e applicazione sperimentale UmbriaMediazione linguistica e culturale nellaAsl 4 diTerni UmbriaL’accoglienza in Ospedale Veneto
SEGUE

mative per la prevenzione/educazione a stili divita sani.
2.Gestire e prendere in carico la propria malat-tia-cronicità: ad esempio, gruppi di auto-aiutoin ambito sanitario e socio-sanitario.
3.Accedere all’organizzazione dei servizi: ad esem-pio, servizi come l’URP, gestione reclami e nu-mero verde,“Carta dei Servizi”.
4. Accedere al processo decisionale di cura: adesempio, il consenso informato, la cartella cli-nica integrata.
Gli ambiti entro i quali si possono ritrovare espe-rienze di empowerment organizzativo sono:1. condividere il processo decisionale di cura: adesempio mediazione dei conflitti, mediazioneculturale nel rapporto medico-paziente;
2. condividere la pianificazione dei servizi: pro-getti e/o contesti che coinvolgono i cittadininell’analisi, progettazione, valutazione dei biso-gni come, ad esempio, l’Audit civico, i Labora-tori del cittadino;
3. condividere la gestione dei servizi: per esem-pio l’inserimento dei caregivers e dei volonta-ri nella gestione di alcuni aspetti dell’organiz-zazione nell’accoglienza e guida.
Gli ambiti entro i quali si possono ritrovare espe-rienze di empowerment di comunità sono:1. fare ascoltare la propria voce: ad esempio i mo-vimenti di difesa, pressione e stimolo dei dirit-ti del malato verso le istituzioni sanitarie, le re-ti di ospedali che cooperano per realizzare e
implementare pratiche di umanizzazione del-l’assistenza;
2. contribuire al governo locale della comunità:processi/strumenti di governo locale capaci dicoinvolgere i cittadini e le organizzazioni nel-le scelte in merito a problemi, bisogni, doman-de come, ad esempio, i Patti di solidarietà o iForum dei cittadini, gli strumenti di program-mazione strategica.
La definizione degli ambiti sopra elencati non so-lo ha permesso di organizzare l’eterogeneità del-le esperienze pervenute,ma ha fornito anche unaconcreta esemplificazione di come un costruttocomplesso come l’empowerment possa essere tra-dotto in azioni specifiche all’interno dei servizisanitari. Il lavoro svolto dal gruppo interregiona-le, caratterizzato da una costante attenzione a tra-durre la teoria nella pratica, ha fornito una primarisposta agli interrogativi rispetto a cosa signifi-chi promuovere empowerment nell’ambito del-la sanità pubblica. Il percorso del gruppo interre-gionale non si è limitato ad un mero esercizio diconoscenza ma si è sviluppato anche come occa-sione di scambio e diffusione a livello nazionale,internazionale e regionale.A livello nazionale, nel corso della ricerca è sta-to organizzato un seminario di approfondimen-to che ha coinvolto 60 professionisti segnalati da18 Regioni (Roma, 2 aprile 2009): i partecipan-ti sono stati invitati a conoscere e condividere imateriali elaborati dal gruppo e discutere tre spe-cifiche esperienze di empowerment (individua-
IL SISTEMA SANITARIO E L’EMPOWERMENT
SEGUE TABELLA 1 - Le iniziative di empowerment rilevate
SCHEDE DI RILEVAZIONE DELLE INIZIATIVE DI EMPOWERMENT DI COMUNITÀLa promozione della salute e gli standard Hph, accreditamento regionale e obiettivi del piano regionale di prevenzione: proposteper uno sviluppo integrato nelle aziende sanitarie dell’Emilia-Romagna Emilia-Romagna“Studenti & Cittadini”: tre percorsi di partecipazione rivolti dall’ assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna al mondodella scuola e dell’ università Emilia-RomagnaSalute e benessere nella provincia di Ferrara – Profilo di comunità Emilia-RomagnaSalute Partecipata Emilia-RomagnaGruppi diAuto MutuoAiuto Emilia-RomagnaOspedale Interculturale ToscanaPartecipazione attiva al percorso di cura in collaborazione con alcune associazioni di tutela dei malati ToscanaForum dei Cittadini ToscanaIl coraggio di Milga ToscanaHealth Promoting Hospitals and Health Services (Hph): implementazione del programma degli ospedali e dei servizi sanitariper la promozione della salute P.A. diTrento
segue da pag. 14�
16
IQU
AD
ERN
IDI

le, organizzativo e di comunità). I risultati finalidella ricerca sono stati successivamente diffusi inoccasione del Convegno nazionale Empowermentdel cittadino in sanità (Roma 28 e 29 settembre2009) e a livello internazionale presso la XXVIConferenza della Società Internazionale per laQualità dell’Assistenza (ISQua, Dublino, 14 ot-tobre 2009).A livello regionale, sono state organizzate 15 ini-ziative di informazione/formazione, finalizzatealla diffusione del modello e delle esperienze ri-levate, che hanno coinvolto più di 800 professio-nisti (Riquadro 2). Le iniziative locali (convegni,workshop, seminari, laboratori, corsi di forma-zione per professionisti sanitari, cittadini, associa-zioni di pazienti, amministratori locali) hannopromosso il confronto all’interno delle Regionie hanno fornito l’occasione per ampliare il kno-wledge network che era stato promosso localmen-te nella fase di rilevazione delle iniziative.
Attraverso gli eventi locali ed il convegno na-zionale si sono attivati una serie di scambi conIstituzioni, Fondazioni,Università, Centri di Ri-cerca e Associazioni, impegnati nel campo dellapromozione della salute e della formazione.Nel-la convinzione che l’integrazione tra i saperi ela multidisciplinarietà non siano solo un’oppor-tunità ma anche una necessità, il gruppo di la-voro interregionale e l’Agenas hanno ritenutoutile favorire una sinergia tra esperti, per af-frontare un tema particolarmente complesso epregnante: la valutazione.Tale tematica è dive-nuta sempre più rilevante nel corso di questi an-ni e pone numerosi interrogativi riguardo ai prin-cipi ispiratori, agli scopi, ai modelli ed ai possi-bili strumenti.In questo Quaderno di Monitor sono, quindi, rac-colti i contributi di alcuni esperti a cui abbiamorichiesto indicazioni rispetto a tali interrogativi.I contributi spaziano dalle raccomandazioni emer-
I risultati della Ricerca Agenas
17
IQU
AD
ERN
IDI
RIQUADRO 2 - Le iniziative di diffusione locale realizzate dalle Regioni e Province Autonome
� febbraio-aprile 2009: Ciclo di incontri con i referenti della Comunicazione Istituzionale delle Asl della regioneAbruzzo.
� marzo-aprile 2009: Ciclo di incontri Promuovere la co-responsabilità nella comunicazione,Trento.
� marzo-settembre 2009: Ciclo di incontri Promuovere la co-responsabilità nella valutazione delle forme associative inmedicina generale nella Provincia Autonoma diTrento.
� 21 maggio 2009: Seminario Promuovere contesti relazionali empowering nelle organizzazioni sanitarie,Zanhotel Europa, Bologna.
� 26 maggio 2009:Workshop Teatro dell’Oppresso, Zanhotel Europa, Bologna.
� 29 maggio 2009: Seminario Gli strumenti che aiutano a difendere la salute, Palazzo Cgil,Viterbo.� 15 giugno 2009:Workshop Open SpaceTechnology, Zanhotel Europa, Bologna.
� 16 giugno 2009: Convegno L’empowerment del cittadino,Villa la Quiete, Firenze.
� 23 giugno 2009: Laboratorio Progettazione partecipata per la valutazione e il miglioramento dei servizi,Zanhotel Europa, Bologna (rivolto a chi ha partecipato al progetto Audit Civico regionale).
� 23 giugno 2009: Seminario Le domande che aiutano a guarire, Centro Anziani, Latina.
� 29 giugno 2009: Giornata dell’Empowerment, Il CITTADINO competente e attivo nel sistema SALUTE,Chiesa di San Bevignate, Perugia.
� 19 settembre 2009: Convegno Empowerment del cittadino per la tutela della salute. Una nuova cultura per facilitare lescelte di tutela della salute,Termoli.
� 23 settembre 2009: 1° Seminario regionale Cittadini attivi nel governo della salute: volontariato, enti locali e aziendesocio-sanitarie a confronto,Villa Contarini, Piazzola Sul Brenta (Padova).
� 23 settembre 2009: Empowerment del cittadino,Auditorium Palazzo della Regione, Udine.
� settembre-novembre 2009: Laboratorio Analisi dei casi di empowerment individuale, organizzativo e di comunità,Bologna (rivolto a quanti hanno messo in campo azioni di empowerment nei servizi sanitari e socio-sanitariregionali).

se nell’ultima Conferenza Internazionale sulla Pro-mozione della Salute (Nairobi, 2009), ai cinqueprincipi guida ritenuti dalWHO di riferimentoper la valutazione degli interventi di promozio-ne della salute (partecipazione, multidisciplina-rietà, empowerment, equità, appropriatezza, so-stenibilità); dallo scopo della valutazione del-l’empowerment – accountability e miglioramentocontinuo della qualità – all’esemplificazione di unpossibile percorso metodologico volto alla valu-tazione dei processi di empowerment; dagli ap-procci dell’Empowerment Evaluation di Fettermane dei domini operativi di Laverack, ad una detta-gliata rassegna degli strumenti di misurazione del-l’empowerment, riconducibili a tre diversi ambi-ti: medico, organizzativo e di comunità. Credia-mo che la pubblicazione di questi contributi pos-sa costituire la premessa per un dibattito che infuturo potrà portare ad individuare alcuni ele-menti condivisi a livello nazionale.Nel Quaderno vengono, inoltre, descritte due in-teressanti esperienze che hanno come protagoni-sti i cittadini. L’una riguarda un progetto forma-tivo rivolto ai cittadini e finalizzato all’acquisi-zione di competenze che permettano di parteci-
pare alla pari, con conoscenza e consapevolezzacritica, al dibattito con le istituzioni e la comuni-tà scientifica sulle scelte di politica sanitaria e diricerca. L’altra riguarda una importante esperien-za di valutazione civica, della quale viene descrittadettagliatamente la storia e la struttura, in cui icittadini sempre più competenti, in collaborazio-ne con gli operatori sanitari, promuovono il mi-glioramento continuo dei servizi sanitari.Il lavoro del gruppo interregionale sin qui de-scritto ha rappresentato il primo percorso di ri-flessione e condivisione sui temi dell’empower-ment a livello nazionale.Attraverso il dibattito diquesti anni, sono stati identificati elementi co-muni (definizione, modello di analisi, strumentidi rilevazione), individuate e diffuse esperienzeesemplari, creati gruppi di lavoro locali ad hoc,allacciate collaborazioni all’interno e tra i sistemiregionali, aperti nuovi campi di studio e appro-fondimento.Desideriamo ringraziare tutti coloro che con illoro contributo hanno permesso la realizzazionedi questo lavoro ed i referenti regionali che han-no reso il percorso di ricerca un processo “gene-ratore”13.
IL SISTEMA SANITARIO E L’EMPOWERMENT
18
IQU
AD
ERN
IDI
13 Nicoli M.A., La metodologia della ricerca, Convegno nazionale Empowerment del cittadino in sanità, 28 settembre 2009, Sala Auditorium Ministero della salute, Roma.

LE VOCI DELLE REGIONIE PROVINCE AUTONOMEI percorsi sviluppati nell’ambito della ricerca
La ricerca “Metodi e strumenti per la partecipazione attiva dei cittadini alla valu-tazione dei servizi ed alle decisioni locali in materia di organizzazione dei servizi sa-nitari” è stata realizzata con il finanziamento del Ministero della salute - Diparti-mento dell’innovazione - Direzione Generale della Ricerca scientifica e tecnologica,nell’ambito dei progetti di ricerca corrente 2007, ex art. 12 del d.lgs 502/92 e suc-cessive modificazioni.

IL SISTEMA SANITARIO E L’EMPOWERMENT
20
iQua
dern
idi L
a partecipazione al progetto “Metodi estrumenti per la partecipazione attiva deicittadini alla valutazione dei servizi edalle decisioni locali in materia di orga-
nizzazione dei servizi sanitari” è stata, per la Re-gione Campania, un momento positivo per l’ap-profondimento cognitivo sul tema dell’empo-werment. Il confronto/discussione con il grup-po interregionale è stato fondamentale nella de-finizione dei criteri di riferimento da adottare peraddivenire all’individuazione degli ambiti e del-le esperienze di empowerment. La necessità diuno strumento di lavoro unico e condiviso nelsuo contenuto e nella terminologia ha portato al-la formulazione di una scheda di rilevazione del-le esperienze di empowerment a livello indivi-duale, organizzativo e di comunità.Tale strumento di lavoro è stato sperimentato nel-la sua attuazione pratica con la partecipazione del-le Aziende Sanitarie e Aziende Ospedaliere dellaRegione. Sono state coinvolte nella rilevazione,con nota circolare dell’AGC Assistenza Sanitariadell’Assessorato, tutte le Asl, le AO e le AziendeUniversitarie.Si è ritenuto necessario organizzare un Gruppodi Lavoro Locale (Gll) costituito dai referenti lo-cali, coordinato dal referente regionale, per me-glio analizzare i contenuti della scheda di rileva-zione del processo di empowerment e sperimen-tare l’applicazione a livello locale. Nel corso del2008 sono state organizzate varie riunioni del Gll
per la condivisione degli strumenti di rilevazio-ne e l’analisi delle criticità. Ogni referente, nel-l’ambito della propria realtà, ha svolto un attentolavoro di ricerca e selezione delle esperienze diempowerment. Sono state, infatti, selezionate espe-rienze di empowerment nell’ambito delle Asl(CE/1,NA/1,CE/2,NA/5,Azienda Ospedalie-ra San Sebastiano di CE,AV/2, BN).Nella maggior parte dei casi sono state riferiteesperienze generiche di partecipazione del citta-dino in materia sanitaria quali ad esempio: Uffi-cio URP; attivazione del numero verde per i re-clami, comunicazione ed informazione ai citta-dini; stesura di protocolli d’intesa che regolano ilrapporto tra Associazioni di volontariato eAzien-de. Tutte iniziative meritevoli, che privilegianomomenti di ascolto e di incontro con il cittadi-no, allo scopo di favorirne la partecipazione con-sapevole ed informata alla vita dell’azienda.Tra le iniziative rilevate sul territorio regionale,una è stata ritenuta particolarmente significativaed è stata segnalata all’Agenas attraverso la sche-da di rilevazione condivisa. Le esperienze più si-gnificative selezionate sono state diffuse e messea disposizione di tutti gli operatori del gruppo lo-cale utilizzando sia la posta elettronica che mate-riale cartaceo.È stata, inoltre, vagliata la possibilità di un appro-fondimento tematico attraverso l’organizzazionedi seminari regionali programmati: tali seminarinecessiteranno di una nuova programmazione
L’ESPERIENZADELLA REGIONE CAMPANIA
di Gina FrancoSettore Assistenza Sanitaria - Assessorato alla Sanità, Regione Campania

L’esperienza della Regione Campania
poiché, a seguito dell’accorpamento territorialedelle Asl, si è determinato il cambio dei referen-ti inizialmente individuati per il Gll.Le attività realizzate, anche nella loro esiguità, han-no consentito di fornire alle strutture locali, at-traverso i referenti, un valido strumento di anali-si e lavoro che consentirà in seguito un maggio-re approfondimento del processo di empower-ment grazie all’informazione e formazione rea-lizzata attraverso diversi incontri, a cui hanno par-tecipato i referenti locali.Come accennato sopra, un’esperienza è stata ri-tenuta di particolare interesse ed è stata segnala-ta all’Agenas attraverso la scheda di rilevazione.Si tratta dell’iniziativa Il Mio Ospedale, realizzatadall’Unità Operativa Relazioni con il Pubblico,Distr. San. 13 (ex Distr. San. 26/27) e del Presi-dio Ospedaliero Maddaloni – Azienda SanitariaLocale Caserta 1.Il progetto Il Mio Ospedale nasce dalla considera-zione che andare in ospedale significa, per adultie bambini, sperimentare sia sofferenza fisica chevacatio forzata della vita quotidiana e dei legamicon ciò che è fuori. L’analisi dei reclami segnala-ti all’Urp del Presidio Ospedaliero, inoltre, rivelasfiducia dei cittadini verso le prestazioni sanita-rie. L’ospedale viene percepito come ‘altro’ ri-spetto alla vita e al territorio, il comfort alber-ghiero non è sempre soddisfacente e gli operato-ri, a volte, non vengono vissuti come persone dis-ponibili. Emerge quindi la necessità di interveni-re, individuando all’interno strategie di monito-raggio e tutela dei percorsi erogati e all’esternoazioni di informazione e promozione mirate alcoinvolgimento degli stakeholder, della rete de-gli enti, delle OdV, onlus e agenzie informativeterritoriali.In base a tali considerazioni, l’Unità OperativaRelazioni con il Pubblico (Uorp) del PO Mad-daloni ha progettato un intervento finalizzato aridurre il gap tra le prestazioni adeguate, perce-pite come eccellenze, e i pregiudizi generalizzatisulla “malasanità”, a migliorare il servizio offerto,ad elaborare buone pratiche condivise con gli sta-
keholder, favorendo la partecipazione dei citta-dini ai processi di erogazione dei servizi e pro-muovendo la presa in carico dell’ospedale perce-pito come risorsa e bene pubblico.Il progetto Il Mio Ospedale è rivolto ad una plu-ralità di soggetti:� fasce di popolazione residente in età evolutiva(tutti gli alunni di una scuola elementare dellacittà di Maddaloni);
�genitori degli scolari;� insegnanti;� tutti i cittadini-utenti;�gli operatori sanitari.L’intervento si caratterizza per un approccio in-tersettoriale che prevede il coinvolgimento dipartner diversi. Partecipano, infatti, all’attuazionedel progetto gli Enti Locali (Comune di Madda-loni), le Istituzioni scolastiche (Scuola Elementa-re “Luigi Settembrini”Maddaloni) le Organizza-zioni diVolontariato (Casa dei Diritti Sociali “Per-ché no” Caserta – Gruppo AMA Auto MutuoAiuto Maddaloni), le Associazioni Culturali (Po-lis Maddaloni – Libertà è partecipazione), le As-sociazioni professionali (Associazione CampanaEducatori Professionali) e i mass media (TempoReale Channel – Steaming tv).Tutti gli stakeholder hanno condiviso sull’obiet-tivo di promuovere l’integrazione socio-sanitariae la cultura della cittadinanza attiva favorendol’empowerment nella condivisione della “res pu-blica”. È stato individuato come obiettivo paral-lelo quello di intervenire sulle rappresentazionisociali collettive, attivando processi di cambia-mento. Per il raggiungimento degli obiettivi con-divisi è stato articolato un piano operativo cheprevede le seguenti azioni:� riunioni operative tra soggetto promotore e part-ners;
� incontri di sensibilizzazione erogati ai destina-tari da formatori e facilitatori dell’ente promo-tore e delle agenzie partner presso la scuola;
� focus-group;�visite guidate con i tre gruppi di destinatari pres-so la struttura ospedaliera:
21
IQU
AD
ERN
IDI

-“Voliamo nel nido”(i bambini visitano il nidodell’ospedale);-“Giocare? Si può!” (i bambini giocano nellaludoteca dell’ospedale);-“Condividiamo i percorsi” (i genitori, già in-formati sui percorsi di facilitazione all’utenzaattivati dall’Azienda, visitano la struttura ospe-daliera per contribuire con i loro suggeri-menti).
�“Insegniamo imparando” (i docenti vengono in-formati sul Regolamento Aziendale di Pubbli-caTutela ed arricchiscono il loro contributo for-mativo-informativo agli alunni);
�azioni e buone pratiche (adozione delle aree ver-di dell’ospedale: i bambini, con il Comune, con-tribuiscono al miglioramento degli spazi verdi);
�attivazione di indagini di gradimento con som-ministrazione schede agli utenti;
�elaborazione delle informazioni e distribuzionedel materiale prodotto dal Sarpm CE/1-UorpPO – Distr.San.26/27;
�convegno conclusivo organizzato da stakehol-ders, ASL e agenzie partner;
�produzione e diffusione sul sito aziendale e strea-ming-tv delle azioni e delle buone pratiche pro-dotte.Tutte le azioni previste rientrano nell’ottica del-la tutela dei diritti del cittadino-utente (Regola-mentoAsl CE1 di Partecipazione e PubblicaTu-tela), nelle finalità operative del Servizio azien-dale RP/Marketing e delle Unità Operative Re-lazioni con il Pubblico dell’Asl CE/1,nonché nel-le linee guida Oms e di integrazione socio-sani-taria nazionali e regionali.Tutti gli Enti pubblici e le Organizzazioni part-ner, nelle proprie mission, promuovono il mi-glioramento della qualità di vita delle persone, lapartecipazione attiva dei cittadini ed interventiformativi di crescita civile.L’utilizzazione di interventi formativo-informa-tivi, partendo dalle fasce di soggetti in età evolu-tiva, si estende alla rete degli insegnanti e dei ge-nitori per arrivare, come proposizione ed appli-cazione di buone pratiche, a tutti i cittadini e agli
stessi operatori della sanità.Tale utilizzo dei pro-cessi formativi evidenzia il carattere innovativodel progetto che, attraverso la collaborazione del-le Organizzazioni diVolontariato, dell’Ente Co-mune, della scuola e di altre Agenzie, amplifica ladiffusione dell’esperienza e ne favorisce la ripro-ducibilità.La partecipazione degli stakeholders caratteriz-za tutte le fasi dell’intervento dalla definizionedell’idea progettuale, alla sua realizzazione e al-la divulgazione dei risultati. Per quanto riguar-da, infine, la valutazione dei risultati, i sogget-ti coinvolti saranno la Commissione Mista Par-tecipativa Asl CE1, il Direttivo Nazionale del-la OdV CDS Focus e il Provveditorato agli Stu-di di Caserta. Ad un anno dalla realizzazionedel progetto, inoltre, i cittadini saranno coin-volti direttamente nella valutazione attraversoun’indagine di soddisfazione sui percorsi di fa-cilitazione condivisi e realizzati con gli stake-holders.La ricaduta del progetto è attesa su due livelli:� il primo relativo all’informazione (sia come pub-blicizzazione della qualità dei servizi sanitari of-ferti, che come divulgazione della praticabilitàdi interventi di cittadinanza attiva);
� il secondo relativo alla formazione di una cul-tura partecipativa nelle fasce più giovani dellapopolazione che, intervenendo positivamentesul vissuto della malattia, influisca sulla perce-zione dell’istituzione ospedaliera come risorsaper la salute.L’iniziativa del Presidio Ospedaliero di Maddalo-ni è stata selezionata dalla Regione Campania peressere segnalata all’Agenas poiché rappresenta unesempio di promozione di empowerment orga-nizzativo, attraverso il quale gli utenti del presi-dio ospedaliero condividono la pianificazione deiservizi.Le azioni programmate sono state realizzate pergli step previsti, allo stato è in itinere l’ultima fa-se divulgativa e la consegna per la messa a dimo-ra delle piantine nell’area verde del Presidio Ospe-daliero da parte dell’Ente Comune.
IL SISTEMA SANITARIO E L’EMPOWERMENT
22
IQU
AD
ERN
IDI

Le buone prassi realizzate sono attualmente og-getto di studio per il Direttivo Nazionale di Ca-sa dei Diritti Sociali Focus-Roma e della Dire-zione Sanitaria del PO di Maddaloni, con l’o-biettivo di riproporle ad altre realtà della rete diorganizzazioni di volontariato e ospedali.La collaborazione tra i diversi partner, inoltre, hafavorito l’ampliamento del numero di attori co-
involti nel progetto (associazioni medici di fami-glia; di promozione; per la tutela dei diversamenteabili e migranti; di cittadinanza attiva, ecc.). La re-te si è consolidata attraverso molteplici azioni tracui la presentazione di nuovi progetti di empo-werment (aree comunicazione, promozione, for-mazione) presentati al Centro Servizi Volontaria-to di Caserta e Napoli per Bandi d’idee 2008/09.
L’esperienza della Regione Campania
23
IQU
AD
ERN
IDI

IL SISTEMA SANITARIO E L’EMPOWERMENT
24
iQua
dern
idi L
a Regione FriuliVenezia Giulia (Fvg) haavuto un ruolo attivo, negli anni 2008-2009, al tavolo interregionale sull’Empo-werment del cittadino, sviluppando tale te-
matica nell’ambito del progetto di Ricerca Cor-rente 2007 Metodi e strumenti per la partecipazioneattiva dei cittadini alla valutazione dei servizi ed alledecisioni locali in materia di organizzazione dei servi-zi sanitari.Il Gruppo di lavoro interregionale, che si è ri-unito periodicamente presso la sede dell’Agenasa Roma, ha intrapreso un percorso metodologi-co rigoroso che, partendo dall’analisi della lette-ratura, potesse individuare una definizione uni-voca di empowerment e criteri di classificazionecomune, sulla base dei quali costruire uno stru-mento di rilevazione (scheda di rilevazione) ca-pace di identificare le esperienze significative diempowerment, al fine di favorirne la diffusione epromuoverne il trasferimento.A tal fine, nel secondo semestre 2008, il gruppodi lavoro locale del Fvg, attivato presso l’AgenziaRegionale della Sanità di Udine – soppressa dal-la Legge regionale n. 12/2009 con attribuzionedelle competenze alla Direzione Centrale dellasalute, integrazione sociosanitaria e protezione so-ciale – ha avviato una fase di rilevazione delle ini-ziative di empowerment che ha portato alla rac-colta di 4 esperienze significative presentate alConvegno sul tema dell’Empowerment del cittadi-no, tenutosi a Udine il 23 settembre 2009 e al
Convegno nazionale sull’Empowerment del cittadi-no in sanità, tenutosi a Roma dal 28 al 29 settem-bre 2009.Per giungere alla selezione delle esperienze loca-li più significative, è stato necessario un percorsocaratterizzato dalle seguenti fasi:� recupero dei progetti regionali e aziendali di em-powerment;
�contatto coi referenti dei progetti ritenuti mag-giormente rilevanti a livello regionale;
� ricognizione e valutazione dei progetti sul temacoordinati dall’Agenzia Regionale della Sanità;
�coinvolgimento dei referenti dei progetti;�condivisione delle esperienze raccolte;�diffusione attraverso il convegno del 23 settem-bre 2009.
TARGET E OBIETTIVI DELL’EVENTOREGIONALE SULL’EMPOWERMENTAll’evento locale (primo vero appuntamento perla condivisione della metodologia, degli strumentie della buona pratica di empowerment nella re-gione) hanno partecipato i rappresentanti dei Di-partimenti di Prevenzione, dei Dipartimenti diSalute Mentale, degli Urp una rappresentanza deimmg, del Gruppo dell’Audit Civico, dei servizisociali, delle Associazioni di volontariato e deiconsumatori, oltre ai referenti aziendali e ai co-ordinatori dei progetti di empowerment.Gli obiettivi dell’evento sono stati:�diffondere la conoscenza sui processi di empo-
REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA:PRESENTAZIONE DEL PERCORSOSVILUPPATOA LIVELLO REGIONALE
di Simonetta Gagliardi, Giorgio SimonDirezione Centrale salute, integrazione sociosanitaria e protezione sociale - Regione FriuliVenezia Giulia

werment, per far crescere una cultura che valo-rizzi, sostenga, accresca le capacità dei cittadininel prendere parte attiva ai processi di cura, almiglioramento dei servizi e ai processi di co-struzione di comunità competenti;
�offrire un’occasione di discussione e riflessioneinterprofessionale sul tema dell’empowermentnelle organizzazioni sanitarie;
�promuovere un confronto tra gli operatori e rap-presentanti dei cittadini, favorendo lo scambioe la partecipazione, a partire dalle esperienze ma-turate nel contesto regionale.Le esperienze locali presentate durante l’eventoe descritte di seguito sono state:�Diamo peso al benessere;�Audit civico;� Il ruolo del Medico di medicina generale;�Genitori più.
DIAMO PESO AL BENESSERE(Referenti:Anita Cacittie Liliana Zuliani)Oltre al calo ponderale, la finalità di questa ini-ziativa è quella di far crescere nelle persone in so-vrappeso/obese, una capacità progettuale che, at-traverso una nuova consapevolezza di sé, permet-ta loro di cambiare il proprio modo di vivere e ilrapporto con gli altri.L’iniziativa ha un sistema teorico che concepisce:� la persona come valore;� il comportamento come conseguenza della per-cezione personale di successo o insuccesso;
� l’empowerment personale come metro del cam-biamento e del potere personale su se stessi esulla comunità;
� il gruppo/comunità come spazio nel quale at-tivare questi processi a livello consapevole.Gli strumenti utilizzati a questi scopi vanno dalcontatto terapeutico, al diario di viaggio, alleriunioni settimanali di gruppo, al brainstorming,alla lettera personale, alla collaborazione coifamiliari, fino ad arrivare al lavoro sul corpo.Il programma fornisce agli utenti un percorsoterapeutico che parte dall’inserimento nel grup-
po e continua con il processo di self-empowermentper concludersi con la valorizzazione e conso-lidamento delle esperienze di successo e la va-lorizzazione dei punti di forza di ciascun parte-cipante.La valutazione del cambiamento riguarda diver-si aspetti:1) la percezione personale misurata con un que-stionario pre e post trattamento;
2) il cambiamento comportamentale raccontatodall’utente tramite lettera;
3) la modifica del clima familiare che emerge daivari colloqui con le persone più significative.
I risultati del progetto Diamo peso al benessere so-no molto incoraggianti; ad oggi sono stati coin-volti circa 400 partecipanti che dichiarano di averottenuto un notevole miglioramento della quali-tà della loro vita.
AUDIT CIVICO(Referenti: Giorgio Simon,Monica Masutti e GiorgioVolpe)L’iniziativa consiste nella valutazione, da parte deicittadini in forma associata, dell’aderenza dellestrutture e delle organizzazioni sanitarie regiona-li agli standard di qualità, attraverso il reperimen-to di dati oggettivi come le evidenze documen-tali e le visite sul campo.L’Audit Civico nasce nel 2000 per iniziativa diCittadinanzattiva, sulla base dell’esperienza delTribunale dei diritti del malato e nel 2009 ha ot-tenuto il patrocinio del Ministero del Lavoro, del-la Salute e Politiche Sociali.Le basi normative dell’Audit Civico a livello na-zionale sono:� l’art.118 della Costituzione: Stato, Regioni, Cittàmetropolitane, Province e Comuni favoriscono l’auto-noma iniziativa dei cittadini, singoli o associati, perlo svolgimento di attività di interesse generale, sullabase del principio di sussidiarietà;
� i diritti definiti dalla Carta Europea (diritto al-la prevenzione, all’informazione, al consenso,al rispetto di standard di qualità, alla sicurezza,al reclamo, ecc.).
Regione Friuli Venezia Giulia: presentazione del percorso sviluppato a livello regionale
25
IQU
AD
ERN
IDI

IL SISTEMA SANITARIO E L’EMPOWERMENT
26
IQU
AD
ERN
IDI
Questi principi sono stati recepiti nel Piano Sa-nitario e Sociosanitario Regionale che, tra gliobiettivi indicati come prioritari, prevede che tut-te le strutture regionali siano valutate, in accordocon le associazioni dei cittadini, secondo la me-todologia dell’Audit Civico.Le Linee per la gestione del Ssr del 2007, 2008 e2009 contengono poi le indicazioni per l’intro-duzione e il consolidamento delle attività del-l’Audit Civico in tutte le Aziende sanitarie re-gionali, le quali partecipano alla fase di progetta-zione operativa e applicano lo strumento ai ser-vizi e alle strutture di propria competenza.Sulla base di queste indicazioni normative regio-nali, a partire dal 2008 sono stati indagati i se-guenti aspetti:� l’orientamento verso i cittadini;� l’impegno delle Aziende Sanitarie nel promuo-vere alcune politiche di particolare rilievo so-ciale e sanitario;
� il coinvolgimento delle organizzazioni civichenelle politiche aziendali;
� la capacità delle Aziende di dare risposta ad unproblema concreto vissuto come urgente dallacomunità locale.Lo strumento principale di raccolta di informa-zioni sono state le interviste strutturate ai re-sponsabili aziendali. Dall’analisi di questi dati so-no emerse le aree critiche e i punti di forza del-le realtà indagate che sono state descritte nei rap-porti locali confluiti poi in un unico RapportoRegionale.Per creare un maggior coinvolgimento tra le par-ti interessate è stato creato un tavolo tecnico co-stituito da Cittadinanzattiva, MoVi e AgenziaRegionale della Sanità ed è stato creato il coor-dinamento regionale, costituito dai referentiaziendali e di parte civica unitamente al tavolotecnico.L’effettuazione delle attività previste dal pro-gramma di Audit Civico ha costituito in Fvg unodegli obiettivi incentivanti dei Direttori Genera-li delle Aziende sanitarie e ha rappresentato unostrumento di empowerment del cittadino quale
mezzo di conoscenza dei servizi e di migliora-mento delle organizzazioni sanitarie.
GENITORI PIÙ(Referenti: Giorgio Simon,Monica Masutti e Barbara Lavia)GenitoriPiù è una campagna di comunicazioneavviata su iniziativa del Ministero della Salute acui ha aderito anche la regione Fvg. Il program-ma, che ha integrato e potenziato le iniziative re-gionali già in atto, è nato per orientare i genito-ri verso scelte di salute consapevoli e praticabilie per sensibilizzare la popolazione e gli operato-ri sanitari sui determinanti di salute ritenuti prio-ritari in ambito perinatale e infantile, in accordocon quanto raccomandato dalla letteratura scien-tifica:1. assunzione di acido folico nel periodo peri-concezionale;
2. astensione dal fumo in gravidanza e nei luoghifrequentati dal bambino;
3. allattamento al seno esclusivo nei primi sei me-si di vita;
4. posizione supina nel sonno;5. utilizzo di appropriati mezzi di protezione inauto;
6. vaccinazioni;7. lettura precoce ad alta voce.Per diffondere in maniera capillare la conoscen-za di questi importanti determinanti di salute, lacampagna ha previsto le seguenti fasi:� informazione della popolazione e degli operato-ri sanitari tramite quotidiani locali e nazionali,contatto diretto coi professionisti e distribuzio-ne di materiale informativo;
� formazione degli operatori del percorso nascita edei distretti sanitari;
�valutazione delle conoscenze e dei comporta-menti dei neogenitori e degli operatori.La campagna si è conclusa con un recall telefo-nico agli operatori dopo 6 mesi dalla conclusio-ne della stessa (eseguito dalle regioni Fvg e Pu-glia) che ha dimostrato un notevole aumento diconoscenze e competenze.

IL RUOLO DEL MEDICO GENERALE(Referenti:Alberto Gianmarini Barsantie Luigi Canciani)L’accordo collettivo nazionale della Medicina Ge-nerale, reso ufficiale nel luglio 2009, all’art. 13 bisrecita: il mmg espleta le seguenti funzioni:�assume il governo del processo assistenziale re-lativo a ciascun paziente in carico;
� si fa parte attiva della comunità dell’assistenzaper i propri assistiti;
�persegue gli obiettivi di salute dei cittadini conil miglior impiego possibile delle risorse.Il contesto legislativo, ossia il riconoscimento for-male che lo Stato dà alla figura professionale delmedico di famiglia, si basa sul principio che il rap-porto tra mmg e cittadino/paziente si fonda sul-la fiducia e l’empowerment (condivisione e par-tecipazione al percorso di cura da parte del pa-ziente) è imprescindibile da questo rapporto fi-duciario.Il Mmg è, pertanto, coinvolto nel processo di em-powerment per tre fondamentali ragioni:1)nella stragrande maggioranza dei casi, è il pri-mo professionista della salute che viene con-sultato dal cittadino;
2)è stato calcolato che ogni mmg incontra, nelcorso della sua attività professionale, in mediacirca 8 volte in un anno, ognuno dei suoi assi-stiti;
3) in ognuna di queste occasioni, anche inconsa-pevolmente, viene svolta attività di counselling.
È chiaro quindi che l’obiettivo a cui deve punta-re il mmg è la salute del cittadino e per raggiun-gere questo scopo deve:
�poter contare su un insieme di servizi (organiz-zazioni sanitarie) che consentono di raggiunge-re o avvicinarsi il più possibile a questo scopo;
�poter attingere a queste risorse per non “restaresoli” a confrontarsi con problematiche semprepiù complesse.La Società Italiana di Medicina Generale (Simg),attraverso i suoi iscritti, si dichiara pronta a soste-nere l’onere e l’onore di recitare un ruolo di pri-mo piano negli interventi di educazione sanita-ria attraverso tre grandi canali:�mass media (articoli o diffusione di programmi);� incontri coi cittadini a livello di singoli distret-ti o realtà locali;
� incontri periodici con i propri pazienti riunitiin gruppi di ascolto.Per concludere, grazie alla filosofia dell’empo-werment, siamo in grado di dire che i mmg vo-gliono aiutare i cittadini di questo Paese a pren-dersi cura della propria salute.
CONCLUSIONICome si può ricavare dalle esperienze raccol-te a livello regionale, l’empowerment del cittadi-no è auspicabile in tutte le organizzazioni sani-tarie e sociali. Il convegno locale che è statorealizzato si è rivolto a coloro che, a vario ti-tolo, hanno promosso e sostengono strategie eprogetti che mettono al centro la persona e isuoi bisogni. L’incontro ha dato un primo im-pulso alla diffusione della cultura dell’empo-werment e ha gettato le basi per una serie diiniziative future che la Regione continuerà asostenere.
Regione Friuli Venezia Giulia: presentazione del percorso sviluppato a livello regionale
27
IQU
AD
ERN
IDI

IL SISTEMA SANITARIO E L’EMPOWERMENT
28
iQua
dern
idi E
mpowerment è una parola oggi di mo-da, di cui non si è ancora trovata la giu-sta traduzione in italiano.Tutte le volteche questo succede è segno di un im-
maturo approfondimento culturale nel nostro Pae-se del reale significato del termine in questione.Per questo motivo, l’Agenzia Regionale per i Ser-vizi Sanitari del Piemonte (AReSS), nel momentoin cui è stata delegata dalla Regione ad affronta-re il tema dell’empowerment, ha ritenuto op-portuno aderire alla rete interregionale promos-sa dall’Agenzia nazionale per i servizi sanitari re-gionali e ha partecipato al seminario di appro-fondimento sul tema, organizzato a Roma dal-l’Agenas, in occasione del quale sono state illu-strate le esperienze regionali più significative esono stati condivisi i tre livelli in cui si articolal’empowerment: individuale, organizzativo e dicomunità.A livello piemontese si è deciso di iniziare l’atti-vità con una riunione a cui fossero chiamate lepersone che più avevano approfondito il concet-to di empowerment a livello regionale, per favo-rire una discussione collettiva che meglio potes-se definirne il significato, nelle stesse tre acce-zioni individuate dal tavolo di lavoro interregio-nale promosso da Agenas.Si è partiti da una lettura critica delle parti delPiano Socio Sanitario Regionale 2007-2010 chetrattano l’argomento. Nella premessa del Pianostesso dal titolo Una nuova politica per la salute so-
no indicate “la centralità delle cittadine e dei cittadi-ni che, in quanto persone singole o gruppi sociali radi-cati in un territorio, sono titolari originari del diritto al-la salute che va tutelato attraverso una vigile, assidua,e per certi versi radicale partecipazione democratica.At-tiene a questa concezione l’attenta considerazione perl’applicazione dei criteri di dignità, di umanizzazionee di giustizia, che si concretizzano anche in un’acco-glienza che ne tuteli i diritti, faciliti l’accesso e rispettiil tempo delle cittadine e dei cittadini” e “un deciso eresponsabile coinvolgimento degli enti locali i quali, at-traverso le loro espressioni di democrazia delegata, de-liberativa e partecipata, pianificano e programmano azio-ni di tutela e promozione della salute ed esercitano an-che la valutazione della qualità dei servizi nonché del-la loro efficacia nel rispondere ai bisogni della popola-zione”.È però soprattutto nel capitolo intitolato La per-sona/il cittadino/il paziente che si affronta più a fon-do l’argomento. Se ne riportano le parti ritenutepiù significative:�“il singolo individuo nel rapporto e nel contesto deisistemi sanitario e sociale assume rilevanza e ruoli dif-ferenti:- è persona in quanto è portatore di dignità, rispetto,valori, cultura, conoscenze;- è cittadino in quanto portatore di diritti esigibili ine-renti la tutela della salute, la disponibilità di servizie l’accesso agli stessi e, nel contempo, porta con sé idoveri derivanti dall’essere parte della comunità;- è paziente nel momento in cui è direttamente coin-
PERSONA,CITTADINO,PAZIENTE:IL PROGRAMMA DIEMPOWERMENT IN PIEMONTE
di MonicaViale, Oscar BertettoAReS.S - Agenzia Regionale per i Servizi Sanitari, Piemonte

Persona, cittadino, paziente: il programma di empowerment in Piemonte
29
IQU
AD
ERN
IDI
volto nei processi assistenziali”;�“nel contesto specifico del percorso assistenziale l’in-dividuo deve essere partecipe e consapevole delle cure,poiché è lui stesso attore della buona riuscita delle scel-te assistenziali. Non siamo di fronte a processi di cu-ra oggettivi da imporre ai cittadini, ma a percorsi dicura da tradurre nel contesto culturale e sociale in cuivive la persona”;
�“la stessa evoluzione della medicina rispecchia nellatrasformazione del rapporto medico/paziente questoeffetto che attribuisce maggior peso al paziente (em-powerment). Dal paternalismo direttivo che in pas-sato connotava questo rapporto, attraverso la fase delconsenso informato quale trasmissione di informa-zioni e assunzione di responsabilità del soggetto, sideve arrivare alla fase della negoziazione tra un cit-tadino protagonista che possiede le proprie informa-zioni ed è consapevole dei propri bisogni e il profes-sionista che, non rinunciando agli aspetti di specificaresponsabilità in merito alle proprie competenze tec-niche, si propone come consulente fiduciale al fiancodel cittadino. L’oggetto della loro relazione non è piùla malattia in sé, ma è la soggettività del pazientestesso rispetto alla condizione di malattia, che vive lasua autonomia nella scelta dei percorsi di cura più cor-rispondenti alla propria individualità. Le decisionidel percorso assistenziale non sono uniformementeapplicabili ma sono il risultato del rispetto della sog-gettività, dell’autonomia conseguente alla consape-volezza della condizione di malattia che vive l’indi-viduo”;
�“in questo contesto di relazioni tra cittadino e siste-ma dei servizi deve essere esaltata la differenza di ge-nere, che va contestualizzata, in particolare, nei mo-menti di analisi del bisogno, di valutazione dei fatto-ri di rischio, di individuazione dei percorsi assisten-ziali e di prevenzione e delle scelte operative”.La riunione è stata condotta con il metodo delbrainstorming ed ognuno dei numerosi parteci-panti ha liberamente espresso le proprie opinio-ni, portato la propria esperienza, sottolineato aspet-ti particolari del problema.Al termine della dis-cussione si è raggiunto un accordo su che cosaintendere per empowerment a livello regionale e
quindi quali iniziative andare a “fotografare” nel-le esperienze delle varie Aziende sanitarie.Sin da questa prima discussione si è particolar-mente sottolineata l’importanza di prendere inconsiderazione gli indicatori con cui valutare leesperienze promosse ai diversi livelli aziendali. So-prattutto attraverso questi, infatti, si può indivi-duare se l’iniziativa risponda all’effettivo “empo-werment” e non ad attività che, pur organizzatecon ampia partecipazione e volontà da parte deiproponenti, sono riconducibili ad altri aspetti.Proprio per questo motivo si è ritenuto oppor-tuno che la scheda di rilevazione proposta daAge-nas e a cui l’Agenzia ha deciso di aderire, doves-se essere somministrata con precise modalità e dapersonale appositamente preparato (a cura di pro-fessionisti delle Facoltà di Psicologia e Medicinae Chirurgia dell’Università diTorino) e non sem-plicemente inviata per la sua compilazione alleAziende.È importante, infatti, che gli operatori siano co-involti in tutto il progetto per meglio definire conil loro contributo le esperienze realmente signi-ficative. Occorre individuare le persone di rife-rimento da intervistare a livello aziendale affin-ché siano in grado di fornire informazioni esau-stive su tutte le iniziative e capaci di individuarele segnalazioni utili. L’obiettivo non è tanto di ar-rivare ad un completo censimento di tutte le espe-rienze, pur necessario come corretta fonte di co-noscenza, ma di individuare quelle pratiche cheabbiano la caratteristica di essere “buone”, tantoda poter essere segnalate alle Aziende regionaliper una loro diffusione.Si tratta quindi, contemporaneamente, di prov-vedere all’elaborazione dei dati provenienti dallascheda di rilevazione, e forniti ad Agenas, e di in-dividuare anche i criteri con cui valutare la qua-lità delle esperienze censite.Delle esperienze qualitativamente migliori oc-corre capire se siano peculiari del luogo ove si so-no sviluppate e quindi non riproducibili in altrocontesto, oppure siano trasferibili a tutta la Re-gione. Nel secondo caso, si intende predisporre

IL SISTEMA SANITARIO E L’EMPOWERMENT
30
IQU
AD
ERN
IDI
tutte le indicazioni utili a consentire il trasferi-mento dell’esperienza.Inoltre, dall’analisi dei dati raccolti e dall’appro-fondimento da parte di un gruppo di esperti del-la letteratura elaborata sull’argomento a livello na-zionale e internazionale, si intende predisporredelle raccomandazioni a cui le Aziende debbanofar riferimento per la futura elaborazione dei lo-ro progetti di empowerment.Per realizzare questi obiettivi è stata organizzatauna giornata di formazione articolata in un mo-mento collettivo in cui si è discussa la definizio-ne di empowerment elaborata: “Processo dell’a-zione sociale attraverso il quale le persone, le organiz-zazioni e le comunità acquisiscono competenza sulleproprie vite, al fine di cambiare il proprio ambiente so-ciale e politico per migliorare l’equità e la qualità di vi-ta” e si è condivisa la mappa concettuale. Il la-voro si è poi sviluppato in sottogruppi per ap-profondire concetti quali “consapevolezza criti-ca”, “partecipazione”,“diversità e interconnes-sione tra le tre componenti dell’empowerment”.L’incontro è terminato con la restituzione e con-divisione dei lavori dei sottogruppi in seduta ple-naria e la validazione di una scheda da inviare aireferenti aziendali per la segnalazione sino ad unmassimo di 4 iniziative di empowerment ritenu-te rilevanti e significative in base ai criteri adot-tati nella giornata. Sulla base di tali indicazioniverranno organizzate le interviste tutorate pres-so le Aziende con l’utilizzo della scheda di rile-vazione Agenas.Il coinvolgimento delle Aziende è avvenuto at-traverso un organismo centrale di governance ditutte le iniziative partecipative portate avanti inPiemonte, che ha visto la sua nascita presso l’A-genzia in occasione dello sviluppo di un proget-to di Audit Civico che si è esteso a tutte le Asrcon la collaborazione di Cittadinanzattiva.Taleorgano centrale di governance è costituito perogni Azienda da un referente per l’Audit prove-niente prevalentemente dagli uffici per le Rela-zioni con il pubblico o dagli uffici Qualità e dalreferente per la promozione ed educazione alla
salute (Repes). In tale sede sono assunte colle-gialmente, dopo ampie discussioni che coinvol-gono tutti i referenti aziendali, le decisioni del-l’Agenzia relative alle iniziative di partecipazioneed empowerment e allo stesso modo saranno dis-cussi i futuri progetti in merito.Ad oggi con questo organismo, oltre alle deci-sioni relative all’Audit Civico, sono state avviatele seguenti iniziative: il progetto di democraziapartecipata relativo all’Ospedale pediatrico edostetrico-ginecologico diTorino; la raccolta uni-ficata delle segnalazioni dei cittadini agli Urp; l’i-stituzione del Parco per la salute e alimentazio-ne; l’istituzione su un apposito portale “Osiris”di uno spazio dedicato alla raccolta di tutti i re-golamenti istitutivi delle conferenze di parteci-pazione previsti per ogni Azienda e i verbali del-le loro deliberazioni; la partecipazione dei paziential processo di accreditamento (percorso per la pro-tesi d’anca), la valutazione della qualità percepitadai cittadini in merito ai servizi forniti dagli spor-telli unici per i servizi sanitari e socio assistenzia-li realizzati a livello dei distretti territoriali e alleprestazioni dei gruppi di cure primarie/casa del-la salute recentemente attivati.L’Audit Civico è stato condotto presso tutte leAziende sanitarie del Piemonte, con il coinvolgi-mento di oltre 400 cittadini che hanno rispostoad un bando elaborato e diffuso in collaborazio-ne con Cittadinanzattiva e hanno partecipato adun corso di formazione con valutazione finaledella loro idoneità ad essere intervistatori e “visi-tatori critici” delle strutture sanitarie. Il questio-nario somministrato nelle interviste è stato quel-lo concordato con il Ministero della Salute, conalcune modifiche necessarie per adattarlo allarealtà piemontese. Si sono analizzati non soltan-to gli ospedali ma, per la prima volta, in modo si-stematico anche i distretti territoriali di tutte leAziende. Le principali criticità evidenziate nelrapporto finale sono state analizzate con i rap-presentanti delle Direzioni delle singole Aziendee sottoposte alla discussione delle conferenze dipartecipazione.Oltre a tale analisi a livello locale

31
iQua
dern
idi
è in corso l’elaborazione complessiva regionaleper consentire un benchmarking tra le diverseaziende. Il progetto sarà concluso con l’elabora-zione di un rapporto in cui saranno indicate lespecifiche azioni correttive che si riterrà oppor-tuno adottare per superare le criticità, con unaprevista rivalutazione dell’efficacia delle soluzio-ni prospettate a distanza di un anno.Il progetto di Democrazia partecipata è nato dallanecessità di dare una risposta attraverso un va-sto dibattito pubblico ad un problema peculia-re della sanità torinese.Nella città diTorino, in-fatti, vi sono due presidi ospedalieri, l’uno confunzioni pediatriche, l’altro con funzioni oste-trico-ginecologiche costituenti un’unica Azien-da sanitaria, che è anche sede delle attività di-dattiche e di ricerca universitarie in tali disci-pline. I servizi offerti dai suddetti presidi pre-sentano dunque, per buona parte della popola-zione, un forte valore anche simbolico riguar-dante la cura dei bambini, la maternità, la salu-te delle donne.Dovendosi assumere decisioni re-lative ai due presidi, riguardanti anche un loroeventuale trasferimento presso altra sede, si è ri-tenuto opportuno affrontare tale importante de-cisione con il confronto e il coinvolgimento am-pio dei principali stakeholders: utenti, volonta-ri, associazioni, personale infermieristico, oste-trico, tecnico, amministrativo,medici. Il proget-to ha previsto l’attivazione di una cabina di re-gia presso l’Agenzia, una ricognizione organiz-zativa per produrre una mappa delle strutturedei due presidi, un’attenta analisi documentale(carta dei servizi, funzionigrammi, verbali ecc.),l’attivazione di un sito internet apposito con imateriali di diffusione e di informazione, un’at-tività di ascolto e di indagine.L’ attività ha comportato 50 interviste in profon-dità condotte con i responsabili delle strutture egli opinion leader, l’analisi di 122 schede di rile-vazione qualitativa relative al personale medico,sanitario e amministrativo somministrate duran-te una settimana dedicata all’ascolto dei dipen-denti, 354 questionari compilati dagli utenti (174
del presidio ostetrico-ginecologico, 180 del pre-sidio pediatrico), due focus group con i volonta-ri ospedalieri.Al termine di questa prima fase èstata predisposta una mostra riassuntiva dei diversiscenari e delle diverse opinioni emerse con l’al-lestimento di un open house event in diversi localidei presidi. Sono quindi previsti 6 incontri con lapartecipazione di 50 operatori ciascuno che la-voreranno in sottogruppi facilitati da un condut-tore per permettere un confronto approfonditosui principali quesiti emersi e raccogliere indica-zioni strategiche sulle posizioni maggiormentecondivise.A conclusione dei lavori è program-mata una seduta plenaria per la fase finale deli-berativa. Ulteriore compito dell’Agenzia è la va-lutazione complessiva della validità di tale pro-getto di democrazia partecipata per una sua even-tuale estensione ad altre decisioni sanitarie di ri-lievo.Per la raccolta unificata delle segnalazioni dei cittadi-ni agli Urp si sono riuniti i responsabili azienda-li per decidere le modalità comuni con cui cata-logare le diverse segnalazioni pervenute. L’appli-cativo informatico adottato è stato quello deno-minato “Segnalazioni in sanità”, attualmente uti-lizzato dall’Agenzia Sanitaria e Sociale Regio-nale dell’Emilia Romagna, per il quale si è ri-chiesto e ottenuto il diritto al “riuso”. È previ-sta, insieme ai dati statistici che si raccoglieran-no con tale software – per rendere meno noiosae impersonale la loro lettura – la pubblicazionedi storie ed esperienze che siano rappresentativedei problemi e delle soluzioni pratiche adottateche stanno dietro a quei numeri e a quelle per-centuali.Il Parco della Salute alimentare è nato nel 2009 conla collaborazione tra l’Agenzia Regionale per iServizi Sanitari e l’Asl CN2 di Alba/Bra. Il suointento è sviluppare i temi del rapporto tra ali-mentazione e salute e promuovere studi, ricerchee sperimentazione di nuovi modelli in questo set-tore. L’attività si articola in 6 forum dedicati apromuovere una nuova cultura alimentare, con-sapevole della ricaduta delle scelte nutrizionali
Persona, cittadino, paziente: il programma di empowerment in Piemonte

IL SISTEMA SANITARIO E L’EMPOWERMENT
32
IQU
AD
ERN
IDI
sullo stato di salute; sviluppare le necessarie azio-ni di sensibilizzazione ai nuovi stili alimentari pres-so le comunità, nelle istituzioni pubbliche e pri-vate anche con un approccio culturale, socio am-bientale ed economico, gastronomico territoria-le, in grado di determinare alleanze in ambiti ex-trasanitari quale il mondo della scuola e l’Uni-versità degli Studi di Scienze Gastronomiche diPollenzo (CN). In alcune di queste iniziative èprevista la collaborazione di Cittadinanzattiva, inparticolare per l’analisi e la revisione critica degliaspetti gastronomico culturali e logistico orga-nizzativi della ristorazione ospedaliera e nelle Re-sidenze Socio Assistenziali per anziani. Si trattadi un settore dove le iniziative di empowermenthanno una ricaduta non soltanto in ambito sani-tario, ma coinvolgono un diverso approccio indifesa dell’ambiente, in favore di una agricolturache tuteli la biodiversità di varietà e razze, di unadistribuzione del cibo e delle tecniche della suatrasformazione più sicure e pulite.Il Portale Osiris consente a tutti i cittadini di co-noscere la composizione, il regolamento, le atti-vità e le decisioni assunte dalle conferenze di par-tecipazione dell’Azienda sanitaria a cui si riferi-scono. Tali organismi sono stati costituiti pressociascunaAzienda in seguito ad una deliberazionedi Giunta Regionale che definisce le modalità diindividuazione dei componenti (organismi di rap-presentanza degli utenti, rappresentanti del terzosettore e dell’imprenditorialità sociale, rappresen-tanti delle componenti aziendali impegnate nel-la programmazione e nella garanzia della qualitàdei servizi), le funzioni e l’organizzazione dei la-vori. La delibera ribadisce la centralità del citta-dino, titolare del diritto alla salute, da tutelare an-che attraverso la partecipazione democratica; ilrapporto privilegiato con le associazioni degliutenti, gli organismi del volontariato, della pro-mozione sociale e del privato sociale; la promo-zione del confronto a livello aziendale e distret-tuale con le organizzazioni dei cittadini per mi-gliorare l’appropriatezza della domanda, l’acces-so ai servizi e lo sviluppo di servizi di accoglien-
za, ascolto e accompagnamento dei pazienti neipercorsi di diagnosi e cura.Il processo di accreditamento in Piemonte avviene at-traverso la valutazione di percorsi diagnostico te-rapeutico assistenziali.Tra i percorsi inizialmenteanalizzati vi è stato quello relativo alla protesi d’an-ca dove si è sperimentato il coinvolgimento atti-vo del paziente con tre obiettivi principali: 1) mi-gliorare le prestazioni fornite, 2) migliorare la co-municazione tra struttura e paziente, 3) miglio-rare la qualità percepita. Il primo obiettivo si è ot-tenuto fornendo al paziente un questionario qua-le strumento per tenere sotto controllo i punticritici del percorso definito e il mantenimentodei precisi standard di qualità concordati; il se-condo obiettivo si è raggiunto attraverso un’arti-colata e strutturata informazione iniziale com-piuta dal personale medico e infermieristico nonlimitata solo ad una comunicazione orale,ma an-che mediante supporti cartacei e audiovisivi; ilterzo obiettivo è stato realizzato mediante l’atti-va partecipazione al monitoraggio del pazienteche, edotto in merito al razionale dei diversi mo-menti del percorso, ne verifica i passaggi e ne per-cepisce concretamente la qualità. Si costituiscequindi una vera e propria alleanza terapeutica conla sottoscrizione di un contratto tra la struttura eil cittadino, dove la struttura si impegna a rispet-tare standard definiti di qualità – accertati duran-te il processo di accreditamento – e il cittadino apartecipare al percorso e a rispettare le regole del-la struttura che lo ospita.Nella Regione Piemonte sono stati istituiti spe-rimentalmente, dopo una deliberazione congiun-ta degli Assessorati alla Salute e alWelfare, gli spor-telli unici di ingresso per i servizi sanitari e socio assi-stenziali. I destinatari del servizio sono i cittadiniresidenti nell’ambito territoriale di pertinenza conparticolare riferimento alla condizione di non au-tosufficienza. Le attività dello sportello riguarda-no l’accoglienza, l’ascolto e la presa in carico conrisposte integrate socio sanitarie, l’orientamentodel cittadino nella rete dei servizi, l’attivazione del-le procedure per l’accesso alle prestazioni, la faci-

Persona, cittadino, paziente: il programma di empowerment in Piemonte
33
IQU
AD
ERN
IDI
litazione dell’accesso ai servizi per le persone e fa-miglie in condizioni di fragilità con particolare at-tenzione ai residenti in zone svantaggiate (areemontane e collinari, periferie urbane). L’Agenziaè stata incaricata di monitorare l’attività degli spor-telli (sono attualmente attivati in Regione 58 spor-telli di cui 10 nella città diTorino), concorrere al-la formazione del personale, organizzare i sistemiinformativi e valutare la qualità percepita dai cit-tadini: a questo proposito si è deciso di aderire alprogetto nazionale denominato Mettiamoci la fac-cia. Tale progetto prevede una modalità semplicedi valutazione del grado di soddisfazio-ne/insoddisfazione immediatamente dopo l’ac-cesso ai servizi degli sportelli, gestibile via web.La valutazione del gradimento sui servizi offertiagli utenti dei gruppi di cure primarie/case della sa-lute è avvenuta con la somministrazione di unquestionario, all’uscita dei pazienti dagli ambula-tori, a cura di intervistatori di Cittadinanzattivaappositamente formati. I gruppi di cure primarie
attive in Regione sono 23 e si prevede di inter-vistare, per ottenere un campione statisticamen-te significativo, almeno 2000 cittadini. Il questio-nario tende a valutare il grado di conoscenza daparte degli utenti dei servizi offerti dalla nuovamodalità organizzativa, la soddisfazione relativaall’orario complessivo di apertura degli ambula-tori, al confort ambientale, alla comprensibilitàdelle informazioni fornite, alla riservatezza da par-te del personale, alla sua cordialità, alla accessibi-lità e ai tempi di attesa.Contemporaneamente a queste iniziative si ritie-ne utile tener vivo anche un dibattito culturalecontinuativo sull’empowerment con diverse mo-dalità quali: l’organizzazione di convegni in col-laborazione con il Centro regionale di docu-mentazione per la promozione della salute (Dors);l’apertura di un’area dedicata sul sito istituziona-le dell’Agenzia, una apposita pubblicazione mo-nografica e la richiesta ad ogni Azienda di dedi-care un incontro seminariale su queste tematiche.

IL SISTEMA SANITARIO E L’EMPOWERMENT
34
iQua
dern
idi L
a Regione Umbria ha aderito al Proget-to “Metodi e strumenti per la partecipa-zione attiva dei cittadini alla valutazionedei servizi e alle decisioni locali in mate-
ria di organizzazione dei servizi sanitari” indivi-duando in prima battuta le esperienze delleAzien-de sanitarie pubbliche che potevano essere ricom-prese nell’ambito di un percorso di empowerment.Dalla ricognizione effettuata all’interno delleAziende sanitarie pubbliche territoriali e ospe-daliere è emersa una serie di progetti classificabi-li in contesti di empowerment individuale e diempowerment organizzativo.
ESPERIENZEDI EMPOWERMENT INDIVIDUALEPromozione e sviluppo della partecipazio-ne (Azienda Usl n. 1)Progetto finalizzato a migliorare l’accesso ai ser-vizi ospedalieri attivando la funzione di acco-glienza ed accompagnamento del cittadino/utentee a favorire l’ascolto e la partecipazione.Tale ini-ziativa ha come obiettivo anche quello di realiz-zare le seguenti azioni:� la revisione partecipata del regolamento di pub-blica tutela;
� l’individuazione condivisa dei diritti e doveridei pazienti;
� l’istituzione della Commissione Mista Conci-liativa;
� l’individuazione e destinazione di spazi per at-
tività socio culturali e di educazione alla salute,da utilizzare congiuntamente o disgiuntamentecon le associazioni di volontariato;
� la preparazione di materiali per l’attivazione diun sistema di valutazione della qualità percepi-ta dagli utenti;
� la formazione del personale del front-office inmateria di comunicazione interpersonale e con-seguente attribuzione di funzione di accompa-gnamento dei cittadini anche con l’ausilio di vo-lontari;
� l’aggiornamento delle informazioni per la revi-sione del sito web aziendale e per la carta deiservizi.
Mediazione culturale nei servizi sanitari(Azienda Usl n. 2)Il progetto è partito dalla constatazione della con-sistenza della popolazione straniera in Umbria.Premessa dell’iniziativa è stata un’attività speri-mentale, promossa dall’Assessorato regionale allaSanità, che aveva fornito da una parte elementi diconoscenza delle problematiche sanitarie relativesoprattutto alle donne e all’infanzia, dall’altra in-dicazioni per una sistematizzazione dell’interventodi mediazione culturale nei servizi sanitari. Il Pro-getto si propone, quindi, di rimuovere gli ostaco-li culturali che ostacolano e/o impediscono la co-municazione tra i servizi socio sanitari e l’utenzastraniera, al fine di promuovere un migliore uti-lizzo dei servizi da parte del target ed una mag-giore efficacia di intervento degli stessi.Tutto ciò
REGIONE UMBRIAIL CITTADINO COMPETENTEE ATTIVO NEL SISTEMA SALUTE
di Antonio PerelliDirezione Regionale Sanità e Servizi Sociali, Regione Umbria

Regione Umbria. Il cittadino competente e attivo nel sistema salute
nel rispetto e per la valorizzazione delle specifi-cità culturali, promuovendo al contempo la con-sapevolezza dei comportamenti favorevoli alla sa-lute, soprattutto in un’ottica preventiva e di cor-retto utilizzo dei servizi.Numero unico per la salute (Azienda Usl n. 2)Il progetto prende le mosse dalla riscontrata cri-ticità da parte dell’Azienda sanitaria interessata(con un potenziale di utenza di 347.870 perso-ne, residenti in 24 Comuni su una superficie di2.494 kmq, suddivisa in 4 aree territoriali e 5 ospe-dali e con più di 100 sedi di erogazione di servi-zi) di erogare un’informazione puntuale e omo-genea. Obiettivo principale del progetto è quel-lo di garantire equità ed efficienza informativa,offrendo un supporto alla capacità del cittadinodi orientarsi nell’offerta dei servizi sociosanitari,attraverso un servizio aggiornato, con ampio ora-rio, di facile consultazione, che informi sui ser-vizi e sulle offerte attive per la salute.La novità è rappresentata dalla previsione di unnumero unico per le informazioni, con un nu-mero di utenti destinato ad aumentare nel corsodegli anni.A tal fine è stato stipulato un accordo con il Co-mune di Perugia, la Gesenu e l’APM per la rea-lizzazione di un contact-center unico, per la pre-disposizione di una banca dati e per la formazio-ne degli operatori.Contact center per tessera sanitaria on line(Azienda Usl n. 2)L’applicazione dellaTessera sanitaria nazionale at-tivata in Umbria dal 2005 ha determinato nume-rosi casi di disservizio, dovuti a cattiva informa-zione e disguidi nel recapito delle tessere stesse.Si è ravvisata quindi l’opportunità/necessità di so-stenere l’applicazione corretta e rapida del pro-gettoTessera sanitaria, rispondendo alle richiestedi informazione, risolvendo casi di mancata o er-rata trasmissione della Tessera sanitaria e orien-tando il cittadino verso i servizi in grado di ri-solvere il suo problema.Tale progetto prevede leseguenti attività:� supporto al cittadino e agli operatori sanitari per
prevenire e gestire situazioni di difficoltà;�disponibilità di uno strumento semplice (il te-lefono) per ricevere informazioni e servizi;
� riduzione della necessità di doversi recare di per-sona presso gli sportelli sia dell’Agenzia delle En-trate che della Asl stessa.
Come orientarsi nel mondo degli ausili(Azienda Usl n. 2)Il progetto è rivolto ad un target specifico di uten-ti (chi ha bisogno di ausili) in modo che la ri-chiesta degli ausili stessi possa avvenire in tempirapidi e in maniera corretta, così da rendere il cit-tadino consapevole dei propri diritti e opportu-nità, rispetto ad un mondo complesso per le nu-merose regole e procedure.Si è scelto di informare attraverso la predisposi-zione di una “linea guida” su supporto cartaceo,che pur presentando il limite dell’impossibilitàdi provvedere ad un aggiornamento dei dati (conconseguente scelta di rimandare informazionidettagliate ai servizi), presenta il pregio della sem-plicità del mezzo informativo e della possibilitàdi raggiungere persone che non usano internet.Integrazione del servizio accoglienza e me-diazione interculturale presso l’ospedale diSpoleto (Azienda Usl n. 3)La crescente presenza di immigrati e di utenti stra-nieri, che accedono in ospedale a vario titolo, coni problemi di comunicazione connessi alla lingua,hanno indotto la direzione dell’Ospedale di Spo-leto a creare uno spazio per l’accoglienza e l’a-scolto all’interno dell’ospedale, promuovendo laconoscenza dei servizi sanitari a disposizione, lemodalità di accesso e il loro utilizzo, con la fina-lità di consentire l’integrazione della popolazio-ne immigrata tramite l’ottimizzazione dell’acces-so e della fruibilità alle prestazioni del Serviziosanitario nazionale e di erogare un’informazioneefficace e pertinente sui servizi sanitari ospeda-lieri e territoriali inerenti le modalità di accessoe il loro utilizzo. Nello specifico sono state pre-viste le seguenti attività:�adozione della convenzione con l’associazione“Mappamondo” che opera nella città di Spole-
35
IQU
AD
ERN
IDI

to in favore delle popolazioni immigrate;�progettazione di una scheda di rilevazione deidati per monitoraggio delle attività di informa-zione e accoglienza;
�elaborazione e diffusione di un bollettino multiet-nico, tradotto in varie lingue, come guida all’o-spedale e nel quale vengono illustrate le norme ge-nerali per accedere all’assistenza sanitaria in Italia;
�monitoraggio dei bisogni socio-sanitari.Progetto accoglienza (Azienda ospedalieradi Perugia)La struttura del nuovo Polo Ospedaliero Uni-versitario di Perugia ha reso difficile per gli stes-si addetti ai lavori ed, a maggior ragione per gliassistiti, districarsi in una molteplicità di flussi edi percorsi, di ambulatori e multi professionali-tà, di tecnologie avanzate, conciliando la com-plessità e la tecnologia della “macchina ospeda-le” con aspetti quali la dimensione umana, la fi-ducia, l’accoglienza, in una parola l’umanizza-zione dello stesso.Il progetto punta proprio agli aspetti relazionali dicomunicazione e informazione e all’organizzazio-ne del front office come punto cruciale di incon-tro tra il cittadino e l’ospedale e si pone come obiet-tivo principale quello di garantire ai cittadini:�disponibilità all’ascolto e privacy;� informazioni chiare ed uniformi;�orientamento nell’utilizzo dei percorsi internianche con l’accompagnamento della persona neivari servizi sanitari;
� superamento delle barriere architettoniche,met-tendo a disposizione ausili per soggetti portato-ri di handicap.Il progetto, che ha contemplato il passaggio attra-verso diverse fasi (fase organizzativo logistica, fase for-mativa e fase attuativa),è stato ulteriormente svilup-pato in coincidenza della riapertura del nuovo in-gresso a seguito del restyling con l’attivazione del si-stema integrato di orientamento – SIO del cittadi-no all’interno della struttura ospedaliera. SIO è unsoftware che permette la ricerca e la visualizzazionedel percorso suggerito per raggiungere il reparto oil professionista richiesto con la possibilità (versione
online) di indicare l’ingresso più comodo a secondadella provenienza e stampare il percorso suggeritoall’interno dell’ospedale.La versione online sarà ospi-tata nel sito dell’Azienda Ospedaliera di Perugia,mentre la versione offline è installata all’ingresso prin-cipale dell’ospedale e aiuta gli utenti a trovare medi-ci e reparti partendo dal punto in cui si trovano.Continuità assistenziale tra ospedale e ter-ritorio (Azienda ospedaliera di Terni)Il progetto mira alla definizione di percorsi pro-tetti di assistenza a garanzia della continuità e del-la completezza degli interventi assistenziali per ipazienti anziani o fragili con patologie croniche,per creare una rete a supporto dei reparti ospe-dalieri e dei servizi territoriali per la creazione diun modello assistenziale di continuità delle cureche garantisca e fornisca risposte appropriate, con-crete, sicure ed efficaci ai bisogni assistenziali.Obiettivi misurabili previsti sono costituiti dallariduzione dei tempi di degenza ospedaliera, dal-la riduzione dei ricoveri ripetuti per stessa pato-logia, dall’attivazione di una valutazione multidi-mensionale, dalla definizione del piano di dimis-sione protetta e presa in carico territoriale e dal-la formazione del personale coinvolto.L’iniziativa consta delle seguenti fasi/attività:�creazione del centro interaziendale tra ospeda-le e Azienda territoriale;
�definizione del processo di continuità assisten-ziale con valutazione multidimensionale dei pa-zienti ricoverati;
�definizione del piano di attività assistenziale al-la dimissione;
�presa in carico dei pazienti dopo la dimissione;� formazione del personale;�valutazione degli indicatori per il monitoraggioed il controllo delle dimissioni protette.
Star meglio in ospedale (Azienda ospeda-liera di Terni)Il progetto parte dalla constatazione che, in base al-le evidenze scientifiche disponibili, agli scenari epi-demiologici e ai cambiamenti socio-culturali, la sog-gettività, gli atteggiamenti e i comportamenti svol-gono un ruolo significativo, collocando la dimen-
IL SISTEMA SANITARIO E L’EMPOWERMENT
36
IQU
AD
ERN
IDI

sione psicologica individuale e relazionale tra le de-terminanti della salute e della malattia, insieme conquella biochimica e ambientale.Di qui la necessitàdi migliorare la partecipazione dell’utente alle cu-re, le modalità di gestione della malattia, le cono-scenze e le abilità degli operatori su questi aspetti.Le attività progettuali mirano a:� fornire abilità agli utenti e ai caregiver per af-frontare al meglio le cure e la gestione della ma-lattia;
� fornire conoscenze agli operatori sugli aspettisoggettivi che incidono sulla malattia e sul pro-cesso di cura;
�prevenire il burnout.Verso un ospedale senza dolore (Aziendaospedaliera di Terni)Partendo dalla rilevazione delle criticità del pro-blema dolore in ospedale e nel territorio (il dolo-re è tenuto“nascosto” in quanto non viene misu-rato e documentato dal personale sanitario, il per-sonale medico prescrive farmaci e tecniche antal-giche in misura inadeguata alle necessità, il pa-ziente sofferente e i familiari non sono consape-voli delle possibilità terapeutiche del controllo deldolore), l’iniziativa mira a trovare una soluzionealla sofferenza del paziente con dolore cronico on-cologico/non oncologico e del paziente con do-lore acuto postoperatorio. Con la finalità di ac-crescere la consapevolezza dei singoli pazienti, fa-miliari, operatori socio sanitari e amministratori,il progetto, attraverso lo sviluppo di un Centro diRiferimento per l’ascolto e il sollievo dei malati,persegue l’obiettivo primario di assicurare al pa-ziente sofferente una condizione sostenibile di be-nessere, così definita dallo stesso, con l’impegno elo sforzo del personale sanitario e dei familiari sup-portati dai servizi sociali e dal volontariato.
PROGETTIDI EMPOWERMENT ORGANIZZATIVODefinizione linee guida regionali per il bi-lancio sociale e applicazione sperimentale(Azienda Usl n. 2)Il forte orientamento al governo clinico assunto
dalla programmazione regionale nel triennio2004-2006 ha indotto l’Assessorato regionale Sa-nità ad istituire il Centro Interaziendale per la rea-lizzazione del Bilancio Sociale nelle Aziende Sa-nitarie.La rendicontazione sociale è finalizzata ad au-mentare consapevolezza critica (delle Aziende Sa-nitarie verso la propria attività – “ rendersi con-to per rendere conto” – e dei cittadini) ed au-mentare la capacità dei cittadini di partecipare al-le scelte della programmazione socio- sanitaria.Le attività previste dal progetto sono state artico-late nelle fasi di seguito riportate:�Fase I attivazione del Coordinamento regiona-le, individuazione del tavolo interaziendale;
�Fase II attivazione del percorso di “formazio-ne- lavoro”;
�Fase III redazione delle Linee Guida regionali;�Fase IV sperimentazione nella Usl capofila, conla redazione e pubblicazione del Bilancio So-ciale.
Mediazione linguistica e culturale nella Asl4 di Terni (Azienda Usl n. 4):Fa da sfondo al progetto una ricerca sul fenome-no immigrazione in provincia diTerni, con pun-tuale rilevazione delle comunità presenti, incon-tri con i leader religiosi e civili delle comunità, aseguito della necessità rappresentata dai servizi sa-nitari territoriali di predisporre un servizio di me-diazione linguistica e culturale.Prendendo le mosse dal forte legame esistente trafede e salute, necessario per capire e conoscere lemigliori scelte per l’offerta del servizio sanitarioai cittadini immigrati, le attività previste dal pro-getto sono state:� ricerca preliminare sul fenomeno immigrazio-ne in provincia diTerni;
� rilevazione delle comunità presenti;� incontro con i leader religiosi e civili delle co-munità, costituzione della consulta;
� rilevazione dei bisogni di mediazione linguisti-ca dei vari servizi sanitari territoriali;
� formazione di 12 mediatori linguistico culturali;�costituzione del servizio di mediazione.
Regione Umbria. Il cittadino competente e attivo nel sistema salute
37
IQU
AD
ERN
IDI

Con il Psr 2009-2011 e il relativo DocumentoAnnuale di Programmazione la Regione Umbriaha posto l’accento sul tema della promozione del-la salute, sia dal punto di vista della sostenibilitàeconomica e dell’appropriatezza prescrittiva, cheattraverso una ridefinizione delle attività volte aduna politica di prevenzione e ad una valutazionedella qualità fornita e percepita,mantenendo l’o-rientamento verso il principio della sicurezza delpaziente.A tal fine, e sempre nell’ambito del progetto empo-werment, è stata quindi pensata e programmataun’iniziativa regionale, che si è svolta nel giugno2009, con l’obiettivo di coniugare tematiche stret-tamente connesse fra loro quali l’empowermentdel cittadino nel sistema salute, l’Audit civico, laqualità del servizio sanitario e i sistemi di accre-ditamento istituzionale attraverso il confronto conle esperienze di altre Regioni italiane e con i prin-cipali stakeholders coinvolti.
A conclusione del convegno di San Bevignate, èemerso come il concetto di empowerment abbiala peculiarità di concentrare l’interesse sui livellidi potere, o di recare con sé l’aspetto del “darepotere”, ossia mettere i cittadini, sia come singo-li, che come associazioni che li rappresentano,nella condizione di appropriarsi di quegli stru-menti metodologici indispensabili per poter par-
tecipare in maniera attiva e consapevole alla “co-struzione” del proprio benessere e di conseguenzaa quello dell’intera comunità di appartenenza.Contestualmente, la Regione Umbria ha appro-vato e dato seguito al progetto Audit civico (o Au-dit del cittadino) che consiste in un’analisi critica esistematica delle attività delleAziende Usl e Ospe-daliere, con l’obiettivo di migliorare la qualità deiservizi sanitari attraverso la partecipazione attivadei cittadini.L’Audit civico è promosso da Cittadinanzattivasulla base delle esperienze delTribunale per i Di-ritti del Malato e approvato dal Ministero dellaSalute. La Regione Umbria, con il Piano Sanita-rio Regionale 2009-2011, ha stabilito di render-lo operativo in Umbria presso tutte le AziendeSanitarie Regionali nel periodo di vigenza delPiano sanitario stesso.Il programma si ispira all’Art. 118 della Costitu-zione che impegna le istituzioni a “favorire l’au-tonoma iniziativa dei cittadini, singoli ed associati,per lo svolgimento di attività di interesse generale sul-la base dei principi di sussidiarietà” ed ha lo scopodi dare concretezza al punto di vista del cittadi-no e quindi di rendere visibile il modo in cui ilServizio sanitario si presenta a coloro che lo uti-lizzano.Operativamente, l’Audit civico consiste in unaraccolta di dati e informazioni sulla qualità e lasicurezza delle strutture, effettuata da equipe lo-cali composte da cittadini volontari e operatorisanitari attraverso una procedura di valutazioneprestabilita, a cui segue la redazione e pubblica-zione, da parte di Cittadinanzattiva, di un rap-porto regionale e un rapporto nazionale sui ri-sultati.L’Audit civico si ispira a quattro aspetti fonda-mentali delle esperienze del cittadino sui servi-zi sanitari, così come descritti nella tab. 1.La decisione di dotare le organizzazioni dei cit-tadini di uno strumento di valutazione delle azio-ni delle Aziende sanitarie è stata assunta per ri-spondere ad una serie di problematiche rilevatedal Tribunale dei Diritti del Malato, quali:
IL SISTEMA SANITARIO E L’EMPOWERMENT
38
IQU
AD
ERN
IDI
Il 29 giugno 2009, l’Assessorato alla Sanità della Re-gione Umbria ha organizzato a Perugia, presso la Chie-sa di San Bevignate, un convegno dal titolo Giornatadell’Empowerment – Il Cittadino competente e attivo nelsistema salute. Al convegno hanno partecipato in qua-lità di relatori, oltre al Direttore Regionale alla Sani-tà e Servizi sociali, Ing. Paolo Di Loreto, il Dr.GiovanniCaracci,Dirigente Sezione Qualità eAccreditamentodell’Agenas,Agenzia nazionale per i servizi sanitari re-gionali, la Dr.ssa Sara Carzaniga, Sezione Qualità eAc-creditamento dell’Agenas,Agenzia nazionale per i ser-vizi sanitari regionali, la Dr.ssa Daniela Gabellini, Pro-duct Manager Settore Sanità, Istruzione e PA della So-cietà di Certificazione Cermet, il Dr. Marco Menchi-ni, Dirigente Settore Equità e Accesso, Regione To-scana, la Dr.ssa Paola Mosconi, Responsabile Proget-to PartecipaSalute dell’Istituto Mario Negri di Mila-no, il Dr.Alessio Terzi, Presidente di CittadinanzAtti-va e il Dr.Antonio Perelli, Direzione Regionale Sanitàe Servizi Sociali.

�dare una forma concreta alla “centralità del pun-to di vista del cittadino”nell’organizzazione deiservizi sanitari;
� rendere trasparente e verificabile l’azione delleAziende sanitarie;
�creare un contesto che renda possibile la col-laborazione attiva fra cittadini e Aziende sani-tarie;
�acquisire informazioni non attingibili per al-tra via;
� far emergere aree critiche proponendo azionicorrettive.In sostanza, con l’Audit civico si vuole:�migliorare i servizi sanitari sul territorio;�umanizzare gli ospedali;�coinvolgere le organizzazioni di tutela dei citta-dini nelle politiche aziendali;
� risolvere i problemi che impediscono di mette-re a disposizione dei cittadini servizi accessibili,sicuri e di buona qualità.Allo stato attuale sono state costituite le equipelocali con la presenza di rappresentanti delleAzien-de sanitarie, di Cittadinanzattiva, della RegioneUmbria e dei cittadini volontari che sono statireclutati tramite un apposito bando pubblico eun idoneo stage formativo.
Nel mese di aprile 2010 si è tenuto a Perugia,nell’ambito del Progetto di ricerca finalizzata “Va-lutazione dell’impatto sulla salute nei programmidell’Umbria” (che vede la partecipazione dellaRegione Umbria, dell’Università degli Studi diPerugia, del Comune di Perugia, dell’Aur e del-l’Arpa Umbria), un seminario dal titolo “Presup-posti scientifici e istituzionali dell’empowermentnei programmi della salute pubblica” avente co-me scopo quello di promuovere lo sviluppo del-la partecipazione dei cittadini alla costruzione egestione delle mappe territoriali del rischio, at-traverso una sostanziale rilettura del concetto dipartecipazione della comunità alla costruzione diun nuovo modello di tutela della salute.In tale ottica l’empowerment dovrebbe presup-porre un dialogo a tre voci:� la voce della scienza, per fare chiarezza su ciò cheserve alla tutela della salute, distinguendolo daciò che è solo frutto delle convenienze del mer-cato;
� la voce della comunità, come titolari di diritti chenon vanno solo reclamati ma anche esercitati elasciati esercitare;
� la voce delle istituzioni locali, sollecitate a rispon-dere alle sfide dell’egemonia del mercato me-
Regione Umbria. Il cittadino competente e attivo nel sistema salute
39
IQU
AD
ERN
IDI
TABELLA 1 - Gli ambiti di attenzione dell’Audit civico
Aspetto Domanda AzioneIl cittadino inteso come utente dei servizi, coinvoltoin un processo di prevenzione, diagnosi, cura e riabi-litazione
Il cittadino inteso come soggetto malato, affetto dapatologie gravi o croniche
Il cittadino e i suoi diritti
Il cittadino e la comunità in cui vive
“Quali sono le azioni promosse dalle aziende sanita-rie per mettere concretamente i cittadini e le loroesigenze al centro dell’organizzazione dei servizi sa-nitari?”
“Quale priorità assumono nell’azione delle aziendesanitarie alcune politiche di particolare rilievo sanita-rio e sociale, come la gestione del rischio e del dolo-re, nel sostegno ai malati cronici?”
“La partecipazione dei cittadini è considerata dalleaziende sanitarie una risorsa essenziale per il miglio-ramento dei servizi sanitari o viene promossa (quan-do lo è) solo come un adempimento burocraticoprevisto da alcune leggi?”“Quali risposte ha fornito l’azienda sanitaria ad unproblema ritenuto urgente dalla comunità locale?”
Analizzare le attività delle aziende sanitarie per ga-rantire una buona informazione dei servizi, per ri-spettare i diritti dei malati, per rendere confortevolie accoglienti le strutture, per sostenere le famigliedei malati gravi, ecc.Analizzare gli interventi messi in atto dalleAziendesanitarie sulla sicurezza delle strutture, i provvedi-menti relativi alla prevenzione degli eventi avversi, lemisure per la gestione del dolore e l’attività volta afacilitare l’utilizzazione dei servizi da parte dei malaticronici e terminali.Verificare lo stato di attuazione delle disposizioni le-gislative finalizzate alla partecipazione dei cittadini, lavolontà di cercare nuove modalità di confronto conle comunità locali e, infine, la capacità di dare unospessore strategico ai rapporti cittadino/azienda.Articolare un processo di confronto interattivo fra ivari attori (amministrazione, personale medico, infer-mieristico, cittadini, ecc.) da concludersi con una ini-ziativa pubblica.

IL SISTEMA SANITARIO E L’EMPOWERMENT
40
IQU
AD
ERN
IDI
diante politiche ispirate alla supremazia dell’in-teresse pubblico.Il seminario pertanto verterà sullo sviluppo delconcetto di empowerment sui seguenti tre prin-cipali argomenti di discussione:� lo stato dell’arte della ricerca evidence-based al fi-ne di valutare quanto i dati epidemiologici pos-sono sostenere la politica della salute (empo-werment scientifico);
� le problematiche a sostegno di nuove politichenel campo della partecipazione come base di co-involgimento dei cittadini, delle associazioni deiconsumatori, dei network sociali (empowermentdemocratico);
� le responsabilità degli attori responsabili degliinterventi sul territorio nei vari livelli decisio-nali politici e tecnici (empowerment istituzio-nale).

41
iQua
dern
idi
Il bilanciamento tra l’esigenza di garantireegualmente a tutti i cittadini il diritto fonda-mentale alla salute e di rendere compatibile laspesa sanitaria con la limitatezza delle risorse
disponibili, è la sfida e la contraddizione appa-rente che oggi caratterizza il sistema sanitario pub-blico. Le fonti internazionali, in materia di salu-te pubblica, riportano il cittadino al centro del si-stema sanitario e fanno emergere come il rispet-to dei principi di responsabilità, autonomia deci-sionale e sussidiarietà sia connesso alla partecipa-zione informata dei cittadini alle scelte del siste-ma sanitario medesimo.Nella gestione del sistema sanitario regionale,maicome oggi è in primo piano l’obiettivo di valo-rizzare tutte le risorse disponibili, anche attraver-so una maggiore partecipazione informata dei cit-tadini. Quest’ultima è stata ritenuta fondamenta-le strumento di efficienza del sistema e di corre-sponsabilizzazione nel difficile compito di gover-no della sanità1.La questione va vista nel quadro della program-mazione generale degli interventi aventi comeobiettivo la qualità dell’assistenza socio sanitaria,nel rispetto dell’equilibrio economico finanzia-rio. Approfondire tale contesto è stato utile, co-
me si vedrà, anche per ipotizzare linee di orien-tamento delle politiche regionali, connotate dal-la recente accresciuta sfera di autonomia.
LA PARTECIPAZIONE DELVENETOALPROGETTODI RICERCA SULL’EMPOWERMENTIN SANITÀ CONDOTTO DAAGENASNell’ultimo biennio, ilVeneto è stato coinvoltoin un progetto nazionale volto ad individuare stru-menti per la partecipazione attiva dei cittadini al-la governance sanitaria. La RegioneVeneto haaderito al progetto di ricerca corrente condottoda Agenas “Metodi e strumenti per la partecipa-zione attiva dei cittadini alla valutazione dei ser-vizi ed alle decisioni locali in materia di organiz-zazione dei servizi sanitari”. In tale ambito ha in-trapreso un cammino volto da un lato a sensibi-lizzare le strutture territoriali e i referenti localidel mondo del volontariato vicino al sistema sa-nitario, dall’altro ad avviare percorsi comuni disensibilizzazione destinati a personale sanitario,cittadini e amministratori locali.
La rilevazione della presenza associazionisticanel sistema sanitario venetoIn particolare, nel partecipare al gruppo di lavo-
REGIONE VENETOIL MIGLIORAMENTO CONTINUOTRA PARTECIPAZIONE ECORRESPONSABILIZZAZIONE
di Paola De Polli, Maria Grazia CavazzinDirezione Servizi Sanitari - RegioneVeneto
1 Rapporto CEIS – Sanità 2007.

ro attivato da Agenas nel corso del 2008 e 2009,ilVeneto ha offerto un contributo al seminarionazionale organizzato nel mese di aprile 2009.Inoltre, ha scelto di condurre, presso tutte le di-rezioni generali delle Aziende socio sanitarie lo-cali, una rilevazione volta a fotografare le carat-teristiche del rapporto tra le strutture sanitariepubbliche e l’associazionismo locale, presentan-done gli esiti ad una prima iniziativa seminaria-le2. Il mondo del volontariato è risultato luogo dielezione della partecipazione consapevole e stru-mento di sussidiarietà, espressione tipica di em-powerment. Infatti, dalla fotografia dei rapportitra strutture sanitarie pubbliche e mondo del noprofit, sono emersi alcuni dati interessanti:�numerosità e presenza capillare: almeno 855 as-sociazioni risultano in contatto con le strutturesanitarie pubbliche delVeneto;
�consapevolezza: tutte le Aziende sanitarie di-chiarano di conoscere l’attività svolta dalle asso-ciazioni locali e forniscono informazioni sullemedesime (attraverso gli operatori, gli Urp, pub-blicazioni, ecc.);
� strutturazione (delle relazioni e della logistica):i canali di collaborazione sono nella quasi tota-lità derivanti da accordi scritti e la maggior par-te delle strutture sanitarie pubbliche mette a dis-posizione dei locali per le associazioni;
�efficacia ed efficienza: la quasi totalità delle strut-ture sanitarie dichiara di disporre di strumentidi raccordo con le associazioni per la presa incarico del paziente.
Possibili evoluzionidel ruolo regionale in temadi empowerment del sistema sanitarioAlla luce dei dati e delle riflessioni emerse sem-bra interessante ipotizzare, nel dibattito inter isti-tuzionale, anche i possibili nuovi ruoli che la Re-gione potrebbe assumere in questo contesto. I li-velli di analisi sono numerosi, su tutti paiono emer-gere quelli riguardanti:
� il profilo organizzativo: la Regione potrebbe di-ventare facilitatore di una rete interistituziona-le, con il compito di far dialogare i diversi livel-li di governo del sistema sanitario regionale conla voce del volontariato;
� il profilo giuridico amministrativo: la Regionepotrebbe rendere disponibili strumenti standarddi regolazione dei rapporti delle strutture sani-tarie con il terzo settore, anche individuando re-quisiti e percorsi, analogamente a quanto già èprevisto (come si vedrà) per l’accreditamentodelle strutture sanitarie;
� il profilo informativo: la Regione potrebbe di-ventare luogo ideale di attivazione e animazio-ne di strumenti informativi (sito, forum perma-nente, ecc.), con il coinvolgimento della retedelle strutture sanitarie e delle associazioni;
� il profilo scientifico: la Regione, con gli istitutidi ricerca e le Università, potrebbe attivare pro-getti per lo studio e la formulazione di propo-ste volte a facilitare la diffusione delle iniziativedi partecipazione dei cittadini al sistema di go-verno della sanità anche attraverso il mondo delvolontariato.
IL MIGLIORAMENTO CONTINUOATTIVATOCON I PROCEDIMENTI DI CONFERMADELL’AUTORIZZAZIONEALL’ESERCIZIODELLE STRUTTURE SANITARIE DELVENETOAccanto a tale specifico ambito, volto a veicola-re la consapevolezza delle risorse provenienti dalmondo del no profit, ilVeneto si è reso protago-nista di una specifica esperienza, di un vero e pro-prio percorso di empowerment, che ha coinvol-to tutte le strutture sanitarie pubbliche e privateattive nell’erogazione di prestazioni sanitarie nel-l’ambito del sistema sanitario regionale. Il sistemasanitario veneto è contraddistinto da una strettainterconnessione tra la dimensione del livello digoverno regionale e le strutture sanitarie che a li-vello territoriale erogano il servizio sanitario pub-blico e quelle private che lo erogano con oneri a
IL SISTEMA SANITARIO E L’EMPOWERMENT
42
IQU
AD
ERN
IDI
2 Primo seminario regionale Cittadini attivi nel governo della salute: volontariato, enti locali e aziende socio-sanitarie a confronto, Piazzola sul Brenta 23 settembre 2009.

carico del SSR.Tale connessione è assai strettanon solo perché gli indirizzi e le scelte program-matorie coinvolgono tutte le strutture,ma ancheperché gli standard di erogazione del servizio so-no stati uniformati.Infatti, in attuazione della riforma del sistema sa-nitario introdotta dal D.Lgs. 502/92, ilVeneto staportando a compimento il complesso iter che dalsistema di regolazione pubblico privato fondatosull’esistenza di convenzioni3, introduce la disci-plina dell’autorizzazione all’esercizio e dell’ac-creditamento istituzionale quale presupposto perl’erogazione di prestazioni in nome, per conto econ oneri a carico del sistema sanitario regiona-le, sia per le strutture pubbliche che per quelleprivate4.Il passaggio da un sistema all’altro è stato regola-to da provvedimenti legislativi nazionali e regio-nali, i quali hanno delineato un percorso per ade-guare la situazione di fatto dei soggetti ex “con-venzionati” alla nuova realtà normativa, discipli-nando alcuni snodi cruciali.A partire dalla l. 724del 19945, che ha stabilito la cessazione dei rap-porti convenzionali in atto e l’entrata in vigoredei nuovi rapporti fondati sull’accreditamento,sulla remunerazione delle prestazioni e sulla ve-rifica della qualità e ha previsto una fase tempo-ranea in cui i soggetti privati “già convenziona-ti” sono stati, in maniera automatica, transitoria-mente accreditati6.Successivamente, la legge finanziaria per l’anno20077 è intervenuta disponendo che le Regioniadottassero provvedimenti finalizzati a garantireche dal 1° gennaio 20108 cessino gli accredita-menti provvisori delle strutture private, non con-fermati dagli accreditamenti definitivi9.
Il percorso di confermadell’autorizzazione all’eserciziodelle strutture sanitarie veneteIn tale quadro normativo, ilVeneto ha scelto diutilizzare quest’occasione per offrire un segnaleeffettivo di attenzione alla qualità. Dopo essersidotato di una legge regionale ad hoc10, ha datoanzitutto avvio al percorso per la conferma delleautorizzazioni all’esercizio delle strutture sanita-rie definendo i requisiti per l’esercizio di attivitàsanitarie e socio-sanitarie da parte delle strutturepubbliche e private.Tale disciplina ha disegnatoun processo nel quale sono stati coinvolti i mol-teplici portatori di interesse:� le strutture sanitarie, chiamate a fotografare re-sponsabilmente le proprie caratteristiche e a ri-muovere le carenze emerse;
� le strutture tecniche, deputate alla verifica del-l’adeguatezza delle strutture ai requisiti prescritti(in primo luogo l’Agenzia regionale socio sani-taria11);
� i Comuni (per le strutture ambulatoriali) e laRegione (per le strutture di ricovero), compe-tenti a rilasciare l’autorizzazione all’esercizio an-che attraverso la definizione di prescrizioni allequali le strutture sono tenute ad adempiere.
L’autorizzazione all’eserciziodelle strutture di trasporto e trasportoe soccorsoTrait d’union del percorso avviato con il proget-to di ricerca corrente e con la revisione del siste-ma di autorizzazione all’esercizio è stata la disci-plina specificamente prevista dalVeneto per lestrutture private di trasporto e trasporto e soc-corso con ambulanza. Con tale disciplina, nel-
Regione Veneto. Il miglioramento continuo tra partecipazione e corresponsabilizzazione
43
IQU
AD
ERN
IDI
3 Previsto dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio Sanitario nazionale.4 D. Lgs. 502/92 artt. 8 bis, 8 ter, 8 quater, 8 quinquies.5 Si veda l’art. 6, comma 6 della l. 724 del 1994 “Misure di razionalizzazione della finanza pubblica”.6 A condizione che venisse accettato il nuovo sistema di remunerazione a prestazione, in attesa della regolamentazione a regime dell’istituto dell’accreditamento.7 Legge 27 dicembre 2006, n. 296.8 Termine prorogato di un anno, dalla legge 191/09, pertanto gli accreditamenti provvisori non confermati da accreditamenti definitivi cesseranno a far data dal 1° gennaio 2011.9 Di cui all’art. 8 quater, comma 1 del decreto legislativo n. 502/1992.10 La legge regionale delVeneto n. 22 del 2002 “Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio- sanitarie e sociali”. Il comma 6 dell’art. 22 della LR 22/2002, che disci-plina per l’appunto l’accreditamento a livello regionale, ha stabilito, secondo la tecnica del rinvio, che – nelle more dell’applicazione del provvedimento di accreditamento istituzionaleprevisto dall’art. 15 della legge stessa – sono provvisoriamente accreditate le strutture private che risultano transitoriamente accreditate ai sensi dell’art. 6, comma 6, della legge 26dicembre 1994, n. 724.Tali erogatori privati sono stati, fin dall’anno 1996, comunemente indicati con il termine di “pre-accreditati” appunto perché non accreditati in via definitiva.
11 Istituita con legge regionale delVeneto n. 32 del 2001.

l’ambito della ridefinizione del sistema di emer-genza ed urgenza, sono stati delineati dei requi-siti specifici ritenuti necessari a rispondere aglistandard di sicurezza ormai divenuti patrimonioscientifico condiviso. In tale contesto sono più diun centinaio le strutture, tutte appartenenti allacategoria del privato “no profit”, divenute parte-cipi del percorso previsto per il rilascio dell’au-torizzazione all’esercizio dell’attività di trasportoe trasporto e soccorso. Le stesse, una volta pre-sentata domanda, sono infatti coinvolte nella ve-rifica in loco svolta da esperti che riportano gliesiti alla Regione, competente al rilascio dell’au-torizzazione all’esercizio.
L’empowerment “diffuso”nel sistema regionale veneto.Primi risultati e prospettive futureIn tale quadro giuridico, amministrativo, orga-nizzativo, se, come si è detto nell’ambito del pro-getto di ricerca menzionato, per empowermentsi intende un processo dell’azione sociale attra-verso il quale le persone, le organizzazioni e lecomunità acquisiscono competenza sulle proprievite, al fine di cambiare il proprio ambiente so-ciale e politico per migliorare l’equità e la qua-lità di vita, non c’è dubbio che le iniziative de-scritte abbiano dato avvio allo sviluppo diffusodi competenze in una dimensione che va ben ol-tre la singola struttura sanitaria o la singola am-ministrazione competente ad adottare il provve-dimento autorizzativo. In tal senso va sottolinea-to come sia stato coinvolto l’intero sistema sani-tario veneto, con una modalità che si potrebbedire interseca la dimensione dell’empowermentorganizzativo e di comunità. Infatti, se si indagala portata del fenomeno e ci si addentra nell’a-nalisi del processo autorizzativo, si comprendecome ogni passaggio del percorso che ha porta-to alla conferma dell’autorizzazione all’eserciziodelle strutture sanitarie abbia offerto l’occasioneper accrescere tutte le componenti dell’empo-werment.Infatti, sotto il profilo della partecipazione, il si-
stema ha reso protagonisti tutti i portatori di in-teresse:� la Regione e i Comuni sotto il profilo della ca-pacità di comprendere il livello delle strutturee presidiare non solo la dimensione formale rap-presentata dal potere autoritativo che esse espri-mono in materia di autorizzazione all’esercizio,ma anche e soprattutto quella dell’efficacia de-gli interventi programmatori (sia nell’indivi-duare le strutture strategiche, sia nel destinarele risorse);
� le strutture sanitarie pubbliche, che per la pri-ma volta si sono dotate di una mappatura con-sapevole delle caratteristiche e degli interventinecessari ad adeguare le stesse agli standard re-gionali;
� le strutture sanitarie private, coinvolte nel fun-zionamento del sistema sanitario regionale, chesotto il profilo dell’analisi dell’adeguatezza de-gli standard sono state poste su un piano di ef-fettiva pariteticità con le strutture pubbliche;
�gli organismi di verifica (in particolare l’Agen-zia socio sanitaria regionale) che hanno indivi-duato e formato una comunità di esperti nellavalutazione multidisciplinare delle strutture sa-nitarie.Tale complessa azione di coinvolgimento ha da-to origine alla diffusione di una consapevolezzacritica che ha consentito alle strutture sanitarie dipresentare progetti per portare a buon fine gli ade-guamenti necessari a rispondere agli standard pre-scritti dalla disciplina regionale e, in definitiva, adattivare una metodologia per il miglioramentocontinuo.Grazie a tale consapevolezza, anche la dimensio-ne del controllo, componente fondamentale del-l’empowerment, ha consentito a tutti i soggetticoinvolti di influenzare efficacemente le decisio-ni in materia di autorizzazione, consentendo l’i-dentificazione degli adeguamenti necessari.La condivisione delle responsabilità sostanziali,l’incoraggiamento alla partecipazione, la mobili-tazione efficace di risorse, la valorizzazione di mo-menti decisionali e la definizione di obiettivi con-
IL SISTEMA SANITARIO E L’EMPOWERMENT
44
IQU
AD
ERN
IDI

divisi, ha messo in luce le capacità, le interdipen-denze del sistema e le aree di miglioramento sul-le quali intervenire.Il passo successivo sarà la conclusione dei proce-dimenti di conferma degli accreditamenti e laconclusione del passaggio tra il precedente regi-me dei c.d. convenzionamenti e l’attuale discipli-na12, che dispone che “l’esercizio di attività sani-tarie”, “l’esercizio di attività sanitarie per contodel Servizio sanitario nazionale” e “l’esercizio diattività sanitarie a carico del Servizio sanitario na-zionale” sono subordinate, rispettivamente, al ri-
lascio dell’autorizzazione all’esercizio, al rilasciodell’accreditamento istituzionale e alla stipula diprecisi accordi contrattuali.In attesa del definitivo compimento di questo iter,la conclusione del percorso per la conferma del-l’autorizzazione all’esercizio delle strutture sani-tarie ha coinvolto tutti i portatori di interesse inun impegno che lungi dal risolversi in un adem-pimento formale, ha portato ad un risultato assaisignificativo, e cioè alla raggiunta consapevolezzache il miglioramento continuo del sistema sani-tario è non solo doveroso, ma possibile.
Regione Veneto. Il miglioramento continuo tra partecipazione e corresponsabilizzazione
45
IQU
AD
ERN
IDI
12 Di cui al comma 3 dell’art. 8 bis del D.Lgs. 502/92 citato.

FOCUS SU DUEESPERIENZE SPECIFICHE

IL SISTEMA SANITARIO E L’EMPOWERMENT
48
iQua
dern
idi P
oter controllare in maniera autonoma lapropria vita e poterla modellare – da so-li ma anche assieme ad altri – è un pre-requisito essenziale per la salute.
Nella Carta di Ottawa, documento fondamen-tale per la promozione della salute, non si trova laparola empowerment,ma si trova la seguente fra-se: “Per raggiungere uno stato di completo benessere fi-sico, mentale e sociale, un individuo o un gruppo deveessere capace di identificare e realizzare le proprie aspi-razioni, di soddisfare i propri bisogni, di cambiare l’am-biente circostante o di farvi fronte.”Ed anche nella Dichiarazione di Jakarta, unaltro documento molto importante in questo am-bito, nel capitolo “Le priorità per la promozionedella salute nel 21° secolo” si legge:“Per migliora-re la capacità delle comunità di promuovere la salute so-no necessari un’istruzione pratica, un addestramento adassumere un ruolo di guida e l’accesso alle risorse. L’at-tribuzione di maggiori poteri agli individui necessita diun accesso più affidabile e costante al processo decisio-nale, e richiede le abilità e le conoscenze di base per de-terminare il cambiamento”.Parlando di empowerment, si possono sottolinea-re due presupposti che appaiono particolarmenteimportanti. Il primo si potrebbe definire “com-petenze”: essere sani non è solo una questione divolontà, ma è strettamente legato alle possibilitàcontingenti. Solo se le persone dispongono di in-formazioni e competenze sufficienti per tradurrein fatti le loro conoscenze in tema di salute, pos-
sono scegliere una vita sana. Proprio per questo,la FondazioneVital (www.fondazionevital.it) in-tende rafforzare le competenze in materia di sa-lute, in particolare tra le fasce di popolazione so-cialmente disagiate, che per tale motivo godonodi minori opportunità.Il secondo presupposto potrebbe essere indivi-duato nella “partecipazione”. La partecipazio-ne attiva della popolazione o dei direttamente in-teressati è fondamentale. Le persone interessatedevono diventare protagoniste della realizzazio-ne collettiva dei processi sociali, sia nella fase dipianificazione che nella concretizzazione dei pro-getti.Empowerment significa che persone, gruppi oorganizzazioni (Lenz,A., Stark,W., 2002):�dispongono di maggiori competenze riguardoalla propria salute;
�hanno la capacità di prendere decisioni in ma-niera autonoma;
�hanno accesso ad informazioni e risorse;� trovano diverse alternative d’azione e possibili-tà di scelta;
�hanno la sensazione di poter smuovere qualco-sa, in quanto individui o gruppi;
�hanno la facoltà sia di individuare aree proble-matiche che di formulare strategie risolutive;
�hanno anche la facoltà di attuare tali strategie;�hanno la sensazione di non essere soli,ma di es-sere parte di un gruppo o di una rete sociale;
�hanno la capacità di valutare cambiamenti nel-
P. A. BOLZANOLa certificazione delle imprese come occasioneper la promozione della salute e l’empowerment
di Franz PlörerDirettore FondazioneVital, Provincia Autonoma di Bolzano

la propria vita e nel proprio contesto sociale;�hanno la capacità di apprendere nuove compe-tenze ritenute importanti per sé.Sulla base di quanto esposto sopra, si potrebbe af-fermare che i professionisti della promozione del-la salute debbano intervenire su tre livelli:� rafforzare, a livello individuale, l’attitudine al dia-logo e la capacità di prendere decisioni assiemead altri;
�creare, all’interno delle organizzazioni, le con-dizioni per rendere partecipi le persone sin-gole;
�creare delle condizioni generali in senso giuri-dico, politico e culturale.Ma quali sono le condizioni fondamentali affin-ché l’empowerment, inteso come “processo checonduce dal senso di impotenza alla competenzae alla partecipazione attiva” (www.gesundheitliche-chancengleichheit.de) possa aver successo?Si possono individuare le seguenti fasi evolutive(Lenz,A., Stark,W., 2002):�mobilitazione: si infrange un atteggiamentoabituale di disinteresse, indolenza, devozione ver-so l’autorità e un’immagine di sé come “per-dente”. Si scoprono le proprie potenzialità e leproprie risorse;
� impegno e promozione: esaurito l’entusia-smo iniziale si sviluppa un impegno più stabile;
� integrazione e routine: le attività rientrano inparte in una routine e sono integrate nella vitaquotidiana;
�convinzione e continuità: si raggiunge unasicurezza nell’applicazione delle competenze par-tecipative e si matura una capacità organizzati-va e di soluzione dei conflitti.Resta invariata laconvinzione che è possibile apportare dei cam-biamenti.Uno dei più grandi ricercatori della promozionedella salute,Aaron Antonovsky, ha usato il fiumecome metafora per la vita. Noi tutti non passeg-giamo semplicemente sulla riva del fiume, manuotiamo in queste acque, che qualche volta so-no inquinate, qualche volta sono in piena. Il que-sito che ci poniamo è quindi sempre “quali sono
i fattori che agevolano il nuoto in queste acque?”Seguendo questa simbologia l’empowerment si-gnifica imparare a nuotare (insieme).Il termine “empowerment” descrive un processodurante il quale si superano delle condizioni divita discriminanti attraverso il sostegno recipro-co e le azioni sociali.“L’empowerment mira a tra-smettere alle persone le capacità necessarie pergestire la salute e la malattia aiutandoli a conqui-stare la forza e l’autostima per riuscire ad adotta-re in prima persona le decisioni giuste relative al-la loro salute” (Naidoo, J.,Wills, J., 2003).All’interno di questo quadro risulta interessantesoffermarsi su un termine che recentemente èstato oggetto di discussione nell’area germano-fona e anglofona, ovvero il termine di health lite-racy. Il termine non è nuovo, viene utilizzato sindagli anni ’70 nell’ambito dell’educazione sani-taria nelle scuole. Da alcuni anni health literacyviene però utilizzato anche per indicare l’obiet-tivo della promozione della salute e può essereinteso come una competenza fondata sulla co-noscenza finalizzata alla conduzione di una vitaall’insegna della promozione della salute.“Que-sta conoscenza si manifesta, in prima linea, in unsapere pratico per la gestione della salute e dellamalattia, del proprio corpo e delle condizioni divita sociali che influenzano lo stato di salute”(BZgA, 2006).
�Nella sua forma funzionale riguarda le com-petenze di base di lettura e scrittura;
�nella sua forma interattiva riguarda, ad esem-pio, la capacità di ottenere e scambiare delle in-formazioni;
�nella sua forma critica, si manifesta nella ca-pacità di analizzare in maniera critica le infor-mazioni, impiegandole poi nella vita quotidia-na (Nutbeam, 2000).I concetti di health literacy ed empowerment nonsi escludono a vicenda, al contrario si integrano:mentre il concetto di health literacy sottolineamaggiormente le capacità cognitive del capire edel comprendere, l’empowerment mette in pri-
P.A.Bolzano - La certificazione delle imprese come occasione per la promozione della salute e l’empowerment
49
IQU
AD
ERN
IDI

mo piano la capacità sociale di assumere il con-trollo della propria vita, organizzandola con re-sponsabilità. La promozione della salute che pun-ta al successo tiene conto di entrambi questi con-cetti: consente un miglior accesso alle informa-zioni relative alla salute, sostiene le persone nel-l’interazione critica con queste informazioni elancia dei processi per far sì che le persone pos-sano risolvere in autonomia i loro problemi.La difficoltà di integrare la prospettiva dell’em-powerment nel lavoro dei professionisti della pro-mozione della salute consiste in primo luogo nelfatto che i processi di empowerment possono es-sere attivati da questi, ma il processo vero e pro-prio si svolge – per definizione – senza il loro ap-porto. L’empowerment non può quindi essereparagonato ad altre modalità d’intervento più di-rette, tipiche dell’ambito psicosociale come il co-unselling, l’assistenza o la terapia.L’empowerment come atteggiamento professio-nale significa creare occasioni in cui svilupparecompetenze, rendere situazioni malleabili, get-tando così le basi per processi aperti, non prede-finiti. In questo senso l’empowerment è una sor-ta di “autorizzazione” a prendersi le proprie re-sponsabilità. La partecipazione va letta come ilcoinvolgimento attivo dei diretti interessati nonsolo nella rilevazione del bisogno ma anche nel-la pianificazione, nell’attuazione e nella valuta-zione degli interventi attuati a loro favore. L’o-biettivo è perseguire autonomamente i propri in-teressi. In questo senso la partecipazione è sia unpresupposto dell’empowerment – infatti è neces-sario aver sviluppato precise competenze per po-ter agire attivamente – ma anche una sua conse-guenza. Le abilità acquisite vengono messe a frut-to nei processi partecipativi.La Provincia Autonoma di Bolzano, con la Leg-ge Provinciale nr. 10 del 18 novembre 2005, haistituito la FondazioneVital la cui missione con-siste nello stimolare, pianificare e realizzare con-cetti e iniziative finalizzate al mantenimento e al-la promozione della salute.Tra i suoi compiti prin-cipali rientrano anche l’informazione e la sensi-
bilizzazione dei cittadini sulle malattie cronichee sui fattori che possono influenzare il loro be-nessere.La FondazioneVital ha fatto una scelta strategicanel senso che realizza progetti in diversi ambiti:scuole, ospedali, Comuni,Aziende. In particolareha avviato e realizzato il programma“Impresa Sa-na®” che, rispetto ai temi della partecipazione edell’empowerment, risulta di notevole interessesoprattutto per due specifici elementi del pro-gramma. Il primo elemento riguarda il sondag-gio tra i collaboratori e le collaboratrici, il se-condo elemento sono i cosiddetti circoli dellasalute.Il sondaggio e i circoli della salute, che nelle pa-gine successive vengono descritti con maggiordettaglio, costituiscono due elementi chiave delProgramma Impresa Sana® che è stato realizzatocon successo non solo in aziende del settore so-cio-sanitario, ma anche in aziende del settore pro-duttivo e dei servizi (vedi fig. 1).Le domande del sondaggio – che in tutto sono48 – riguardano:� il carico fisico e le condizioni di lavoro;� i compiti e le esigenze al lavoro;�gli orari di lavoro e lo svago;� le prestazioni dell’azienda;� la politica d‘informazione e la partecipazionedei dipendenti;
� la soddisfazione in merito allo stile di direzionedel superiore;
� l’ambiente di lavoro;� l’identificazione dei singoli con l’azienda;� i disturbi fisici;�gli stati emozionali;� le attività come per esempio misure ergonomi-che, prevenzione abuso alcool, tabacco e via di-cendo.La costruzione del sondaggio è stata ispirata an-che a quanto suggerito nel modello di job straindel sociologo americano Robert Karasek, le cuiipotesi sono state ampiamente confermate da stu-di epidemiologici (Karasek & Theorell, 1990).Questo modello suggerisce che la relazione tra
IL SISTEMA SANITARIO E L’EMPOWERMENT
50
IQU
AD
ERN
IDI

P.A.Bolzano - La certificazione delle imprese come occasione per la promozione della salute e l’empowerment
elevata domanda lavorativa e bassa libertà decisio-nale definisce una condizione di job strain o stresslavorativo percepito, in grado di spiegare i livellidi stress cronico e l’incremento del rischio car-diovascolare che aumenta il doppio rispetto a per-sone che lavorano in condizioni meno pesanti.Questo potrebbe voler dire che persone che svol-gono mansioni caratterizzate da scarsi livelli diautonomia ed elevato carico di lavoro sono espo-ste ad un maggior rischio di ammalarsi; significaanche che queste persone saranno meno interes-sate ad attivarsi per questioni di promozione del-la salute e che vanno quindi – in primo luogo –create le condizioni organizzative affinché sia re-sa possibile la partecipazione del personale a pro-cessi di promozione della salute (vedi fig. 2).Il fulcro del programma Impresa Sana® sono i cir-coli della salute. Nel circolo della salute si iden-tificano i fattori di carico e di sollecitazione ec-cessiva connessi al lavoro, nonché – aspetto mol-to importante anche dal punto di vista salutoge-netico – le risorse di cui si dispone per gestirli.Sulla base del proprio bagaglio di conoscenze ed
esperienze, i partecipanti elaborano delle propo-ste risolutive concrete che permettono di pro-muovere le risorse e di ridurre i carichi. Ne ri-sulta un elenco di misure che sarà presentato al-la Direzione. Il circolo della salute nella prima fa-se del progetto si riunisce 5 o 6 volte. Ogni in-contro dura circa 2 ore.Vi partecipano al massi-mo 10-12 persone, provenienti da tutti i repartidell’azienda se questo è possibile. È importanteche gli uomini e le donne siano rappresentati inmodo equilibrato, vale a dire in funzione della lo-ro percentuale sulla totalità dell’effettivo.Va precisato che vi sono diversi modelli: esiste ilcosiddetto “modello di Berlino“ e il “modello diDüsseldorf ”. Il modello di Berlino è stato svi-luppato da un gruppo di ricercatori dell’Univer-sità Tecnica di Berlino ed è stato applicato neglistabilimenti diVolkswagen. Il gruppo target diquesto circolo della salute era costituito da dei ca-po operai, dato che la figura di interfaccia tra di-pendenti e management appare particolarmenteesposta allo stress psico-sociale. Un criterio di-stintivo importante rispetto al modello di Düs-
51
IQU
AD
ERN
IDI
1 . P r e p a r a z i o n eP re p a ra z io n e
2 . F a s e S t r a t e g i c a
At t iv i tà p re l im in a ri
Work s h op s tra te g ic o
F irm a L e t te ra d i im p e g n o
Az ion i in f o rm a z ion e in te rn a
3 . A n a l i s i Qu a n t i t a t i v aS o n d a g g io t ra i co l la b o ra to ri
S on d a g g io t ra i q u a d ri
4 . A n a l i s i Q u a l i t a t i v aCirco lo / i d e l la s a lu te
5 . D e f i n i z i o n e d e lP r o g r a m m a d i a z i o n e
Wo rk s h op f in a le
Az ion i in f o rm a z ion e in te rn a
An a l is i eP ia n i f ic a z ion e
Du ra t a :8 m e s i
( p ro rog a b iles e s u s s is ton o
e v id e n t i ec om p rov a tem otiv a z io n i)
A TT I V I TA 'F A S IM A CR O
F A S I
FIGURA 1 - Il processo Impresa Sana®: analisi e pianificazione
Fonte: Fondazione Vital

seldorf è dato dal fatto che secondo il modello diBerlino i partecipanti ai circoli della salute sonoreclutati dallo stesso livello gerarchico, mentre ilmodello di Düsseldorf, sviluppato dall’Istituto disociologia medica dell’Università di Düsseldorf,recluta soggetti appartenenti a livelli gerarchicidiversi, in maniera tale che nel circolo della salu-te siano rappresentati allo stesso modo sia i di-pendenti del livello gerarchico più basso che i di-rettori di reparto, il medico aziendale o la pro-prietà dell’azienda.
IL CIRCOLO DELLA SALUTE:ELABORARE PROPOSTELa FondazioneVital ha deciso di adottare il mo-dello di Berlino partendo dalla considerazioneche il circolo della salute deve essere uno spazioin cui i dipendenti si possono esprimere libera-mente, in tutta sincerità, senza soggezione ancherispetto alle abilità di leadership del proprio su-periore, dato che questa è una variabile preditti-va fondamentale per il benessere fisico delle per-sone in un’organizzazione. Per evitare che la pre-senza di un superiore possa essere percepita co-me limitante, la FondazioneVital ha adottato ilmodello“egualitario”, dato che tra i compiti prin-cipali del circolo della salute vi è anche il ”riuscire
ad esprimersi“, ovvero dare alle persone che nel-l’attività quotidiana non vengono quasi percepi-te uno spazio protetto in cui possono esprimerele loro impressioni, i loro desideri e le loro aspet-tative.In altre parole: l’obiettivo del circolo della saluteè quello di dare uno spazio alle persone interes-sate che in questo modo diventano persone co-involte. I lavoratori e le lavoratrici hanno la pos-sibilità d’influenzare le decisioni che determina-no le loro condizioni e la loro realtà concreta dilavoro, dando il loro contributo, eventualmenteattraverso un loro coinvolgimento diretto nel pro-cesso decisionale.Un aspetto fondamentale è chei circoli della salute non sono costretti a trattaresoltanto di tematiche predefinite, ma hanno lapossibilità di parlare di aspetti che riguardano tut-ta l’azienda.Una premessa da non sottovalutare è che i circo-li della salute devono essere condotti da personequalificate in materia.Un altro punto fondamen-tale è che la direzione dell‘azienda deve essere fa-vorevole alla promozione della salute nell’azien-da stessa, altrimenti è meglio non iniziare il pro-cesso perché non si arriva da nessuna parte. L’A-zienda, inoltre, deve permettere ai collaboratoridi partecipare ai circoli della salute durante l’ora-
IL SISTEMA SANITARIO E L’EMPOWERMENT
52
IQU
AD
ERN
IDI
Domanda
ControlloLAVOROPASSIVO
LAVOROATTIVO
LAVOROBASSO STRAIN
LAVOROALTO STRAIN
Diagonalestrain
alto
alto
basso
basso
Diagonaleapprendimento
FIGURA 2 - Il modello domanda-controllo
Fonte: BKK, 2002

rio di lavoro e riprendere le proposte nate dal cir-colo della salute per metterle in pratica, così si dàun segnale forte di apprezzamento e anche di sti-molo, facendo capire di prendere sul serio ciò chepensano i collaboratori.
IL CIRCOLO DELLA SALUTE: MOMENTOCENTRALE DELLA PARTECIPAZIONEEsistono alcune difficoltà nell’attuazione di unprocesso di questo tipo (www.kmu-vital.ch), peresempio:� le risorse sono già esaurite dalle attività di ordi-naria amministrazione;
�esistono delle concomitanze con altre offerte in-terne;
� il lavoro part-time, la turnazione, il lavoro not-turno o l’attività in sedi esterne limitano ladisponibilità a partecipare;
�processi paralleli come ristrutturazione, proces-si di controllo e gestione della qualità possonocreare delle difficoltà;
� la cultura organizzativa nella gestione dei con-flitti interaziendali.Visto che l’impegno non è da poco, quali risul-tati possiamo aspettarci? Detto in termini econo-mici: ricerche scientifiche hanno dimostrato chela promozione della salute in azienda può dare unreturn on investment (ROI) di uno a tre (Sockollet al., 2008). In alcune ricerche si parla addirittu-ra di uno a cinque e uno a otto.Altri indicatoriper misurare gli effetti di un circolo della salutesono: la soddisfazione dei collaboratori tramite ilsondaggio, il tasso di assenteismo ovvero di flut-tuazione, il grado di partecipazione attiva ai variprogetti ecc.Questo significa che l’efficacia del processo è mi-surata mediante l’utilizzo di diversi indicatori. Lanostra metodologia prevede da un lato delle in-terviste ai collaboratori che vengono eseguite inmaniera anonima all’inizio e alla fine del proces-so e, dall’altro, la valutazione della qualità degli in-terventi determinati dai dipendenti durante l’a-nalisi quantitativa e qualitativa: sulla base di que-sti dati si elabora un piano di interventi con la di-
rezione da realizzarsi in maniera vincolante en-tro un tempo predeterminato.A questo proposi-to appare particolarmente interessante la questionerelativa alla tipologia di interventi decisi: posso-no essere soltanto degli interventi che riguarda-no più o meno il livello comportamentale e chepertanto lasciano ipotizzare una persistenza infe-riore nel tempo, oppure possono essere delle mi-sure strutturali (orari di lavoro, organizzazione dellavoro, ergonomia, informazione e comunicazio-ne) che producono degli effetti anche a lungo ter-mine.Per quanto riguarda l’empowerment, la questio-ne rilevante è quella relativa al ruolo che i di-pendenti hanno assunto nella programmazionee nella realizzazione concreta degli interventi. Èimportante vedere se svolgono un ruolo proprioe contribuiscono in maniera attiva al processooppure se continuano a reagire perlopiù in ma-niera passiva. L’esperienza della FondazioneVi-tal ha dimostrato che la qualità dei processi di-pende moltissimo dalla “cultura” delle aziende.In termini generali si può dire che nelle aziendein cui incontriamo una cultura aziendale orien-tata ai dipendenti, dove si dà valore alla stima re-ciproca e che presenta un elevato capitale socia-le, la promozione della salute riesce a svilupparedelle dinamiche diverse rispetto a quelle che siottengono nelle aziende in cui è già un succes-so ottenere l’applicazione delle norme di sicu-rezza previste dalla legge e il pagamento regola-re dei salari. Il compito degli health professionalsconsiste nell’individuare già in “fase strategica”la tipologia di azienda con la quale si troverannoad interagire. Questo è un modo per evitare ledelusioni e le frustrazioni legate a delle aspetta-tive errate.Non si deve, inoltre, dimenticare che la promo-zione della salute orientata al setting non si ponesoltanto l’obiettivo della partecipazione e del-l’empowerment delle persone che studiano, la-vorano o giocano in quel contesto, ma si trattasempre e soprattutto di ottenere la partecipazio-ne e l’empowerment dei soggetti che vi adotta-
P.A.Bolzano - La certificazione delle imprese come occasione per la promozione della salute e l’empowerment
53
IQU
AD
ERN
IDI

BIBLIOGRAFIA• Albert Lenz & Wolfgang Stark [Hrsg.](2002), Empowerment.Neue Perspektiven für psychosoziale Praxis und Organisation.Fortschritte der Gemeindepsychologie und Gesundheitsförde-rung, Band 10.Tübingen: DGVT-Verlag.
• BZgA (2006) BZgA, Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklä-rung (Hg.), Leitbegriffe der Gesundheitsförderung, Schwabenheim
• Karasek R., & Theorell T. (1990),Healthy work: stress, produc-tivity, and the reconstruction of working life, NewYork, NY: Ba-sic Books, pp. 89-103, zit. nach: BKK Bundesverband (2002),Psychische Belastungen am Arbeitsplatz sind einfach zu er-
mitteln, Essen.• Lenz A., Stark W. (Hrsg.) (2002), Empowerment. Neue Per-spektiven für psychosoziale Praxis und Organisation, dgvt-Ver-lag, Tübingen.
• Naidoo J.,Wills J. (2003), Lehrbuch der Gesundheitsförderung,Köln.
• Nutbeam D., (2000), Health literacy as a public health goal,Health Promotion International, 125, 259-267.
• Sockoll I., Kramer I., Bödeker W., Iga-Report 13,Wirksamkeitund Nutzen betrieblicher Gesundheitsförderung und Prävention,Essen 2008.
no le decisioni, indipendentemente che si trattidi direttori scolastici, titolari di aziende o prima-ri di un reparto ospedaliero. La promozione del-la salute orientata al setting è sempre un proces-so che va sviluppato e realizzato sia bottom-upche top-down. La promozione della salute non èuna strada a senso unico.Preme sottolineare che si corre il rischio di otte-nere uno scarso risultato se chi deve adottare ledecisioni non capisce gli obiettivi e la metodolo-gia di lavoro, in quanto i ruoli chiave e i model-li di base per un’organizzazione che promuova lasalute restano invariati.A cosa serve un circolodella salute, se il superiore non riesce a parlare con
il dipendente allo stesso livello, se non si crea unclima di fiducia reciproca, se in azienda si vive sol-tanto la contrapposizione e non la collaborazio-ne? Se vengono formulate soltanto delle aspetta-tive e non viene resa alcuna controprestazione, sela comunicazione è soltanto unilaterale (mono-loghi) e non bilaterale (dialogo)?È,quindi, fondamentale che chi è deputato a pren-dere delle decisioni, sia consapevole che il benes-sere fisico non è soltanto una questione privatadel dipendente, e anche coloro che adottano ledecisioni possono contribuire in maniera fonda-mentale a realizzare,modificare e migliorare il be-nessere attraverso le condizioni di lavoro.
IL SISTEMA SANITARIO E L’EMPOWERMENT
54
IQU
AD
ERN
IDI
FondazioneVitalLa FondazioneVital è nata con apposita legge provinciale nel 2005 ed è un’istituzione della Provincia Autonoma diBolzano. La FondazioneVital segue un approccio salutogenetico, ovvero ci si domanda quali siano i criteri o le con-dizioni di vita e di lavoro per stare sani.Detto in altri termini: l’orientamento patogenetico della medicina e della pre-venzione non fa parte della nostra mission.Anche dal punto di vista organizzativo non facciamo parte dell’azienda sa-nitaria, ma siamo un ente strumentale della Provincia con una certa autonomia.Attualmente in AltoAdige stiamo realizzando il processo di promozione della salute in diciassette aziende private epubbliche con un totale di circa 5.700 dipendenti. Entro la fine dell’anno partiranno altre 5 o 6 aziende. Purtroppoabbiamo anche dovuto notare che la crisi economica e finanziaria ha frenato in qualche maniera la dinamica messain atto due anni fa.

55
iQua
dern
idiN
el corso degli ultimi anni i paesi in-dustrializzati si sono trovati a do-ver affrontare delle sfide in ambitosanitario legate a diversi cambia-
menti, tra cui l’invecchiamento della popolazio-ne e il conseguente aumento delle malattie cro-niche, l’aumento dei costi dei servizi sanitari afronte della richiesta sempre maggiore di presta-zioni sanitarie di elevata qualità, nonché la cre-scente richiesta da parte dei cittadini di un mag-giore coinvolgimento e di un ruolo più attivo nel-la gestione della propria cura e salute.Per affrontare queste sfide occorre, quindi, im-plementare nuovi modelli per l’erogazione di ser-vizi sanitari riguardanti sia la dimensione della cu-ra (soprattutto la cura rivolta ad anziani e malaticronici) che la dimensione della prevenzione (es.stili di vita, alimentazione, attività fisica, ecc.) inun paradigma di sanità personalizzata.L’implementazione di questi nuovi modelli devetenere conto di una condizione necessaria: il coin-volgimento del cittadino nella gestione della pro-pria salute (patient empowerment) e la delega di unruolo attivo nel processo di cura (self-care).Le applicazioni di Sanità elettronica (eHealth) pos-sono supportare tale paradigma, mettendo a dis-posizione del cittadino strumenti tecnologici chelo aiutino e lo accompagnino nella gestione del-
la propria salute nella vita di tutti i giorni, con fa-cilità, attraverso vari dispositivi (computer, smart-phone, televisione, ecc.), ovunque esso si trovi (ca-sa, lavoro, ferie) e nel momento del bisogno (per-vasive e-care).L’importanza di Internet e delle applicazioni disanità elettronica per implementare le policies dipatient empowerment è stata recentemente oggettodi uno studio in ambito europeo1. L’utilizzo sem-pre più massiccio di Internet ha aperto nuovi sce-nari nei quali il cittadino/utente assume una nuo-va centralità rispetto all’accesso e alla gestione del-le proprie informazioni sanitarie disponibili informato elettronico. Uno dei più interessanti ri-guarda l’utilizzo di una piattaforma di servizi co-struiti esplicitamente per gli obiettivi del cittadi-no/paziente, comunemente chiamati PersonalHealth Records (PHR) e fondati sulla tecnolo-giaWeb-based2.Un sistema PHR (Personal Health Record) si di-stingue in primo luogo dai precedenti sistemi in-formativi sanitari (es.EMR:Electronic Medical Re-cord) per il capovolgimento dei termini della rela-zione paziente/cittadino-sistema sanitario nel suocomplesso. In un certo senso la prospettiva PHRmette in luce le potenzialità che i cittadini/pazientipossono rappresentare per la costruzione di un si-stema sanitario sempre più efficiente ed efficace.
P.A.TRENTOCartella Clinica del Cittadino-TreC:uno strumento per l’empowerment
di Luciano Pontalti*, Diego Conforti*, Enrico Piras**, Stefano Forti**
*Servizio Organizzazione e Qualità delleAttività Sanitarie,Assessorato alla Salute e Politiche Sociali,ProvinciaAutonoma diTrento**Fondazione Bruno Kessler (FBK) - Povo (TN)
1 Patient Empowerment. Report on Priority Topic Cluster 2.Towards the Establishment of a European Research Area, March 31, 2007.2 Connecting Americans to their Healthcare. Final Report, July 2004, Markle Foundation (www.connectingforhealth.org/resources/wg_eis_final_report_0704.pdf).

Uno dei concetti chiave della PHR è che i citta-dini/pazienti possono non solo dotarsi di stru-menti che, sfruttando le potenzialità di Internet,consentono loro di avere accesso continuo ai pro-pri dati sanitari, ma anche di divenire essi stessi‘produttori’ di informazioni e/o di integrazionitra dati sanitari diversi.Infatti, l’utilizzo crescente di dispositivi perl’auto misurazione in ambito domestico hacontribuito considerevolmente all’aumento diinformazioni sanitarie prodotte dai cittadinistessi. Fino a poco tempo fa, il termometro eral’unico strumento medico posseduto dai citta-dini. Oggi, nelle case, si possono incontraresempre più frequentemente misuratori di pres-sione, glucometri, spirometri (per fare soloqualche esempio), ausili per la gestione di pa-tologie croniche o per il monitoraggio di para-metri vitali che richiedono particolare atten-zione. Accanto a questi, poi, sono divenuti sem-pre più accessibili strumenti utilizzati nelle at-tività del tempo libero come i cardiofrequen-zimetri, pedometri oppure strumenti per ilcontrollo del proprio equilibrio biologico co-me le bilance automatizzate, tutti strumenti chepermettono di tenere traccia e di interveniresugli stili di vita e anzi che prevedono la rea-lizzazione di veri e propri diari personali di sa-lute.Queste potenzialità offerte dalle nuove tecnolo-gie sono in linea con i più recenti orientamentidelle istituzioni sanitarie del mondo occidenta-le che considerano fondamentale l’educazione el’empowerment del cittadino per il manteni-mento e la gestione della propria salute e benes-sere.
IL PROGETTO CARTELLA CLINICA DELCITTADINO-TreCLa Provincia autonoma diTrento, nell’ambito del-le proprie politiche di sviluppo del sistema sani-tario ed in un’ottica di valorizzazione della cen-tralità del cittadino, sta promuovendo un model-lo integrato di innovazione attraverso l’imple-
mentazione e lo sviluppo di una serie di iniziati-ve e azioni di eHealth.In particolare, ha avviato un progetto per l'intro-duzione della Cartella Clinica del Cittadino(TreC), che si propone di fornire ai cittadini unapiattaforma di servizi online per accedere, con-sultare, condividere e aggiornare i propri docu-menti sanitari tramite l’uso di un portale inter-net. Offrire ai cittadini uno strumento sempliceche consenta loro di “raccogliere e generare in-formazioni” sulla propria salute e cura e di en-trare in “connessione” sia con gli operatori deiservizi sanitari che con gli altri cittadini, è unobiettivo fondamentale per favorire un coinvol-gimento più attivo del paziente nella gestione del-la propria cura.TreC vuole rappresentare un’opportunità per mi-gliorare la qualità della cura dei cittadini trentinie nel contempo per accelerare l’uso delle tecno-logie dell’informazione e comunicazione in uncontesto di “e-society” e “e-inclusion” in cui ilcittadino è posto al centro del processo di inno-vazione dei servizi basati su tecnologie dell’in-formazione e della comunicazione (Fig. 1)TreC rappresenta quindi il sistema informativodel cittadino integrato con i sistemi informativisanitari degli operatori coinvolti nell’erogazionedi servizi sanitari (Fig. 2).In una prospettiva di lungo termine, questo siste-ma assume la filosofia dell’empowerment del cit-tadino, cioè vuole contribuire alla crescita del-l’autonomia e della consapevolezza delle perso-ne, al fine di poter presidiare tutto il processo digestione della cura e della salute. Questa è la sfi-da ultima del progettoTreC: divenire un sistemainformativo capace di far maturare le persone sulpiano della corresponsabilità per ciò che riguar-da i propri destini di salute.L'attività del cittadino/paziente nel processodi cura può essere ricondotta a cinque macro-ambiti:� la gestione delle informazioni sanitarie perso-nali;
� la gestione condivisa della salute e cura con la
IL SISTEMA SANITARIO E L’EMPOWERMENT
56
IQU
AD
ERN
IDI

P.A.Trento - Cartella Clinica del Cittadino-TreC: uno strumento per l’empowerment
propria famiglia;� la gestione condivisa della salute e cura con glioperatori sanitari;
� la gestione della propria salute con altri gruppidi cittadini;
� il contributo alla salute pubblica.
Nel dettaglio si possono identificare almeno tredimensioni rilevanti:�TreC come Libretto sanitario elettronico.Il sistema garantirà l’accesso alla documentazio-ne clinica prodotta dalle strutture sanitarie pro-vinciali. Referti, esami di laboratorio, lettere di
57
IQU
AD
ERN
IDI
FIGURA 1 - Pagina principale del sistema TreC
FIGURA 2 - TreC Sistema informativo integrato del cittadino

IL SISTEMA SANITARIO E L’EMPOWERMENT
58
IQU
AD
ERN
IDI
dimissione, ecc., attualmente disponibili al cit-tadino in formato cartaceo, tramite TreC po-tranno essere sempre disponibili attraverso in-ternet ed eventualmente scaricabili su una me-moria portatile (es. una chiavetta USB).
�TreC come Diario della Salute.Tramite ilportale i cittadini potranno inserire dati relativialla propria condizione di salute, per tenere trac-cia dell’evolvere di una patologia (es. una ma-lattia cronica) o di una condizione di interesse(es. attività fisica e dieta) o, più semplicemente,per avere una lista sempre aggiornata dei medi-cinali assunti.Questi dati potranno, a discrezio-ne del cittadino, essere condivisi con i proprimedici.
�TreC come nuovo canale di comunica-zione con i medici e le istituzioni sanita-rie. Il sistema permetterà ai cittadini di inter-facciarsi elettronicamente con gli operatori sa-nitari. A seconda delle esigenze TreC potrà es-sere, ad esempio, la piattaforma di comunica-zione in tempo reale di parametri vitali per unmonitoraggio remoto, un sistema di messaggi-stica protetta con i propri medici o un canaleper ricevere informazioni personalizzate da par-te delle istituzioni sanitarie.
I destinatari di TreCI principali destinatari del progettoTreC sono tut-ti i cittadini del territorio della provincia diTren-to. Il sistema prevede tuttavia il coinvolgimentodegli operatori delle istituzioni sanitarie dell’A-zienda Provinciale per i Servizi Sanitari e succes-sivamente anche degli operatori delle strutturesanitarie private. L’adesione a TreC da parte deisingoli sarà assolutamente libera e volontaria.Il progetto si inserisce in una visione di e-inclu-sion ed ha quindi l’obiettivo di creare le condi-zioni affinché il sistema sia accessibile ad ogni cit-tadino, indipendentemente dal proprio livello dietà, sesso, istruzione e dalle proprie competenzeinformatiche.Questo obiettivo richiede una par-ticolare attenzione per gli aspetti di accessibilitàe usabilità attraverso l’utilizzo di interfacce uten-
te molto semplici, tecnologie touch screen, e diogni altro dispositivo che possa facilitare la piùampia accessibilità del sistema. Sul piano tecno-logico il sistema TreC dovrà essere multipiatta-forma e cioè raggiungibile via Internet, telefonocellulare,TV digitale, ecc.
Un progetto di sistemaLa gestione del progetto è condivisa tra Provin-cia Autonoma diTrento,Azienda Provinciale peri Servizi Sanitari di Trento, Fondazione BrunoKessler – FBK.TreC è un progetto di ricerca e innovazione in-ter-disciplinare e inter-istituzionale che prevedeil diretto coinvolgimento dei cittadini e delle As-sociazioni e Comitati dei Cittadini anche nellafase di progettazione e sviluppo del sistema (ap-proccio user-centered). Prevede inoltre la parte-cipazione della Pubblica Amministrazione, degliOrdini delle professioni sanitarie, delle Istituzio-ni di ricerca, del mondo delle imprese private.
DESCRIZIONEDI POSSIBILI SCENARIDI UTILIZZO DI TreCClaudia, giovane mamma del piccolo LucaUn figlio ti cambia la vita. Se ripenso a quello cheè successo da quando sono rimasta incinta, la cosache mi stupisce di più è la quantità di tempo da de-dicare alla salute. Sono sempre stata molto attiva,sport fin da bambina, corsa, nuoto e mai un proble-ma e pochissime medicine. Per me il medico non esi-steva. Da quando aspettavo Luca, invece, ho scoper-to un mondo. Ecografie, analisi, telefonate anche so-lo per un consiglio. E poi l’ospedale, il parto, la scel-ta di un pediatra, i bilanci di crescita, le piccole/grandimalattie dei bimbi. Insomma, davvero un mondo sco-nosciuto. Impari a capire quanto sia importante. Pe-rò poi ti rendi conto di quanto tempo ci voglia perstare dietro a tutto.Da quando ho attivatoTreC per me e per il mio Lu-ca alcune cose sono diventate più semplici e veloci.Adesempio, è molto comodo ricevere direttamente sul com-puter i risultati delle mie analisi invece di andare a ri-

P.A.Trento - Cartella Clinica del Cittadino-TreC: uno strumento per l’empowerment
59
IQU
AD
ERN
IDI
tirarli in clinica. E poi sono tutti lì sul computer, nonoccupano più spazio in casa. E per me che sono abi-tuata a passare ore davanti al Pc è molto più rapidorisistemarli.Nel tempo, poi, sono diventata più attentaa tenere sott’occhio alcuni parametri ed è molto edu-cativo fare dei grafici e delle tabelle sull’andamento delcolesterolo, come mi ha consigliato il medico.Ti dà lasensazione di avere le cose sotto controllo.Poi, quello che ti fa apprezzare TreC è che ti seguenelle attività quotidiane.Ad esempio, la settimana scor-sa ho fissato la visita annuale di controllo dalla gine-cologa con il Cup e immediatamente l’appuntamen-to è apparso sul calendario della miaTreC e automa-ticamente anche sulla mia agenda. Così vedo tutti imiei impegni, da casa, dal lavoro o anche sul cellula-re ho dei promemoria che mi ricordano le scadenze im-portanti.Però è soprattutto per Luca cheTreC mi è davvero in-dispensabile. Da quando io e mio marito Stefano ab-biamo scoperto che il bimbo ha un’allergia ai pollini,siamo diventati molto più attenti a molte cose. Ogniprimavera è una stagione a rischio e solo con la pre-venzione siamo sicuri che Luca potrà stare sereno e
non avere attacchi d’asma. In caso di emergenza sap-piamo come usare il ventolino ma fortunatamente nel-l’ultimo periodo non ne abbiamo avuto bisogno.Quan-do sta per arrivare la stagione della fioritura dei pol-lini, iniziamo a misurare il picco di flusso di Luca esegnaliamo i valori sullaTreC di Luca (Fig. 3).Ognisettimana, poi, si tratta solo di compilare dei brevi que-stionari; segniamo se Luca ha difficoltà a respirare, seriposa bene e tutte quelle piccole informazioni che pos-sono aiutare il pediatra a scegliere il dosaggio del far-maco e quando iniziare la terapia preventiva. Sonopoche informazioni ma è sorprendente vedere che Lu-ca sta meglio di prima anche se prende meno farmacie per meno tempo!Certo, è bello avere tutti i dati di Luca sempre a dis-posizione. Ma quello che ci rassicura è sapere che ilpediatra può leggere giorno per giorno i dati di Lucae vedere se qualcosa non va. Perché una cosa siamonoi, con le nostre conoscenze, una cosa è il medico checonosce Luca fin da quando è nato e lo segue da sem-pre. Ecco, sapere che in ogni momento il suo sistemalo può avvisare di un valore fuori posto è molto im-portante, anche solo per andare alla visita qualche gior-
FIGURA 3 - Diario dell’asma

no prima dell’appuntamento.Ti senti come se non fos-si sola.TreC è il nostro punto di partenza per capire meglioil problema di Luca. Dopo la diagnosi abbiamo sen-tito amici, letto libri e cercato su Internet. E non sem-pre sai se puoi fidarti di quello che ti dicono e che leg-gi. Oggi, con i link selezionati dal medico, sappiamodove andare a cercare informazioni sicure.Tra l’altroTreC ti permette di avere anche informazioni ag-giornate su quello che ti può servire e a cui non avre-sti pensato.Ad esempio, nella pagina di Luca c’è sem-pre l’indicazione del livello dei pollini e un allarmepersonalizzato, così sappiamo quando metterci in mo-to per iniziare la prevenzione o quali zone è meglioevitare per una gita. Ma la cosa più importante pernoi è vedere che anche Luca inizia ad usare la suapagina dei giochi suTreC. Come si fa a spiegare adun bambino della sua età che cosa è l’asma? Eppu-re è un problema che non puoi trascurare perché le al-lergie te le porti dietro per tutta la vita e devi impa-rare prima possibile a farci i conti.Certo non può met-tersi a leggere.A me non piacciono tanto i giochi percomputer e all’inizio è stato strano aiutarlo a gioca-
re… ma i giochini sono molto simpatici e vedo cheinizia a capire.E poi, vuoi mettere? Prima si portava con sé la tesse-ra sanitaria e il libretto pediatrico di Luca.Adesso puoipartire per una vacanza e avere sempre con te i tuoidati sanitari, dovunque vai (Fig. 4). Basta una chia-vetta o il cellulare ed è tutto lì, dovunque tu sia.Unabella comodità. Certo, speri sempre che non ti serva-no mai ma, in caso di emergenza, sempre meglio ave-re dietro qualcosa.
Claudia, donna di 40 anniA quarant’anni le cose cambiano.Tutta una serie dicose a cui non avevi dato importanza diventano….come dire… da tenere sotto osservazione. Mia ma-dre ha avuto dei problemi di noduli al seno, quandoaveva circa quest’età, e con il mio medico abbiamo de-ciso di fare dei controlli ogni due anni, per sicurezza.La vicenda di Luca, poi, mi ha insegnato quanto siaimportante saper gestire da soli alcune misurazioni esoprattutto tenere traccia dei farmaci che si assumo-no. UsareTreC è diventata un’abitudine.Tutto quel-lo che prima mi segnavo su un quadernetto per par-
IL SISTEMA SANITARIO E L’EMPOWERMENT
60
IQU
AD
ERN
IDI
FIGURA 4 - Dati di emergenza

larne col medico, oggi lo scrivo lì (Fig. 5). Non sem-pre, eh? Solo quando penso che possa essere impor-tante. Un periodo mi ero fissata che volevo dimagri-re e mi segnavo tutto quello che mangiavo, poi c’è sta-to il trip dello sport e mettevo dentro quante vaschefacevo in un’ora di nuoto… sono quelle cose che faiper te stessa, non le condividi con il medico, ma sonoimportanti per me.E comunque, ormai, tutti i medici usano il computere hanno una cartella clinica digitale: scrivono le ri-cette, ricevono gli esami, si segnano le loro note. Infondo, come serve a loro per tenere traccia di quelloche fanno con i pazienti, così TreC serve a me peraiutare a ricostruire quello che mi è successo.Ancheperché, ogni medico ha solo una parte della tua sto-ria; se lo cambi, quando vai in ospedale o da uno spe-cialista questi hanno solo piccoli pezzi di tutto quel-lo che hai fatto.La cosa che mi piace di più, comunque, è che conTreCti tieni in contatto, risparmi tempo e sei sempre infor-mata sulle cose che sono importanti per te. Come nelcaso dei noduli al seno: quando ne ho parlato con ilmio medico, lui mi ha inserito nel programma di scree-
ning. Ora non devo fare nulla, sono loro che si preoc-cupano di avvisarmi quando devo fare la visita. E gliavvisi arrivano solo a chi devono arrivare…A quel punto devi solo confermare la prenotazionecon il Cup. E oramai faccio tutto via internet. Così,quando sono a casa posso vedere un calendario sem-pre aggiornato dei miei appuntamenti. E sul mio cel-lulare ho sempre degli avvisi che mi ricordano le sca-denze e come prepararmi prima degli esami.Io e il mio medico riceviamo assieme il referto. Io loleggo da me e per adesso non ci sono mai stati pro-blemi… poi però aspetto che sia lui a dirmi che vatutto bene. Io gli ho concesso l’accesso ai dati sulla miastoria familiare. Così ha un elemento in più per farei suoi ragionamenti. Di solito entro pochi giorni rice-vo la sua mail. Sono solo due righe… ma prima persapere cosa pensava dovevo prendere un appuntamento,uscire dal lavoro prima e prendere un permesso….Molto meglio così, no?
Claudia, donna di 50 anni si prende cura,con i fratelli, del padre anzianoPapà è sempre stato una persona che tiene molto alla
P.A.Trento - Cartella Clinica del Cittadino-TreC: uno strumento per l’empowerment
IQU
AD
ERN
IDI
61
FIGURA 5 - Osservazioni personali

propria indipendenza. Quando è rimasto solo, si èrimboccato le maniche ed è andato avanti senza pro-blemi per anni.Negli ultimi tempi, però, la sua salu-te non è più quella di una volta e noi figli abbiamoiniziato ad organizzarci per aiutarlo.Non che non siaautonomo, ma le medicine le deve prendere e la suamemoria non è più quella di un ragazzino.Prima teneva sulla credenza un foglietto con il do-saggio del medicinale e qualche volta non ricordava selo avesse preso o no.Allora gli abbiamo messo in cu-cina una “scatoletta intelligente”. C’è un cassettinoper ogni giorno e, dentro ogni cassetto, c’è solo la quan-tità di medicine che deve prendere.Ogni domenica c’èuno di noi che gli prepara quello che gli serve per lasettimana e lo registra sulla suaTreC. La sua è dav-vero molto semplice.A dire la verità, è una cornicettaelettronica che si attiva al tocco.Quando arriva il momento di prendere il farmaco, pa-pà viene avvisato da un BIP e da una lucina che siaccende sulla scatoletta, prende la pillola e tocca loschermo… in questo modo non si dimentica più del-le sue medicine. E se le dimentica, può controllare fa-cilmente sullo schermo… E anche noi, da casa o con
il cellulare, possiamo controllare che non si dimentichila pillola. Cosi lui è più autonomo e noi siamo piùsereni (Fig. 6).Ormai capita poche volte… ma quando si dimenticadelle sue medicine, riceviamo un sms che ce lo segna-la. A quel punto basta una telefonata e… il gioco èfatto! Con la sua malattia non si scherza… basta chesi dimentichi per qualche giorno e potrebbe essere ne-cessario il ricovero.La cosa che ci rende più tranquilli, però, è vedere co-meTreC abbia cambiato il modo in cui papà affron-ta la malattia. Prima, al massimo prendeva le medi-cine. Adesso, dopo che dall’ospedale l’hanno inseritoin un programma di monitoraggio a distanza, è di-ventato molto più attento. Innanzitutto si pesa tuttele mattine. Poi, ogni tanto gli mandano un piccoloquestionario di autovalutazione. Questi dati arriva-no al medico dell’ospedale, che ha accesso a tutte leinformazioni su papà. In caso di qualche problema,con tutti i dati davanti, è facile per loro capire se sitratti di qualcosa di importante e contattare subito sialui che noi.E poi è una bella comodità, per noi, essere avvisati
IL SISTEMA SANITARIO E L’EMPOWERMENT
62
IQU
AD
ERN
IDI
FIGURA 6 - Cruscotto medico

delle cose da fare per la salute di papà.Ad esempio,quando arriva la stagione brutta, ti ricordano del vac-cino anti-influenzale: alla sua età è meglio farlo, perevitare complicazioni. Il nostro medico ha segnalatosulla TreC di papà quali sono i suoi problemi e cosìveniamo avvisati solo per quelle campagne di preven-zione che lo riguardano da vicino. E da poco ha sco-perto, sempre su segnalazione del nostro medico, unpiccolo modo per contribuire.Quando ha avuto la feb-
bre il medico gli ha mostrato come segnalarlo alla suaTreC, che ti mostra subito una mappa della regionenella quale vedi dove sono attivi i focolai di influen-za (Fig. 7).Sergio fa regolarmente le visite con il suo medico; i da-ti sanitari raccolti sono tanti e sempre aggiornati; inquesto modo la sua malattia è ben gestita. Sergio è se-reno, i suoi figli sono tranquilli e il suo medico è sod-disfatto.
P.A.Trento - Cartella Clinica del Cittadino-TreC: uno strumento per l’empowerment
63
IQU
AD
ERN
IDI
FIGURA 7 - Vigilanza epidemiologica

POLITICHE ESTRATEGIE REGIONALI

IL SISTEMA SANITARIO E L’EMPOWERMENT
66
iQua
dern
idi
Clinical governance è l’espressione chesintetizza nel Sistema sanitario na-zionale regionale e locale l’unionedelle tre fondamentali dimensioni del-
la qualità: qualità professionale, qualità percepita (chepuò differenziarsi fortemente dalla prestazione ri-cevuta), qualità gestionale-organizzativa.L’obiettivo principale della Clinical governanceè costituire un ambiente che favorisca l’eccellen-za professionale, basato sulla comunicazione effi-cace, sulla fiducia reciproca fra professionisti del-l’organizzazione orientati al lavoro di gruppo ealla multiprofessionalità.Clinical governance sottolinea pertanto la valen-za della dimensione professionale più che di quel-la monetaria che pone attenzione esclusivamen-te al controllo della spesa.Il raggiungimento di migliori livelli di qualità di-pende, pertanto, da una visione sistemica dellaqualità, data dalla combinazione di tre ambiti disviluppo riguardanti:� il paziente/utente/cliente/cittadino attraversol’empowerment;
� il comportamento degli operatori socio-sanita-ri valorizzando le performance professionali;
� l’organizzazione del sistema attraverso l’elabo-razione di strategie aziendali per il nuovo asset-to dei servizi, tramite la Formazione permanente,la Ricerca e Progetti di innovazione.Il processo di empowerment assume la centralità
dei cittadini nel sistema favorendone l’acquisi-zione di conoscenze, la crescita di capacità di par-tecipazione attiva, per conseguire risultati che nemigliorino l’esistenza.Lo stile comportamentale degli Operatori favo-risce l’empowerment dei cittadini.L’accoglienza delle persone nei Servizi socio-sani-tari è il primo grande momento di comunica-zione e di rispetto; rassicura sulla risposta al biso-gno di salute evitando l’insorgenza di meccani-smi di difesa.Il colloquio professionale, pertanto, deve creareun’atmosfera di sostegno collaborativo basatosulla centralità della persona. L’interazione fraAziende sanitarie e cittadini deve essere un pre-supposto codificato nell’Atto aziendale di cia-scuna Asl.Per tale finalità gli operatori devono essere pre-parati all’autodiagnosi delle proprie capacità emo-zionali espresse e delle resistenze che creano ri-serve mentali, analizzando la propria posizione,che può essere conservatrice o temporeggiatriceo anticipatrice ovvero esprimere un atteggiamentodi equilibrio fra le tre attitudini.Valorizzando leproprie qualità individuali, gli operatori modifi-cano anche il potenziale gruppale dei comporta-menti evitando di essere prigionieri di situazioniconflittuali e di dinamiche di sopraffazione.La consapevolezza che il clima gruppale lavorati-vo è determinato da una leadership democratica più
REGIONE ABRUZZOLo stile comportamentaledegli operatori del sistema sanitarioper favorire l’empowerment dei cittadini
di LorettaTobia*, Fabio Forgione**
*Dirigente della Direzione Regionale Politiche della Salute,Referente della Comunicazione Istituzionale - RegioneAbruzzo**Agenzia Sanitaria Regionale ASRAbruzzo - Referente Comunicazione Istituzionale/Audit civico

che da quella autoritaria e/o laisser faire, favori-sce l’empowerment del cittadino, target protago-nista dell’intervento professionale quotidiano.Si evidenzia la necessità che le competenze sca-turiscano dall’interazione coerente fra l’identitàpersonale e l’identità professionale degli operato-ri che, come è noto, sono figure storiche e/o fi-gure nuove dell’organizzazione sanitaria quali,Medici – Infermieri – Tecnici Sanitari,Tecnicidella Riabilitazione e della Prevenzione – Edu-catori – Operatori Socio-Assistenziali – Ammi-nistrativi.Il metodo del counseling/nursing nel colloquio con i pa-zienti/utenti indica agli operatori di evitare la presun-zione, il linguaggio estremamente tecnico, il falso otti-mismo, il pessimismo colpevolizzante, l’escalation del-la difensiva, la totale dipendenza lamentosa, di consi-derare le caratteristiche della persona come accessorie al-
la cura, di causare frustrazioni, di utilizzare soluzionicomunicative preconfezionate.Rinforzando nel contempo l’autostima profes-sionale e personale degli operatori si praticano re-gole comportamentali contro lo stress e la burnout syndrome che minano l’organizzazione dei ser-vizi dalle fondamenta.Investire in professionalità, implementando un ef-ficace metodo di responsabilizzazione, costituiscela più alta forma di Clinical governance per la ra-zionalizzazione delle risorse a disposizione del Si-stema Socio-Sanitario per dare risposte di salutepsico-fisica ai cittadini resi protagonisti consape-voli di quanto hanno a disposizione (Leggi qua-dro dello Stato italiano a partire dalla Legge diRiforma Sanitaria n. 833/1978, dal D.Lgs.n.502/1992 e dal D.Lgs n.229/1999 e loro mo-dificazioni ed integrazioni).
Regione Abruzzo. Lo stile comportamentale degli operatori per favorire l’empowerment dei cittadini
67
IQU
AD
ERN
IDI

IL SISTEMA SANITARIO E L’EMPOWERMENT
68
iQua
dern
idi
Alivello comunitario si parla di empo-werment quando si fa riferimento al-l’attivazione dei cittadini in relazionealle strutture sociopolitiche e allo svi-
luppo delle loro capacità di incidere sulle trasfor-mazioni sociali (Perkins & Zimmerman, 1995)(cfr. Dallago, 2006).La prospettiva che qui assumiamo è pertanto quel-la della comunità locale, soffermandoci sulle mo-dalità che questa ha a disposizione per prendersicura dei problemi che la coinvolgono.Detto in altri termini, il compito o, se si preferi-sce, la sfida è quella di realizzare una “comunitàcompetente” (Nicoli e Zani, 1998).Una comunità è definita competente quando lepersone e i gruppi che la compongono:a) possiedono le conoscenze adeguate sui proble-mi e su come e dove reperire le risorse per af-frontarli;
b) sono motivati ad agire e hanno fiducia nelleproprie capacità (autostima);
c) hanno potere, inteso come repertorio di pos-sibilità e di alternative considerate valide perintervenire.
Le strategie di sviluppo di comunità assumonoche la comunità abbia in sé le conoscenze, le ri-sorse e il potenziale organizzativo e di leadershipper realizzare un cambiamento costruttivo a li-vello comunitario. Gli obiettivi di tali strategie
sono perciò indirizzati a:�creare un senso di coesione sociale;� sensibilizzare i cittadini sulle problematiche piùrilevanti della comunità e a proporre mete co-muni di azione;
�utilizzare le competenze dei professionisti edesperti per sostenere ed incrementare la parte-cipazione, la cooperazione, le esperienze di au-to mutuo aiuto;
�promuovere le capacità dei responsabili locali edei leader informali;
�contribuire al coordinamento tra i servizi, i mo-vimenti di opinione e i gruppi sociali.Interessanti sono le definizioni date dagli autoriche più di altri costituiscono punto di riferimentonella letteratura di questo settore.Tra i primi figurano Iscoe e Harrison (1984), cheidentificano tre fattori alla base di comunità daloro definiti competenti:a) il potere di generare opportunità ed alterna-tive;
b) la coscienza di come ottenere risorse di variogenere, cioè la presenza di strumenti necessariper risolvere un problema;
c) l’autostima che si evidenzia in termini di or-goglio, ottimismo e motivazione.
Zimmerman (2000) evidenzia che una comunità èempowered se prevede spazi adeguati affinché i sin-goli possano esprimere le loro competenze, eser-
EMPOWERMENT DI COMUNITÀ:GLI ORIENTAMENTI IN REGIONEEMILIA ROMAGNA
di Maria Augusta Nicoli*, Marco Biocca*,Antonio Brambilla**, Sara Capizzi*, Bianca Maria Carlozzo*,AnnaMarcon***, FrancescaTerri*
*Agenzia sanitaria e sociale regionale Regione Emilia Romagna**ServizioAssistenza distrettuale,medicina generale,pianificazione e sviluppo dei servizi sanitari,Direzione Sanità e Politiche Sociali***Dottore di ricerca in psicologia sociale

citare le diverse forme di controllo e accedere li-beramente alle risorse esistenti (dimensione delcontrollo). In aggiunta, dovrebbe essere capace diriflettere sui problemi sociali e politici esistenti,di identificare le necessità, stabilire gli obiettivi eidentificare le strategie per raggiungerli (dimen-sione della consapevolezza critica). Ciò è possi-bile solo in presenza di una struttura di governopartecipativa, che accetta e rispetta le diversità, fa-vorisce lo scambio e il confronto tra i cittadini elo sviluppo di coalizioni e reti tra le diverse or-ganizzazioni e agenzie del territorio (dimensio-ne partecipativa).Una comunità può divenire empowered graziead interventi che attraverso forme diverse, comel’educazione civica, favoriscano la partecipazionedei cittadini all’analisi dei problemi esistenti, aiprocessi di problem solving e alle conseguenti ini-ziative intraprese per garantire il rispetto della de-mocrazia e dei diritti civili.Attraverso queste di-verse azioni si auspica che una comunità acqui-sisca maggior controllo, maggior comprensionecritica e partecipazione effettiva.Da tale concettualizzazione diversi sociologi han-no preso una certa distanza (cfr Laverack, 2001)in quanto ritengono che sia difficile renderla ope-rativa. Come risposta, hanno proposto 9 dominioperativi: partecipazione, leadership, strutture or-ganizzative, valutazione dei bisogni e dei proble-mi, mobilitazione delle risorse, chiedersi il per-ché, legami con persone e organizzazioni, agen-ti esterni, gestione dei progetti.Tali domini possono essere definiti come aree diinfluenza che portano gli individui o i gruppi adorganizzarsi e mobilitarsi verso dei cambiamentisociali e politici (Jackson, Mitchell, &Wright,1989; Labonte, 1990; Laverack, 2001, 2006). Essiforniscono una guida per gli operatori definen-do delle aree specifiche sulle quali agire per pro-muovere l’empowerment di comunità.È solo agendo su questi nove domini operativiche secondo Laverack si agisce nell’ottica dellapromozione dell’empowerment della comunità.Un aspetto significativo che è stato ripreso più
recentemente si riferisce agli interventi volti adincrementare il senso di comunità, intendendocon ciò un dato soggettivo basato sulla percezio-ne della qualità delle relazioni interpersonali al-l’interno di un contesto specifico, sul riconosci-mento della interdipendenza con gli altri, sulladisponibilità a mantenere questa interdipenden-za offrendo o facendo per gli altri ciò che ci siaspetta da loro.Accrescere il senso di comunitàporta i membri a saper affrontare eventi impor-tanti, sviluppando solidarietà di fronte ai perico-li e alle difficoltà, in alcuni casi incrementandoanche forme di controllo sociale alternative a quel-le tradizionali.In questa ottica i problemi sociali, variamente con-notati (svantaggio culturale, disagio psichico, emar-ginazione) non sono più considerati di pertinen-za esclusiva dei professionisti/tecnici, ma vengo-no ridefiniti come responsabilità dell’intera co-munità.
GLI ORIENTAMENTI REGIONALI:LA COMUNITÀ “AL CENTRO”Nel Piano sociale e sanitario 2008-2010 il ri-chiamo alla comunità come punto di riferimen-to delle policy è costantemente presente.Tale ri-chiamo può essere ricondotto a due necessità difondo.In primo luogo c’è la necessità di ricomporre lacontrapposizione di processi che vedono da unaparte il sistema sanitario che rafforza i criteri diselettività e quindi di contenimento dell’azionedi cura/assistenza, dall’altra il sistema informaledi cura che è fortemente compromesso dalle tra-sformazioni socio-economiche in atto e dall’af-fievolirsi delle reti sociali che fungevano da so-stegno sociale comunitario. Paradossalmente inun’epoca di maggiore “bisogno” (si sta andandoverso un incremento delle patologie croniche) ilsistema formale delle cure “restringe ed affina” ipropri ambiti di intervento e il sistema informaleè sempre più carente di risorse proprie per farfronte alle nuove emergenze di cura e di assi-stenza (Nicoli, 2003). Come rileva in un recen-
Empowerment di comunità: gli orientamenti in Regione Emilia Romagna
69
IQU
AD
ERN
IDI

te articolo Hunter D.J. (2008) “Health needs mo-re than health care”, ovvero la consueta lettura inchiave individuale dei bisogni di salute va oggirivista e soprattutto si dovrebbe aprire un dialo-go serrato nella comunità, per ri-negoziare leforme della cura e promuovere nuove forme dipresa in carico, a partire dalle specificità e com-plessità della contemporaneità.A questo propo-sito, come sostenuto in un precedente contri-buto (Nicoli,Cinotti, 2008), le diverse forme cheun’organizzazione sanitaria mette in campo perascoltare i cittadini sono fondamentali se costi-tuiscono momento di apprendimento per la stes-sa organizzazione, se rappresentano percorsi per“imparare a pensare nell’organizzazione” (Fab-bri, 1998).In definitiva, attivare percorsi di partecipazione,di coinvolgimento e di ascolto dell’altro, in que-sto caso del cittadino rispetto all’organizzazione,diventa vitale per le sfide che ci attendono: in ge-nerale rispetto alla definizione delle politiche(quali dovrebbero essere i nuovi patti di solida-rietà, di integrazione tra sistemi formali ed in-formali ecc.) ed, in particolare, alla programma-zione dei servizi.Per poter comunque attivare tali percorsi occor-re aver chiaro che si tratta di processi in cui è be-ne attrezzarsi per reggere il conflitto, la discussio-ne aperta con l’altro, per creare le condizioni omeglio gli spazi in cui il rapporto di fiducia reci-proco può consentire il dialogo e il confronto.In secondo luogo vi è la necessità di superare ilcarattere di occasionalità che ha caratterizzato l’e-
sperienza in questi anni, andando verso l’identi-ficazione di luoghi-forme dell’interazione tra isti-tuzioni e cittadini, a carattere permanente (Pelle-grino, 2009). La sfida è quella di ideare tali “for-me e luoghi”, per collocare (e integrare, sosti-tuendoli) tutti i micro progetti di ‘comunicazio-ne’, di ‘ascolto’, di ‘co-progettazione’ tra istitu-zioni e cittadini che oggi stanno prendendo spa-zio crescente nelle scuole e nei servizi (una verae propria moda) conservando però un carattere di“spot”, senza incrementare davvero il capitale so-ciale della comunità, la sua capacità di vedersi nel-l’insieme e di definirsi come ‘interazione tra par-ti-gruppi’.In altre parole, gli indirizzi progettuali dovrebbe-ro con forza virare da una impostazione che con-sidera la comunità come“bacino di utenza”ad unavisione della comunità come “attore sociale”.In questa ottica, sono state prese in considerazio-ne, all’interno del progetto promosso da Agenas,iniziative che avessero più di altre le caratteristi-che riportate in tabella 1.In particolare, le azioni identificate e realizzate alivello regionale in ambito sanitario sono ricon-ducibili a due tipologie di azione:�azioni di advocacy: fare ascoltare la propria vo-ce in contesti di condivisione che presuppon-gono partecipazione attiva di cittadini, profes-sionisti, al fine di realizzare un progetto o unamission, come ad esempio i movimenti di di-fesa, pressione e stimolo dei diritti del malatoverso le istituzioni sanitarie, oppure le reti diospedali che cooperano per realizzare e im-
IL SISTEMA SANITARIO E L’EMPOWERMENT
70
IQU
AD
ERN
IDI
TABELLA 1 - Elementi che caratterizzano un orientamento di comunità come “bacino di utenza”versus un orientamento di comunità come “attore sociale”
comunità come bacino di utenza vs comunità come attore sociale• Bisogno/problema• riceve/consuma• popolazione come utenza• il centro è il servizio• potere come potere d’acquisto• dipendenza/passività• non responsabilità• identità eterodefinita
• Risorsa/capacità• agisce/partecipa• popolazione come insieme di cittadini attivi• il centro è la comunità• potere come potere di produzione• autonomia/autodetermina• responsabilità• identità autodefinita

plementare pratiche di umanizzazione dell’as-sistenza;
�partecipazione al governo locale della comunità: crea-zione di spazi pubblici di prossimità che, attra-verso processi/strumenti di governo locale ca-paci di coinvolgere i cittadini e le organizzazio-ni, partecipino alle scelte in merito a problemi,bisogni, domande di salute, come ad esempio iPatti di solidarietà o Forum di cittadini, o a spe-cifiche fasi di programmazione, come ad esem-pio i Piani per la Salute.
EMPOWERMENT “DI COMUNITÀ”Nel rapporto curato dall’Oms1 What is the evi-dence on effectiveness of empowerment to improvehealth? si evince che le iniziative di empower-ment possono accrescere gli esiti in termini disalute e che l’empowerment costituisce una stra-tegia fondamentale per un sistema di sanità pub-blica.Storicamente, la Regione Emilia Romagna hafortemente sostenuto azioni e buone pratiche im-prontate all’empowerment e, nella fase attuale, gliorganismi regionali stanno compiendo un note-vole sforzo nella direzione di portare a sistemal’esperienza acquisita affinando anche gli stru-menti di valutazione e monitoraggio, ponendosiil problema e l’ambizione dell’esportabilità di unmodello di programmazione partecipativa che hal’obbiettivo di sviluppare competenze nei citta-dini. Nella programmazione regionale l’empo-werment costituisce uno strumento e al tempostesso un fine della promozione della salute.I processi partecipativi sono sicuramente alla ba-se dell’empowerment di comunità, ma la parte-cipazione da sola è insufficiente se le strategie chesi utilizzano non riescono a promuovere quellecapacità che permettono alle comunità, alle or-ganizzazioni e agli individui di prendere decisio-
ni sulle questioni che li riguardano. In particola-re, negli ultimi anni, le politiche regionali di go-verno in ambito sociale e sanitario si sono, quin-di, sviluppate secondo criteri che promuovono esostengono ambiti decisionali e di programma-zione condivisi tra decisori/operatori e rappre-sentanti delle parti sociali/cittadini, nella convin-zione che tali ambiti, opportunamente gestiti da-gli operatori/dirigenti coinvolti, costituiscano ilmomento in cui le capacità critiche e decisiona-li delle comunità possano adeguatamente svilup-parsi.Tale percorso, sostenuto da specifici organismi dirappresentanza e specifici momenti di confrontosu tematiche sociali e sanitarie, tende a sviluppa-re le competenze necessarie per lo sviluppo di unempowerment di comunità.In questa prospettiva, risultano particolarmenterilevanti gli orientamenti sanitari che pongonoin primo piano la necessità di passare da una pro-grammazione centrata sulle “prestazioni” ad unabasata su obiettivi di salute da raggiungere.Si amplia, pertanto, il fronte di coinvolgimento aiprogrammi di politica sanitaria, anche ai non pro-fessionisti del settore, ma soprattutto si condivi-dono e si perseguono obiettivi di salute che ogniattore sociale contribuisce a realizzare. Esempla-re rispetto alle forme innovative di coinvolgi-mento dei cittadini2 è l’esperienza maturata at-traverso i Piani per la Salute3 (o anche nei Pianidi Zona). L’idea che li caratterizza e che viene quimutuata dai recenti studi sull’economia solidaleè quella di individuare strategie di intervento apartire dalla creazione di “luoghi pubblici di pros-simità“ (Laville,1998) quali spazi per la discussio-ne e la condivisione delle soluzioni dei problemiche quello specifico territorio presenta.Si sono attivati, di fatto, laboratori dove è possi-bile sperimentare la capacità di integrare un’a-
Empowerment di comunità: gli orientamenti in Regione Emilia Romagna
71
IQU
AD
ERN
IDI
1 Wallerstein N. (2006),What is the evidence on effectiveness of empowerment to improve health?, Copenhagen,WHO Regional Office for Europe (Health Evidence Networkreport; http://www.euro.who.int/Document/E88086.pdf, December 2007).
2 Nelle esperienze maturate in questi anni sia a livello internazionale sia a livello locale si assiste ad una oscillazione di forme che sono rappresentate dalla seguente polarità:forme tradizionali di ascolto basate sulla rilevazione di opinioni, preferenze; forme innovative nella tradizione della democrazia deliberativa.
3 L’esperienza dei Piani per la salute è stata dettagliatamente descritta in “Cittadini competenti costruiscono azioni per la salute. I Piani per la salute in Emilia-Romagna 2000-2004” a cura di M. Biocca, Franco Angeli, 2006.

zione sociale ampia con l’azione specifica delleagenzie preposte alla risposta sanitaria. I diversiattori sociali sono impegnati a ridefinire un nuo-vo equilibrio negoziale e relazionale, dove do-vranno essere esplicitate, in un’ottica di parteci-pazione, le azioni tese alla promozione della sa-lute (Capizzi e Nicoli, 2006;Nicoli, Capizzi, Pe-rino, Cipolla, 2006).Un piano per la salute (Pps) è infatti definito co-me “un piano poliennale di azione elaborato erealizzato da una pluralità di attori, coordinati dalgoverno locale, che impegnano risorse umane emateriali allo scopo di migliorare la salute dellapopolazione anche attraverso il miglioramentodell’assistenza sanitaria”. Esso richiede quindi ilcoinvolgimento più vasto possibile, il rafforza-mento delle alleanze esistenti e la creazione dinuove. Il Pps costituisce il Patto locale di solida-rietà per la salute.L’esperienza maturata attraverso i Piani per la sa-lute ha messo in luce4 la necessità di rendere piùforte quei “domini”di “infrastruttura”, secondo laconcettualizzazione di Laverack, che possono so-stenere i processi di partecipazione comunitaria.I “domini infrastrutturali” che la Regione Emi-lia Romagna si è data per lo sviluppo dell’empo-werment della comunità dei cittadini rientranonella nuova programmazione integrata derivante dalPiano Sociale e Sanitario 2008-2010, che vede idiversi attori del sistema contribuire alla defini-zione e monitoraggio degli obiettivi di salute in-dividuati nelle singole province e distretti. NelPps, per il conseguimento del benessere dei cit-tadini della regione, si promuovono interventi ca-paci di coinvolgere e mobilitare risorse diverse(pubbliche, del terzo settore, della solidarietà spon-tanea e non organizzata, private ecc.) ricercandol’integrazione delle politiche sociali con le poli-tiche sanitarie e, allo stesso tempo, di queste conle politiche ambientali, urbanistiche, abitative, for-
mative, occupazionali e culturali.È evidente che tali indirizzi necessitino di un for-te e complesso coinvolgimento di tutti gli ope-ratori e i cittadini nelle forme delle loro rappre-sentanze nei diversi livelli istituzionali (Eell,Ctts,Comitati di Distretto) e nelle differenti rappre-sentanze delle parti sociali.
NON È SOLO UNA QUESTIONE DISTRUMENTI, MA…Nonostante non manchino le condizioni per unavvio dei processi di empowerment di comunitàsi rileva una difficoltà legata ad un permanere didistanza tra le istituzioni e la collettività, allonta-nando sempre più il riconoscimento reciproco eil senso di appartenenza alla comunità locale diriferimento.Elementi che sono essenziali per unaresponsabilità sociale e per una effettiva presa incarico comunitaria delle questioni che caratte-rizzano uno specifico territorio.Con questa consapevolezza, l’indicazione da as-sumere è quella di orientare gli interventi versoforme di “capitalizzazione comunitaria” imper-niate sulle capacità di elaborare domande che pos-sano riattivare un pensiero collettivo. Solo agen-do verso obiettivi generatori di forme identitariecaratterizzate dal senso di appartenenza che evo-ca il “noi”, si riducono le derive di appartenenzeidentitarie individuali.Su questa base si stanno promuovendo in diversicontesti territoriali regionali5 iniziative tese a ri-collocare alcune domande, solitamente poste co-me espressione di una comunità vista come ba-cino di utenza (bisogni/problema) anziché vistacome attore sociale (risorse/capacità).Ad esem-pio il tema della nascita o del dolore può esseredeclinato diversamente, a seconda di quale delledue prospettive si assume.Si è inoltre innescato, a livello locale, un proces-so di “tutoraggio” delle iniziative promosse al fi-
IL SISTEMA SANITARIO E L’EMPOWERMENT
72
IQU
AD
ERN
IDI
4 Si veda l’analisi condotta sui processi partecipativi all’interno dell’esperienza dei Piani per la salute in Capizzi e Nicoli, 2006; Nicoli, Capizzi, Perino, Cipolla, 2006.5 Nel Documento curato da Ervet nel 2009 sono raccolte le diverse iniziative realizzate in Regione Emilia Romagna per contribuire a realizzare un Osservatorio Regionale sullaPartecipazione.Tra queste figurano quelle censite all’interno del progetto curato dall’Agenzia Sanitaria e Sociale Regionale come sviluppo locale del progetto nazionale coordi-nato da Agenas (ERVET Rappresentanza e Partecipazione, Bologna, Rapporto Dicembre 2009).

ne di costituire competenze in grado di gestire iprocessi e prendersi cura anche dei “beni relazio-nali prodotti”.Una riflessione va fatta inoltre sugli strumenti otecniche. Queste non costituiscono di per sé ilsuccesso di una iniziativa partecipativa. Parados-salmente alcuni di questi strumenti amplificanoun modus operandi che ancora sempre più le scel-te alle decisioni individuali.L’idea di fondo è quindi quella di utilizzare stru-menti/tecniche orientate all’acquisizione di ca-pacità nell’elaborare e decidere collettivamente,favorendo la consapevolezza che il problema chesi è posto ha senso e può essere affrontato solo inuna ottica di presa in carico comunitaria.In particolare sono in corso alcuni interventi co-munitari in cui vengono utilizzati alcuni stru-menti quali l’Open SpaceTechnology e ilTeatrodell’Oppresso in relazione ad interrogativi colle-gati alla nascita, al dolore, al lutto e al dono.Taliinterrogativi sono collocati nella quotidianità dei
percorsi biografici delle persone e dei moltepliciscenari di cura delineati all’interno dei processisociali di una comunità.Per vari motivi, il valore che possono avere i pro-cessi decisionali collettivi discende dal legame checreano tra gli individui e dall’espressione che cia-scuno riceve di contare agli occhi di tutti sin dalmomento in cui partecipa. Le persone hanno ineffetti bisogno di sapere di prender parte alle co-se, sapere che le cose dipendono dalla loro ener-gia e abilità.Come riportato da Moscovici e Doise (1992), Lé-vi-Bruhl osserva:“Non si danno prima gli uomini e poi la loro parteci-pazione. Perché possano essere dati, perché possano esi-stere, c’è già bisogno di partecipazione.Una partecipa-zione non è soltanto una fusione, misteriosa e inespli-cabile, di esseri che al tempo stesso perdono e conserva-no la propria identità.Essa entra nella costituzione stes-sa di questi esseri: senza partecipazione, non sarebberodati nella loro esperienza, non esisterebbero”.
Empowerment di comunità: gli orientamenti in Regione Emilia Romagna
73
IQU
AD
ERN
IDI
BIBLIOGRAFIA• Capizzi S., Nicoli M.A. (2006), La partecipazione come co-struzione sociale: incontri con i protagonisti, in Biocca M. (a cu-ra di), Cittadini competenti costruiscono azioni per la salute,Franco Angeli, Milano, pp.98-117.
• Dallago L. (2006), Che cos’è l’empowerment, Carocci, Roma.• Fabbri D. (1998), Imparare a pensare nelle organizzazioni, in
Demetrio D., Fabbri D., Gherardi S., Apprendere nelle orga-nizzazioni, Carocci, Roma.
• Iscoe I., Harris LC. (1984), Social and community interventions,in Annu Rev Psychol., 35: 333-60.
• Hunter D.J. (2008), Health needs more than health care: theneed for a new paradigm, in The European Journal of PublicHealth, 18 (3), 217-219.
• Jackson T., Mitchell S., Wright M. (1989), The community de-velopment continuum, in Community Health Studies, 8, 66-73.
• Labonte R. (1990), Empowerment: Notes on professional andcommunity dimensions, in Canadian Review of Social Policy, 26,64-75.
• Laverack G. (2001), An identification and interpretation of theorganizational aspects of community empowerment, in Com-munity Development Journal, 36, 40-52.
• Laverack G. (2006),Using a “domains” approach to build com-munity empowerment, in Community Development Journal, 4,4-12.
• Moscovici S., Doise W. (1991),Dissensi e Consensi, Il Mulino,
Bologna.• Nicoli M.A. (2003), I cittadini tra i processi di selettività dellecure e coinvolgimento delle comunità: problemi e prospettive, inAnimazione Sociale, 8/9, pp.22-30.
• Nicoli M.A., Capizzi S., Perino A., Cipolla C., Sulle tracce di unametodologia sociale appresa collettivamente, in Biocca M. (acura di), Cittadini competenti costruiscono azioni per la salute,FrancoAngeli, Milano, pp.118-151.
• Nicoli M.A., Cinotti R. (2008), Lo studio della qualità percepi-ta come momento di ascolto, in Studi Zancan, anno IX, 1, 41-54.
• Nicoli M.A., Zani B. (1998), Mal di psiche. La percezione so-ciale del disagio mentale, Carrocci, Roma.
• Pellegrino V. (2009), Progettazione partecipata per la valuta-zione e il miglioramento dei servizi, intervento al LaboratorioEmpowerment dei cittadini e delle comunità, Bologna, 23 giu-gno 2009.
• Wallerstein N. (2006),What is the evidence on effectivenessof empowerment to improve health?, Copenhagen, Who Re-gional Office for Europe (Health Evidence Network report;http://www.euro.who.int/Document/E88086.pdf , Decem-ber 2007).
• Zimmerman M.A. (2000), Empowerment theory: psychologi-cal, organizational and community levels of analysis, in Rappa-port J., Seidman E., eds, Handbook of community psychology,New York, Kluwer Academic/Plenum Publishers: 43–63.

IL SISTEMA SANITARIO E L’EMPOWERMENT
74
iQua
dern
idi
Il termine inglese empowerment deriva dal ver-bo to empower, che significa “acquisire potere,competenza”.
Con tale termine si individua un processo, che faleva sulle risorse già presenti, finalizzato all’am-pliamento delle possibilità di un soggetto (perso-na fisica, comunità, gruppo, persona giuridica) inmodo da aumentarne la capacità di raggiungerepropri obiettivi di miglioramento.Tale definizione si regge su alcuni presupposti:1) si tratta di un processo, quindi di una realtà di-namica, in evoluzione continua;
2)agisce per rendere possibili azioni e comporta-menti virtuosi e non ancora in opera;
3) interessa ogni componente della società, ad ognilivello di aggregazione, dal singolo individuo-persona, all’aggregazione di persone giuridichedi varia natura;
4) smuove risorse già presenti ma non ancora at-tive (per così dire “dormienti”), permettendoloro di immettersi nel sistema.
L’empowerment è quindi uno stato organizzati-vo in cui le persone e le organizzazioni minorisono in coordinamento con gli orientamenti stra-tegici ed hanno sviluppato un proprio ruolo so-ciale per cui sono consapevoli:�della propria autodeterminazione (libertà di as-sumersi responsabilità relative alla propria con-dizione);
�della propria competenza;�della propria importanza per il sistema.
LA PECULIARITÀ DEL CASO LOMBARDIALa premessa di cui sopra è necessaria come pun-to di sintesi del significato dell’empowerment perprocedere nel percorso che in Regione Lombar-dia si è pensato ed attuato.Dalle considerazioni in premessa, infatti, si desu-me che non si tratta quindi di un processo ga-rantito da un potere centrale,ma piuttosto di unamentalità relativa al modo di interpretare il pro-prio ruolo all’interno del sistema.In sostanza il concetto di empowerment acquistaun proprio senso compiuto quando inserito inun contesto favorevole ad accogliere l’iniziativadel singolo, sia esso inteso come persona fisica checome persona giuridica. In altre parole, ciò di cuistiamo parlando si riassume con la centralità delpaziente all’interno del sistema.Estrapolare l’empowerment da un tale contesto si-gnifica relegarlo nell’ambito dei processi delegatidal centro di potere, ovvero ridurne la potenzialitàfino al livello del mero completamento di fattorinon determinanti del sistema, al sostegno di ambi-ti di nicchia,con impatto concentrato più sulle com-ponenti psicologiche e motivazionali dell’indivi-duo che sui metodi e le tecniche di funzionamen-to del sistema.Viceversa il sistema deve rendersi dis-
REGIONE LOMBARDIA:EMPOWERMENT E SUSSIDIARIETÀ
di Franco MilaniDirezione Generale Sanità - Regione Lombardia

Regione Lombardia: Empowerment e sussidiarietà
75
IQU
AD
ERN
IDI
ponibile al cambiamento,quando proposto secon-do le regole generali che il sistema si è posto. Unsistema è tanto più creativo nel trovare soluzioni ef-ficaci e mirate per la domanda emergente di servi-zi quanto più permette che ogni singolo punto del-la rete che lo costituisce possa non solo avere ideesul miglioramento della propria condizione,ma siamesso in grado di attuarle utilizzando anche partedelle risorse che il sistema utilizza per il suo fun-zionamento. Un processo di empowerment cheagisca solo su porzioni marginali del sistema,o pro-duca solo un incremento di partecipazione,non svi-luppa quindi tutte le potenzialità che la società nelsuo complesso ha a disposizione.In Regione Lombardia ciò che si è realizzato ne-gli scorsi anni in materia di sanità rispecchia que-sto percorso dall’Istituzione, intesa come centrodi potere unico, alla governance di un sistema po-licentrico e multilivello, dove il paziente è attoreprotagonista.Anche se il termine empowerment in RegioneLombardia non è molto diffuso, ciò nondimenoil processo cui tale definizione sottende è sul ter-ritorio lombardo particolarmente attivo, anche seassume di volta in volta definizioni differenti.Infatti, come spesso capita alle definizioni teori-che, esse sono un modello per descrivere, dipin-gere la realtà che può essere adottata o meno, sen-za che i fatti cambino.In definitiva per quanto accennato in preceden-za pare chiaro che il processo che va sotto la de-finizione di empowerment si realizza tanto com-piutamente quanto più in un determinato terri-torio è attuato il concetto di sussidiarietà.Nelle righe seguenti si descrivono più dettaglia-tamente alcune caratteristiche dell’empowermentper mostrarne gli stretti collegamenti con la sus-sidiarietà.
LE CONDIZIONI DI BASEPER L’EMPOWERMENTIl carattere della leadershipe del processo decisionalePer fare ciò che il processo di empowerment sot-
tende, è necessaria una leadership evolutiva, ingrado di governare, promuovere e realizzare ilcambiamento “continuo” in ottica evolutiva, uti-lizzando un metodo decisionale non autoritarioné tantomeno privo di regole, ma con caratte-ristiche di “processo diffuso” ovvero di gover-nance.In sintesi è auspicabile che il processo decisiona-le faccia riferimento ad un sistema a rete, più chead un sistema gerarchico piramidale.Ciò è esattamente quanto è avvenuto negli scor-si anni in Regione Lombardia, dove in tutti gliambiti dell’azione istituzionale si è proceduto al-l’innesto di una modalità di governo meno cen-tralistica e burocratica di quanto accadeva in pre-cedenza, sostituendo ad essa modalità diffuse, par-tecipate, a tratti caratterizzate da “geometrie va-riabili” (tenendo conto delle differenze del ter-ritorio).
I riferimenti valoriali del sistemaLa cultura che supporta i processi precedente-mente descritti considera la persona in quanto ta-le, e non come risorsa-uomo (se lavoratore) o pa-ziente/utente.Sembrerebbe una fine definizione puramente fi-losofica, con debole influenza sulla concreta at-tuazione delle strategie istituzionali. Pur tuttaviaè necessario sottolineare che la chiara definizio-ne dei riferimenti valoriali nella fase iniziale delprocesso decisionale assume un carattere fondan-te sia dal punto di vista dell’azione che ne con-segue, sia per la concreta attuazione delle strate-gie, sia infine dal punto di vista motivazionale de-gli attori coinvolti.A mero titolo di esempio si ricorda qui lo slogan“il paziente al centro del sistema sanitario” (cheriassume molto della mission di chi opera nel si-stema con responsabilità a vario livello), eviden-ziando come sia conoscenza comune il fatto cheaffinché questa dizione non resti lettera morta ènecessario considerare il paziente quale elemen-to attivo del sistema, riconoscendogli capacità diagire nel e per il sistema, e ciò contribuisce inol-

tre ad un uso più efficiente delle risorse immes-se nel sistema.
La cultura dell’ascoltoParrebbe inutile sottolineare la necessità di talepredisposizione come fondamentale per il pro-cesso di empowerment, se non fosse evidente al-l’esperienza di ciascuno la difficoltà dell’istitu-zione a concepirsi in dialogo perpetuo con il cit-tadino.Pertanto, lo sforzo di chi è preposto al governodella cosa pubblica, in particolare nel sistema sa-nitario, deve essere sempre indirizzato alla co-struzione di relazioni dirette con gli stakehol-ders, inserendo nelle proprie regole di sistemameccanismi e metodi con i quali l’istituzione siauto-obblighi a determinati comportamenti diascolto.Particolarmente chiaro in quest’ottica è il PianoSocio-Sanitario vigente in Regione Lombardia,dove si legge:“Particolare attenzione deve essere rivolta all’imple-mentazione di una nuova strategia di confronto e di ri-cerca di sinergie, che possa essere applicata a molti de-gli interventi previsti dal Piano socio-sanitario regiona-le ed in particolare a quelli che sono in diretta relazio-ne con il cittadino. In questo senso: attivazione di un‘Tavolo delTerzo settore Sanitario’.Questa articolazione organizzativa, espressione forte di‘sussidiarietà orizzontale’, consentirà interventi effica-ci nei percorsi dell’accoglienza (accessibilità, tempi di at-tesa, ecc.) dei cittadini, oltre che nelle attività di ‘edu-cazione’ e ‘prevenzione’, individuando eventualmentefonti di finanziamento per poter sostenere il settore delvolontariato in sanità.Le associazioni di pazienti o parenti sono molto at-tive sia nella informazione sulla malattia sia nel sup-porto pratico ai potenziali nuovi utenti. Inoltre, taliassociazioni giocano un ruolo strategico nella sinergiadei progetti di promozione della salute e sono attentelettrici del bisogno dei pazienti, per cui, in un’otticadi sussidiarietà spinta, possono sicuramente offrire si-gnificativi contributi a politiche sanitarie sempre piùefficaci.
(...) Si intende consolidare ed innovare il sistema delpartnerariato quale modello di governance istituziona-le che, nel riconoscimento dell’importanza reciproca deidiversi livelli di governo e dei differenti ruoli, favorisceil coinvolgimento di tutti gli attori della società civile nelprocesso di progettazione e attuazione delle politiche disviluppo sociale”.
LA SUSSIDIARIETÀIn tale contesto viene utile il collegamento conil concetto di sussidiarietà, la cui definizione si-stematica si deve all’enciclica di Pio XI Quadra-gesimo anno del 1931 (che affonda le sue radici fi-losofiche in Aristotele,Tommaso d’Acquino, Jo-hannes Althusius,Alexis de Tocqueville e JohnStuart):“A ogni livello della convivenza umana i sog-getti o le comunità maggiori non devono sostituirsi aquelli minori nell’esercizio delle loro funzioni,ma piut-tosto aiutarli in tale svolgimento”.In tal senso il concetto guida è che la società hauna priorità originale e una precedenza fun-zionale rispetto allo Stato; anzi, la ragion d'es-sere dello Stato (in qualunque sua articolazio-ne) è aiutare la creatività della persona e dei cor-pi sociali.Il principio di sussidiarietà ha poi trovato spazioanche in sede europea con la sua introduzione neltrattato di Maastricht. La conseguenza è duplice,nel senso che nessuna funzione deve essere attri-buita a istituzioni superiori se una inferiore o lo-cale è in grado di adempiervi adeguatamente e leistituzioni superiori hanno il compito di aiutarequelle inferiori se – e fintanto che – esse non sia-no in grado di svolgere determinate funzioni piùadeguatamente.Empowerment e sussidiarietà hanno in sanità uneffetto fortemente positivo. In questo senso Re-gione Lombardia ha consolidato negli anni un in-tenso rapporto con enti e associazioni del terzosettore.
LE SOLUZIONI NORMATIVEIN REGIONE LOMBARDIACon la legge 31/97 la Regione Lombardia ha po-
IL SISTEMA SANITARIO E L’EMPOWERMENT
76
IQU
AD
ERN
IDI

sto in essere un sistema integrato pubblico-pri-vato di fornitura di servizi sanitari al cittadino,che fa leva sul concetto di sussidiarietà, lasciandolibero spazio all’organizzazione e fornitura delleprestazioni sanitarie all’iniziativa privata di singo-li, associazioni o imprese, svolgendo nel contem-po un’approfondita azione di controllo perché ciòavvenga all’interno dei vincoli normativi nazio-nali e regionali.Tale normativa ha quindi permesso lo sviluppodi un sistema di quasi-mercato, dove il cittadi-no/paziente non solo può liberamente trovarerisposta alla sua domanda di salute presso ope-ratori sia pubblici che privati (che vengono sot-toposti alle stesse categorie di vincoli e con-trolli) in regime di Servizio Sanitario Regio-nale, ma è considerato come il significato stes-so del sistema (in tale ottica ad esempio vannoletti anche gli interventi per l’informatizzazio-ne dei dati sanitari del cittadino, con l’esito cheogni residente ha a disposizione il proprio fa-scicolo sanitario consultabile in ogni momentovia web tramite la propria carta dei servizi sa-nitari).Per completare il quadro del sistema appena de-scritto, è necessario aggiungere che la RegioneLombardia ha voluto sviluppare anche la possi-bilità prevista dall’articolo 9-bis del D.Lgsn.502/92 e s.m.i che disciplina le sperimenta-zioni gestionali attivabili dalle aziende sanitariepubbliche in collaborazione con soggetti priva-ti, con particolare riguardo alle modifiche a talearticolo derivanti dall’art. 3, comma 7 della l.405/01, il quale sancisce che l’art. 9-bis sia mo-dificato prevedendo il passaggio della compe-tenza autorizzatoria delle sperimentazioni ge-stionali dalla Conferenza Stato-Regioni alle Re-gioni.Infatti già nel 1999 con la Delibera di GiuntaRegionale n.VI/42718 del 29 aprile Criteri inordine al reperimento di nuove risorse per il settoresanità della Regione Lombardia, a seguito della ri-forma normativa in materia di sanità effettuatacon l’introduzione della legge regionale 31/97,
la Lombardia aveva sancito un modello di inte-razione pubblico-privato che andava oltre leconsuete categorie di contrapposizione e con-correnza, affermando che “L’attuale assetto delsistema sanitario regionale richiede la individuazio-ne di nuove forme gestionali che consentano alle azien-de sanitarie una maggiore flessibilità operativa e ge-stionale, funzionale sia al processo di aziendalizza-zione sia alla corrispondenza tra i bisogni espressidai cittadini e il loro soddisfacimento. Si ritiene chela collaborazione tra strutture pubbliche e private, ol-tre ad essere uno stimolo utile alla realizzazione delmodello aziendale, possa contribuire a colmare il di-vario tra l’affermazione dei bisogni collettivi e la ca-pacità del pubblico a farvi fronte finanziariamente ba-sandosi esclusivamente sui consueti canali di entratepubbliche”.
UN ESEMPIO DI INIZIATIVATra i vari esempi dell’inscindibile rapporto trasussidiarietà ed empowerment, quello forse piùsignificativo in ordine all’ambito sanità è quellogenerato dal rapporto con l’associazione Aisla(Associazione Italiana Sclerosi Laterale Amiotro-fica).Infatti nel 2007 in Regione Lombardia è statocostituito un gruppo di lavoro interassessorile incollaborazione con Aisla con lo scopo di indivi-duare le modalità più opportune per l’affronto diproblemi specifici quali ad esempio:� semplificazione delle procedure amministrativeaffrontate dai malati e da chi li assiste;
� sostegno all’assistenza domiciliare;� rapporto attivo con il volontariato.Quindi, sulla base dei rapporti intercorsi, si ègiunti alla elaborazione di un progetto di cui so-no stati condivisi scopi e metodi (Progetto Ne-mo – Realizzazione di un Centro Clinico inte-grato dedicato alla ricerca, diagnosi e cura nelcampo delle distrofie muscolari e patologie cor-relate).Con istanza del 15 settembre 2006 l’AziendaOspedaliera Ospedale Niguarda Cà Granda si èproposta quale ambito per la realizzazione di ta-
Regione Lombardia: Empowerment e sussidiarietà
77
IQU
AD
ERN
IDI

le progetto, finalizzato a strutturare, realizzare ecoordinare i servizi di:�attività clinica diagnostica e riabilitativa in regi-me di degenza e Day Hospital;
�ambulatorio dedicato alla Distrofia Muscolare emalattie correlate;
�consulenza e diagnosi genetica;�accompagnamento all’accesso a centri di eccel-lenza presenti nel proprio territorio di originee Sportello nazionale per la segnalazione di strut-ture sanitarie;
� sportello informativo rivolto al pubblico sullemalattie neuromuscolari;
� sportello Consulenza Ausili;nonché effettuare convegni e momenti di for-mazione specifici.Anche lo strumento per la gestione del progettoè stato identificato avendo come obiettivo la mi-gliore applicazione del concetto di sanità sussi-diaria.Infatti, con atto notarile del 20.10.2005, l’Unio-ne Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare (Uildm),Telethon e Ospedale Niguarda Cà Granda han-no costituito la “Fondazione Serena”, fondazio-ne non a scopo di lucro finalizzata all’assistenzaalle persone affette da patologie neuromuscolari,ricerca clinica e attività terapeutica su patologieneuromuscolari.Tale Fondazione è stata quindiidentificata quale soggetto gestore del Centro Ne-mo.Nell’ottica quindi di un efficiente utilizzo dellerisorse a disposizione, l’atto costitutivo della Fon-dazione Serena prevede che l’azienda Ospedalie-ra Ospedale Niguarda Cà Granda conceda, a ti-tolo di comodato in uso gratuito, una parte di im-mobile per lo svolgimento delle attività della Fon-dazione stessa.La dotazione di posti letto prevista dal progetto èstata definita all’interno dell’assetto organizzativoaccreditato dell’Azienda Ospedaliera, per un to-tale di 20 posti letto di degenza riabilitativa e 4posti letto di Day Hospital, e l’ambulatorio poli-specialistico attivato prevede le branche di Car-diologia, Neurologia, Pneumologia, Psichiatria,
medicina fisica e riabilitazione.Si deve però sottolineare che punto fondamen-tale di questo progetto è l’attivazione di una col-laborazione tra soggetti privati che rappresenta-no le istanze dei pazienti ed una struttura pub-blica che ha fornito gli spazi e le specifiche com-petenze tecnico-professionali al fine di renderepossibile un miglioramento dell’assistenza ai pa-zienti affetti da distrofia muscolare, creando unambiente confortevole per i pazienti e le loro fa-miglie, realizzando un punto di eccellenza perl’adozione di soluzioni innovative e nel contem-po garantire sinergie con gruppi di ricerca na-zionali/internazionali sulla patologia, garanten-do standard di assistenza di alta qualità e la crea-zione di un centro di formazione e ricerca perle professioni in ambito sanitario e socio-assi-stenziale.Ovviamente la creazione del Centro non ha in-fluito sull’organizzazione dell’ospedale, essendocostituito quale unità operativa (punto di ero-gazione) indipendente dall’assetto organizzati-vo dell’Ospedale Niguarda, dal quale può peròacquisire in convenzione tutti i servizi essen-ziali.All’Ospedale è stato quindi assegnato il ruolo diindirizzo e governo del progetto; per quanto ri-guarda poi la dotazione di personale, il Centro haautonomamente provveduto al reperimento diesso senza alcuna ricaduta sul Sistema SanitarioRegionale, e nel rispetto dei vincoli normativi edi accreditamento in materia.Gli introiti del Centro Nemo sono garantiti dal-l’erogazione dei servizi sanitari in regime di Ser-vizio Sanitario Regionale, con le seguenti preci-sazioni:�gli eventuali utili saranno interamente reinvesti-ti nell’attività del Centro Clinico;
� la copertura di eventuali perdite è garantita daisoggetti fondatori, e non potrà gravare a nessuntitolo sul Sistema Sanitario Regionale;
�nell’ambito della Fondazione, il rischio impren-ditoriale è sostenuto dal partner privato;
� l’A.O. contribuisce unicamente con la conces-
IL SISTEMA SANITARIO E L’EMPOWERMENT
78
IQU
AD
ERN
IDI

sione di spazi a titolo gratuito e la fornitura diservizi in convenzione;
� l’A.O. provvede alla certificazione dei risultaticonseguiti in termini di efficacia ed efficienzagestionale, mix di servizi attivati, tempi di rea-lizzazione, criticità riscontrate, gradimento de-gli utenti e del personale coinvolto.
IL PROGETTOLa motivazione principale da cui prende l’avvioil progetto Nemo non sta tanto nella mancanzadi centri di cura o di erogazione di servizi sani-tari ad hoc per malati di distrofia muscolare, quan-to invece nel fatto che i pazienti lamentano cheil servizio offerto risulta spesso inadeguato perl’assenza di un approccio polispecialistico ed om-nicomprensivo alla malattia ed alle sue ricaduteper la qualità della vita della persona.Da ciò è nato il principale elemento innovativodel progetto, che si qualifica in quello che nelcontesto di questo testo si definisce “Empower-ment”, e che consiste nel fatto che un’associa-zione di pazienti propone, organizza e finanziala realizzazione di un nuovo servizio quale fat-tore di sviluppo del Servizio Sanitario Regio-nale nell’ambito di una grande Azienda Ospe-daliera, assumendosi il rischio imprenditorialedella gestione e mantenimento dell’opera rea-lizzata.Il valore di tale iniziativa è quindi sintetizzabilecon quanto si diceva nella premesse, ovvero cheil concetto di priorità originale della società ci-vile si attua in un contesto dove l’Istituzione sipone in ascolto delle istanze del cittadino in tut-te le sue associazioni, il quale è messo in grado(anche finanziariamente e/o logisticamente) diprovvedere alla gestione di servizi al pubblico, as-sumendosi di conseguenza le responsabilità cheda ciò derivano.Peculiare poi il fatto che il cuore del progettoconsista nell’approccio multidisciplinare disponi-bile attorno al letto del paziente, ovvero nella rea-lizzazione anche pratica dell’ideale del pazientecome centro di attenzione.
Quindi, in tale contesto, il paziente non necessi-ta di trasferimenti presso diversi erogatori per dif-ferenti prestazioni o consulenze, ma la gestionecompleta del paziente avviene all’interno dell’U-nità Operativa, tramite un piano personalizzatodi cura affidato dal punto di vista organizzativoad un “case-manager”. Inoltre il personale dedi-cato agisce con modalità di team, superando le ri-gidità poste da ruoli/competenze, grazie a mo-menti periodici di condivisione di informazionie prospettive sulle attività in corso, alla condivi-sione delle risorse, e al fatto che ricercatori e cli-nici lavorano a stretto contatto e condividono irisultati del loro lavoro.Inoltre, il progetto, che prevede tutti i livelli di as-sistenza (degenza ordinaria, Day Hospital, attivi-tà ambulatoriale, counselling, assistenza domici-liare) fornisce una modalità particolarmente effi-cace per assicurare la continuità delle cure tra l’o-spedale e il territorio (fino alla realizzazione diun ambulatorio mobile – muscle bus – in gradodi portare al domicilio del paziente, in caso di ne-cessità, servizi diagnostici e terapeutici di sup-porto).Dalla sua attivazione a tutto il 2009 il Centro Ne-mo ha ricoverato in regime di Day Hospital unamedia di circa 20 pazienti/mese,mentre in regi-me di degenza ordinaria più dell’80% dei casi trat-tati ha prodotto un Drg relativo a malattie neu-rologiche o correlate (Drg 12 o 35).
CONCLUSIONICiò che si è tentato di descrivere con questo te-sto non è in definitiva il frutto di un’azione, perquanto intelligente ed efficace, che scaturisce dal-l’istituzione e vede come unico attore sempre l’i-stituzione che agisce quale “sovrano illuminato”nei confronti della società civile, le cui relazionicon cittadini e altre realtà sociali possono esserericomprese nell’ambito del rapporto burocraticoclassico, o ancora come supporto alla motivazio-ne, o al limite come coinvolgimento tramite in-formazione in relazione ai processi programma-tori dell’istituzione stessa (che, sia ben inteso, so-
Regione Lombardia: Empowerment e sussidiarietà
79
IQU
AD
ERN
IDI

IL SISTEMA SANITARIO E L’EMPOWERMENT
80
iQua
dern
idi
no comunque azioni positive, necessarie e meri-torie in alcuni ambiti e situazioni).Diverso e più importante è però un processo co-me quello descritto che, a fronte di un ampio per-corso comune di reciproco ascolto e approfondi-mento delle istanze e dei vincoli normativi, trat-ta della riconsegna del potere di agire ad una por-zione di società civile costituita da un’associazio-ne di malati, dai quali è nata una esigenza parti-colare che difficilmente sarebbe stata colta diver-samente dai referenti istituzionali, e ciò non tan-
to nel senso che l’Istituzione preposta ha unila-teralmente deciso di delegare a qualcuno una por-zione del suo potere centrale,ma della reale pre-sa d’atto del ruolo del cittadino/paziente qualepunto fondante dell’intero sistema, con il conse-guente semplice riconoscimento del suo poteredi agire.Si è così concretizzato un percorso di empower-ment, sostenuto e amplificato nel pieno del suosignificato, dal riferimento costante al concetto disussidiarietà nel sistema sanitario.

Apartire dagli anni ’90 un profondocambiamento culturale ha interessa-to la Pubblica Amministrazione.An-che leAziende sanitarie sono state co-
involte da questa trasformazione che ha rinnova-to il tradizionale rapporto tra ente e cittadino.Par-tecipazione, accesso, informazione, trasparenza,tutela sono diventati i principi ispiratori del rap-porto della Pubblica Amministrazione con il cit-tadino, sempre più protagonista consapevole deipropri diritti di cittadinanza.La centralità del cittadino viene sancita anche conl’obbligo di attivare gli Uffici relazioni con il pub-blico e di adottare la Carta dei servizi, strumentidi una nuova visione nell’ottica di un più ampioprocesso di interazione e di comunicazione.La Carta dei servizi pubblici, che nasce con la Di-rettiva del Presidente del Consiglio dei Ministridel 27 gennaio 1994 e diventa vincolante per glienti erogatori di servizi pubblici con la legge273/95, si configura come “patto” tra il soggettoerogatore del servizio e il cittadino, è uno stru-mento di formalizzazione dei diritti dei cittadinie degli impegni assunti dai soggetti gestori deiservizi.Nella direttiva viene affermato per la prima vol-ta il principio in base al quale “le aziende si impe-gnano nei confronti del cittadino-utente a fornire deter-minati livelli di servizio ed a garantire precise forme di
tutela” ed “i soggetti erogatori danno immediato ri-scontro all’utente circa le segnalazioni e le proposte daesso formulato”.La carta dei servizi è composta da quattro sezio-ni: 1) la presentazione dell’azienda, 2) la guida aiservizi sanitari con le modalità di accesso e frui-zione, 3) gli impegni che l’azienda sanitaria ha as-sunto per garantire la qualità dei servizi, 4) le pro-cedure di tutela. È spesso presentata come un in-sieme di opuscoli o un’unica guida,maneggevo-le e di facile lettura, a disposizione di tutti negliUffici per le relazioni con il pubblico.Se per i cittadini deve essere in primo luogo unostrumento di informazione sull’attività offerta, suilivelli di qualità garantiti e sui meccanismi di tute-la, dal punto di vista interno dell’azienda la Cartadeve essere vista come una significativa occasionedi miglioramento del servizio.Richiede infatti chele strutture sanitarie siano dotate di efficaci mec-canismi di misurazione della qualità dei servizi edi controllo del raggiungimento degli obiettivi.
LO SVILUPPO DEL SISTEMA CARTADEI SERVIZI SANITARI IN TOSCANALe politiche regionali (Legge Regionale 40/2005,vari Piani Sanitari Regionali) puntano da semprealla soddisfazione e alla partecipazione del citta-dino e pongono al centro dell’azione la personacon i suoi diritti.
DIRITTI E PARTECIPAZIONENELLE POLITICHEDELLA REGIONE TOSCANA
di Marco Menchini*, Roberta Bottai**
*Responsabile Settore Qualità,diritti e partecipazione,Direzione Generale Diritto alla Salute e politiche di solidarietà,RegioneToscana**Promozione processi di partecipazione e tutela dei diritti degli utenti,Direzione Generale Diritto alla Salute e politiche disolidarietà,RegioneToscana
81
IQU
AD
ERN
IDI

La Giunta Regionale già nel 1995 ha dato le pri-me direttive alle aziende sanitarie sull’attuazio-ne della Carta dei servizi con l’individuazionedi tempi perentori per la definizione dei fattoridi qualità e degli standard di riferimento deglistessi.L’obiettivo di una maggiore appropriatezza nel-l’erogazione delle prestazioni richiede cittadinisempre più informati e consapevoli dei propri di-ritti e doveri.Questo processo trae sostegno da una strategia diinformazione/comunicazione nella quale svol-gono un ruolo essenziale l’Ufficio relazioni conil pubblico e la Carta dei servizi sanitari.La Legge Regionale 40/2005, all’articolo 16“Tu-tela dei diritti dell’utenza” ribadisce che la Cartadei Servizi è lo strumento attraverso il quale leaziende sanitarie orientano ed adeguano le pro-prie attività alla soddisfazione dei bisogni degliutenti. Nella Carta sono definiti gli obiettivi, gliimpegni assunti per il raggiungimento di questiultimi, gli standard di riferimento, le modalità permisurare i risultati e il livello di soddisfazione del-l’utente.In particolare, la Regione Toscana, a partire dal1996, ha messo in atto una serie di iniziative siaorganizzative sia metodologiche tese a integraree rendere sinergici due strumenti strategici per laqualità: la Carta dei servizi e l’accreditamento, nel-la consapevolezza che qualsiasi tentativo di mi-glioramento del sistema è efficace solo se inseri-to in un contesto organizzativo dove sono defi-nite con precisione le regole per elevare e man-tenere determinati standard qualitativi. In questocontesto si è sviluppato il sistema carta dei servi-zi con l’osservatorio dei reclami, le indagini sul-la qualità, il sistema di tutela.
L’OSSERVATORIO REGIONALE CARTADEI SERVIZI SANITARI: UNO STRUMENTODI MONITORAGGIOLa misurabilità degli obiettivi, dei risultati e de-gli effetti è una condizione imprescindibile perun modello ispirato alla credibilità e alla traspa-
renza dell’azione pubblica. Il D.Lgs. 502/92 ha in-trodotto l’adozione sistematica del metodo di ve-rifica e revisione della qualità delle prestazioni sa-nitarie con riferimento non solo a parametri diefficienza (indicatori art.10) ma anche a indica-tori di qualità orientata all’utente (art.14).Sono stati definiti come indicatori per la valuta-zione della qualità del servizio aspetti quali l’u-manizzazione dei servizi, il diritto all’informa-zione e la partecipazione dei cittadini.La Regione Toscana, nel corso del 1997, avevaaderito alla sperimentazione attivata a livello na-zionale relativa agli indicatori di qualità orienta-ta all’utente (art.14 del d.lgs 502/92). In esito aquesta iniziativa, sempre nel 1997,ha istituito l’Os-servatorio regionale carta dei servizi sanitari: unefficace strumento di monitoraggio del sistema,unico nel suo genere a livello nazionale.Si tratta di un flusso informatizzato che annual-mente raccoglie informazioni dalle aziende sugliaspetti che riguardano l’accessibilità, la cosiddet-ta umanizzazione dell’assistenza, la tutela dei cit-tadini. L’accesso al flusso Osservatorio da partedelle aziende sanitarie e la trasmissione dei datialla Regione avviene tramite Internet, utilizzan-do la rete telematica regionale. Il flusso Osserva-torio è infatti rintracciabile nel sito della Regio-ne Toscana, ciascuna azienda sanitaria ha la pro-pria password di accesso e inserisce ogni anno leinformazioni richieste organizzate nei seguenticapitoli: Sistema carta dei servizi,Tutela (gestio-ne reclamo e casistica dettagliata dei reclami), In-formazione ed accessibilità,Prestazioni alberghiere,Prevenzione (Sup).I dati raccolti permettono di avere un insieme diindicatori utili alla valutazione della qualità deiservizi per la componente più orientata verso l’u-tente. I risultati dell’osservatorio sono elementiimportanti per focalizzare le criticità e orientaregli interventi di miglioramento, in particolare quel-li finanziati dalla Regione.La Carta dei servizi può svilupparsi solo se i prin-cipali processi che la supportano costituisconoparte integrante del sistema qualità aziendale, cioè
IL SISTEMA SANITARIO E L’EMPOWERMENT
82
IQU
AD
ERN
IDI

Diritti e partecipazione nelle politiche della Regione Toscana
83
IQU
AD
ERN
IDI
gli impegni dichiarati sulla carta devono essere larisultante di scelte strategiche aziendali e verifi-cabili. Per questo motivo nel 2003 la Giunta re-gionale ha approvato un repertorio di 32 impe-gni, comuni per tutte le aziende sanitarie, con re-lativi indicatori e standard.Tra questi impegni siricordano: il numero telefonico unico per l’in-formazione ai cittadini sull’accesso ai servizi; l’am-pliamento delle fasce orarie di visita nei presididi ricovero; la mediazione culturale per gli uten-ti stranieri.Il repertorio regionale degli impegni viene mo-nitorato attraverso l’osservatorio e da alcuni an-ni è diventato un elemento di valutazione del-le performance aziendali, nell’ambito del ber-saglio MeS.
GLI IMPEGNI DELLA CARTA DEI SERVIZICOME STRUMENTO DIVALUTAZIONENEL BERSAGLIO MESIl bersaglio MeS (“Laboratorio Management eSanità” svolge attività di formazione manageria-le, ricerca e valutazione per il Sistema sanitariotoscano) è un importante strumento di governoed è collegato al sistema di incentivazione per ladirezione aziendale.Per rappresentare adeguatamente i risultati ri-portati da ogni azienda sono state individuate seidimensioni di sintesi, capaci di evidenziare gliaspetti fondamentali della performance in un si-stema complesso quale quello sanitario: stato disalute della popolazione, capacità di perseguire lestrategie del sistema regionale, valutazione sociosanitaria, valutazione esterna, valutazione interna,valutazione dell’efficienza operativa e della per-formance economico-finanziaria.I risultati del sistema di valutazione vengono pre-sentati con una simbologia semplice e chiara: ilbersaglio è suddiviso nei sei settori identificatividelle dimensioni e in cinque colori che indicanole fasce di valutazione in cui ogni indicatore an-drà a posizionarsi, rendendo immediatamente evi-dente i punti di forza o di debolezza nella per-formance dell’azienda analizzata.
A partire dal 2008, dopo una prima sperimenta-zione nel 2007, è stato inserito nel “BersaglioMeS” (nella dimensione Capacità di perseguire lestrategie del sistema regionale) un nuovo indicato-re: il “rapporto col cittadino”. Questo macroo-biettivo si basa su tre componenti principali: 1)il sistema Carta dei servizi, ovvero i processi azien-dali per garantire un sistema orientato al cittadi-no, alla difesa dei suoi diritti, 2) il Front-Office te-lefonico, la capacità dell’azienda nel gestire l’in-formazione telefonica, 3) l’informazione ai cittadi-ni, l’informazione sui servizi sanitari fornita dal-l’azienda, percepita e giudicata dai cittadini stes-si. La prima componente tiene conto dei 32 im-pegni del repertorio regionale, in elaborazionecon un altro parametro che riguarda la presenzao meno di un comitato di partecipazione. La se-conda componente è il Front-Office telefonicoche si basa su un pacchetto di parametri: nume-ro verde, orario del servizio telefonico, possibili-tà di essere richiamati, test sul tempo di attesa te-lefonica. La terza componente è il giudizio deicittadini sul servizio telefonico, sull’informazio-ne ricevuta.I dati relativi a queste tre componenti vengonorilevati mediante il flusso dell’Osservatorio Car-ta dei Servizi,mentre il giudizio dei cittadini vie-ne raccolto con una indagine campionaria tele-fonica rivolta ai cittadini toscani.
IL SISTEMA DI TUTELAPer quanto riguarda la tutela dei diritti dei citta-dini, è stato definito un percorso del reclamo chiaroe univoco per il cittadino che coinvolge più sog-getti, interni ed esterni all’azienda: la direzionesanitaria, l’Urp, la Commissione Mista Concilia-tiva e il Difensore civico regionale.Il cittadino, qualora non ritenga soddisfacente larisposta dell’azienda, può ricorrere, per un riesa-me del caso, alla Commissione Mista Conciliati-va, composta da sette membri: tre rappresentan-ti delle associazioni di volontariato e tutela, tredipendenti dell’azienda ed un presidente desi-gnato dal Difensore civico del Comune dove ha

sede la Direzione generale dell’azienda, d’intesacon le associazioni di volontariato e tutela.Per i reclami nei quali è ipotizzabile la responsa-bilità professionale di operatori sanitari, la prati-ca è trattata in primo luogo dalla Direzione sani-taria dell’azienda, che valuta gli eventuali prov-vedimenti da adottare.Se l’utente non si ritiene soddisfatto della rispo-sta aziendale, la pratica viene trasmessa al Difen-sore civico regionale, il quale, senza alcun costoper il cittadino, esamina il caso e fornisce all’in-teressato indicazioni in merito all’opportunità omeno di ricorrere alle vie giudiziarie.Visto che le questioni più di frequente poste al-l’attenzione degli Urp delle Commissioni misteconciliative e del Difensore civico regionale daparte dei cittadini riguardano i temi della qualitàdell’informazione e dell’umanizzazione dell’assi-stenza, la Regione ha finanziato, nel corso deglianni, progetti aziendali che promuovessero que-sti aspetti.Per venire incontro alle Aziende, a loro volta im-pegnate nell’adeguare il regolamento aziendale ditutela in coerenza con gli indirizzi regionali, è sta-to realizzato un applicativo software, interamentefinanziato dalla Regione Toscana, per la raccoltadei reclami e per la registrazione dei vari tipi dicontatto col cittadino (segnalazioni, proposte, elo-gi, prese in carico…). Questo consentirà di uni-formare il procedimento tra le varie Aziende.Successivamente, i dati raccolti a livello azienda-le andranno ad alimentare un vero e proprio flus-so regionale dei reclami e degli elogi, da allinea-re con l’Osservatorio regionale carta dei servizisanitari e l’Osservatorio dei sinistri.È inoltre oggetto di sperimentazione la costitu-zione, presso due aziende sanitarie, di una Came-ra di conciliazione per lo svolgimento di contro-versie in materia di responsabilità sanitaria.Que-sto strumento è finalizzato ad un contenimentodei tempi di risoluzione e dei costi complessivi,giudiziali e assicurativi, sia per le aziende che perle persone coinvolte.È basato sulla figura del conciliatore: non un giu-
dice che attribuisce colpe o responsabilità,ma unapersona esperta che favorisce l’incontro e la con-ciliazione bonaria tra il danneggiato e l’azienda.È una procedura volontaria,molto rapida, e se leparti trovano l’accordo il cittadino viene risarci-to in tempi molto brevi; opera fino a 50.000 eu-ro per fatti riguardanti ad es. l’errata terapia, la ri-tardata diagnosi, lo smarrimento protesi, le cadu-te accidentali ecc.Tale strumento comunque do-vrà essere revisionato nei prossimi mesi in base airisultati che sta fornendo la sperimentazione e al-la luce del Decreto legislativo in attuazione del-l’art. 60 della legge 19 giugno 2009, n. 69 recan-te delega al Governo in materia di mediazione edi conciliazione delle controversie civili e com-merciali – 26 febbraio 2010.
“LA GUIDA DELLA SALUTE” INVIATAATUTTE LE FAMIGLIE TOSCANELa diffusione dei contenuti della Carta dei servi-zi presso la cittadinanza può incidere in modo si-gnificativo sulla effettività dei diritti degli utentiin ambito sanitario e su un accesso più consape-vole ed appropriato alle prestazioni.Per questo motivo nel settembre 2009 è stata in-viata nelle case delle famiglie toscane “La guidadella salute – 2009”. Si tratta della Carta dei ser-vizi sanitari dellaToscana, realizzata dalla Regio-ne insieme alle aziende sanitarie, che punta, gra-zie a un’ampia distribuzione, a diffondere unamaggiore conoscenza fra i cittadini sulla molte-plicità dei servizi sanitari offerti.Si tratta di un provvedimento rilevante perché inquesti anni le singole aziende hanno realizzatociascuna la propria Carta dei servizi con la soladistribuzione presso gli sportelli aziendali, la qua-le non ha consentito fino a oggi una reale cono-scenza di questo strumento tra i cittadini.Questaoperazione quindi è stata condotta in modo darazionalizzare e ottimizzare le risorse in campo ein maniera tale da garantire una percezione or-ganica del sistema sanitario e al tempo stesso sal-vaguardare le specificità delle singole realtà.La Carta è strutturata con un format comune per
IL SISTEMA SANITARIO E L’EMPOWERMENT
84
IQU
AD
ERN
IDI

tutta la regione ed una parte specifica aziendale,sono state realizzate 12 edizioni secondo il terri-torio di riferimento.Nella guida un capitolo è dedicato ai rapporti conil medico di famiglia e pediatra, primo riferimentoper la nostra salute, e un altro ai percorsi assisten-ziali più consolidati: la nascita, la non autosuffi-cienza, il malato oncologico, il malato di diabe-te. Inoltre, per rendere la guida quanto più pos-sibile semplice e comprensibile per il cittadino, iltesto è stato revisionato con i rappresentanti delForum per la Sanità, composto dai rappresentan-ti delle associazioni di tutela dei cittadini.
IL FORUM REGIONALEDELLE ASSOCIAZIONI DEI CITTADINIA livello regionale, già da diversi anni, opera il“Forum permanente per l’esercizio del dirittoalla salute”, composto da undici associazioni ditutela dei consumatori/utenti, con il quale si han-no momenti di confronto, consultazione e pro-posta su tutte le materie attinenti al diritto allasalute.In questi ultimi anni il Forum ha acquistato sem-pre più autorevolezza, recentemente è stato inse-rito in atti regionali strategici, per funzioni con-sultive e di monitoraggio, quali il progetto per lasanità di iniziativa (chronic care model) e il pro-gramma di accreditamento (LR 51/2009).A livello locale, in alcune delle Ausl, già da annisono presenti i Comitati di partecipazione, che ri-uniscono rappresentanti dei cittadini e categoriedi malati.Tali comitati svolgono attività di con-sulenza sui processi organizzativi aziendali di ri-levanza socio-sanitaria e di proposizione di azio-ni di miglioramento riguardanti i percorsi assi-stenziali e il rapporto con i cittadini.Il Forum dovrà svolgere sempre di più un’attivi-tà di coordinamento nei confronti di questi or-ganismi locali.
SEMPRE DI PIÙVERSO L’EMPOWERMENTLa concezione di salute sta rapidamente evolven-do nel contesto nazionale e internazionale verso
nuovi significati e prospettive.Nel passaggio dal concetto di sanità a quello disalute vanno implementate le azioni che deter-minano la promozione della salute dell’individuoe della comunità, con il coinvolgimento di citta-dini sempre più competenti e partecipi.In questo contesto si inserisce il gruppo di lavo-ro interregionale sull’empowerment, costituito nel2007 dall’Agenas, che ha avviato un processo diriflessione e autovalutazione delle Regioni suquesto tema e sta promuovendo una culturacondivisa.Con il termine “empowerment” si intende “unprocesso dell’azione sociale attraverso il quale lepersone, le organizzazioni e le comunità acquisi-scono competenza sulle proprie vite, al fine dicambiare il proprio ambiente sociale e politicoper migliorare l’equità e la qualità di vita” (Wal-lerstein 2006).L’attività del gruppo ha permesso in primo luo-go la condivisione di un modello di analisi delprocesso di empowerment e successivamente laricerca e selezione delle esperienze più significa-tive in ambito locale.Gli strumenti di analisi e dimetodo messi a punto ci possono guidare nel-l’approntare nuovi interventi di empowermentsecondo caratteristiche e percorsi condivisi.Per individuare le esperienze più significative diempowerment nell’ambito del nostro contesto lo-cale, siamo partiti da un censimento regionale del-le iniziative aziendali di umanizzazione già in cor-so, con il quale abbiamo raccolto più di 300 pro-getti secondo queste tipologie di argomento: acco-glienza/orientamento, diversità/fragilità/intercultura,partecipazione attiva al percorso di cura,valutazio-ne partecipata, lotta al dolore, percorso oncologi-co, chronic care model, cartella del paziente, atten-zione al dipendente.Contestualmente al censimento è stata individuatauna rete di referenti aziendali per le iniziative diumanizzazione, in diverse aziende questi opera-tori sono anche referenti aziendali HPH.Sempre nell’ambito delle iniziative promosse dalgruppo di lavoro è stato organizzato un conve-
Diritti e partecipazione nelle politiche della Regione Toscana
85
IQU
AD
ERN
IDI

gno sul tema Empowerment del cittadino: esperienzee strumenti a confronto (16 giugno 2009, Firenze),per offrire un momento di approfondimento econfronto su un tema importante ed innovativoquale quello dell’empowerment nelle organizza-zioni sanitarie. In questa occasione sono state il-lustrate esperienze di livello regionale, nazionalee internazionale, spaziando dall’esperienza clini-ca, alla medicina di base con il chronic care mo-del, al punto di vista dei cittadini.La politica per la salute si deve sviluppare in mo-do organico sia con le strategie sociali, economi-che e ambientali, sia con il coinvolgimento di cit-tadini sempre più competenti e partecipi.È necessario favorire l’autonomia decisionale de-gli utenti, sviluppare nei cittadini una capacità in-dividuale e collettiva di autotutela della salute.Una modalità di operare in questo senso sono, inToscana, i Piani integrati di salute, programmi diazioni elaborati e redatti da una pluralità di sog-getti, istituzionali e non, che impegnano risorseumane e materiali allo scopo di migliorare la sa-lute della popolazione intervenendo sui deter-minanti che la condizionano.Sempre in questo ambito rientrano le iniziativedel Chronic Care Model: questo modello si basainfatti su una forte interazione tra i pazienti (ma-lati cronici), che devono essere resi esperti dellapropria malattia, le loro famiglie e i diversi ope-ratori.
NUOVI STRUMENTI E NUOVI PERCORSI DIPARTECIPAZIONE: DALTOWN MEETINGALL’ACCADEMIA DEL CITTADINONel 2007 l’Assessorato alla salute della Regione harealizzato un momento di confronto diretto con icittadini/utenti tramite uno strumento di demo-crazia partecipata come il Town Meeting (TM).IlTM ha coinvolto un pubblico di circa 300 cit-tadini estratti a sorte da un campione causale di15 mila toscani e ha avuto luogo in nove sedi di-verse (circa 150 cittadini raccolti nello spazio diCarrara Fiere e gli altri suddivisi in altre otto se-di distribuite nella Regione); questi cittadini si
sono confrontati sul tema della compartecipazio-ne alla spesa sanitaria.È stato scelto questo tema sia per la rilevanza cheesso assume nell’ambito delle politiche sanitarieregionali, sia per l’impatto che ha nella percezio-ne dei cittadini, chiamati a discutere di un argo-mento che li tocca direttamente. I partecipantisono giunti a questo evento preparati, infatti han-no ricevuto a casa circa quindici giorni prima del-l’evento una guida con le informazioni fonda-mentali sul tema oggetto della discussione.I partecipanti hanno discusso in gruppi di 10-15persone, riuniti attorno a tavoli rotondi insiemead un facilitatore, che ha avuto il compito di sor-vegliare la discussione e garantire che si svolges-se in maniera fluida e democratica. I momenti didiscussione si sono alternati a momenti di incontrocon degli esperti. Infine i partecipanti, dotati diun telecomando individuale, hanno espresso leproprie preferenze attraverso il televoto.L’Assessorato ha voluto coinvolgere sia gli addet-ti ai lavori e gli esperti, sia tutti i soggetti tradi-zionalmente deputati alla rappresentanza di grup-pi di interesse, nella costruzione dei diversi pun-ti di vista che sono stati messi a confronto. Sonostati coinvolti 112 soggetti attraverso lo svolgi-mento di interviste e di incontri di lavoro, con lametodologia dei focus group tematici.I risultati delTM hanno mostrato che la maggiorparte dei cittadini non mette in discussione lacompartecipazione, ma solleva critiche rispettoalle modalità con cui il sistema è organizzato (chipaga, come paga, come si usano le risorse che nederivano). Il percorso di analisi dell’Assessorato ele iniziative legate al potenziamento dei control-li sono strettamente legate a quanto emerso dalTM. Dopo questa prima esperienza positiva lostrumento delTown meeting è stato recentementeutilizzato per affrontare un dibattito sul testamentobiologico.La Legge Regionale 69/2007 sulla partecipazio-ne promuove sul territorio anche altre forme dipartecipazione democratica,mettendo a disposi-zione finanziamenti ad hoc per progetti locali ed
IL SISTEMA SANITARIO E L’EMPOWERMENT
86
IQU
AD
ERN
IDI

un supporto metodologico.Queste iniziative di “democrazia partecipativa”comprendono forme di coinvolgimento direttodella popolazione nei processi decisionali; l’in-tervento diretto della popolazione avviene attra-verso assemblee e tavoli di lavoro aperti ai sem-plici cittadini (giurie di cittadini, open space tech-nology, focus group, ecc.). In questa maniera lasocietà civile e le istituzioni si impegnano insie-me per migliorare lo stato delle amministrazionipubbliche e la loro rispondenza alle capacità e al-le esigenze crescenti dei cittadini.Fino ad oggi queste iniziative hanno riguardatopolitiche del territorio legate essenzialmente al-l’urbanistica; è intenzione però della Regione an-dare a sperimentare queste nuove modalità di co-involgimento diretto dei cittadini anche su pro-blematiche sanitarie.L’“accademia del cittadino” è una recente inizia-tiva regionale che nasce con la finalità di forma-re sui temi della salute e della sanità i rappresen-tanti di associazioni di cittadini e pazienti.Si tratta di un’iniziativa di formazione ispirata alprogetto formativo Partecipasalute, che si proponedi costruire un’alleanza strategica tra associazio-ni di pazienti e cittadini con la comunità medi-co scientifica (l’Istituto di Ricerche Farmacolo-giche Mario Negri di Milano). L’iniziativa è fi-nalizzata proprio ad abilitare rappresentanti di as-sociazioni di cittadini e pazienti ad un dialogo pa-ritario e ad una collaborazione attiva con il mon-do dei professionisti sanitari non solo per fare scel-te consapevoli ma anche per partecipare al mi-glioramento.In particolare questa attività formativa si è postagli obiettivi di condividere le conoscenze di ba-se relative alla ricerca clinica ed epidemiologicae di rendere maggiormente competenti i parte-
cipanti nella conoscenza delle problematiche del-la salute e nella valutazione e promozione dellaqualità e sicurezza.Come indicano infatti le ricerche pubblicate inletteratura, la presenza di non professionisti nellesedi in cui si discute di salute e sanità porta unavisione nuova e diversa dei problemi, spesso tra-scurata da operatori sanitari e decisori politici.Il sistema della partecipazione nella sanità tosca-na si sta sempre di più ampliando: oltre ai comi-tati di partecipazione aziendale, le consulte delterzo settore, le associazioni dei malati, ci sono inuovi comitati di partecipazione delle “Societàdella salute”. Le Società della Salute (SDS) sonoconsorzi pubblici tra i Comuni e le Aziende sa-nitarie territoriali.Con questa nuova modalità or-ganizzativa si intende ricomporre un governo delterritorio finalizzato all’integrazione dei servizisocio-sanitari e ad un maggior raccordo tra le po-litiche per la salute e quelle per l’ambiente.Tuttele SDS stanno dedicando particolare attenzionea sviluppare ampi processi partecipativi, attraver-so il coinvolgimento delle comunità locali e deipropri organismi di partecipazione, volendo as-sumere un ruolo di rappresentanza del bisognodella cittadinanza.A questo punto diventa necessario da un lato co-ordinare i vari organismi di partecipazione cheoperano sul territorio in modo da rendere siner-gici i loro interventi, dall’altro vedere di utilizza-re al meglio anche i nuovi strumenti di parteci-pazione diretta dei cittadini in una visione di si-stema.In questo contesto così ampio e complesso ilgruppo interregionale sull’empowerment rap-presenta un’occasione di approfondimento e di-battito molto importante per orientare le azionifuture.
Diritti e partecipazione nelle politiche della Regione Toscana
87
IQU
AD
ERN
IDI

EMPOWERMENTE VALUTAZIONE:PROSPETTIVE E METODIA CONFRONTO

IL SISTEMA SANITARIO E L’EMPOWERMENT
90
iQua
dern
idi
In un recente documento dell’Organizzazio-ne Mondiale della Salute (Oms: Lavervack,2009) un gruppo di esperti, individuato tra ipartecipanti alla settima Conferenza Interna-
zionale di promozione della salute di Nairobi, de-finisce i cinque punti che devono essere svilup-pati in ciascun piano che si proponga di imple-mentare azioni di promozione della salute: il quin-to punto recita “misurare cosa capita e perché”ed è accompagnato dalla domanda proposta neltitolo. L’obiettivo che ci proponiamo, con questobreve scritto, è di declinare le caratteristiche chedovrebbe avere lo sviluppo di questo punto quan-do applicato ai progetti di empowerment: nellaconclusione verrà illustrata una ipotesi di ricercacoerente con i principi enunciati.
COSA MISURAREL’empowerment è proposto nella letteratura sot-to due punti di vista, diversi ma sempre più inte-grati: come strumento e come obiettivo. Lo svi-luppo dell’empowerment, visto come strumentoper raggiungere gli obiettivi di salute individua-ti da coloro che progettano l’intervento, vieneperseguito perché ritenuto necessario per otte-nere nella comunità i cambiamenti desiderati.Quando invece l’empowerment diventa l’obietti-vo dell’intervento, la tensione di coloro che sonocoinvolti nella progettazione è per lo più rivolta
alla costruzione e mobilitazione, attraverso pro-cessi partecipati, delle risorse interne ed esterne,che sono necessarie perché i soggetti della co-munità possano mettere in atto scelte autonomee responsabili: partecipazione e controllo suglieventi della propria vita rappresentano infatti glielementi costitutivi della definizione di promo-zione della salute proposta dall’Oms (Oms 1998).Coerentemente con l’impostazione seguita neidue approcci, per verificare l’impatto degli inter-venti, diversi saranno gli elementi che verrannoosservati e “misurati”.Nel primo caso verrà per-lopiù verificato il solo raggiungimento degli obiet-tivi di salute mentre le valutazioni di processo ren-diconteranno le azioni condotte (riunioni effet-tuate, collaborazioni attivate, ecc.) e, al più, si da-rà ragione delle informazioni acquisite o dellasoddisfazione dei partecipanti agli interventi.Me-no diffuse le esperienze di valutazione nel secondoapproccio e, quello che segue, sono i suggerimentiemersi dal documento prodotto dagli esperti del-la Conferenza di Nairobi e dalla letteratura delsettore.Visto che il processo per raggiungere gli obietti-vi di salute e quello per incrementare l’empo-werment sono due sentieri che variamente si in-trecciano, la prima indicazione che appare utileaccogliere è quella di individuare costantemente,nella progettazione e nella valutazione, elementi
EMPOWERMENT: MISURARECOSA CAPITA E PERCHÉ
di Patrizia Lemma*, Norma De Piccoli**, Mariella Di Pilato***, ClaudioTortone***,Alessandra D’Alfonso****
*Dipartimento di Sanità Pubblica Università diTorino**Dipartimento di Psicologia Università diTorino***Do.R.S. Regione Piemonte Centro di Documentazione per la Promozione della Salute****Asl Torino 2

osservabili che segnalino il progredire lungo i duepercorsi (Oms: Laverack 2009;Wallerstein 2006);solo così sarà infatti possibile cumulare conoscen-za sul ruolo svolto dallo sviluppo dell’empower-ment nel raggiungimento degli obiettivi di salu-te. Per quanto riguarda poi le indicazioni su qua-li possano essere gli elementi osservabili da moni-torare, la letteratura internazionale ha, negli ulti-mi anni, dedicato uno spazio crescente all’indivi-duazione di quegli elementi di capitale sociale edi quelle capacità che possono operativamente aiu-tare a delineare lo sviluppo dell’empowerment diuna comunità.Tra le esperienze più interessanti sipossono citare quella inglese (Morgan and Swann,2004) e quella australiana (Laverack, 2007). Nelprimo caso alcune aree (rete sociale, supporto so-ciale, coesione, partecipazione e impegno civico,fiducia, controllo e auto-efficacia, percezione dellivello di capitale sociale della comunità) vengo-no esplorate attraverso sia un questionario indivi-duale, sia indicatori ricavabili dai sistemi infor-mativi correnti.Nel secondo, alcuni domini (par-tecipazione comunitaria, capacità di analisi dei pro-blemi, capacità di ‘chiedersi perché’, gestione deiprogrammi, leadership locali, capacità di ricerca egestione delle risorse, collaborazioni con altri, re-lazioni con consulenti esterni, strutture organiz-zative) divengono, attraverso griglie di osservazio-ne, oggetto di valutazione partecipata da parte deidiversi attori sociali coinvolti negli interventi. Inentrambi i casi gli elementi in osservazione deri-vano da ampie revisioni bibliografiche che hannoindividuato gli elementi di capitale sociale, nel pri-mo caso, e di capacità nel secondo, più utilizzatiper costruire interventi di comunità tesi allo svi-luppo di empowerment, e che vanno quindi va-lutati nello svilupparsi del progetto.
MISURARE COSA CAPITAE PERCHÉ CAPITAAffermare che un insieme di azioni condotte conuna comunità siano state in grado di sviluppareempowerment richiede di poter descrivere “checosa sia accaduto”, in termini di effetti previsti o
non previsti, desiderabili o meno, in seguito allarealizzazione degli interventi predisposti per otte-nere un cambiamento dei livelli di “salute” nellacomunità in osservazione. In questo approcciomanca un elemento che è tradizionalmente pre-sente quando si affronta la valutazione all’internodei processi decisionali: il confronto rispetto aglieffetti attesi. Quelli che si confrontano sono in-fatti i presupposti stessi su cui si basa la valutazio-ne delle azioni avviate: da una parte il program-ma viene considerato come la risposta razionale aun problema adeguatamente investigato e com-preso, e la valutazione è lo strumento per ricon-durlo alle attese; dall’altra esso rappresenta inveceil “suggerimento” prescelto, perché considerato ilpiù adeguato per sviluppare le potenzialità pre-senti nell’insieme dato dalle persone e dal conte-sto, e la valutazione diviene allora lo strumento siaper cogliere dove e perché tale suggerimento èstato raccolto, sia per sostenere le scelte che si fa-ranno nel tempo (Pawson eTilley, 1997).Accogliere questa impostazione richiederà quin-di l’ammettere che, nel campo delle azioni di co-munità, per valutare l’efficacia degli interventi con-dotti sia necessario descrivere non solo ciò che sista introducendo nel sistema,quindi l’insieme del-le azioni condotte, ma anche quanto accade nel-l’interazione tra le differenti azioni messe in cam-po e i diversi elementi interni.Occorrerà cioè de-scrivere il continuo mutare dell’equilibrio inter-no del sistema e le condizioni in cui cause ester-ne e interne hanno agito.Aprire la “scatola nera”dell’intervento vorrà allora dire sì indagare sui nes-si causali che sostengono l’ipotesi di cambiamen-to, ma nella convinzione che in ogni situazione sidebba scoprire il modo particolare in cui un de-terminato programma può funzionare.Questo ri-chiederà anche accettare che, in ogni situazione,il legame tra un input (il programma di interven-to) e un risultato (lo sviluppo dell’empowerment)può essere ottenuto attraverso strade diverse, equindi anche non ottenuto, in relazione al modocon cui gli attori reagiranno al programma e co-me lo interpreteranno (Pawson eTilley, 1997).
Empowerment: misurare cosa capita e perché
91
IQU
AD
ERN
IDI

Per rilevare causalità bisognerà allora concentra-re l’attenzione sul processo d’incontro tra il pro-gramma di intervento, i diversi gruppi di perso-ne e i differenti contesti, per cercare di identifi-care i meccanismi che tra questi elementi si ven-gono a creare. L’obiettivo non sarà quindi piùquello di confermare, una volta per tutte, l’effica-cia di una determinata azione nel produrre il ri-sultato atteso, attraverso un definito meccanismo,ma ci si dovrà invece sforzare di capire perché,con un determinato gruppo di persone e in undeterminato contesto, in presenza di quell’inputsi sia ottenuto un certo risultato. L’attenzione sa-rà tutta centrata sul processo, alla ricerca dei mec-canismi che hanno prodotto quel risultato.
PERCHÉ MONITORAREVa da sé che la complessità del “sistema empo-werment” trovi una naturale conseguenza in unacomplessità metodologica che permetta di mo-nitorare e valutare, coerentemente con quanto af-fermato, sia i risultati ottenuti, sia i processi chehanno permesso il raggiungimento o meno deirisultati. Incidenza e prevalenza non costituisco-no infatti, a questo proposito, dei parametri suf-ficienti e, tra l’altro, potrebbero non essere iden-tificabili e misurabili nel breve periodo.Il monitoraggio, così come il processo di valuta-zione, non può, e non deve, basarsi solo su indi-catori oggettivamente reperibili e quantificabili,ma è altresì imprescindibile rilevare la percezio-ne dei risultati ottenuti e la valutazione che gliattori coinvolti danno dello stesso processo. Ri-cerca qualitativa e ricerca quantitativa, da-ti/indicatori oggettivi e dati/indicatori soggetti-vi costituiscono allora gli “ingredienti” a disposi-zione di un sistema di valutazione il più possibilepartecipato, che permetta di registrare i processi,i risultati ottenuti, le criticità rilevate, al fine dipoter riprogettare e rilanciare nuove iniziative fa-cendo tesoro dell’esperienza.Si tratta, in sintesi, di operare una valutazione par-tecipata. Questo non significa prescindere dall’u-tilizzo di strumenti e metodi qualificanti, ma è
necessario che questi siano anche funzionali a re-perire i risultati così come sono percepiti e a re-stituire la dinamicità del processo.Perché questo approccio? Proviamo a formula-re alcune risposte riprese da una recente lette-ratura:�perché riduce la resistenza alla valutazione (Bo-wers Andrews, 2004);
�perché può soddisfare le esigenze dei diversi at-tori sociali direttamente o indirettamente coin-volti, interessati a conoscere certi dati e non al-tri (chi è stato coinvolto? Quante persone? Qua-li gli effetti in termini di qualità della vita? Qua-li gli effetti in termini di sviluppo della parteci-pazione nella comunità? Quali effetti, ad esem-pio, in termini di ricaduta indiretta per i servi-zi socio-sanitari?) (Bowers Andrews, op. cit.);
�perché aiuta a creare una cultura della valuta-zione all’interno di una organizzazione o di unacomunità (Fetterman, 2002) contribuendo a svi-luppare una maggiore capacità analitica a com-prendere, generare e utilizzare l’evidenza (Carr,Lhussier,Wilkinson, Gleadhill, 2008).Infine, prendendo spunto dalle riflessioni svilup-pate da Fetterman (2002), Weaver e Cousins(2004), Carr, Lhussier,Wilkinson e Gleadhill(2008), le ragioni per assumere una valutazionedell’empowerment hanno una triplice valenza:�pratica, nel senso che si basa sugli aspetti prag-matici dei professionisti coinvolti;
�politica, nel senso che si prefigge anche di of-frire un mezzo ai politici e ai funzionari prepo-sti alla promozione della salute nella comunitàdi partecipare al dibattito locale strategico;
�epistemologica, poiché pone un focus parti-colare sulla conoscenza relativa al contesto del-la valutazione.In sintesi, rilevano gli autori, la valutazione par-tecipata racchiude in sé elementi sia pragmaticisia trasformativi, con l’obiettivo, tra gli altri, di da-re pieni poteri ai professionisti di comprendere eprodurre evidenza.Inoltre, in aggiunta alle considerazioni sin qui ri-prese, si deve considerare che le iniziative di em-
IL SISTEMA SANITARIO E L’EMPOWERMENT
92
IQU
AD
ERN
IDI

powerment sono intrinsecamente situate e con-testualizzate. La valutazione di un processo di em-powerment deve quindi obbligatoriamente esse-re una valutazione situata, che consideri anche lecaratteristiche contestuali. Deve inoltre rintrac-ciare le basi di un’epistemologia della ricerca scien-tifica che non si propone né la possibilità di unageneralizzazione dei dati, né di una loro applica-bilità secondo un riduzionismo causa-effetto. L’o-biettivo non è quello di postulare forze ed entitàche esistono indipendentemente dal punto di vi-sta degli investigatori. Bensì il valore della cono-scenza su cui si basa questo tipo di indagine è nel-la sua ricchezza descrittiva, nell’utilità esplicativae nella robustezza concettuale, piuttosto che nel-la sua indipendenza situazionale, nella sua abilitàdi dimostrare un fatto generale e nella sua gene-ralizzabilità dei risultati: il tutto secondo una pro-cessualità partecipata.Poiché, parafrasando Habermas (1986), l’accesso
ai fatti è fornito dalla comprensione del signifi-cato, è pertanto necessario che tutte le fasi di em-powerment, dalla sua attivazione ai cicli di valu-tazione (in itinere e finale), siano co-partecipatesecondo una modalità dialogica:“ogni processo conoscitivo è un impegno di trasforma-zione della realtà da parte dell’uomo. I significati cheemergono nel corso di esso, cioè i concetti, delineanonuovi metodi di trasformazione e di operazione in vi-sta di rendere la realtà più conforme agli scopi umani”(Dewey, 1961).
COME MONITORAREA partire dall’impianto teorico prima delineato èpossibile proporre un percorso metodologico, ar-ticolato in più fasi, che abbia come finalità la va-lutazione di processi di empowerment (vedi ta-bella 1). Individuato un insieme di progetti di pre-venzione e promozione della salute, che dichiari-no di perseguire obiettivi di salute adottando stra-
Empowerment: misurare cosa capita e perché
93
IQU
AD
ERN
IDI
TABELLA 1 - Gli obiettivi di un possibile percorso metodologico
OBIETTIVO GENERALEValutare il modificarsi dell’empowerment di una comunità in seguito ad interventi di promozione della salute, condividendo e sistematizzando con gli operato-ri i risultati.OBIETTIVO SPECIFICO 1Mettere a punto, a partire dalle principali esperienze internazionali e nazionali, un set di strumenti utili all’osservazione dei cambiamenti dell’empowerment diuna comunità.Attività 1 - Individuare nella letteratura internazionale e nazionale le esperienze di osservazione dei cambiamenti di empowerment di una comunità con i rela-tivi strumenti utilizzati.Attività 2 - Definire, tenendo conto delle specificità del contesto sociale in studio, gli strumenti che verranno utilizzati.Attività 3 - Sottoporre gli strumenti al giudizio di idoneità (al panel di esperti) e di appropriatezza e fruibilità (al panel di operatori e di cittadini).OBIETTIVO SPECIFICO 2Valutare nella comunità coinvolta nell’intervento il modificarsi del capitale sociale e il livello di capacità possedute.Attività 1 - Definizione dei criteri di selezione e individuazione dei progetti che verranno sottoposti ad osservazione e per ciascun progetto.Attività 2 - Raccolta delle informazioni necessarie all’analisi del contesto in cui si conducono gli interventi.Attività 3 - Conduzione di interviste narrative, di focus group e somministrazione di questionari che permettano di ricostruire gli elementi di capitale socialedella comunità coinvolta nell’intervento.Attività 4 - Conduzione di laboratori che coinvolgono responsabili e operatori del progetto, con opinion leader e rappresentanti dei cittadini della comunitàper verificare il cambiamento in termini di sviluppo di capacità.OBIETTIVO SPECIFICO 3Produrre la documentazione descrittiva degli interventi effettuati e dei processi e risultati osservati sia in termini di sviluppo di empowerment sia in termini diimpatto sulla saluteAttività 1 - Descrivere sinteticamente gli interventi effettuati, i processi e i risultati osservati.Attività 2 - Proporre ipotesi sui possibili meccanismi che hanno sostenuto o ostacolato processi e risultati descritti.Attività 3 - Sottoporre la documentazione descrittiva al giudizio di completezza (panel esperti) e di appropriatezza e fruibilità (panel di operatori e cittadini).OBIETTIVO SPECIFICO 4Costruire un sito web che permetta di condividere i risultati del progetto e di trasferire la metodologia utilizzataAttività 1 - Progettazione della struttura e dei contenuti in base al target dei diversi fruitori (cittadini, operatori, decisori).Attività 2 - Pubblicazione del sito web e studio e valutazione di fruibilità.OBIETTIVO SPECIFICO 5Costruire raccomandazioni e linee guida per l’osservazione e la valutazione dei processi di empowermentAttività 1 - Redigere raccomandazioni con il coinvolgimento di tutti i principali soggetti.Attività 2 - Sottoporre le raccomandazioni al giudizio di idoneità (al panel di esperti) e di appropriatezza e fruibilità (al panel di operatori e di cittadini).Attività 3 - Redigere, condividere e diffondere con i decisori e gli operatori del settore il prodotto finale (pianificazione delle strategie di comunicazione).

tegie di sviluppo di “empowerment”, se ne osser-verà e descriverà sia il processo che l’impatto. Perciascun progetto selezionato si prevedono:a) momenti di confronto con i responsabili e glioperatori del progetto, con opinion leader erappresentanti dei cittadini della comunità co-involta nel progetto, per verificare il cambia-mento in termini di sviluppo di capacità (at-traverso griglie di riferimento) e di impatto sul-la salute;
b) interviste narrative, focus group e questionariper ricostruire gli elementi di capitale socialedella comunità coinvolta nell’intervento, ac-cresciuti o modificati durante l’intervento;
c) analisi del contesto attraverso le informazioniraccolte;
d)produzione della documentazione descrittiva
degli interventi effettuati, dei processi e risul-tati osservati, sia in termini di sviluppo di em-powerment sia di impatto sulla salute.
Questo nella convinzione che:� l’avvio del processo di accumulo di conoscenzeintorno alle azioni utili a sostenere lo sviluppodi empowerment delle comunità e alla loro va-lutazione, si debba sviluppare mettendo in co-mune “buone pratiche” che permettano il con-fronto fra i decisori, i professionisti e la comu-nità locale;
� la valutazione partecipata in un processo di em-powerment è conditio sine qua non per sviluppa-re “buone pratiche”;
� l’interazione, riflessione e apprendimento favo-risce lo sviluppo della partecipazione attiva (Frei-re, 1972).
IL SISTEMA SANITARIO E L’EMPOWERMENT
94
IQU
AD
ERN
IDI
BIBLIOGRAFIA• Bowers Andrews A. (2004), Start at the end: empowermentevaluation product planning. Evaluation and Program Planning,27, 275-285.
• Carr S.M., Lhussier M., Wilkinson J., Gleadhill S. (2008), Em-powerment evaluation applied to public health practice, in Cri-tical Public Health, 18, 2, 161-174.
• Dewey J. (1961),Democrazia ed educazione, Firenze, La Nuo-va Italia (ed. or. 1917).
• Fetterman D.M. (2002), Empowerment Evaluation: BuildingCommunities of Practice and a Culture of Learning, in Ameri-can Journal of Community Psychology, 30, 1, 89-102.
• Fetterman (2005),Empowerment evaluation, principles in prac-tice, London: Guilford Press.
• Freire P. (1972), Pedagogia degli oppressi, Milano, Mondado-ri, (ed. or. 1970).
• Habermas J. (1986), Teoria dell'agire comunicativo, Bologna, IlMulino (ed. or. 1981).
• Laverack (2007), Building empowered communities, London:Open University Press.
• Laverack G. (2009), Community Empowerment ConferenceWorking Document, Nairobi 7 th Global Conference onHealth Promotion,Who (www.who.int/healthpromotion/conferences/7gchp/documents/en/index.html).
• Morgan and Swann (2004), Social capital for health: issues ofdefinition, measurement and link for health, London: HealthDevelopment Agency.
• Pawson e Tilley (1997), Realistic evaluation, London, Sage.• Robson C. (2000), Small-scale evaluation: Principles of practi-ce, London, Sage.
• Wallerstein N. (2006),What is the evidence on effectivenessof empowerment to improve health?, Copenhagen, Who Re-gional Office for Europe (Health Evidence Network report;http://www.euro.who.int/ Document/E88086.pdf).
• Weaver L., Cousin J.B. (2004), Unpacking the participatoryprocess. Journal of multidisciplinary evaluation, 1, 19-40.

95
iQua
dern
idi
L’Organizzazione mondiale della sanitàidentifica l’azione nella comunità e l’em-powerment come prerequisiti per la sa-lute2. L’empowerment dei cittadini in
generale,ma anche relativamente alla salute, ha ri-cevuto crescente attenzione da parte delle istitu-zioni negli ultimi anni a livello internazionale, con-tribuendo a creare una nuova cultura che poggiasulla partecipazione, essenziale per conseguire i ri-sultati migliori possibili.Molteplici fattori hannostimolato tale sviluppo; per quanto riguarda la sa-nità particolarmente importante è stato il crescenteimpegno delle associazioni di volontariato e di tu-tela dei cittadini e dei pazienti.Stanno progressivamente aumentando le oppor-tunità di confronto tra le esperienze maturate, fa-vorendo il reciproco apprendimento. Inoltre, lasistematizzazione delle conoscenze che vengonoprodotte rispetto ad approcci,metodi e strumen-ti stimola la ricerca anche in questo ambito.Come in tutti i processi, anche per quanto ri-guarda l’empowerment, per assicurare efficacia edefficienza è necessario controllare e valutare al fi-ne di rendere conto (accountability delle scelte e
delle azioni intraprese), identificare gli ambiti dimiglioramento e le aree su cui effettuare ricerca.Nel presente contributo viene proposto un ap-proccio alla valutazione dell’empowerment ed al-cune indicazioni per lo sviluppo della stessa.
EMPOWERMENTPer delineare un approccio valutativo va in primoluogo definito il fenomeno oggetto di valutazione.Il concetto di “empowerment” ha avuto moltepli-ci definizioni, in relazione alla sua applicazione edai soggetti a cui è stato applicato,si citano le seguenti:a) un processo attraverso cui le persone, le orga-nizzazioni e le comunità acquisiscono la capa-cità di gestire i loro affari3;
b)un processo di azione sociale attraverso cui gliindividui, le comunità e le organizzazioni pa-droneggiano le loro vite per cambiare il loroambiente sociale e politico per migliorare l’e-quità e la qualità di vita4;
c) il processo attraverso cui gli individui e i grup-pi aumentano la loro capacità di fare scelte etrasformare tali scelte nelle azioni e nei risulta-ti desiderati, costruendo le risorse delle perso-
LA VALUTAZIONEDELL’EMPOWERMENT:PROSPETTIVE
di Piera PolettiCeref1 - Padova
1 Ceref - Centro Ricerca e Formazione- Padova, ESQH Office for Patient involvement; Membro del direttivo SIQuASVRQ, Membro dello Strategic Advisory Board dell’Interna-tional Forum for Quality & Safety (IHI & BMJ).
2 Canadian Public Health Association, Health andWelfare Canada,World Health Organization. Ottawa Charter for Health Promotion.Adopted at an International Conferenceon Health Promotion,The Move Towards A New Public Health, Ottawa, 17–21 November,1986;World Health Organization.The Jakarta Declaration on Leading Health Pro-motion into the 21st Century. Fourth International Conference on Health Promotion. Jakarta.
3 Rappaport J., Terms of empowerment/exemplars of prevention: toward a theory for community psychology, in American Journal of Community Psychology, 1987, 15(2):121–148.4 Wallerstein N., Powerlessness, empowerment, and health: implications for health promotion programs, in American Journal of Health Promotion, 1992, 6(3):197–205.
Guardare, ascoltare, riflettere, apprendere,cambiare per crescere... e poi ricominciare

ne e migliorando così l’efficienza del contestoin cui vengono usate tali potenzialità5;
d) l’espansione delle possibilità delle persone po-vere di partecipare, negoziare, controllare e ge-stire le istituzioni che influenzano le loro vite6;
e) l’empowerment viene esercitato in diversi do-mini, dal livello di singola persona ad azionepolitica e collettiva7.
Secondo Saltman & Figueras8, i cittadini empowe-red devono potersi esprimere rispetto alla sceltadel proprio medico e dell’ospedale a cui rivol-gersi; la propria cura (decisione clinica condivi-sa); la politica locale dei servizi per la salute. PerStrauss & Corbin9 si tratta di un concetto strati-ficato in corrispondenza ai diversi livelli della so-cietà: micro, meso, macro, che configurano i di-versi livelli di rapporto:medico-paziente, utenti-enti erogatori, comunità-scelte di politica sanita-ria. L’empowerment è quindi un concetto di cre-scita della progettualità e del protagonismo indi-viduale e collettivo profondamente radicato nel-la cultura di una società e pertanto deve essere sti-molato e sostenuto nelle singole realtà con pienaconsapevolezza del contesto.Con riferimento al singolo individuo, nella faci-litazione del processo di empowerment va tenu-to presente che la persona si rapporta con la suasalute in modo attivo o passivo, in relazione ad al-cune caratteristiche della sua storia e della sua per-sonalità, ed in particolare vanno considerati il suolocus of control, l’abilità nell’assumere decisioni– anche in relazione alla capacità di affrontare l’in-certezza e il rischio per quanto riguarda l’inte-grità del sé, la sua percezione di auto efficacia10,il livello di comprensione linguistica. Speer & Hu-
ghey enfatizzano come l’empowerment sia unprocesso dinamico tra l’acquisizione di un con-trollo interno e l’abilità nel superare le barriereesterne nell’accesso alle risorse11.Per Funnell et al12 i pazienti sono empowered quan-do hanno la conoscenza, le abilità, le attitudini ela consapevolezza necessaria per influenzare il pro-prio e l’altrui comportamento per migliorare laqualità della propria vita.Un paziente “empowered”13 è una persona checomprende e sceglie, è in controllo dell’ambien-te con cui interagisce e si rapporta produttiva-mente con tutti gli altri soggetti, pianifica per ilfuturo, è il proprio case manager, è un self care-giver, un manager dei propri stili di vita, prota-gonista attivo della propria vita e del proprio be-nessere, che interagisce in forma proattiva. Perconseguire tale risultato, i servizi debbono accer-tare le aspettative e le priorità dei pazienti; coin-volgere i pazienti nei propri piani di cura e assi-stenza ed utilizzare l’approccio della decisionecondivisa, richiedere il loro feedback anche suiservizi ed avviare conseguenti processi di miglio-ramento.Roberts14 sottolinea il fatto che per molti pazientiessere empowered significa solo essere più infor-mati sulle proprie condizioni, mentre altri vo-gliono avere pieno controllo delle decisioni cli-niche che li riguardano.Thompson15 propone unatassonomia che parte dal non coinvolgimento perarrivare alla piena autonomia. Lo stesso autore de-scrive le seguenti motivazioni per il coinvolgi-mento: a) diritto della persona basato su ragionimorali, politiche, sociali ed economiche; b) la co-noscenza da parte della persona della propria si-
IL SISTEMA SANITARIO E L’EMPOWERMENT
96
IQU
AD
ERN
IDI
5 What is empowerment?,TheWorld Bank, 2005, (http://web.worldbank.org/ content accessed March 25, 2007).6 Narayan D., Empowerment and poverty reduction: a sourcebook,Washington,World Bank, 2002.7 Laverack G.,Health promotion practice: power and empowerment, London, Sage Publications, 2004; Labonte R.,Health promotion and empowerment: reflections on professional practi-ce, in Health Education Quarterly, 1994, 21(2):253–268.
8 Saltman R. B., Figueras J, European Health Care Reform,Who Europe, 1997.9 Strauss, Corbin, Basic of qualitative research: grounded theory procedures and techniques, Sage, Newbury Park (CA), 1990.10 Bandura A., Self-efficacy: the exercise of control, NewYork,WH Freeman, 1997.11 Speer PW, Hughey J., Community organizing: an ecological route to empowerment and power, in American Journal of Community Psychology, 1995, 23(5):729–748.12 Funnell MM,Anderson RM,Arnold MS et al., Empowerment: an Idea whose time has come in Diabetes Education, in The Diabetes Educator, 1991; 17: 37-41.13 Poletti P., Patient empowerment & the discrepancy between patients’ rights and reality. European Health Forum Gastein 2004; 245-252.14 Roberts JFL, Patient empowerment in the United States: a critical commentary, in Health Expectations 1999; 2: 82-92.15 Thompson A.,Motivated for Involvement? Citizen Participation in Health Care. Research Briefing 2002; 1-4.

tuazione e la capacità quindi di concorrere allapropria cura; c) il desiderio di controllare il pro-cesso di cura.Non è una questione esclusivamentedi un passaggio di potere16, ma una simbiosi, tesaa produrre un processo di cura più efficace, attra-verso la reciprocità tra operatore ed utente.Una disamina delle metodologie di partecipazio-ne e della loro efficacia dimostrata è stata effet-tuata da Coulter e Ellins17 sulla scorta della revi-sione della letteratura, specialmente per quantoriguarda l’informazione e l’assunzione di deci-sioni da parte dei pazienti.Analizzando l’applica-zione del concetto di empowerment, dalla revi-sione di Aujoulat et al18 emerge che gli obiettividebbono riguardare lo sviluppo o il rinforzo diabilità psico-sociali, debbono essere definiti conil paziente e considerare la sua specifica situazio-ne e priorità; le metodologie educative debbonoessere esperienziali e la relazione tra operatore epaziente deve essere continua e coinvolgente daentrambe le parti.La diversità delle persone può fornire un alibi acoloro i quali tutt’oggi ritengono che la personanon vada coinvolta, sostenendo che la maggiorparte delle persone non vogliano esserlo (oltre anon essere competenti rispetto alle problemati-che sanitarie) e preferiscono delegare agli esper-ti. Anderson e Funnell19 evidenziano come l’em-powerment richieda ai professionisti un cambiodel paradigma nell’operatività e nel rapporto conil paziente, molto difficile da effettuare.In sintesi, la facilitazione dell’empowerment del-la singola persona assicura:� l’efficacia, a cui concorrono cittadini e operato-ri. Il cittadino pertanto: i. assume comportamenticonsapevoli, anche dei rischi; ii. segnala al per-sonale sanitario situazioni e comportamenti chepossono implicare rischi, in modo da favorirescelte terapeutiche appropriate; iii. pone do-mande in modo da assumere scelte idonee; iv.
avendo fiducia nella equipe con cui ha instau-rato un rapporto di collaborazione, ascolta e se-gue le prescrizioni e segnala situazioni percepi-te come diverse e non conformi; v. assume la re-sponsabilità delle proprie scelte, sviluppa auto-nomia decisionale;
� l’appropriatezza: la conoscenza del fruitore con-sente agli operatori di effettuare scelte idonee;
� l’efficienza: Scelte mirate ed idonee favorisconol’utilizzo parsimonioso delle risorse, evitando ri-dondanze e sprechi.L’empowerment implica responsabilità verso sestessi e corresponsabilità negli interventi per lapropria salute e nell’uso delle risorse collettive(empowerment nella dimensione istituzionale edi politica sanitaria).
UN MODELLO PER LAVALUTAZIONEDELL’EMPOWERMENTPrima di delineare un modello per la valutazio-ne, è necessario chiarire lo scopo della valutazio-ne dei processi di empowerment. Oltre che perrendere conto delle scelte, delle attività svolte edelle risorse investite, i risultati del processo va-lutativo devono indicare la strada per il migliora-mento continuo della qualità e della sicurezza de-gli interventi e dei servizi sanitari.Nella progettazione della valutazione dell’em-powerment vanno considerate tutte le dimen-sioni del processo valutativo, in relazione alle di-verse fasi: progettazione, applicazione (raccoltaed elaborazione dei dati), conclusione (interpre-tazione dei risultati) e formulazione del giudizio(ed eventuali inferenze).Nella progettazione van-no scelti: le variabili da valutare (il modello diempowerment), gli indicatori relativi, i metodidi rilevazione dei dati, le modalità di elaborazio-ne dei dati e i criteri di valutazione, in relazioneagli standard. Il processo di controllo va quindideclinato in base ai momenti in cui viene appli-
La valutazione dell’Empowerment: Prospettive
97
IQU
AD
ERN
IDI
16 McKay B, Forbes JA, Bourner K., Empowerment in general practice: the trilogies of caring, in Australian Family Physician, 1990; 19: 513-520.17 Coulter A, Ellins J, Effectiveness of strategies for informing, educating, and involving patients, in BMJ 2007;335:24-27 (7 July).18 Aujoulat I, d’HooreW, Deccache A, Patient empowerment in theory and practice: Polysemy or cacophony?, in Patient Education and Counseling, 66, 1, 13-20.19 Anderson R M, Funnell MM, Patient empowerment: reflections on the challenge of fostering the adoption of a new paradigm, in Patient Education and Counseling, 57 (2005) 153–157.

cato, e cioè: a) prima di implementare un’attivi-tà, un progetto:Valutazione prospettica; b) du-rante l’applicazione di un’attività, di un proget-to:Verifica funzionale/monitoraggio; c)Valuta-zione finale ed inferenziale; d)Valutazione d’im-patto.In ogni fase vanno considerati gli scopi della va-lutazione, i soggetti coinvolti nel processo, i tem-pi e i metodi della raccolta dei dati. Per la valu-tazione è fondamentale la disponibilità di un per-tinente, mirato e specifico sistema informativo,definito come l’insieme dei soggetti, delle strut-ture, degli strumenti e delle procedure aventi perscopo la rilevazione, l’elaborazione e la diffusio-ne dei dati.Il quadro che segue (Fig. 1) offre una visione ge-nerale del sistema, che dovrà essere declinata perogni specifica situazione.
La valutazione deve tenere in considerazione seil processo di facilitazione dell’empowerment ri-guarda:a) la singola persona in un processo di prevenzio-ne, diagnosi precoce, cura o riabilitazione e seciò riguarda il coinvolgimento (informazione,scelta, educazione) oppure la partecipazione so-ciale, ossia il suo contributo al miglioramentodei servizi (valutazione dei servizi, partecipa-zione a progetti di miglioramento) o la parte-cipazione alle scelte generali di politica sanita-ria (consultazioni, comitati, assemblee);
b)un gruppo/associazione per la partecipazioneai processi di miglioramento a livello istituzio-nale o nella più ampia programmazione sani-taria;
c) la popolazione, relativamente ai processi pro-grammatori e di valutazione.
IL SISTEMA SANITARIO E L’EMPOWERMENT
98
IQU
AD
ERN
IDI
Persone
Gruppi/associazioni
• normativaoperatoriculturadell’empowermentmezzi e strumenti
••
•
- analisi del contesto
- analisi dei bisogni
- progettazione degli interventi
- organizzazione degli interventi
- erogazione degli interventi
- valutazione
- processi decisionali
- gestione del sistema informativo
- formazione degli operatori
- gestione della conoscenza
- sviluppo / miglioramento
Verifica funzionale / monitoraggio
Risorse /INPUT
Prodotti /OUTPUT
Valutazione finale
Processi
Interventi di:
• informazione• educazione / formazione• coinvolgimentonei processi decisionali
• coinvolgimentonei processidi miglioramento
• coinvolgimentonei processi valutativi
Livelli di progettualità dei singoli e della comunità
Impatto: processoUtilizzo dei risultati dell’empowerment
per migliorare
Impatto: esiti
Stabilità dei comportamentiProgettualità
Valutare l’empowerment
EsitiLivelli di empowerment:scelte e comportamenti
Valutazione di impatto
Comunità
FIGURA 1 - Visione di sistema per la valutazione dell’empowerment

Il modello di valutazione dei processi di empo-werment è multidimensionale, riguarda cioè i di-versi assi.1. Scopoa. Singola persona• Propria salute1. Promozione/educazione a stili di vita2. Adesione allo screening3. Cura/riabilitazione4. Autocuraa. Singolo episodiodi cura/riabilitazione
b. Cronicità•• Partecipazione sociale1. Contributo al miglioramentodei servizia. Feedback (focus group, questionari)
2. Partecipazione alla programmazio-ne/valutazione delle politiche sani-tariea. Comitati/gruppi di consultazione esviluppo
b. Incontri per:- Programmazione- Valutazione - Bilancio sociale
b. Gruppo• Partecipazione sociale1. Comitati/Gruppi di consultazione esviluppo
c. Popolazione• Partecipazione sociale1. Programmazionea. Collaborazione alle scelteb. Valutazione delle scelte program-matiche
2. Valutazione della politica sanitaria
2. ProcessoLa valutazione deve accompagnare i processi diempowerment, sin dalla fase di progettazione de-gli interventi e considerare:- risorse-processi-prestazioni
3. RisultatiMolto complessa è la valutazione degli esiti, so-prattutto per quanto riguarda la loro stabilità neltempo. I processi di empowerment dovrebberoportare infatti al protagonismo ed alla progettua-lità delle persone, alla responsabilizzazione rispettoa se stessi o ai processi sociali complessivi, che de-vono pertanto rimanere nel tempo.a. Risultati/esiti.b. Impiego dei risultati per il miglioramento e losviluppo. Nella valutazione va anche conside-rato come i risultati dei processi di valutazionevengano utilizzati nelle istituzioni per miglio-rare i processi di empowerment e, più in ge-nerale, le istituzioni stesse.
Va sottolineata l’importanza di utilizzare un ap-proccio sistemico alla valutazione,perché per com-prendere un aspetto è necessario inserirlo nelcomplesso degli elementi da cui è influenzato edanalizzare il sistema nel contesto più generale, conparticolare attenzione alla cultura della parteci-pazione.
Indicatori e standardIn relazione alle variabili del modello di empo-werment oggetto di valutazione è necessario iden-tificare appropriati indicatori.Volendo valutareun’azienda sanitaria sarà utile identificare se l’em-powerment fa parte della politica aziendale ed èquindi trasversale a tutte le unità operative op-pure se dipende dalla buona volontà di qualchedirigente o coordinatore; se le azioni sono occa-sionali o parte integrante di tutti i processi, se ri-guardano solo le singole persone relativamente aiprocessi di cura o considerano anche la parteci-pazione sociale ai processi di miglioramento e svi-luppo dei servizi, alle scelte di programmazione;se, infine, le azioni si rivolgono anche alle asso-ciazioni (la cui partecipazione è peraltro previstadal decreto legislativo 229 del 1999) e più in ge-nerale alla comunità.A livello esemplificativo si riportano i seguentiindicatori:a) risorse
La valutazione dell’Empowerment: Prospettive
99
IQU
AD
ERN
IDI

- n.medio di ore per operatore dedicate alla for-mazione per l’empowerment / n.medio delle oreper operatore dedicate alla formazione nell’anno
- n. operatori impegnati nell’empowerment/ n.operatori
- n. di riviste con contenuti relativi all’empo-werment / totale riviste disponibili in abbona-mento aziendale
b)processo- n.di incontri pubblici finalizzati al coinvolgimen-to / totale interventi aperti al pubblico nell’anno
- n. medio equivalente di ore operatore dedica-te all’empowerment / n. medio ore operatorelavorate nell’anno
- n. pazienti nella cui documentazione clinica fi-gura la registrazione di attività finalizzate al-l’empowerment / totale pazienti dell’unità ope-rativa nell’anno
c) esito- n. di pazienti che sono in grado di gestire inautonomia la propria condizione alla dimissio-ne / n. di pazienti con analoga condizione cli-nica nell’anno
- n. di richieste di follow-up informativo telefo-nico, con accesso diretto all’unità operativa daparte di pazienti dimessi (o loro famigliari) / n.di pazienti dimessi nell’anno
- n. di pazienti che compilano i questionari pro-posti / n. di pazienti nell’anno
Il processo di valutazione si conclude con un giu-dizio che si dovrebbe basare sul confronto tra lasituazione analizzata (dati raccolti con riferimen-to agli indicatori scelti) e gli standard di riferi-mento (come ci si aspettava dovesse essere la si-tuazione). Si rende necessario, nel momento incui si scelgono gli indicatori, stabilire anche i re-lativi standard che dovrebbero fare riferimentoalla letteratura e considerare lo specifico conte-sto.Vanno, quindi, scelte le elaborazioni da effet-tuare sui dati e le relative modalità di rappresen-tazione, al fine di facilitare l’interpretazione e laformulazione dei giudizi.
Metodi e strumentiTra le metodologie, qualitative e quantitative, perla raccolta dei dati utili per la valutazione del-l’empowerment, da scegliere in relazione agliobiettivi conoscitivi ed alla loro efficacia diffe-renziale, ma anche alla fattibilità, si citano:a) analisi di documentazione: • Dati clinici, assisten-ziali, educativi, gestionali, amministrativi;•• Fotografie, video
b) indagini: • Interviste; •• Focus group; ••• Que-stionari; Delphi
c) osservazioned) studio di casi
Elaborazioneed interpretazione dei datiLa tecnica statistica da utilizzare per l’elaborazio-ne dei dati va accuratamente scelta in relazione almodello ed alle variabili, con riferimento agli sco-pi. Si intende qui sottolineare l’importanza masoprattutto la strumentalità della tecnica, laddovetalvolta vengono applicate tecniche sofisticate sen-za una effettiva scelta da parte di chi ha promos-so ed effettuato la valutazione e che deve inter-pretare i risultati.Vanno identificate con cura an-che le modalità di rappresentazione (diagrammie tabelle), in relazione ai fini e ai destinatari deirisultati.
Soggetti valutatoriLa valutazione è un processo complesso e con va-lore anche educativo e formativo, quindi è utilecoinvolgere tutti i soggetti che concorrono (nelcaso della verifica funzionale) o hanno preso par-te al processo di empowerment,ma anche chi di-rige e chi sceglie le politiche, sia per assicurareche tutti gli elementi vengano considerati, che perfavorire il successivo utilizzo dei risultati per ilmiglioramento. È importante anche riconoscerele implicazioni e le difficoltà per chi facilita i pro-cessi di empowerment ed è necessario creare lecondizioni migliori perché ciò avvenga; soltantoinfatti se gli operatori sono a proprio agio nel-l’applicazione del processo lo stesso sarà efficace.
IL SISTEMA SANITARIO E L’EMPOWERMENT
100
IQU
AD
ERN
IDI

La formulazione dei giudiziLa formulazione dei giudizi non è soltanto l’esi-to di un confronto tra dati, ma richiede l’inter-pretazione degli stessi e l’identificazione dei fat-tori che hanno concorso ai risultati positivi e del-le cause e fattori contribuenti delle situazioni cri-tiche, al fine di poter identificare le leve per il mi-glioramento e nel contempo far crescere la cul-tura dell’empowerment e della sua valutazione.
Il sistemaDa non trascurare è la valutazione dell’impattodei processi di empowerment sul sistema sanita-rio, considerando sia il rapporto costi-benefici(diretti e indiretti), sia lo sviluppo della culturaorganizzativa ad essi associato e l’apprendimentocondiviso.
CONCLUSIONILa sensibilità per la valutazione dell’empower-ment sta diffondendosi, come evidenziato anchedalle esperienze italiane presenti negli altri arti-coli pubblicati in questo numero dei Quaderni diMonitor.A livello internazionale l’impegno per la valuta-zione sta acquisendo sempre maggiore attenzio-ne, anche se le esperienze sono ancora limitate esi rivolgono, in particolare, alla valutazione del-l’apprendimento per lo sviluppo delle capacità di
autocura da parte del singolo paziente, soprattut-to per le patologie croniche.A tal proposito si ci-tano, ad esempio, il lavoro di Alegría et al.20, fina-lizzato ad incrementare l’adesione al trattamentoe la permanenza nello stesso da parte di pazientipsichiatrici; sempre con la stessa tipologia di pa-zienti, Cortes et al.21 hanno sviluppato invecel’empowerment per le decisioni di cura.È necessario investire nella valutazione delle espe-rienze e nella costruzione di una specifica “cul-tura della valutazione dell’empowerment”, anchecon il contributo della ricerca, per lo sviluppo diconoscenze relative sia al contenuto (cosa valuta-re?) che al metodo (chi, come, quando), metten-do in evidenza i fattori di contesto, di processo(considerando i costi dell’empowerment ma an-che della valutazione dello stesso) e l’impatto.Vaprestata attenzione costante ai fini dell’empo-werment e della sua valutazione ed utilizzato unapproccio sistemico, che consideri tutte le di-mensioni nella triangolazione istituzioni, opera-tori, comunità (cittadini, pazienti, associazioni),nella consapevolezza della corresponsabilità e del-l’importanza della collaborazione e della traspa-renza.
La pura e semplice veritàraramente è pura e mai semplice(O.Wilde)
La valutazione dell’Empowerment: Prospettive
101
IQU
AD
ERN
IDI
20 Alegría M, Polo A, Gao S, Santana L, Rothstein D, Jimenez A, Hunter ML, Mendieta F, OddoV, Normand SL., Evaluation of a patient activation and empowerment intervention inmental health care, Med Care. 2008 Mar;46(3):247-56.
21 Cortes DE, Mulvaney-Day N, Fortuna L, Reinfeld S,Alegría M. Patient-provider communication: understanding the role of patient activation for Latinos in mental health treat-ment. Health Educ Behav. 2009 Feb;36(1):138-54.

IL SISTEMA SANITARIO E L’EMPOWERMENT
102
iQua
dern
idi I
l tema di quest’articolo è il rapporto tra em-powerment nella salute e valutazione degli in-terventi di promozione della salute. I due ar-gomenti che si vuole far reagire rappresenta-
no altrettanti punti critici nel settore della pro-mozione della salute; il primo ne costituisce in-fatti il contenuto principale laddove si intenda lapromozione della salute come l’insieme delle at-tività organizzate volte ad aumentare il controllodelle persone e delle comunità sui determinantidella propria salute al fine di proteggerla e mi-gliorarla; il secondo tema, che ha a che fare es-senzialmente con la possibilità di produrre unaconoscenza valida ed attendibile sul cambiamen-to determinato dalle azioni di promozione dellasalute, ha al suo interno aspetti epistemologici emetodologici del tutto peculiari rispetto al mo-do in cui viene tradizionalmente concepita la va-lutazione nelle discipline biosanitarie. Lo svolgi-mento del tema verrà quindi affrontato fissandoprima di tutto alcuni riferimenti sulla promozio-ne della salute nel suo attuale sviluppo tematicoe organizzativo, all’interno di questa parte si cer-cherà di offrire anche un quadro di riferimentoconcettuale al tema dell’empowerment per la sa-lute. Successivamente si discuteranno gli elementiprincipali sui quali oggi si articola il dibattito scien-
tifico e culturale sulla valutazione in promozio-ne della salute e che ne esplicitano la natura deltutto peculiare rispetto al resto della sanità pub-blica. Queste due parti offriranno lo spunto persperimentare, poi, gli esiti della “reazione” tra l’ap-proccio valutativo in promozione della salute e ilconcetto di empowerment, individuando i duepoli del problema nell’approccio costituito daimetodi partecipativi e da quello rappresentatodall’“Empowerment Evaluation”.
PROMOZIONE DELLA SALUTE: QUADRODI RIFERIMENTO CONCETTUALEORGANIZZATIVOLa promozione della salute rappresenta ormai lafilosofia guida e la strategia cardine delle azionirivolte alla salute delle comunità.Ne fa fede l’am-plissima produzione di letteratura scientifica e ilconsolidato orientamento dei principali atti dipolitica sanitaria, quali i recenti Piani Sanitari Na-zionali e il documento strategico “Guadagnare inSalute”1.A partire dalla visione olistica della persona e dauna visione della salute come equilibrio dinami-co in perenne sviluppo (Fig. 1), essa fornisce i ri-ferimenti strategici per le diverse condizioni cheinteressano la salute delle persone:“sane” o “ma-
EMPOWER(ING)MENT EVALUATIONValutare in promozione della saluteper produrre salute
di Giancarlo Pocetta*
Ricercatore sanità pubblica, Università di Perugia
* Ricercatore in Sanità Pubblica. Coordinatore del Master in promozione della salute ed educazione sanitaria presso l’Università di Perugia. È membro dello European Trai-ning Consortium in Health Promotion and Public Health. Si occupa di ricerca e formazione nel campo della progettazione e della valutazione dei processi educativi appli-cati alla salute.

late”2.Anche rimanendo all’interno del campo dilavoro più tradizionale della medicina biomedi-ca, la malattia, è indicativo di questo l’affermarsidi iniziative che legano la promozione della salu-te e il contesto di cura: dalla nuova visione dellapatient education all’esperienza della “Rete degliospedali promotori di salute”.La promozione della salute è dunque considera-ta il paradigma di quella che viene chiamata, nellinguaggio della promozione della salute:“Nuo-va Sanità Pubblica”3.Oggi, la promozione della salute comincia a per-vadere, a testimonianza della sua forza concettualee operativa, anche gli altri settori della vita pub-blica, oltre quello strettamente sanitario.A parti-re dal concetto di “determinante di salute”, gli al-tri settori, pubblici e privati, della società comin-ciano a collocare la salute e il benessere della per-sona come una delle “priorità” del proprio agirepolitico4. Ad iniziare dal settore scolastico, poil’ambito del lavoro, il settore ambientale, ecc., nel-la consapevolezza che il punto di partenza è il
considerare la salute non un fine in sé ma un mez-zo per raggiungere la felicità.La visione promozionale della salute e del benes-sere ha anche riorientato le relazioni “tra” i set-tori della vita pubblica contribuendo a costruireun orizzonte concettuale per lo stabilirsi di mo-delli di progettazione integrata territoriale che, apartire dalla progettazione sociale, si estendonoalle politiche per la salute, per l’ambiente, per laridefinizione degli assetti di un territorio, ecc.Ad una tale, poderosa influenza sulla vita pub-blica e sui comportamenti di tanti attori socialie professionali verso la salute, per paradosso, fa dacontraltare una non ancora risolta definizioneconcettuale! In specie per quello che è il con-cetto chiave della promozione della salute, ovve-ro il concetto di empowerment. Quando unapersona o una comunità sono in grado di dimo-strarsi “empowered”? Ovvero, quando si può di-re che essi esprimono“controllo sui determinantidi salute”?5
Il costrutto della “salutogenesi” elaborato da Aa-
Empower(ing)ment evaluation.Valutare in promozione della salute per produrre salute
103
IQU
AD
ERN
IDI
M AL ATTI AM AL ATTI A
F ATTOR I DI R I S CHI O
R IS OR S E F ATTOR I DI R I S CHI O
R
SALUTEPOSITIVA
IS OR S E
AM B I E NTE S OCI O-E COL OGI CO
Op p ortu n i t à d i s a lu te
AM B I E NTE S OCI O-E COL OGI CO
Op p ortu n i t à d i s a lu te
I NDI V IDU II NDI V IDU I
ME NTAL E S OCIALEME NTAL E S OCIALE
F IS ICA
S AL U TE
CAP ACI TA‘
DI S AL U TE
CAP ACI TA‘
DI S AL U TE
P ATOGE NE S IS AL UTOGE NE S I P R OS P E TTI V E ANAL IT I CHE
S UL L O S V I L U P P O DI S AL UTEP ATOGE NE S IS AL UTOGE NE S I P R OS P E TTI V E ANAL IT I CHE
S UL L O S V I L U P P O DI S AL UTE
PRO
MO
ZIO
NE
DEL
LASA
LUT
E
PRO
TEZ
ION
ED
ELLA
SALU
TE
PREV
ENZ
ION
EC
UR
AFIGURA 1 - Il modello EUHPID (European Health Promotion Indicators Development) sullo sviluppo di salute

ron Antonovsky6 si interessa principalmente diciò che crea salute, ovvero di tutto ciò che per-mette alle persone, anche in situazioni di forteavversità, di compiere scelte che si rivelano pro-duttive di benessere. Le due dimensioni princi-pali della salutogenesi sono: le Risorse Generali diResistenza (GRRs) e il Senso di Coerenza (SOC)7.Le risorse sono di diverso tipo: interne (fattoribiologici, caratteristiche di personalità) ed ester-ne (beni a disposizione nel proprio contesto, re-lazioni). Non ci si riferisce solo a ciò che c’è adisposizione ma a ciò che le persone sono in gra-do di utilizzare e riutilizzare; infatti, possono es-serci risorse a disposizione ma se le persone nonle riconoscono o non vi hanno accesso, è comese non esistessero. Le Risorse di Resistenza agi-scono a livello individuale, comunitario, sociale,organizzativo; con esse le persone possono co-struirsi un bagaglio di esperienze in grado di aiu-tarle a ricostruire la trama della loro esistenza insituazioni di stress, a trovare un significato per di-rigersi verso il polo positivo del proprio equili-brio di salute. Risorse sono ad esempio: denaro,conoscenze, esperienze, autostima, strategie dicoping, legami, supporto sociale, impegno, cul-tura, intelligenza, tradizioni, ideologie, arte, reli-gione.Tuttavia, come si è già affermato, più im-portante della disponibilità di risorse è l’abilitàdi utilizzarle; per fare questo le persone hannobisogno di comprendere la situazione in cui sitrovano, in quel momento e nel suo insieme, diriconoscere le risorse e di utilizzarle con succes-so. Il muoversi in direzione della salute è favori-to da quello che Antonovsky definisce “Senso diCoerenza”:“un globale,…, sentire che qualsiasi co-sa accada nella vita essa può divenire comprensibile epuò essere gestita. C’è anche uno scopo ed un signifi-cato legati ad ogni cosa”… “che: gli stimoli che pro-vengono dall’ambiente interno ed esterno nel corso del-la vita sono strutturati, predicibili e spiegabili, che so-no disponibili le risorse per rispondere a questi stimo-li, ed infine che questi stimoli rappresentano sfide de-gne di investimento ed impegno”. Le componentichiave del Senso di Coerenza vengono dunque
riassunte in: comprensibilità (knowledgeability), ov-vero la componente cognitiva; gestibilità (mana-geability), ovvero la componente operativa e com-portamentale; significatività (meaningfulness), ov-vero la componente motivazionale.Si possono, quindi, definire risorse utili quelle checontribuiscono al verificarsi di esperienze di vi-ta che diano un senso, sia di tipo cognitivo cheemotivo, al mondo di ognuno. Il Senso di Co-erenza si correla positivamente agli esiti di salu-te, alla qualità di vita ed a misure psicologiche dibenessere migliori. Esso stesso rappresenta unadelle risorse interne per la salute. La profonditàdel Senso di Coerenza incide sulle capacità dellepersone di utilizzare le risorse disponibili per con-servare salute e benessere. Le persone con un mar-cato Senso di Coerenza reagiscono in manieraflessibile alle sollecitazioni e possono attivare ri-sorse adeguate alla situazione.Gli studi di Antonovski e dei suoi successori – iquali cercano di costituire un nesso tra modellosalutogenico, promozione della salute e sanità pub-blica8,9 – hanno, tutto sommato, solo recentementecontribuito a rispondere all’interrogativo “Checosa promuove/produce salute?”, fornendo sia glielementi di una definizione concettuale di em-powerment all’interno della teoria della promo-zione della salute, sia i primi strumenti di cono-scenza empirica.
VALUTARE INTERVENTI DI PROMOZIONEDELLA SALUTEUn aspetto rilevante per la promozione della sa-lute è oggi rappresentato dal come valutare le azio-ni che si richiamano a questa filosofia e strategiadi sanità pubblica.Vi sono diversi filoni che af-frontano questo tema e che si confrontano so-stanzialmente con il problema di come coniuga-re, nella valutazione della capacità della promo-zione della salute di impattare la salute delle per-sone, il rigore scientifico con la specificità dellapromozione della salute. Lo sguardo valutativosulla promozione della salute ha generato molteproblematicità e pochi punti di accordo finora,
IL SISTEMA SANITARIO E L’EMPOWERMENT
104
IQU
AD
ERN
IDI

che proviamo qui a riassumere affrontando la que-stione dal punto di vista più critico ma interes-sante, quello dell’efficacia delle azioni di promo-zione della salute.All’interno del paradigma biosanitario, il puntodi partenza per ritenere etiologicamente valido eattribuibile ad intervento un cambiamento (adesempio, un vantaggio terapeutico indotto da unnuovo farmaco) è la possibilità di costruire un set-ting di valutazione che escluda (riduca al mini-mo accettabile) la possibilità che fattori esterniinfluenzino “l’esperimento”. Questo è alla basedello Studio Clinico Randomizzato Controllato(SCRC) nelle sue varie versioni. Caratteristicafondamentale è lo svolgersi di questo processo al-l’interno di un solido e unitario paradigma scien-tifico condiviso. Il punto di partenza di un dis-corso su valutazione e promozione della salute, alcontrario, non può che essere la considerazionedella natura multidisciplinare e contestuale di ta-le settore, che lo distingue chiaramente dall’ap-proccio biomedico tradizionale di stampo posi-tivista. Questo impedisce la possibilità che la va-lutazione dell’efficacia si basi su un singolo ap-proccio ritenuto lo standard di riferimento, co-me accade nella tradizione scientifica biomedicacon lo SCRC. Il golden standard della valutazio-ne in promozione della salute dovrebbe essere ri-assunto in questa frase:“La costruzione della cono-scenza valutativa nella promozione della salute non cor-risponde né a un approccio di tipo positivista né a unapproccio di tipo unicamente costruttivista; la conoscen-za valutativa è piuttosto l’esito di un processo critico emultiplo da un punto di vista epistemologico e meto-dologico”.Rootman10 sottolinea come alla base di un ap-proccio promozionale alla salute debbano esser-vi alcuni “principi guida” alla luce dei quali sta-bilire la coerenza di ogni successiva scelta meto-dologica, strumentale e organizzativa riguardo al-la valutazione. Ciascuno di essi rappresenta con-temporaneamente un elemento del “ciclo di vi-ta” dell’intervento promozionale e un endpoint diesso, in un approccio di tipo ricorsivo:
�partecipazione: in ogni sua fase, la valutazio-ne deve coinvolgere tutti coloro che hanno unruolo o un interesse nell’azione di promozionedella salute e in particolare deve assicurare la par-tecipazione di coloro che sono interessati in pri-ma persona al problema di salute affrontato; ap-prendere capacità di partecipare è un elementodell’efficacia dell’intervento;
�multidisciplinarietà: la valutazione utilizza di-verse discipline e strategie operative nella rac-colta e interpretazione dei dati, fondamental-mente integrando approcci metodologici di ti-po qualitativo e di tipo quantitativo, in coeren-za con la complessità dei fenomeni affrontati da-gli interventi di promozione della salute;
�empowerment: la valutazione deve contribui-re a un processo di acquisizione di controllo daparte delle persone e delle comunità riguardo ideterminanti di salute;
�equità: la valutazione deve dimostrare, non so-lo come tensione etica ma come contenuti me-todologici, la capacità del progetto di assicura-re che tutti i portatori di un bisogno di salutesiano nelle condizioni di soddisfarlo esplicitan-do gli elementi di disequità nella salute;
�appropriatezza: il disegno di valutazione de-ve essere coerente con il modello di salute e dipromozione della salute posto alla base delle azio-ni e deve tenere conto della possibilità di effet-ti che si manifestino a lungo termine;
�sostenibilità: il processo valutativo deve consi-derare tra i suoi obiettivi conoscitivi la eviden-ziazione e la misura di ciò che rende sostenibi-le l’intervento di promozione della salute.Ogni metodo dovrebbe essere adattato alla do-manda alla quale si deve dare una risposta. Se lavalutazione deve rispondere a molte domandenon può adottare un unico e solo metodo.I valutatori, in tal modo, sono visti come “meto-dologi eclettici” che adattano le loro pratiche aibisogni che sono all’origine di una particolare ini-ziativa, così come formulati dai decisori, daglioperatori e dai partecipanti. Si può vedere in que-sto ultimo aspetto un punto di forte criticità: è
Empower(ing)ment evaluation.Valutare in promozione della salute per produrre salute
105
IQU
AD
ERN
IDI

evidente, infatti, che le diverse discipline che con-corrono al processo di promozione della saluteaffondano le proprie radici in diverse epistemo-logie che non possono essere facilmente messeinsieme. E ancor meno possono essere messe in-sieme da un singolo valutatore.È questo tuttavia il campo di lavoro valutativo cheuna visione aggiornata della promozione della sa-lute oggi propone e con il quale, diremmo,“oc-corre fare i conti”.Riassumendo sono tre le aree di criticità nella va-lutazione in promozione ed educazione alla salute:1. gli interventi sono context based, multipli, im-plicano coinvolgimenti plurimi. Gli interventidi promozione della salute sono strettamenteancorati al contesto nel quale si svolgono. Diconseguenza i risultati degli interventi devonoessere considerati a partire dal contesto e il tra-sferimento di un intervento in un contesto di-verso deve essere attentamente gestito.
2. Il confronto con il paradigma razionalista do-minante nella medicina. L’assunto su cui è ba-sato il metodo del trial clinico controllato, ov-vero di poter eliminare qualsiasi causa di con-fondimento nell’analisi degli effetti di una pro-cedura sanitaria, non è praticamente applicabi-le alla promozione della salute i cui effetti sonodipendenti dal contesto in cui esso è applicato.
3. I valori ai quali è ancorata la promozione del-la salute (i “principi” di Rootman). La meto-dologia di valutazione di un intervento di pro-mozione della salute deve essere coerente coni principi teorici che connotano la promozio-ne della salute stessa.
Se, dunque, la valutazione è deputata a fornire laconoscenza necessaria a permettere di formulareun giudizio sul cambiamento che si è determi-nato a seguito dell’intervento nelle dimensionidefinite dai modelli teorici che sono alla base deicontenuti specifici dell’intervento stesso, è deter-minante che coloro che hanno la responsabilitàdella valutazione del programma siano orientatitanto agli esiti finali del programma, quanto allavalutazione dei processi messi in atto. La valuta-
zione deve sapere osservare e ascoltare la comu-nità che agisce per poi trarre delle conclusioni va-lide.Vi sono alcune conseguenze in questa scel-ta. La più importante è che attivare processi par-tecipativi nella valutazione dei processi in atto,può voler dire in qualche caso aprire uno spazioper una ridefinizione, da parte degli attori in gio-co in primo luogo i cittadini, degli obiettivi ini-ziali alla luce di un cambiamento in corso. La va-lutazione è quindi essa stessa una fonte di empo-werment.
DALLAVALUTAZIONE PARTECIPATADELL’EMPOWERMENTALL’EMPOWERMENT EVALUATIONCosa può succedere se si cerca di far “reagire”l’approccio valutativo alla promozione della salu-te con il concetto di empowerment? Qui il dis-corso può essere presentato attraverso due pola-rità rappresentate una da quel grande contenito-re chiamato “valutazione partecipata”, l’altra dalpiù recente lavoro sull’Empowerment Evaluation.Il tentativo di costituire un ponte tra valutazioneed empowerment è alla base di una molteplicitàdi ricerche, condotte generalmente sul modellodell’action research, nelle quali si è tentato di col-mare il divario tra i due concetti,mettendo a pun-to disegni concettuali e operativi tesi a valorizza-re la centralità degli utenti (“users”) della valuta-zione. Questi approcci, nella loro diversità, rico-noscono un’origine comune nel concetto gene-rale di “partecipazione”, come snodo teorico edempirico in grado di caratterizzare un approcciocoerente alla valutazione e alla promozione del-la salute.Come esempio del primo versante si può citareil lavoro di Labonte e Laverack sull’empowermentdi comunità11. Essi rimodulano le fasi progettua-li (definizione di priorità ed obiettivi, scelte stra-tegiche, gestione/implementazione e valutazio-ne) alla luce dell’orientamento all’empowerment.Per tutte le fasi dell’intervento, e in particolareper quella valutativa, essi individuano nell’ap-proccio narrativo12 in un setting partecipativo, l’o-
IL SISTEMA SANITARIO E L’EMPOWERMENT
106
IQU
AD
ERN
IDI

rientamento in grado di produrre una conoscen-za situata sul cambiamento/apprendimento ge-nerato dall’azione di promozione della salute sul-le dimensioni patogeniche, ma soprattutto salu-togeniche, della salute delle persone e delle co-munità (Fig. 2).Si deve però al lavoro iniziato da David Fetter-man il merito di aver cominciato a cercare unnesso concettuale diretto tra i due termini, valu-tazione ed empowerment, attraverso il suo ap-proccio noto come Empowerment Evaluation.Il fondamento teoretico dell’Empowerment Eva-luation risiede nel concetto di autodeterminazio-ne intesa come:“la capacità di tracciare la rotta
del proprio corso di vita”13.David M.Fetterman,introducendo il volume“Empowerment Evalua-tion. Knowledge and Tools for Self-assessmentand Accountability”, definisce questo approcciovalutativo come:“l’uso dei concetti della valuta-zione e delle tecniche valutative per migliorarel’autodeterminazione delle persone”.Guardare airisultati di un intervento di promozione della sa-lute dal punto di vista di empowerment, signifi-ca studiarne le conseguenze riguardo alla sua ca-pacità di “aumentare il controllo della persona (edella comunità) sui determinanti della salute”. Seprendiamo come esempio la dimensione comu-nitaria, l’empowerment evaluation si basa, in ge-
Empower(ing)ment evaluation.Valutare in promozione della salute per produrre salute
107
IQU
AD
ERN
IDI
FIGURA 2 - L’empowerment della comunità nella promozione della salute: un framework per la pianificazione
ObiettiviCome sono collocati nel progetto gliobiettivi di salute e quelli diempowerment della comunità?
Obiettivi(Empowerment della comunità)Grado di controllo e di sceltariguardo alla decisioni sulla salute
Linea operativa“Programma” Linea operativa“Empowerment”
Obiettivi
Programma:Il progetto tiene conto delle caratteristichedell’empowerment?IdentificazioneValutazioneConsenso
Caratteristiche del processo di empowermentTempoAmpiezza del coinvolgimentoAttenzione alla marginalità
In chemodo l’approccio strategico delprogetto rafforza l’approccio strategicoall’empowerment della comunità?
Empowerment individuale > Piccoligruppi > Organizzazioni > reti >Azione politica
Strategia
Valutazione degli esitiIl progetto valuta inmodo appropriatol’empowerment della comunità?
Valutazione del livello diempowermentUsodi tecnichedivalutazionepartecipata
Valutazione
ImplementazioneIn chemodo il progetto raggiunge icambiamenti nei dominii operativi?
Dominii operativipartecipazione,struttureorganizzative, legami,mobilizzazionedi risorse, leadership,attivazione diagenti esterni,gestione del progetto,riflessività,valutazione del problema
Gestione

nerale, su un processo di autoriflessione che i cit-tadini attuano rispetto all’intervento al quale han-no preso parte e nel quale gli operatori svolgonoil compito di facilitatori piuttosto che di espertie si costituiscono, essi stessi, come una risorsa adisposizione dei partecipanti al programma.L’em-powerment evaluation contribuisce, quindi, all’e-sito finale di un’azione di promozione della salu-te, al cambiamento non solo individuale ma delcontesto e la valutazione non è più il punto di ar-rivo ma un passaggio nel processo di migliora-mento individuale e comunitario che si sviluppaper tutto il corso della vita. Parte integrante delprocesso valutativo orientato all’empowermentsono cinque aspetti che rappresentano le qualitàdel processo valutativo e in qualche modo anchei suoi stadi di sviluppo.
TrainingIl valutatore guida i partecipanti a sviluppare au-tonome capacità per autovalutarsi nel corso ed altermine dell’intervento.Una ricaduta è quella diportare la valutazione e il ruolo del valutatoremolto vicino ai soggetti del cambiamento, pro-ducendo un impatto non solo relativamente ai ri-sultati ma di forte autoconsapevolezza e respon-sabilizzazione dei partecipanti come soggetti at-tivi del cambiamento. In questa fase, quindi, si av-via un processo autoriflessivo in cui per prima co-sa ci si pronuncia su quali siano le parti dell’in-tervento da ritenere fondamentali (core component)e viene dato un giudizio sulle risorse disponibilinella comunità/setting e quelle da acquisire, suiruoli e sui rapporti di potere.
FacilitazioneQuesto aspetto richiama il ruolo del valutatore edella funzione valutativa all’interno del program-ma di promozione della salute. Nell’Empower-ment evaluation il valutatore è il “gruppo” in cam-
biamento, non il singolo professionista o il ma-nager di turno. Il contributo dell’operato-re/professionista è quello di assicurare che la va-lutazione rimanga nelle mani del gruppo for-nendo le informazioni necessarie (vedi nota**).Il compito dei professionisti è quello di guidareun processo di valutazione partecipata in cui sidescrive il cambiamento desiderato, viene stabi-lito come documentare le fasi dell’intervento ecome utilizzare i risultati della valutazione per mi-gliorare interventi futuri.
AdvocacyIn questa fase, ciò che deve essere assicurato è chei partecipanti siano in grado di determinare la di-rezione della valutazione, suggerendo possibili so-luzioni, sostenendoli anche ad essere attivi nelprocesso di cambiamento sociale. Supportati da-gli operatori, i partecipanti entrano nel processodi valutazione definendo i “propri” obiettivi va-lutativi, le forme della documentazione delle evi-denze e come usare i risultati della valutazione.
IlluminazioneUna valutazione orientata a generare empower-ment, tipicamente produce una ridefinizione del-la realtà attraverso la nuova comprensione dei ruo-li, della struttura e delle dinamiche del program-ma. Questo sguardo nuovo può, ad esempio, ri-flettersi in spiegazioni non previste dei dati rile-vati, oppure in una diversa visione di sé (ruolo,potere) da parte dei partecipanti al processo valu-tativo, oppure nella individuazione di nuove pistedi azione o di nuovi stakeholder nella comunità.
LiberazioneIn ultimo, la valutazione orientata all’empower-ment determina una riscrittura dei ruoli degli sta-keholder e dei partecipanti al programma, dei le-gami di potere tra essi e con le altre espressioni
IL SISTEMA SANITARIO E L’EMPOWERMENT
108
IQU
AD
ERN
IDI
** Fetterman, nel descrivere il ruolo del professionista al processo di empowerment evaluation, richiama esplicitamente la figura del Coach. Questa, tra le figure di facilitato-re dell’apprendimento esperienziale (counselor, tutor, mentore, appunto, coach), racchiude due caratteristiche distintive. La prima è quella “motivazionale e di traino (Zan-nini L., 2005) di allenatore all’autodeterminazione e all’autovalutazione. La seconda caratteristica è quella di essere un soggetto significativo” nel contesto in cui si attual’intervento. Questa caratteristica si adatta bene al ruolo e all’immagine degli operatori dei nostri servizi sociosanitari impegnati nell’assistenza di base.

della comunità/territorio in cui si attua l’inter-vento, sia individuandone di nuove sia liberan-dosi da visioni e aspettative tradizionali.
Queste qualità dell’Empowerment Evaluation pos-sono essere lette anche come stadi successivi disviluppo del percorso di acquisizione di empo-werment di una comunità e dei suoi membri: dauna fase di sviluppo di consapevolezza verso l’au-todeterminazione rispetto agli esiti della parteci-pazione a un programma di cambiamento.Lo sfor-zo successivo di Fetterman è quello di collocaretutto ciò in un processo organizzato che guidi lepersone nell’autovalutazione14.Così presentato, seppure in modo sintetico, l’Em-powerment Evaluation appare estremamente at-traente per il lavoro di promozione della salute.Essa sembrerebbe fornire, per la prima volta, unostrumento concettuale altamente coerente alla va-lutazione in questo settore. Molto più degli ap-procci genericamente partecipativi, l’Empower-ment Evaluation ha l’ambizione di connettere l’e-sigenza valutativa – formulazione rigorosamentescientifica di un giudizio sul program-ma/intervento di promozione della salute – conquella che ne è la dimensione concettuale por-tante.Tuttavia un’attenta analisi svela proprio nel-la non ancora chiara formulazione del concettodi empowerment da parte di Fetterman e dei suoico-autori, il principale punto debole puntual-mente rilevato dai suoi critici, secondo i qualil’Empowerment Evaluation non sarebbe in gra-do di definirsi autonomamente rispetto al più no-to approccio partecipativo.La critica più forte vie-ne mossa non a caso proprio da Scriven, autoredi un modello di valutazione fortemente centra-to sull’utente della valutazione “Utilization focu-sed Evaluation”, il quale obietta che Fettermannon propone tanto una nuova metodologia valu-tativa, quanto piuttosto un’originale ed efficacemetodo di formazione dei valutatori. In questasua osservazione da una parte Scriven coglie losnodo essenziale dell’approccio di Fetterman, ov-vero il ruolo di coaching del valutatore ma, allo
stesso tempo, distrugge la pretesa originalità e in-novatività della proposta.È utile partire da questa osservazione, la più radi-cale che conosciamo al lavoro di Fetterman, percercare di sostenere, al contrario, il valore inno-vativo della sua proposta. L’Empowerment Eva-luation è dunque solamente un modo accattivantedi definire e gestire il ruolo del valutatore in un’ot-tica di valutazione partecipata? O, effettivamen-te, è in grado di contribuire al processo di svi-luppo dell’empowerment di coloro ai quali un’a-zione di promozione della salute esplicitamentesi rivolge?Proponiamo due punti di partenza per affronta-re questa discussione: la valutazione di processo eil ruolo del valutatore.Si deve sottolineare l’importanza di considerarela valutazione di processo come un momento es-senziale dello sviluppo di un programma di pro-mozione della salute.Nell’accezione che ci inte-ressa sottolineare qui essa non assume, come nel-la forma tradizionale, il compito di mero con-trollo del programma in funzione illuminante neiconfronti dei risultati/impatti ottenuti, ma piùfortemente mira a “incrementare la costruzionedelle capacità e delle risorse della comunità … inun processo continuo che documenta e crea real-tà, un processo capace di emettere energia e spe-ranza attraverso il dialogo e l’interazione”15.Il secondo punto importante per comprenderel’originalità del pensiero di Fetterman è partiredal ruolo del valutatore che, nell’EmpowermentEvaluation, assume il ruolo di coach del gruppoe lo guida a identificare i propri bisogni valuta-tivi. Questo opera una distinzione rispetto al ruo-lo di facilitazione alla partecipazione alla valuta-zione: al centro, cioè, non c’è una sottolineaturasui “metodi” che devono essere partecipativi,masul “contenuto”: l’autodeterminazione. Il valuta-tore quindi non si limita ad allestire un settingpartecipativo nel quale far agire processi di rile-vazione e analisi di dati partecipati da parte de-gli utenti. Invece, egli è colui che facilita ciò cheFetterman chiama“Illuminazione”ovvero:“la ca-
Empower(ing)ment evaluation.Valutare in promozione della salute per produrre salute
109
IQU
AD
ERN
IDI

pacità di vedere le cose in modo nuovo”;“Libe-razione” ovvero:“la capacità di trovare nuove op-portunità, vedere le risorse esistenti in una nuo-va luce e ridefinire identità e futuri ruoli;“Crea-zione di una Comunità di Apprendimento”(Community of Learners):“coloro che sono stret-tamente coinvolti nell’arte e nella scienza di va-lutare se stessi”, e quindi l’autonoma riorganiz-zazione, da parte degli utenti, delle informazio-ni per costruire una visione rinnovata dei propribisogni e del contesto e la progettazione delleazioni per raggiungerli. In questo ci pare di co-gliere una vera e propria azione, educativa, di svi-luppo dell’empowerment per la salute.Gli outco-me della Empowerment Evaluation (Illumina-zione, Liberazione) rappresentano dimensioni fa-cilmente riconducibili a ciò che può essere con-
siderato “controllo dei determinanti”. Se si con-fronta questa visione di Fetterman e dell’Empo-werment Evaluation con il sofisticato costruttoconcettuale di Antonovski, si noterà certamenteun notevole sbilanciamento nella forza concet-tuale dei due approcci a favore del secondo.Tut-tavia è proprio in questo spazio che dovrà collo-carsi la ricerca nel campo del rapporto tra valu-tazione in promozione della salute ed empo-werment. La “reazione” tra i due temi ha pro-dotto finora un promettente orientamento or-ganizzativo ed operativo che dovrà essere teori-camente meglio sostanziato per fornire all’Em-powerent Evaluation gli strumenti empirici at-traverso i quali poter collocare pienamente que-sta teoria valutativa nella dimensione di una va-lutazione di impatto.
IL SISTEMA SANITARIO E L’EMPOWERMENT
110
IQU
AD
ERN
IDI
BIBLIOGRAFIA1 Ministero della Salute, Guadagnare Salute. Rendere facili lescelte salutari, http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubbli-cazioni_605_allegato.pdf
2 G. Bauer, J.K. Davies, J. Pelikan and on behalf of the EuhpidTheory Working Group and The Euhpid Consortium, TheEUHPID Health Development Model for the classification ofpublic health indicators, Health Promotion International 200621(2):153-159.
3 Dall’Health Promotion Glossary (cit) si trae questa defini-zione di “Nuova Sanità Pubblica”: “A distinction has beenmade in the health promotion literature between publichealth and a new public health for the purposes of em-phasizing significantly different approaches to the descrip-tion and analysis of the determinants of health, and the me-thods of solving public health problems.This new publichealth is distinguished by its basis in a comprehensive un-derstanding of the ways in which lifestyles and living con-ditions determine health status, and a recognition of theneed to mobilize resources and make sound investmentsin policies, programmes and services which create, main-tain and protect health by supporting healthy lifestyles andcreating supportive environments for health. Such a dis-tinction between the “old” and the “new” may not be ne-cessary in the future as the mainstream concept of publichealth develops and expands”.
4 Stahl T, Wismar M, Ollila E, Lahtinen E, Leppo K, editors,Health in All Policies. Prospects and Potentials, Helsinki: Mi-nistry of Social Affairs and Health, 2006.
5 Who,Health Promotion Glossary, 1998.6 Antonovsky A. (1996),A salutogenic model as a theory to guide
health promotion, Health Promotion International, 11 (1), 11-18.7 Lindström B., Eriksson M. (2005), Salutogenesis, in J of Epi-demiology and Community Health, 59, 440-442.
8 B. Lindstroem, M. Erikson, Contestualizing salutogenesis andAntonovski in Public Healthdevelopment, in Health PromotionInternational, 2006, vol 21, n. 3, pag.:238-244.
9 B. Lindstroem, M. Erikson, The salutogenic approach to thamaking of HiAP/healthy public policy: illustrated by a case study,in Global Health Promotion, 2009, vol. 16, n. 1, pag.: 17-28.
10 Rootman I., Introduction to the book, in Evaluation in HealthPromotion, Part 1 Introduction and framework, (2001) WhoRegional Publications European series n. 92: 5.
11 Laverack G, Labonte R. (2000), A planning framework forcommunity empowerment goals within health promotion, inHealth Policy and Planning, 15(3): 255-262.
12 Garista P., Pocetta G. (2005), Lavorare sui “casi” per lo svi-luppo di conoscenze e il miglioramento di qualità in promo-zione della salute, in Educazione Sanitaria e Promozione del-la Salute, vol. 28(4): 295-308.
13 Fetterman D.M., Kaftarian S.J., Watersman A. (1996), Em-powerment Evaluation. Knoledge andTools for self-assessmentand Accountability,Thousand Oaks, London, New York, Sa-ge Pubblications.
14 Alcuni esempi di ciò sono da me riportati nel volume: G.Pocetta, P. Garista, G.Tarsitani (ed) (2009), Alimentare il be-nessere della persona. Prospettive di promozione della salutee orientamenti pedagogici per l’educazione alimentare in Sa-nità Pubblica, Società Editrice Universo, Roma.
15 K. Roe, K. Roe,Dialogue boxes: a tool for collabortive processevaluation, in Health Promotion Practice,April 2004, vol. 5, n.2, pag.: 138-150.

111
iQua
dern
idiZ
immerman (2000) è uno dei pochi au-tori che ha elaborato un modello teo-rico, integrando i risultati provenien-ti da diversi ambiti applicativi. L’auto-
re definisce l’empowerment come il processo chepermette di accrescere la capacità degli individuidi controllare attivamente la propria vita (Rap-paport, 1981; Hasenfeld, 1987), ma anche il ri-sultato di tale percorso (Parsons, 1991, 2002;Frans,1993;Gutierrez,DeLois,& GlenMaye, 1995;Zim-merman, 2000).Data la sua natura “multilivello”,esso si applica “a livello individuale quando si occu-pa di variabili intrapersonali e comportamentali, […]a livello organizzativo quando ci si occupa di mobili-tazione di risorse e […] a livello di comunità quandosi affrontano le strutture sociopolitiche ed il cambiamentosociale” (Zimmerman, 2000, p. 22; cfr. Francesca-to, Mebane, Sorace,Vecchione, &Tomai, 2007).La tripartizione proposta da Zimmerman in Em-powerment Psicologico (EP),Empowerment Or-ganizzativo (EO), Empowerment di Comunità(EC), si sovrappone in parte ai tre approcci di stu-dio dell’empowerment elaborati nel contesto ma-nageriale-organizzativo: psicologico, strutturale,critico (Tabella 1).Dalla fine degli anni ’70, il termine empower-ment è stato infatti adottato nel linguaggio orga-nizzativo, ed ha definito il superamento di unalogica tayloristica, che per aumentare la produt-tività favoriva la segmentazione dei compiti inazioni e tempi elementari, a favore di una logica
diversa che pone al centro l’individuo, le sue esi-genze, il suo potenziale (Wilkinson, 1996; Qua-glino, 1999): i lavoratori (Piccardo, 1992) non ven-gono più visti come ingranaggi del sistema, mapersone con diritti. La valorizzazione delle risor-se umane diviene quindi un obiettivo primarioper le imprese, volte a promuovere un atteggia-mento di partecipazione e di alto impegno neilavoratori, in altre parole ad incrementare il loroempowerment (Speitzer, 1995). In questa pro-spettiva, denominata da Spreitzer e Doneson(2005) psicologica, si pone attenzione al lavora-tore e alle sue percezioni: essere empowered èsentirsi empowered (Conger &Kanungo, 1988;Thomas &Velthouse, 1990; Spreitzer, 1995).Da questa concettualizzazione prendono le di-stanze gli autori che studiano lo structural empo-werment (Kanter, 1977, 1979, 1983, 1986, 1989;Laschinger, Finegan, Shamian,&Wilk, 2001;Mil-ler, Goddard, & Laschinger, 2001). La loro pro-spettiva, definita per l’appunto struttura-le/relazionale (cfr. Spreitzer & Doneson, 2005)(Burke, 1986; Lawler, 1992; Karsten, 1994;Champy, 1995), si focalizza sulle condizioni am-bientali, che possono essere considerate indica-trici di empowerment nel contesto lavorativo.Kanter (1979), una delle principali fautrici di ta-le prospettiva, per esempio, asserisce che le ca-ratteristiche della situazione possono sia contra-stare sia incoraggiare la performance lavorativaottimale, nonostante le tendenze o predisposi-
EMPOWERMENT E VALUTAZIONE
di Anna Marcon*, Maria Augusta Nicoli**
*Dottore di ricerca in psicologia sociale**Agenzia sanitaria e sociale regionale - Regione Emilia Romagna

zioni personali. Utilizzando l’analogia del cir-cuito elettrico, il potere viene descritto come“on” quando i lavoratori hanno accesso alle fon-ti di informazione, di supporto, alle risorse edopportunità finalizzate ad apprendere e cresce-re. Quando queste fonti non sono disponibili, ilpotere è “off ” ed è impossibile realizzare un la-voro in modo efficiente. Quindi riassumendo,“l’accesso alle informazioni” (Gomez & Rosen,1994),“il supporto” (Ibarra, 1991; Emirbayer &Goodwin, 1994) e “le risorse” (Bowen & Lawler,1995) sono le fonti di empowerment struttura-le il cui accesso dipende dal grado di potere de-rivato dalle condizioni formali (come per esem-pio la visibilità professionale, la centralità del la-voro svolto per l’obiettivo complessivo dell’or-ganizzazione) e informali (alleanze sia all’inter-no dell’organizzazione con superiori e colleghi,sia all’esterno dell’organizzazione) (Chandler,1986; Lashinger, 1996; Laschinger, Finegan, Sha-mian, & Wilk, 2004; Miller, Goddard, & La-schinger, 2001). L’ambiente lavorativo che favo-risce l’accesso a tali fonti di potere è empowe-red. In accordo con questa teoria, il mandato delmanager dovrebbe creare le condizioni per l’ef-ficacia lavorativa garantendo ai propri lavorato-ri l’accesso alle informazioni, al supporto, alle ri-sorse necessarie per portare a termine il lavoroe alle diverse opportunità di sviluppo (Gomez& Rosen, 1994; Bowen & Lawler, 1995; Spreit-zer, 1995, 1996).È su quest’ultimo aspetto, quello della leadership,che si sviluppa la prospettiva critica. Essa eviden-zia come sia necessario creare una reale strutturadi potere condivisa per incrementare l’empo-
werment dei singoli; in altre parole è necessarioche ci sia una reale ed ugualitaria suddivisione dipotere tra tutti gli attori presenti in un’organiz-zazione.Superando gli specifici domini disciplinari, in ma-niera trasversale, l’empowerment è descritto co-me un processo/risultato che accade e si svilup-pa all’interno di un dato contesto. Nel senso piùcompleto, infatti, l’empowerment è dato dalla si-nergia dell’empowerment psicologico e dell’em-powerment “oggettivo-ambientale” (Zani & Pal-monari, 1996).Ne consegue la difficoltà di indi-viduare una definizione universale del costrutto;le stesse componenti dell’empowerment “non pos-sono essere catturate attraverso una specifica operazio-nalizzazione perché queste dimensioni assumono for-me diverse in popolazioni, contesti e momenti tempo-rali differenti” (Zimmerman, 1995, p. 587).Alla ba-se di tale affermazione c’è la consapevolezza checiò che è empowered per una cultura, un indivi-duo, in un determinato momento temporale nonlo sia per altri (Foster-Fishman, Salem,Chibnall,Legler, &Yapchai, 1998). Queste considerazioniintroducono una questione non secondaria: co-me rilevare l’empowerment? Come registrareeventuali cambiamenti nel grado di empower-ment dei singoli, di un’organizzazione, di una co-munità?
RILEVARE L’EMPOWERMENT:ALCUNISTRUMENTI DI MISURAZIONEDall’analisi della letteratura è stato possibile rin-tracciare diverse scale di misurazione dell’empo-werment, riconducibili a tre ambiti di ricerca:medico, organizzativo e di comunità (Tabella 2).
IL SISTEMA SANITARIO E L’EMPOWERMENT
112
IQU
AD
ERN
IDI
TABELLA 1 - Approcci di studio dell’Empowerment in ambito manageriale-organizzativo
Tipo di approccio Origini dell’approccio Interesse centrale Livello di sviluppoSociostrutturale
Psicologico
Critico
Principi democratici e sociologici
Psicologia sociale e delle motivazioni
Teoria postmoderna e decostruzioni-smo
Condivisione di potere e presa di deci-sioneSperimentare il significato, l’efficacia,l’autodeterminazione e l’influenzaCapire chi controlla le strutture di po-tere formale
Estensivo sviluppo teorico e alcune evi-denze empiriche e ricercheSviluppo teorico estensivo e ricercheempiriche;misurazioni rigoroseIdee concettuali iniziali
Fonte: Spreitzer & Doneson, 2005.

L’empowerment in ambito medicoAl primo gruppo appartengono gli strumenti dimisura dell’empowerment di persone affette dadisturbi diversi, sia essi fisici che psicologici.Un esempio concreto è rappresentato da “TheDiabetes Empowerment Scale (DES)” di Ander-son et al., (2000). Gli autori evidenziano comeuna persona affetta da diabete è empowered quan-do riesce ad attuare una “gestione degli aspettipsicosociali del diabete”, ritiene cioè di riusciread ottenere il supporto sociale avvertito come ne-cessario, a gestire lo stress e a prendere delle de-cisioni “giuste per lei” (Anderson et al., 2000, p.740); contemporaneamente è in grado di porsi edi raggiungere degli obiettivi realistici, affrontan-do efficacemente le eventuali difficoltà; infine inpresenza di aspetti legati alla terapia e percepiticome difficili da accettare, quello che caratteriz-za un paziente empowered è la sua capacità di cam-biare, modificare le modalità di affrontare la ma-lattia, assumendo quindi, per quanto possibile, un
atteggiamento propositivo e non arrendevole.L’empowerment è stato studiato non solo in ri-ferimento a persone con disturbi fisici,ma anchepsichiatrici; a riguardo, uno degli strumenti mag-giormente utilizzati (Corrigan, Faber, Rashid, &Leary, 1999; Hansson, & Björkman, 2005) è laMaking Decisions Scale di Rogers, Chamberlin,Eleison e Crean (1977).Dalle applicazioni di tale strumento, il costruttoè stato ricondotto a due sovracategorie (Corri-gan, et al., 1999; Hansson & Björkman, 2005):�empowerment individuale, che consiste nel-la percezione di autostima (Rosemberg, 1965),autoefficacia (Sherer & Adams, 1953) (Mi vedocome persona capace), attivismo (lavorando con gli al-tri nella mia comunità posso aiutare a cambiare le co-se al meglio) e di ottimismo-controllo sulla pro-pria vita (Rotter, 1966) (Posso influenzare cosa miaccadrà);
�empowerment di comunità, che riguarda lapercezione del modo in cui il potere politico e
Empowerment e valutazione
113
IQU
AD
ERN
IDI
TABELLA 2 - Schema riassuntivo dei principali strumenti di rilevazione dell’EP organizzati per area di applicazione
Area Autori Anno Scala Dimensioni EPMedica (fisici)
Medica
Lavoro (prospet-tiva psicologica)
Lavoro (prospet-tiva strutturale)
Di comunità
Anderson et al.
Koren et al.
Rogers,Chamberlin,Eleison, & CreanElder, Regan, Pallerla,Levin, Post, & CegelaSpreitzerLesile,Holzhalb, &HollandShort & Rinehart
Konzack et al.
Kanter, 1977; La-schinger, 1996.Yeatts & Cready
Frans
Zimmerman&ZahniserSpeer & Peterson
Francescato et al.
2000
1992
1977
2007
19951998
1992
2000
2004
1993
19912000
2007
The Diabetes Empowerment Scale
Family Environment Scale (FES)
Making Decisions Scale
The Senior Empowerment andAdvocacy forPatient Safety (SEAPS)Psychological Empowerment ScaleWorker Empowerment Scale
School Participant Empowerment Scale (SPES)
Leader Empowerment Behavior Questionnaire(LEBQ)The Conditions forWork Effectiveness Que-stionnaire (CWEQ-I)Yeatts and Cready Dimensions of Empower-ment Measure
SocialWorker Empowerment Scale
Sociopolitical Control ScaleOperazionalizzazione della dimensione Interper-sonale dell’EP (Zimmerman & Zahniser,1991)Scala di Empowerment Personale e Politico(EMPO)
Gestione degli aspetti psicosociali del diabete; capacità di rile-vare la non adeguatezza di alcuni trattamenti e la disponibilità acambiare; definizione e raggiungimento di obiettiviEmpowerment nella famiglia; il sistema dei servizi; conseguenzedelle azioni dei genitoriAutoefficacia;Attivismo;Ottimismo;Consapevolezza critica;Giusta indignazione.Autoefficacia,Comportamenti, Risultati efficaci,Atteggiamenti
Significato;Competenza;Autodeterminazione; ImpattoOrientamento al lavoro;Controllo dell’ambiente lavorativo;Relazioni lavorativePartecipazione alle decisioni;Crescita professionale; Status;Au-toefficacia; Autonomia; ImpattoDelega dell’autorità;Responsabilità;Autonomia decisionale;Svilup-po delle capacità professionali;Coaching;Performance innovativeAccesso alle opportunità;Accesso al supporto;Accesso alle in-formazioni; Accesso alle risorseAbilità di prendere decisioni lavorative;Abilità di modificare il la-voro;Ascolto da parte del leader dei dipendenti;Consultazioneda parte del leader dei dipendenti; Empowerment complessivoIdentità collettiva; Propensione all’Azione;Concezione di sé;Consapevolezza Critica;Conoscenze ed abilità.Controllo Socio-Politico;ComportamentalePotere sviluppato attraverso le relazioni; Funzionamento Politi-co; Formazione dell’ideologia.Capacità di porsi e perseguire obiettivi; Interesse socio-politi-co; Mancanza di speranza e di fiducia

sociale si esplica (Gli esperti sono nella posizionemigliore per decidere che cosa le persone devono fare oapprendere) e della possibilità di esercitare un’influenzasu di esso attraverso una giusta indignazione (L’in-dignarsi per qualcosa è spesso il primo passo verso ilcambiamento).Questo duplice livello, individuale e di comuni-tà, si riscontra anche nell’operazionalizzazionedell’empowerment dei partecipanti ai gruppi diauto-aiuto, proposta da Cheung et al. (2005).Gliautori hanno dimostrato che coloro che prendo-no parte costantemente ai diversi incontri valu-tano in modo migliore la realtà (maggior ottimi-smo, fiducia, apertura, ecc.), le loro abilità perso-nali (valorizzazione dei propri meriti, accettazio-ne delle debolezze, ecc.) (empowerment intra-personale) e sociali (accettazione dell’aiuto da par-te degli altri, capacità di chiedere e dare aiuto,ecc.) (empowerment interpersonale); in aggiun-ta dichiarano di avere maggior conoscenza deipropri diritti e doveri e del tipo di servizi socialiesistenti (empowerment extrapersonale).Le scale sopra illustrate considerano l’empower-ment come outcome di un percorso attraverso cuiil paziente acquisisce, per quanto possibile, un con-trollo sulla propria vita. L’empowerment in am-bito medico è stato però utilizzato anche conun’accezione diversa, quella della corresponsabi-lità dei cittadini alla messa in atto di comporta-menti salutari.Un recente contributo si inserisce a questo livel-lo, anche se focalizza l’attenzione sulla popola-zione anziana, con l’elaborazione di The SeniorEmpowerment and Advocacy for Patient Safety(SEAPS) (Elder, Regan, Pallerla, Levin, Post, &Cegela, 2007). La scala consta di 40 quesiti conuna modalità di risposta su scala Likert a 5 puntied indaga quanto i pazienti si sentano capaci (self-efficacy) e realmente mettano in atto dei compor-tamenti (behaviors) utili per preservare la salute.Vengono inoltre rilevate le credenze dei pazien-ti sull’efficacia di certe azioni (outcome efficacy) nelpreservare la salute – come per esempio il forni-re al medico una storia dettagliata e precisa dei
propri problemi, o il tenersi aggiornato sui me-dicinali e le cure seguite – ed infine gli atteggia-menti (attitudes) nei confronti di alcuni compor-tamenti, indagati per esempio chiedendo di se-gnalare l’eventuale imbarazzo percepito nel chie-dere a dei conoscenti di accompagnarlo ad unavisita.
L’empowerment in ambito organizzativoNell’ambito manageriale, i principali tentativi dioperazionalizzazione dell’empowerment proven-gono dalla prospettiva individuale e da quella strut-turale/organizzativa.Entro il primo gruppo l’attenzione si è concen-trata sull’empowerment dei lavoratori, rilevatocon la Spreitzer’s Psychological Empowerment Scale.All’interno di tale prospettiva, il lavoratore, ideal-mente empowered si ritiene:�capace di avere un impatto (impact) sulla realtàesterna; ha un locus of control interno (Rotter,1966) ed emozioni opposte allo stato di impo-tenza appresa (Abramson et al, 1978);
�qualificato e capace di portare a termine le azio-ni necessarie per raggiungere un obiettivo.Que-sta sua competenza (competence) (White, 1959)corrisponde al costrutto di self efficacy (Bandu-ra, 1977, 1986);
�agente causale delle sue scelte (choice o self-deter-mination), tale dimensione corrisponde all’auto-determinazione, a quello che DeCharms (1968)denomina locus of causality.In aggiunta, egli avverte una coerenza tra il com-pito-obiettivo in cui è coinvolto e i suoi perso-nali standard e valori (meaning).Questa operazionalizzazione ha trovato estesa ap-plicazione, con adeguati adattamenti, anche nel-l’ambito scolastico (Frymier, Shulman, & Hou-ser, 1996; Schultz & Shulman, 1993) ove l’em-powerment è stato eletto ad obiettivo di inter-venti scolastici rivolti sia ai docenti che agli stu-denti, in quanto associato a sviluppo, crescita, ap-prendimento, realizzazione (Schultz & Shulman,1993).Un ulteriore strumento volto a rilevare l’empo-
IL SISTEMA SANITARIO E L’EMPOWERMENT
114
IQU
AD
ERN
IDI

werment dei lavoratori è laWorker EmpowermentScale (WES) di Leslie,Holzhalb e Holland (1998),che operazionalizza tale costrutto in: orientamentoindividuale, controllo dell’ambiente lavorativo erelazioni lavorative.Se entrambi questi contributi riconducono l’em-powerment a percezioni individuali, altri autorihanno invece posto attenzione alle variabili or-ganizzative-strutturali empowering.Ne è un esem-pio The Conditions forWork Effectiveness Question-naire (CWEQ – I), che rileva 4 dimensioni: l’ac-cesso percepito dal singolo alle opportunità; alsupporto, alle informazioni ed alle risorse presentinel setting lavorativo (Kanter, 1977; Laschinger,1996).Accanto a questa versione di 31 item, è sta-ta prodotta una versione ridotta, la CWEQ-II di19 item (Laschinger et al., 2001).Un altro strumento che proviene dalla prospetti-va strutturale è laMenon Empowerment Scale (Me-non, 2001), che affianca alle due componenti tra-dizionali dell’empowerment (il controllo perce-pito e la competenza percepita), l’interiorizza-zione degli obiettivi organizzativi (cfr. Francesca-to et al., 2007).Il fatto che i lavoratori facciano propri i valori ela mission aziendale dipende però anche dal tipodi leadership esistente. È su questo aspetto che direcente la letteratura ha posto particolare atten-zione. Ne è una testimonianza lo sviluppo delLeader Empowerment Behavior Questionnaire (LEBQ)(Konzack, Stelly, & Trusty, 2000), che misura 7comportamenti empowering del leader: delega del-l’autorità, responsabilità; autonomia decisionale;capacità di problem solving; circolazione delle in-formazioni; sviluppo delle capacità professionalie coaching per performance innovative.Yeatts et al. (2004) hanno il merito di aver ridot-to la distanza tra la prospettiva psicologica e quel-la strutturale con la Yeatts and Cready Dimensionsof Empowerment Measure, che rileva la capacità didecidere nel contesto lavorativo, l’abilità di mo-dificare il lavoro, la percezione che il leader ascol-ti e consulti i dipendenti.Gli strumenti presentati precedentemente hanno
il limite di aver posto in secondo piano, nell’o-perazionalizzazione dell’empowerment, la di-mensione della consapevolezza dei rapporti di po-tere presenti nei contesti di vita del singolo (Fran-cescato et al., 2007).Questo aspetto socio-politi-co è invece centrale nelle operazionalizzazioniche rientrano nell’area della Psicologia di comu-nità.
L’empowerment in ambito di comunitàUno dei principali autori che ha rilevato l’em-powerment in termini di consapevolezza criticadel contesto sociale è Frans (1993); egli descrivel’Empowerment del gruppo degli operatori so-ciali, non solo in termini di percezione positivadi sé (“Mi considero competente quanto gli altri”;“So-no sicuro di me”) e possesso di abilità e conoscen-za professionale (“L’educazione mi ha adeguatamenteformato per questo lavoro”;“Leggo riviste del settore”),ma con ulteriori subscale più attente alle relazio-ne dell’individuo con il contesto circostante.Nel-lo specifico rileva la percezione di un’identità col-lettiva tra gli operatori (“Lavoro con gli altri per ri-solvere i problemi”;“Spendo molto tempo con altri spe-cialisti”), la Consapevolezza critica delle relazio-ni di potere esistenti nel contesto di vita (So chidetiene il potere) e la Propensione all’Azione(Tendo a svolgere attività di volontariato) intesacome impegno per scopi sociali.Questi ultimi aspetti sono stati centrali nel con-tributo di Zimmerman & Zahniser (1991). Gliautori elaborano la Sociopolitical Control Scale (SPC),operazionalizzando la dimensione intrapersonaledell’empowerment in competenza di leadership(“Preferisco essere un leader piuttosto che un seguace”;“Sono spesso un leader nei gruppi”) e controllo so-cio-politico (“Difficilmente c’è differenza tra i can-didati politici, una volta che una persona vince le ele-zioni fa ciò che vuole”;“Penso di avere una buona com-prensione delle questioni politiche della nostra società”).In aggiunta rilevano la dimensione comporta-mentale dell’empowerment (Kieffer, 1984;Rap-paport, 1987; Speer & Peterson, 2000; Zimmer-man, 1995; Human, 1990; Gutierrez & Ortega,
Empowerment e valutazione
115
IQU
AD
ERN
IDI

1991; Bachrach, 1993; Gutierrez, 1995; Zippay,1995; Gant & Gutierrez, 1996; Gilliam, 1996)chiedendo ai soggetti di indicare quante volte nelcorso degli ultimi tre mesi hanno messo in attodei comportamenti di impegno sociale [“Ho fat-to tutto ciò che mi era possibile (partecipare ad una ma-nifestazione, sottoscrivere una petizione...) per fare pres-sione su un determinato cambiamento politico”;“Hopreso parte alle decisioni dei miei contesti di vita (fa-miglia, Università, associazioni, club, gruppo religio-so...)”].La dimensione comportamentale dell’empo-werment in realtà è ad oggi oggetto di dibatti-to teorico: se infatti alcuni autori definiscono ilnesso tra partecipazione ed empowerment “in-clusivo” (Mannarini, 2004), per altri ciò che qua-lifica l’empowerment non sono i comportamenti,le reali azioni messe in atto dal singolo,ma l’in-teresse per le questioni socio-politiche dell’am-biente di vita. La partecipazione diverrebbe unaconseguenza inevitabile di questo coinvolgi-mento psicologico (Speer, Jackson, & Peterson,2001).In questa prospettiva si inserisce il recente con-tributo di Francescato et al. del 2007. Gli autori,a partire da una revisione della letteratura prove-niente dall’ambito della Psicologia di comunità edelle Organizzazioni, focalizzano l’attenzione sutre componenti che a loro avviso qualificano l’em-powerment: la speranzosità, vale a dire la tendenzaad immaginare un futuro favorevole, proprio edaltrui e la credenza che si possa esercitare un cer-to controllo sull’evoluzione degli eventi (cfr. Bru-scaglioni, Gheno 2000); la competenza operativaossia la capacità di mettere in pratica specificheazioni finalizzate al perseguimento degli scopipersonali; la consapevolezza socio-politica, che in-clude la comprensione critica delle questioni so-cio-politiche e l’interesse, più che le reali azioni,a prendervi parte o meno.Un’ultima considerazione riguarda la dimensio-ne Interpersonale dell’empowerment, che è in-vece stata operazionalizzata da Speer e Peterson(2000); gli autori, sulla base della letteratura so-
ciologica, organizzativa e del lavoro sociale, di co-munità (Long, 1958; Lukes, 1974;Brager, Specht,& Torczymer, 1987; Mondres &Wilson, 1994;Robinson & Hanna, 1994;Speer & Hughey, 1995)hanno ricondotto la dimensione interpersonaledell’empowerment alle seguenti convinzioni: a)che il potere si sviluppi nelle relazioni interper-sonali (potere sviluppato attraverso le relazioni)(Robinson & Hanna, 1994; Speer & Hughey,1995); b) che le persone che detengono il pote-re politico esercitino la loro influenza sulla co-munità in tre modi:�elargendo premi o punizioni (funzionamento po-litico) (Long, 1958; Bachrach & Baratz, 1962);
�guidando i dibattiti socio-politici (defining de-bate);
� influenzando il modo di leggere la realtà da par-te della collettività (condivisione di un’ideologia)(Lukes, 1974; Gaventa, 1980).Nella realtà, la scala proposta da Speer e Petersonper rilevare la dimensione interpersonale del-l’empowerment ha avuto meno successo ed è sta-ta meno utilizzata nella ricerca empirica, soprat-tutto nel contesto italiano, rispetto alla SPC, adeccezione di un pre-test effettuato da Marcon eCicognani (2004) che ha evidenziato come per ipartecipanti allo studio una siffatta operaziona-lizzazione sia di faticosa comprensione: essi infat-ti la definiscono come eccessivamente “astratta”e difficilmente rapportabile alla loro esperienzareale.
CRITICITÀ E PROSPETTIVE FUTURE PER LARILEVAZIONE DELL’EMPOWERMENTSebbene l’empowerment sia stato concettualiz-zato nei suoi diversi livelli (individuale, organiz-zativo, di comunità) e nella sua duplice natura (ri-sultato/processo) (Zimmeman, 2004), concreta-mente la ricerca scientifica si è limitata a misura-re l’empowerment così come è percepito dal sin-golo, nella sua natura di outcome individuale, construmenti che “cristallizzano” l’empowerment adun quantum oggettivabile.
IL SISTEMA SANITARIO E L’EMPOWERMENT
116
IQU
AD
ERN
IDI

L’empowerment outcome-individualenella letteraturaIn linea con tali considerazioni si inserisce lo stu-dio di Marcon (2008), che analizza dal punto divista testuale gli abstract pubblicati dal 1983 al2007 e che presentavano nel titolo la parola chia-ve “empowerment” (Marcon, 2008). Nello spe-cifico, attraverso l’applicazione del softwareT-LabMultilingue, versione ProVersione 4.1, su un cor-pus di 1271 abstract, sono state effettuate tre tipidi analisi: mappatura dei cluster semantici, asso-ciazioni di parole e delle corrispondenze.La prima analisi ha permesso di organizzare l’in-tera produzione scientifica considerata in 4 “clas-si semantiche”:�Empowerment organizzativo comprendelemmi che fanno riferimento alla ricerca sul-l’empowerment psicologico dei lavoratori (que-stionnaire, perception, employee, scale) e alle varia-bili ad esso connesse (relationship, job, satisfaction,organizational, leader).
�Empowerment nella promozione della sa-lute fa riferimento al piano dell’intervento pre-ventivo (health, program, mental, intervention, pro-motion) realizzato con tecniche partecipative(collaborative, partecipatory, system, community-ba-sed) e rivolto all’intera comunità (community,people).
�Empowerment socio-politico raccoglie par-te degli abstract che indagano l’empowermentcome processo socio-politico (political, social), diacquisizione di potere (power) da parte di indi-vidui e gruppi in condizione di svantaggio (op-press, identity).Vi rientrano conseguentementelemmi che si riferiscono ai movimenti femmi-nisti (women, feminist).
�Empowerment come Oggetto dal momen-to che raccoglie i lemmi tipici e caratteristicidella ricerca quantitativa (posttest, experimental)volta a rilevare (measure, analyse, level, rate, result)statisticamente (statistically) l’empowerment (FEI,subscales) e le sue dinamiche processuali (predic-tor, variable, regression, effects) in soggetti diversi (ss,child, family).
Al di là del cluster di appartenenza, l’analisi delleassociazioni di parole ha permesso di dimostrareche l’empowerment è stato studiato soprattuttoa livello individuale, come testimonia la forte as-sociazione riscontrata con lemmi quali competen-ce, self-determination,meaning (che corrispondonoalle tre dimensioni proposte da Spreitzer, 1995).Non è comparsa invece la componente impact,che si riferisce alla percezione di avere un’influenzasulla realtà attraverso la propria attività lavorativa.Sembra dunque che di empowerment si parli so-prattutto in riferimento a dimensioni che Zim-merman (2000) considererebbe “intrapersonali”.Diversi autori hanno però evidenziato che esse-re empowered non significa solo sentirsi capaci, ingrado di raggiungere i propri obiettivi e di faredelle scelte in maniera autonoma, ma è un esse-re interessati alle questioni socio-politiche circo-stanti, un desiderare ogni qual volta possibile, pren-dere parte a manifestazioni, attività per l’interes-se collettivo (Le Bosse et al., 1999; Francescato etal., 2007).In aggiunta, l’analisi delle corrispondenze ha per-messo inoltre di evidenziare che l’accentuazionedella componente intrapersonale dell’empower-ment non è una costante della letteratura,ma si èfatta più forte con il passare del tempo. I primiarticoli scientifici infatti sottolineavano i valori ele implicazioni politico-sociali di tale costrutto.Essere empowered significava farsi strada in una si-tuazione di svantaggio, di iniquità per raggiun-gere una condizione sociale migliore, affrontare esuperare le diverse forme di razzismo per giun-gere ad un riconoscimento dei propri diritti.Con il 1995, il modo di considerare l’empower-ment è cambiato: sono gli anni in cui si fa fortela necessità di studiarlo quantitativamente, attra-verso adeguati strumenti di misurazione.Da quel-la data è come se i valori di natura quasi “rivolu-zionaria”, di cambiamento verso una condizionesocio-politica migliore, passassero in secondo pia-no a fronte di un acuirsi delle questioni di carat-tere metodologico. Si è assistito quindi ad un pro-gredire della ricerca scientifica, della rilevazione
Empowerment e valutazione
117
IQU
AD
ERN
IDI

del grado di empowerment del singolo.Ciò nonè avulso da rischi.Ridurre infatti l’empowermentad un level, ad un data da misurare, lo “cristalliz-za”, riducendolo a qualcosa di statico. La naturadi tale costrutto è invece “dinamica”, non è qual-cosa che può essere trasferito da un individuo al-l’altro, ma deve essere conquistato e riconquista-to dal soggetto all’interno delle relazioni e di uncontesto sociale specifico. In altri termini il “tar-get” non è solo “oggetto”, ma “attore” nel pro-cesso di acquisizione di potere.Ed è soprattutto la letteratura del 2007 che, purmantenendo una centratura sulla ricerca, ridà cen-tralità al “protagonismo” del singolo, del gruppoe della comunità.Negli ultimi anni quindi si è sentita la necessitàdi continuare a studiare l’empowerment,ma ana-lizzandone il suo divenire processuale, ridandocentralità al modo in cui l’individuo, il gruppo,l’intera comunità gioca il processo di acquisi-zione di potere all’interno delle relazioni quo-tidiane.Per fare ciò è necessario superare uno dei limitidella ricerca scientifica, ossia la tendenza a foca-lizzare l’attenzione su porzioni del processo diempowerment, a discapito della comprensionedella totale dinamica processuale (Robbins, Cri-no, & Fredendall, 2002).
L’empowerment come processo:una tendenza in attoÈ dall’ambito organizzativo che ha preso avvio laricerca attuale ad “articolare” le prospettive di in-dagine individuale/psicologico, organizzati-vo/strutturale, di comunità/critico (Quinn,Spreit-zer, 1997; Chan, 2005; Siebert, Silver, & Ran-dolph, 2004), per pervenire ad un modello com-plessivo dell’empowerment processuale, che pon-ga attenzione anche alle caratteristiche culturalidell’ambiente politico e sociale entro cui tale pro-cesso si manifesta.Tale proposta è scaturita da os-servazioni empiriche: in alcuni contesti infattil’applicazione di tecniche manageriali considera-te empowering, come per esempio una leadership
partecipativa, sortivano addirittura effetti contra-ri a quelli auspicati, come per esempio un au-mento del sentimento di impotenza appresa. Fo-ster-Fishman e Keys (1997), nel cercare di spie-gare questo fenomeno, hanno evidenziato comequalsiasi iniziativa non si realizzi in un “vuoto”,ma all’interno di una specifica cultura, di sistemicondivisi di significato (Smircich, 1983), che gui-dano le credenze dei diversi soggetti, il loro pen-siero, le loro percezioni, i loro sentimenti e diri-gono i loro comportamenti (Schein, 1985). Le di-verse iniziative empowering quindi avranno mag-gior probabilità di sortire degli effetti desideratiin due casi principali: se sono compatibili con lacultura organizzativa esistente (Schein, 1985) op-pure se in quella organizzazione sono presenti lecondizioni necessarie per il cambiamento, qualiper esempio le abilità di cambiare ed espanderela struttura di potere e di includere i membri del-lo staff nei processi decisionali (Foster-Fishman& Keys, 1997). Naturalmente tutti questi aspettirisentono a loro volta delle caratteristiche cultu-rali dell’ambiente sociale e politico circostante.Randolph e Sashkin (2002), infatti, in una ricer-ca condotta con lavoratori di aziende tessili, han-no riscontrato che persone con una cultura indi-vidualista avevano maggiori difficoltà nel lavora-re in gruppo perché le informazioni, le risorse, icompiti lavorativi vengono percepiti come per-sonali, individuali, non condivisibili.Anche il di-verso grado di “centrismo” di una cultura in-fluenza le prestazioni lavorative di soggetti in con-dizioni di lavoro empowering (Kluckhohn & Strodt-beck, 1961;Hofstede, 1980; Schein, 1992); EyloneAu (1999), a riguardo, hanno riscontrato che gliindividui provenienti da culture di tipo paterna-listico, per esempio abituati alle figure di autori-tà, ad un accesso limitato all’informazione e a re-sponsabilità circoscritte offrivano performancemeno eccellenti in situazioni organizzative di con-divisione.Le considerazioni precedenti sottolineano la com-plessità degli aspetti che entrano in gioco in unprocesso di empowerment e inducono una ri-
IL SISTEMA SANITARIO E L’EMPOWERMENT
118
IQU
AD
ERN
IDI

flessione sugli strumenti utilizzabili per monito-rare e rilevare questi aspetti di natura culturale eprocessuale.
VERSO NUOVI STRUMENTI DIRILEVAZIONE DELL’EMPOWERMENTDato che l’empowerment è un processo che ac-cade e si manifesta all’interno di uno specificocontesto è necessario mettere a punto diversi stru-menti in grado di: a) focalizzare l’attenzione sul“singolo in costante interazione con” il contestoprossimale e distale di cui fa parte; b) rilevare ilprocesso, il cambiamento, le dinamiche relazio-nali che accadono e che possono ostacolare o fa-vorire il processo di acquisizione di potere.Non è quindi più sufficiente la rilevazione del-l’empowerment con questionari ad hoc,ma è ne-cessario utilizzare nuovi strumenti che “allarghi-no” il focus attentivo.La proposta di Laverack (2001) si inserisce in que-sta prospettiva; l’autore propone alcuni dominioperativi (Tabella 3), ottenuti da una revisionedella letteratura esistente, attraverso i quali legge-re e “narrare” il processo di empowerment di unacomunità e valutare l’effettiva efficacia di inter-venti empowering.Tali domini possono essere definiti come aree diinfluenza che portano gli individui o i gruppi adorganizzarsi e mobilitarsi verso dei cambiamentisociali e politici (Jackson, Mitchell, &Wright,1989; Labonte, 1990; Laverack, 2001, 2006). Essi
forniscono una guida per gli operatori definen-do delle aree specifiche sulle quali agire per pro-muovere l’empowerment di comunità e da tene-re “sotto controllo” per valutare il processo atti-vato.Laverack nel 2006 dà un esempio reale dell’uti-lità di ciascun dominio operativo (DO) e del-l’impatto che ha il “narrare e descrivere” un’e-sperienza empowering. Parte da un caso: la defi-nizione di azioni per rispondere al problema del-la violenza sulle donne.Per raggiungere tale obiet-tivo l’autore ipotizza la necessità di creare un cen-tro nel quale le vittime di violenza trovino unaprima accoglienza. La presenza delle donne in ta-le struttura è attiva (DO1; partecipazione), inquanto sono chiamate a partecipare a diversi grup-pi di auto-aiuto guidati da un operatore, con l’o-biettivo di riflettere su quanto accaduto, di indi-viduare i problemi a cui nell’immediato devonorispondere e le strategie per risolverli (DO4; va-lutazione dei bisogni e dei problemi). In aggiun-ta è attraverso la discussione con persone che han-no vissuto vicende analoghe che si possono com-prendere le determinanti sociali della violenza ele eventuali lacune legislative esistenti, con la con-seguente volontà di agire a livello politico percontrastare l’abuso e la violenza (DO6; chiedersiil perchè). La coesione di questi gruppi rafforzal’organizzazione interna del centro ed in alcunicasi determina lo sviluppo di legami con altre or-ganizzazioni delle comunità con finalità simili
Empowerment e valutazione
119
IQU
AD
ERN
IDI
TABELLA 3 - Breve descrizione dei 9 domini operativi di Laverack (2001)
Domini OperativiPartecipazione (DO1)Leadership (DO2)Strutture organizzative (DO3)Valutazione dei bisogni e dei problemi(DO4)
Mobilitazione delle risorse (DO5)Chiedersi il perché (DO6)
Legami con persone ed organizzazioni (DO7)Agenti esterni (DO8)
Gestione dei progetti (DO9)
Partecipare a gruppi e organizzazioni aumenta la capacità di influenzare la propria ed altrui vitaConnessa a partecipazione; la migliore è quella condivisa fra i partecipantiPresenza di gruppi, quali comitati, organizzazioni parrocchiali e giovanili COESEIndividuazione dei problemi, delle possibili soluzioni e di azioni.Apprendimento di nuove competen-ze ed abilitàSia all’interno che all’esterno della comunitàComprendere le ragioni sociali, politiche, economiche dei fenomeni.Aumentare la consapevolezza criticadel proprio territorioPartnership, coalizioni, alleanze volontarie per rispondere ai problemiGruppi, istituzioni, individui in grado di dare supporto infrastrutturale, fungere da facilitatori, finanziare leiniziative, dare sostegno ai leaderControllo degli attori sulle diverse fasi progettuali, di implementazione, finanziarie, amministrative.Chia-rezza di ruoli, responsabilità, ecc.

(DO3; strutture organizzative). In questo percor-so l’operatore assume un ruolo di guida e di fa-cilitazione, favorisce le discussioni nel gruppo, lapresa di coscienza e lo sviluppo di relazioni basa-te sul principio dell’equità con gli agenti esterni(DO8;Agenti esterni). Egli inoltre facilita il pro-cesso di fund-raising. Il centro ed il programmaad esso associato hanno infatti delle risorse limi-tate, le vittime di abusi soprattutto in una primafase collaborano con delle donazioni personali,successivamente si ricercano dei finanziamentiesterni (DO5;mobilitazione delle risorse). Il cen-tro infatti cerca di operare per mantenersi in re-te con altre organizzazioni.Anche a questo livel-lo l’operatore può contribuire fornendo per esem-pio la lista degli enti, delle associazioni con cuirelazionarsi e/o favorendo lo sviluppo di un sitointernet per facilitare il contatto tra centro ed al-tri gruppi (DO7; legami con persone e organiz-zazioni). Se, soprattutto all’inizio, l’operatore as-sume un ruolo centrale in questi diversi compitidi gestione, coordinamento, con il tempo le suefunzioni diminuiscono, pur rimanendo un co-
stante punto di riferimento. Infatti, grazie ancheai diversi corsi di formazione, le donne del cen-tro, che già nelle prime fasi erano state coinvol-te come volontarie nei diversi servizi ammini-strativi (DO2; partecipazione), iniziano ad otte-nere più potere nel controllo, nella gestione-co-ordinamento, nel fund raising e nelle pubbliche re-lazioni con le diverse organizzazioni esistenti(DO9; gestione dei progetti).La proposta operazionale di Laverack è uno deipochi contributi che supera il livello individualedell’empowerment e porta l’attenzione su alcuniaspetti osservabili dall’esterno. Il contributo del-l’autore induce comunque a riflettere sulla ne-cessità di definire nuove modalità per descriveree monitorare dei processi di cambiamento com-plessi, come quelli empowering, spesso “non li-neari”, definiti non solo da aspetti “soggettivi”,ma anche da intenzioni, alleanze in divenire, re-lazioni del singolo con il contesto circostante. So-no però necessari maggiori approfondimenti eulteriori studi per giungere ad elaborare nuovistrumenti di valutazione di processo.
IL SISTEMA SANITARIO E L’EMPOWERMENT
120
IQU
AD
ERN
IDI
BIBLIOGRAFIA• Abramson, Lyn Y.; Seligman, Martin E.; & Teasdale, John D.
(1978). Learned helplessness in humans: Critique and re-formulation. Journal of Abnormal Psychology, 87(1), 49-74.
• Anderson, R. M., Funnell, M. M., Fitzgerald, J.T., & Marrero, D.G. (2000).The diabetes empowerment scale: A measure ofpsychosocial self efficacy. Diabetes Care, 23, 739-743.
• Bachrach, S. B. (1993). The pragmatics of empowerment. La-voro di ricerca. New York: Columbia University.
• Bachrach, P., & Baratz, M. S. (1962).Two faces of power.Amer-ican Political Science Review, 56, 947-952.
• Bandura, A. (1977). Self-efficacy:Toward a unifying theory ofbehavioural change. Psychological Review, 84, 191-215.
• Bandura, A. (1986). Social foundations of through and action:A social-cognitive view. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall.
• Bowen, D., & Lawler, E. III. (1995). Empowering service em-ployees. Sloan Management Review, 36, 73.
• Brager, G., Specht, H., & Torczyner, J. L. (1987). Community or-ganizing. New York: Columbia University Press.
• Bruscaglioni, M., & Gheno, S. (2000). Il gusto del potere: em-powerment di persone ed azienda. Milano: Franco Angeli.
• Burke,W. (1986). Leadership as empowering others. In S. Srivas-tra (Ed.),Executive power (pp. 51-77). San Francisco: Jossey-Bass.
• Champy, J. (1995). Reengineering management:The mandatefor new leadership managing the change to reengineered cor-porations. New York: HarperCollins.
• Chan, Y. H. (2005). A social Exchange-Driven Structural E-quation Model Analysis of Psychological Empowerment. Co-municazione presentata all’ Annual Meeting of Academy ofManagement, “A New Vision of Management in the 21st Cen-tury, Honolulu (On the Island of Oahu), Hawaii, 5-10 Agos-to, 2005. Riferimento disponibile al sito internet:http://apps.aomonline.org/interactivepapers/ipu2005.asp.
• Chandler, G.E. (1986). The relationship of nursing work envi-ronment to empowerment and powerlessness. Unpublisheddoctoral dissertation. University of Utah.
• Cheung,Y. W., Mok, B.-H., & Cheung,T.-S. (2005). Personalempowerment and life satisfaction among self-help groupmembers in Hong Kong. Small Group Research, 36, 354-377
• Conger, J. A., & Kanungo, R. N. (1988).The empowermentprocess: Integrating theory and practice. Academy of Man-agement Review, 13, 471-482.

Empowerment e valutazione
121
IQU
AD
ERN
IDI
• Corrigan, P.W., Faber, D., Rashid, F., & Leary, M. (1999).Theconstruct validity of empowerment among consumers ofmental health services. Schizophrenia Research, 38, 77-84.
• DeCharms, R. (1968). Personal causation:The internal affec-tive determinants of behavior. New York: Academic Press.
• Elder, N.C., Regan, S.L., Pallerla, H., Levin, L., Post, D., & Cegela,D. (2007). Development of an instrument to measure sen-iors’ patient safety health beliefs:The Seniors Empowermentand Advocacy in Patient Safety (SEAPS) survey. Patient Edu-cation and Counseling, 69, 100-107.
• Emirbayer, M., & Goodwin, J. (1994). Network analysis, cul-ture, and the problem of agency. American Journal of Sociol-ogy, 99, 1411-1454.
• Eylon D., & Au, K. (1999). Exploring empowerment cross-cultural differences along the power distance dimension. In-ternational Journal of Intercultural Relations, 3, 373-385.
• Foster-Fishman, P.G., & Keys, C.B. (1997). The Per-son/Environment Dynamics of Employee Empowerment:AnOrganizational Culture Analysis. American Journal of Com-munity Psychology, 25, 345-369.
• Foster-Fishman, P. G., Salem, D. A., Chibnall, S., Legler, R., &Yapchai, C. (1998). Empirical suppor t for the critical as-sumptions of empowerment theory.American Journal of Com-munity Psychology, 26, 507-536.
• Francescato, D., Mebane, M., Sorace, R.,Vecchione, M., & To-mai, M. (2007). EMPO: una scala di misurazione dell’empo-werment personale e politico. Giornale Italiano di psicologia,2, 465-490.
• Frans, D. J. (1993). A Scale for Measuring Social Worker Em-powerment. Research on Social Work Practice, 3, 312-328.
• Frymier, A.B., Hulman, G.M., & Houser, M. (1996).The devel-opment of a learner empowerment measure. Communica-tion Education, 45, 181-199.
• Gant, L. M., & Gutierrez, L. M. (1996). Effects of culturally so-phisticated agencies on Latino social workers. Social Work,41, 624-631.
• Gaventa, J. (1980). Power and powerlessness: Quiescence andrebellion in an Appalachian Valley. Urbana: University of IllinoisPress.
• Gilliam, F. D. (1996). Exploring minority empowerment:Symbolic politics, governing coalitions, and traces of polit-ical style in Los Angeles. American Journal of Political Sci-ence, 40, 56-81.
• Gomez, C., & Rosen, B. (1994).The relationship betweenmanagerial trust, employee empowerment, and employeeperformance. Paper presented at the Academy of Manage-ment Meetings.Dallas,TX.
• Gutierrez, L. M. (1995). Understanding the empowermentprocess: Does consciousness make a difference? SocialWorkResearch, 19, 229-237.
• Gutierrez, L. M., & Ortega, R. (1991). Developing methodsto empower Latinos:The importance of groups. SocialWorkwith Groups, 14, 23-43.
• Hansson L., & Björkman T (2005). Empowerment in peoplewith a mental illness: reliability and validity of the Swedishversion of an empowerment scale. Scandinavian Journal ofCaring Science, 19; 32-38.
• Hasenfeld,Y. (1987). Power in social work practice. Social Serv-ice Review, 61, 469-483.
• Hofstede, G. (1980). Culture’s consequences. International dif-ferences in work-related values. London: Sage.
• Human, L. (1990). Empowerment through development: therole of affirmative action and management development in
the demise of apartheid.Management Education and Devel-opment, 4, 273-86.
• Ibarra, H. (1991). Informal networks of women and minoritiesin management:A conceptual framework.Working paper, Har-vard Business School.
• Jackson,T., Mitchell, S., & Wright, M. (1989).The communi-ty development continuum. Community Health Studies, 8,66-73.
• Kanter, R. M. (1977).Maschile e femminile in azienda. Milano:Edizioni Olivares. (Trad. it. 1988.)
• Kanter, R. M. (1979). Power failure in management circuits.Harvard Business Review, 57, 65-75.
• Kanter, R. M. (1983). The change masters. New York: Simon& Schuster.
• Kanter, R. M. (1986). Empowering people to act on ideas. Ex-ecutives Excellence, 5-6.
• Kanter, R. M. (1989).The new managerial work.Harvard Busi-ness Review, 66, 85-92.
• Karsten, M. F. (1994).Management and gender. New York:Praeger.
• Kieffer, C. H. (1984). Citizen empowerment: A developmen-tal perspective. Prevention in Human Services, 3, 9-30.
• Kluckhohn, F. R., & Strodtbeck, F. L. (1961). Variations in valueorientation. New York: Row, Peterson, and Company.
• Konczak, L.J., Stelly, D.J., & Trusty, M.L. (2000). Measuring Em-powering Behaviors of Managers: Development of an Up-ward Feedback Instrument. Educational and PsychologicalMeasurement, 60, 301-313.
• Koren, P.E., DeChillo, N., & Friesen, B. J. (1992). Measuring em-powerment in families whose children have emotional dis-abilities: A brief questionnaire. Rehabilitation Psychology, 37,305-321.
• Labonte, R. (1990). Empowerment: Notes on professionaland community dimensions. Canadian Review of Social Policy,26, 64-75.
• Laschinger H.K.S. (1996) A theoretical approach to studyingwork empowerment in nursing: a review of studies testingKanter_s theory of structural power in organizations.Nurs-ing Administration Quarterly 20 (2), 25–41.
• Laschinger, H. K. S., Finegan, J., & Shamian, J. (2001).The im-pact of workplace empowerment and organizational truston staff nurses’ work satisfaction and organizational com-mitment. Health Care Management Review, 26, 7-23.
• Laschinger, H. K. S., Finegan, J., Shamian, J., & Wilk, P. (2004). Alongitudinal analysis of the impact of workplace empower-ment on work satisfaction. Journal of Organizational Behavior,25, 527-545.
• Laverack, G. (2001). An identification and interpretation ofthe organizational aspects of community empowerment.Community Development Journal, 36, 40-52.
• Laverack, G. (2006). Using a “domains” approach to buildcommunity empowerment. Community Development Journal,4, 4-12.
• Lawler, E. E. III (1992). The ultimate advantage. San Francisco:Jossey-Bass.
• LeBosse,Y., LaVallee, M., Lacerte, D., Dube, N., Nadeau, J., &Porcher, E (1999). Is community participation empirical evi-dence for psychological empowerment?: Distinction betweenpassive and active participation. Journal of SocialWork and So-cial Sciences Review, 8, 59-82.
• Leslie, D. R., Holzhalb, C. M., & Holland,T. P. (1998). MeasuringStaff Empowerment: Development of a Worker Empower-ment Scale. Research on SocialWork Practice; 8, 212-222.

• Long, N. E. (1958).The local community as an ecology ofgames. American Journal of Sociology, 64, 251-261.
• Lukes, S. (1974). Power:A Radical View. London: Macmillan.• Mannarini,T. (2004).Comunità e partecipazione. Milano: Fran-
co Angeli.• Marcon (2008). L’empowerment degli studenti universi-tari. Analisi del costrutto e sviluppo di uno strumento dimisurazione . Tesi di Dottorato consultabile al sitohttp://amsdottorato.cib.unibo.it/1079/
• Marcon, A., Cicognani, E. (2004). Il Progetto “C’Entro” di Tar-visio eTrasaghis: una occasione per favorire l’empowerment?.In C. Novara & Mandalà M. (a cura di), Le Comunità Possibi-li (pp. 28-30). Preatti del V Congresso Nazionale di Psicolo-gia di Comunità. Palermo 3-5 giugno 2004. Palermo: CentroSiciliano Sturzo.
• Menon, S.T. (2001). Employee empowerment:An integrativepsychological approach. Applied Psychology: An InternationalReview, 50, 153-180.
• Miller, P. A, Goddard, P., & Laschinger, H. K. S. (2001). Evaluat-ing Psysical Therapists’s Perception of Empowerment UsingKanter’s Theory of Structural Power in Organizations. Phys-ical Therapy, 82, 1880-1888.
• Mondres, J. B., & Wilson, S. M. (1994). Organizing for powerand empowerment. New York: Columbia University Press.
• Parsons, R. J. (1991). Empowerment: Purpose and practiceprinciple in social work. Social Work with Groups, 14, 7-21.
• Parsons, R. J. (2002). Guidelines for empowerment-based so-cial work practice. In A. R. Roberts & G. J. Greene (Eds.), So-cial workers’s desk reference (pp. 396-401). New York: Ox-ford University Press.
• Piccardo, C. (1992). Empowerment, una nuova parola d’or-dine per lo sviluppo organizzativo degli anni ’90. Sviluppo eorganizzazione, 134, 21-31.
• Quaglino, G.P. (1999). Voglia di fare. Milano: Guerini Ed.• Randolph,A.W., & Sashkin, M. (2002). Can organizational em-
powerment work in multinational settings? Academy of Man-agement Executive, 16, 102-115.
• Rappaport, J. (1981). In praise of paradox. A social policy ofempowerment over prevention. American Journal of Com-munity Psychology, 1, 1-25.
• Rappaport, J. (1987).Terms of empowerment/ exemplars ifprevention:Toward a theory for community psychology.Amer-ican Journal of Community Psychology, 15, 121-148.
• Robbins,T.L., Crino, M.D., & Fredendall, L.D. (2002). An inte-grative model of the empowerment process. Human Re-source Management Review, 12, 2002, 419-443.
• Robinson, B., & Hanna, M. G. (1994). Lesson for academicsfrom grassroots community organizing: A case study-the In-dustrial Areas Foundation. Journal of Community Practice, 1,63-94.
• Rogers, E. S., Chamberlin, J., Eleison, M. L., & Crean,T. (1997).A Consumer-Costructed Scale to Measure EmpowermentAmong Users of Mental health Services. Psychiatric Services,48, 1042-1047.
• Rotter, J. B. (1966). Generalized expectancies for internal ver-sus external control of reinforcement. Psychological Mono-graphs: General and Applied, 80, 1-28.
• Schein, E. H. (1985).Organizational culture and leadership. SanFrancisco: Jossey-Bass.
• Schein, E. H. (1992).Organizational culture and leadership, vol.12. San Francisco: Jossey-Bass.
• Schultz, S., & Schulman, G. (1993). The development and as-sessment of the job empowerment instrument (JEI). Paper p-resentato al Join CentralStates Communication Associationand Southern States Communication Association, Lexing-ton, KY.
• Sherer, M., & Adams, C. (1983). Construct validation of theSelf Efficacy Scale. Psychological Reports, 53, 899-902.
• Short, P. M., & Rinehart, J. S. (1992). School participant em-powerment scale.Educational and Psychological Measurement,52, 951-960.
• Siebert, S. E., Silver, S. R., & Randolph,W.A. (2004).Taking em-powerment to the next level: A multiple-level model of em-powerment, performance, and employee reciprocity. Journalof Applied Psychology, 81, 219-227.
• Speer, P.W., & Hunghey, J. (1995). Community organizing: Anecological route to empowerment and power.American Jour-nal of Community Psychology, 23, 729-748.
• Speer, P. W., Jackson, C. B., & Peterson, N. A. (2001).The re-lationship between social cohesion and empowerment: Sup-port and new implications for theory. Health Education &Behavior, 28, 716-732.
• Speer, P. W., & Peterson, N. A. (2000). Psychometric prop-erties of an empowerment scale: Testing cognitive, emo-tional, and behavioural domains. Social Work Research, 24,109-118.
• Spreitzer, G. M. (1995). Individual empowerment in work-place: Dimensions, measurement, and validation. Academy ofManagement Journal, 38, 1442-1465.
• Spreitzer, G. M. (1996). Social structural characteristic of psy-chological empowerment. Academy ofManagement Journal,39, 483-504.
• Spreitzer, G. M., & Doneson, D. (2005). Musing on the Pastand Future of Employee Empowerment. In T. Cummings(Eds.), Forthcoming in 2005 in the Handbook of Organization-al Development (pp. 2-25).Thousand Oaks: Sage.
• Thomas, K.W., & Velthouse, B. A. (1990). Cognitive Elementsof Empowerment: An “Interpretive” Model of Intrinsic TaskMotivation. Academy of Management Review, 15, 666-681.
• Wilkinson, R. G. (1996). Unhealthy societies:The allictions ofinequality. New York: Routledge.
• Yeatts, D., Cready, C., Ray, B., DeWitt, A., & Queen, C. (2004).Self-managed work teams in nursing homes: implementingand empowering nurse aide teams. The Gerontologist, 44,256-261.
• Zani, B., & Palmonari, A. (1996).Manuale di psicologia di co-munità. Bologna: Il Mulino.
• Zimmerman, M. (1995). Psichological empowerment: issuesand illustrations. American Journal of Community Psychology,5, 581-599.
• Zimmerman, M. (2000). Empowerment theory. In J. Rappa-port, & E. Seidman (Eds), Handbook of community psycholo-gy (pp. 43-63). New York: Kluwer Academic/Plenum Press.
• Zimmerman, M. A. (2004). Comunicazione presentata al 9th
Biennal Conference of the European Association for Re-search on Adolescence (Porto, 4-8 maggio).
• Zimmerman, M. A., & Zahniser, J. H. (1991). Refinements ofsphere-specific measures of perceived control: developmentof a sociopolitical control scale. Journal of Community Psy-chology, 19, 189-204.
• Zippay, A. (1995).The politics of empowerment. SocialWork,40, 263-267.
IL SISTEMA SANITARIO E L’EMPOWERMENT
122
IQU
AD
ERN
IDI

I CITTADINI,L’EMPOWERMENTE LA VALUTAZIONE

IL SISTEMA SANITARIO E L’EMPOWERMENT
124
iQua
dern
idi
Il cittadino, inteso come colui che si avvale diun servizio sanitario, è chiamato sempre piùspesso ad essere coinvolto in prima personanelle decisioni relative alla sua salute, si pensi
ad esempio alle varie campagne di prevenzioneche si rivolgono direttamente al pubblico. In let-teratura poi si ritrovano diverse esperienze in cuiil cittadino è coinvolto nelle decisioni che ri-guardano le scelte sanitarie della comunità cui ap-partiene. Esempi di queste attività si ritrovano inAustralia, Stati Uniti,Canada,Regno Unito,Nor-vegia e Olanda dove esperienze significative so-no state fatte in particolare nella scelta degli obiet-tivi della ricerca e dell’assistenza, nella scelta del-l’allocazione di risorse e finanziamenti o nel pro-cesso di approvazione di nuovi farmaci o proget-ti di ricerca.A fronte di questo panorama, da più parti si stadiscutendo del possibile ruolo di “cittadini com-petenti” che, conoscendo principi e metodi chegovernano decisioni e scelte in sanità, partecipi-no in modo preparato, autonomo e collaborativoal dibattito in collaborazione con la comunitàscientifica e avendo come interlocutori privile-giati le istituzioni. Le associazioni di cittadini epazienti sono, o dovrebbero essere, in prima lineasu questo fronte alla luce della diretta esperienzain campo sanitario, delle attività di promozione e
difesa dei diritti, dell’autonomia di ruolo. Per ar-rivare a poter avere un ruolo riconoscibile e ri-conosciuto è molto importante investire in atti-vità di empowerment (letteralmente rafforzamentoo potenziamento) che permettano di avere co-noscenze e competenze per un dibattito vera-mente alla pari.PartecipaSalute è un progetto nato nel 2003 dall’u-nione di tre diverse componenti: l’Istituto MarioNegri con il laboratorio di ricerca per il coinvol-gimento dei cittadini in sanità, il Centro Cochra-ne Italiano e Zadig editoria scientifica. Il progettodi ricerca, sostenuto da un finanziamento dellaCompagnia di San Paolo,mira alla creazione di unacollaborazione diffusa tra rappresentanti di pazientie cittadini e della comunità medico scientifica euna delle aree di attività è proprio quella dell’em-powerment. Diverse ma complementari le espe-rienze da cui si è partiti: l’Istituto Mario Negri datempo sviluppa attività con le associazioni di pa-zienti, tra cui corsi di formazione, organizzazionedi conferenze di consenso multidisciplinari e di-vulgazione di informazioni al pubblico; il CentroCochrane Italiano è impegnato nella traduzione inlinguaggio divulgativo dei risultati delle revisionie nel sostegno al Cochrane Consumer Network;Zadig editoria scientifica è coinvolta all’interno delProgramma Nazionale Linee Guida che vede pro-
FARE EMPOWERMENTCON LE ASSOCIAZIONI DICITTADINI E PAZIENTIL’esperienza di Partecipasalute
di Mosconi P.*, Colombo C.*, Liberati A.**, Satolli R.***
* Laboratorio di ricerca per il coinvolgimento dei cittadini in sanità, Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri,Milano;**Centro Cochrane Italiano, Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri,Milano;***Zadig editoria scientifica,Milano

tagonisti anche rappresentanti di cittadini o pazientie si occupa di divulgazione scientifica. Sulla basedelle diverse esperienze si è avviata la discussionedi un programma di formazione dedicato non so-lo a creare competenze ma anche a creare i pre-supposti per collaborazioni fattive (http://www.partecipasalute.it/cms_2/node/40).
IL PERCORSO FORMATIVO DIPARTECIPASALUTESulla base delle esperienze fatte si è messo a pun-to un percorso formativo che fosse strutturato:�come uno scambio di esperienze in un percor-so interattivo mirato a creare occasioni di con-fronto, rifuggendo dal modello docente-discente;
�con argomenti di interesse generale che rappre-sentino occasione per un dibattito più allargatosul valore e il significato metodologico dei te-mi trattati. La scelta esplicita è quella di non fo-calizzarsi su argomenti specie-specifici in basealle caratteristiche delle associazioni partecipan-ti ma offrire un panorama più ampio;
�con una sequenza modulare adattabile a specifi-che richieste formative da parte dei promotori;
� in modo da favorire la creazione di un gruppo dilavoro (GRAL,Gruppo Rappresentanti Associa-zioni e Laici) che condivida le finalità del proget-to e possa essere coinvolto in attività specifiche(http://www.partecipasalute.it/cms_2/search/node/gral).Gli argomenti che hanno fatto da traccia alle quat-tro edizioni del percorso di formazione di Parte-cipaSalute sono stati:� l’alfabeto della ricerca clinica con l’obietti-vo di offrire ai partecipanti un inquadramentoconcettuale e pratico per interpretare la meto-dologia della ricerca epidemiologico/clinica; da-re strumenti per la valutazione critica della me-todologia della ricerca epidemiologico/clinica;educare alla consapevolezza delle potenzialità elimiti della metodologia della ricerca epide-miologico/clinica; approfondire la conoscenzadei rapporti tra la dimensione scientifica ed eti-ca della ricerca epidemiologico/clinica;
� incertezze in medicina con l’obiettivo di ana-lizzare la natura probabilistica delle conoscenzemediche; comprendere le ragioni, intrinseche estoriche, per cui la pratica clinica è altamentevariabile: da medico a medico, da luogo a luo-go, da epoca a epoca; approfondire l’importan-za dei valori e delle preferenze nelle decisionimediche;
�conflitti di interesse in medicina con l’o-biettivo di creare coscienza del problema deiconflitti di interesse nel mondo della ricerca edella sanità; far comprendere le possibili conse-guenze dei conflitti di interesse sulla nostra sa-lute; acquisire gli strumenti necessari per capi-re quando c’è un conflitto di interesse e sottoquali forme si può manifestare; chiarire quali po-trebbero essere le modalità migliori per attenuarele conseguenze dei conflitti di interesse nel cam-po della salute;
�strategie della informazione sulla salutecon l’obiettivo di presentare tecniche e strate-gie nella comunicazione sul farmaco, sugli stu-di clinici in corso e sulla ricerca, usate da diver-se fonti; stimolare una lettura critica delle in-formazioni medico scientifiche;
�credibilità e potenzialità delle associazio-ni con l’obiettivo di discutere i requisiti utili adaumentare la credibilità delle associazioni; iden-tificare potenzialità di partecipazione delle asso-ciazioni nel dibattito in sanità; identificare i pos-sibili ruoli di advocacy (tutela e difesa dei dirit-ti) e lobby (azione di pressione a livello politicoe sanitario); discutere e definire il modulo “Mi-suraAssociazioni” del sito PartecipaSalute;
�partecipare alla pari alle attività dei co-mitati etici con l’obiettivo di discutere le fina-lità e analizzare i modelli di funzionamento deiComitati Etici (CE) in Italia; approfondire co-me i CE oggi operano relativamente alle lorofinalità istituzionali; discutere i rapporti tra di-mensione scientifica ed etica della ricerca; dis-cutere prospettive e modifiche da introdurre nel-l’organizzazione dei CE.Tutto il percorso di formazione viene valutato at-
Fare empowerment con le associazioni di cittadini e pazienti: l’esperienza di Partecipasalute
125
IQU
AD
ERN
IDI

traverso moduli di auto compilazione. Il primogiorno del percorso ad ogni partecipante è chie-sto di compilare in modo non anonimo un que-stionario di valutazione delle proprie conoscen-
ze sui temi del percorso formativo, lo stesso que-stionario è compilato a conclusione del percor-so. I risultati del questionario prima-dopo ven-gono inviati a tutti con una valutazione persona-
IL SISTEMA SANITARIO E L’EMPOWERMENT
126
IQU
AD
ERN
IDI
Edizione anno N. iscritti Associazione/Ente dei partecipantiN.ammessi Associazioni pazienti Associazioni cittadini Altro ente
TABELLA 1 - Caratteristiche degli iscritti e dei partecipanti ai percorsi di formazione di Partecipasalute
1°2005-2006
2°2007
3°2008
4°2009-2010(**)
5624
4332
4928
7331
AILS, SclerodermiaAss. Psoriasi eVitiligineAss. Serena, tumore senoAss. StomizzatiAttivecomeprima, tumore senoFederazione Diabete GiovanileFondazione ParacelsoLa Nostra FamigliaLega Italiana lottaTumoriUILDM,Didstrofia muscolareAFADOC,Ormone crescitaAICE, EpilessiaAILS, SclerodermiaAISLA, SclerosiAmiotroficaALOMAR,Malati reumaticiANIMASS, Sindrome SjongrenAss. Serena, tumore senoAss. Siblings, Sindrome DownAss.TalassemiciAss. Psoriasi eVitiligineFed.Diabete GiovanileFed.Veneta DiabeticiParkinson LombardiaPr.Alice, Sindr. Emolitico UremicaJuvenile Diabetes Res FoundationAss. Serena, tumore senoAIM Rare,malattie rareAMECAV,malattie epaticheAss. Siblings, sindrome DownAss.TetraparaplegiciANIMASS, sindrome SjongrenALOMAR,malati reumaticiParkinson ItaliaAFADOC,Ormone crescitaAISNAF, sindr. neurodegenerativeAss.Crisponi e malattie rareLILA, lotta all'AidsADAP, diabeteAIDE, dislipidemie ereditarieAILS, sclerodermiaAIM Rare,malattie rareAIPA, paz. anticoagulatiAlice Onlus, ictus cerebraliANMAR, paz. reumaticiAPMAR, paz. reumaticiAss.Crisponi e malattie rareAss. Semi per la SidsAss. Serena, tumore senoAss.DiabeteATRACTO, traumi craniciAttoTrapiantiFed.DiabeticiFederasmaLa Lampada diAladino, oncologia
AltroconsumoCittadinanzattivaFederconsumatoriMovim.Difesa ConsumatoriMovimentoVolontariato It.Centro Diritti Malato
AltroconsumoCittadinanzattivaFederconsumatoriMovimento Consumatori
EuroconsumersAltroconsumoMovimento Consumatori
AltroconsumoCittadinanzattivaComitato Cittadini Indipend.FederconsumatoriAss.Mutilati Invalidi
CE HSRCEAO,R. EmiliaCEAO, VeronaCE Università, BariCEAUSL,GrossetoCollegio Ipasvi
Asl Città di MilanoCE HSRCollegio IpasviFondo EdoTempiaIstitutoTumori MiLab.Cittadini SaluteOsp San Carlo MiUniversità Padova
AO della CaritàFond PoliclinicoAsl 3 LiguriaCEAOVeronaNagaAO 4 CosenzaUniversità PadovaF. Pofferi oncologia
(*) questa colonna riporta la media di valutazione della conoscenza dei temi oggetto del percorso formativo espressa da ogni partecipante al momento della presentazione della scheda di iscrizione; (**) La quarta edizionechiamata "L'Accademia del cittadimo" si è svolta in collaborazione con il Centro gestione rischio clinico e sicurezza dei pazienti ed il Settore equità e accesso della Direzione Generale Diritto alla Salute della RegioneToscana

lizzata per ogni partecipante.Inoltre sono previste schede di valutazione ano-nima da compilare alla fine di ogni singola lezio-ne/gruppo di lavoro e di ogni modulo. Queste
schede di valutazione sono mutuate da quelle uti-lizzate nei corsi di formazione Ecm. I risultati del-la valutazione sono resi pubblici e oggetto di dis-cussione tra promotori e partecipanti.Alla fine
Fare empowerment con le associazioni di cittadini e pazienti: l’esperienza di Partecipasalute
127
IQU
AD
ERN
IDI
Caratteristiche dei partecipantiArea geografica M/F Età media,min max Scolarità Conoscenza*media,minmaxNord 17Centro 4Sud 3
Nord 25Centro 4Sud 3
Nord 17Centro 3Sud 8
Nord 3Centro 25Sud 3
7/17
6/26
7/21
8/23
4728-60
4426-80
4627-59
5230-72
Dipl.media 1Dipl. superiore 12Laurea 11
Dipl.media 1Dipl. superiore 14Laurea 17
Dipl.media 1Dipl. superiore 9Laurea 19
Dipl.media 2Dipl. superiore 16Laurea 12(1 dato missing)
41-8
51-8
62-9
41-8

del percorso è prevista anche una ulteriore valu-tazione che riguarda sia gli aspetti di contenutosia quelli logistici e mira a raccogliere commen-ti e suggerimenti dei partecipanti.Per permettere un’ampia partecipazione delle as-sociazioni, il percorso di formazione è totalmen-te gratuito.Ai partecipanti viene fornito mate-riale tra cui slides, articoli di riferimento e la dis-pensa pubblicata da PartecipaSalute; inoltre, perfacilitare la diffusione delle informazioni, tutto ilmateriale didattico è scaricabile dal sito del pro-getto. Ogni partecipante, salvo diversa disponibi-lità da parte dell’associazione stessa, riceve un con-tributo per il viaggio, il pagamento delle notti inalbergo e dei pranzi di lavoro.Ad ogni relatoreviene offerto un gettone di presenza, oltre alla co-pertura delle spese di viaggio.
Il programma e la scheda di iscrizione vengonopubblicati sui siti dei promotori e un invito adhoc è spedito via mail ad un ampio indirizzariodi associazioni e persone interessate. Poiché i po-sti disponibili sono una trentina, vengono appli-cati dal Comitato promotore i seguenti criteri diselezione: geografico (per avere più regioni o pro-vince rappresentate), tipologia dell’associazione(malattia specifica verso generalista), livello di co-noscenza delle tematiche (privilegiando i candi-dati “meno esperti”) e disponibilità a seguire tut-ti i moduli previsti.
RISULTATINelle tabelle 1, 2 e 3 sono riportati i risultati deiprimi 4 percorsi di formazione.In particolare la tabella 1 presenta le caratteristi-
IL SISTEMA SANITARIO E L’EMPOWERMENT
128
IQU
AD
ERN
IDI
TABELLA 2 - Valutazione prima/dopo dei moduli del percorso di formazione di Partecipasalute
Prima/dopo di aver partecipato a questo modulo, quale era il suo livello di conoscenza su...?
Argomento Prima (*) Media (min-max) Dopo (*) Media (min-max)L'alfabeto della ricerca clinica - causa di malattia
2005-2006 3,88 (1-8) 6,35 (3-9)2008 4,94 (1-7) 7,00 (4-9)
2009-2010 3,53 (1-7) 6,00 (1-8)L'alfabeto della ricerca clinica - valutazione efficacia
2005-2006 3,88 (1-6) 6,58 (2-8)2008 4,76 (1-7) 6,82 (3-8)
2009-2010 4,06 (1-8) 7,00 (4-8)Incertezze in medicina
2005-2006 3,73 (2-8) 6,20 (5-10)2008 6,44 (4-8) 8,44 (7-10)
2009-2010 4,56 (2-7) 7,61 (6-9)Conflitti di interesse
2005-2006 5,13 (2-8) 8,13 (7-10)2008 5,88 (2-8) 8,56 (7-10)
2009-2010 4,89 (2-7) 7,78 (7-9)Comitati Etici
2005-2006 4,42 (1-8) 7,57 (4-10)2008 4,73 (1-7) 7,07 (4-8)
(**) 2009-2010Strategie dell'informazione sulla salute
2005-2006 5,37 (6-8) 8,00 (6-10)2008 6,20 (2-8) 7,73 (4-10)
2009-2010 5,31 (2-9) 7,25 (4-8)Credibilità e ruolo associazioni
2005-2006 6,06 (3-9) 7,86 (6-9)2008 4,94 (1-8) 7,63 (5-9)
2009-2010 6,12 (3-9) 7,94 (4-10)
La valutazione per l'anno 2007 non è disponibile(*) la scala di valutazione è un analogo lineare da 1 (nessuno) a 10 (ottimo)(**) In questa edizione l'argomento è stato trattato con una lezione e non con un intero modulo

che dei partecipanti: come si può vedere sono rap-presentate sia associazioni di pazienti che gene-raliste, sono maggiormente rappresentati parte-cipanti residenti nel nord Italia, l’età media è tra44 e 49 anni e c’è sempre una maggioranza dipartecipazione femminile.Nella tabella 2 sono riassunti i risultati delle sche-de di autovalutazione prima-dopo sul livello diconoscenza dell’argomento trattato nei singolimoduli. Come si vede, per i partecipanti si regi-stra sempre un miglioramento. Questo dato èconfermato dai partecipanti stessi che dichiara-no di aver appreso una serie di informazioni chenon facevano parte del bagaglio delle loro co-noscenze.Infine, in tabella 3 sono riportati i dati relativi alquestionario di valutazione prima-dopo sugli ar-gomenti oggetto del percorso formativo. Comesi vede il numero delle risposte corrette aumen-ta tra la prima e la seconda somministrazione chevede passare un arco di tempo tra 4 e 6 mesi, du-rata del percorso formativo.
NOTE DI DISCUSSIONE E PROSPETTIVEFUTUREIl percorso di formazione di PartecipaSalute hamesso in luce la fattibilità di questo genere di ini-ziative con rappresentanti di associazioni; come sivede in tabella 1 ci sono sempre più iscritti cheammessi e molti dei partecipanti chiedono di po-ter continuare il percorso di formazione o parte-cipando ad altre edizioni o creando occasioni diapprofondimento. Dal commento di un parteci-
pante: “…c’è sempre da imparare, la formazione con-tinua dovrebbe essere uno stile di vita, da ogni nuovogradino di conoscenza acquisito si dovrebbe ripartire perraggiungerne un altro…”.La scelta di coinvolgere e mettere fianco a fiancoassociazioni di patologie diverse e di cittadini ri-sponde all’obiettivo di fare rete tra realtà diversefacendole confrontare su tematiche di interessecomune per l’associazionismo organizzato. Nel-lo spirito dei promotori la prospettiva è che ognisingola associazione si faccia volano all’internodella propria area specifica di competenza di quan-to appreso durante il percorso.Dal commento diun partecipante:“… valore aggiunto del corso Parte-cipaSalute: aver conosciuto una rete associativa di pa-zienti e cittadini molto ricca, variegata, vivace, che nonimmaginavo!..”.In occasione della quarta edizione del percorso siè realizzata una fattiva collaborazione con la Re-gioneToscana che si è unita ai promotori del per-corso focalizzando alcuni moduli sul tema del ri-schio clinico e finanziando in parte il percorso diformazione. La collaborazione con le istituzioniè fondamentale per la ricaduta in progetti o atti-vità specifiche in ambito sanitario locale.Dal com-mento di un partecipante:“… a parte le leggi chehanno riconosciuto il ruolo sociale del volontariato, è im-portante che questo sia sempre più competente e formatoper essere più incisivo. E che le Istituzioni,Aziende,Fondazioni, portino avanti un processo di partnershipdi azioni e progetti con iVolontari…”I promotori riconoscono alcuni limiti che posso-no essere da stimolo per la messa a punto dei pro-
Fare empowerment con le associazioni di cittadini e pazienti: l’esperienza di Partecipasalute
129
IQU
AD
ERN
IDI
TABELLA 3 - Questionario di valutazione prima/dopo
Prima DopoNumero risposte esatte sul totale delle risposte fornite Numero risposte esatte sul totale delle risposte fornite
2007 (23 rispondenti) 167/299 (56%) 206/299 (69%)2008 (18 rispondenti) 165/234 (70%) 194/234 (83%)2009-2010 (25 rispondenti) 173/325 (53%) 215/325 (66%)
Le seguenti 13 domande, poste ai partecipanti all'inizio e alla fine del percorso formativo, sono derivate da esperienze di letteratura (Kruse et al. Controlled Clinical Trials 2000;21:223–240) e sono state preliminarmente discusse durante il primo percorso di formazione. D1: in generale, perchè vengono condotti gli studi clinici? D2: perchè viene condotto unostudio clinico controllato? D3: i partecipanti ad uno studio clinico vengono arruolati…D4: Cosa è uno studio clinico randomizzato? D5: perchè viene effettuata la randomizzazione in unostudio clinico? D6: quali requisiti devono essere soddisfatti per legge prima che uno studio clinico possa essere condotto? D7: cos'è il placebo in uno studio clinico su un farmaco? D8:quando è usato il placebo? D9: quali richieste devono soddisfare i pazienti per partecipare a uno studio clinico? D10: quali sono i requisiti per ritirarsi da uno studio? D11: quali sono leconseguenze per chi non vuole partecipare a uno studio? D12: che compito hanno i comitati etici rispetto agli studi clinici? D13: cosa si intende per consenso informato?

grammi delle future edizioni.Tra questi la diffi-coltà di calibrare il tempo dedicato ai diversi mo-menti formativi e di discussione nonché la sceltadegli argomenti che in alcune relazioni si sono so-vrapposti. Dal commento di un partecipante:“…pensare se possibile a più lavori di gruppo con più tem-po a disposizione: sono stati i momenti più importantiall’interno del percorso; usare meno slide; gli interlocu-tori dovrebbero fare uno sforzo ulteriore di costruzionedella lezione proposta per dare spazio e tempo ad undibattito collettivo fra tutti i discenti, anche magari a dis-capito di una conoscenza scientifica approfondita…”.Il Comitato promotore sta al momento discu-tendo la quinta edizione del percorso e modalitàparallele di formazione.Tra queste, l’ipotesi dicreare le condizioni per svolgere un’attività for-mativa a distanza tramite web,modalità che per-metterebbe principalmente di allargare il nume-
ro di partecipanti, ma anche di aumentare la fat-tibilità di partecipazione al percorso e ridurne icosti (ogni modulo ha un costo approssimativo di15.000 euro).Questo tipo di percorsi di empowerment sonouna premessa fondamentale per avere significati-va voce in capitolo nelle scelte in sanità. Nelleprospettive future di PartecipaSalute è in discus-sione un esperimento di democrazia deliberativanel quale coinvolgere “cittadini competenti” chedeliberino efficacemente, in nome della colletti-vità, su un argomento di sanità attuale di ampiaricaduta sociale.
RINGRAZIAMENTISi ringrazia la signora Gianna Costa per aver co-ordinato tutte le edizioni del percorso di forma-zione di PartecipaSalute.
IL SISTEMA SANITARIO E L’EMPOWERMENT
130
IQU
AD
ERN
IDI
BIBLIOGRAFIA• Mosconi P, Colombo C, Satolli R, Liberati A., PartecipaSalu-te, an Italian project to involve lay people, patients’ associa-tions and scientific-medical representatives on the health de-bate, in Health Expect 2007, 10:194-204.
• Il coinvolgimento dei cittadini nelle scelte in Sanità,http://www.snlg-iss.it/lgn_coinvolgimento_cittadini
• Nilsen ES, Myrhaug HT, Johansen M, Oliver S, Oxman AD,Methods of consumer involvement in developing healthcarepolicy and research, clinical practice guidelines and patient in-formation material, in Cochrane Database of Systematic Re-views 2006, Issue 3. Art. No.: CD004563. DOI:10.1002/14651858.CD004563.pub2.

131
iQua
dern
idiL’
Audit civico, inteso come “analisi cri-tica e sistematica dell’azione delle azien-de sanitarie promossa dalle organizza-zioni di cittadini” è nato nel 2000, nel
quadro di una partnership tra Cittadinanzattiva1
e AstraZeneca, per dare una risposta a tre ordinidi problemi sperimentati, spesso con durezza, at-traverso l’esperienza delTribunale per i diritti delmalato. Si voleva: a) dare una forma concreta al-la “centralità del punto di vista del cittadino” datutti invocata ma, di fatto, poco praticata; b) ren-dere più trasparente e verificabile l’azione delleaziende sanitarie, superando l’autoreferenzialitàdei servizi sanitari; c) contenere il rischio di dis-parità nella tutela dei diritti dei cittadini causatodalla federalizzazione del servizio sanitario na-zionale.L’iniziativa ha avuto una diffusione ampiamentesuperiore alle aspettative. Le prime applicazionisperimentali, realizzate nel 2001 e nel 2002 conla collaborazione di 25 Aziende pilota, sono sta-te finalizzate alla definizione e al collaudo del qua-
dro della metodologia.A partire dal 2003, la pos-sibilità di aderire all’Audit civico è stata estesa al-l’universo delle Aziende sanitarie; al termine del2009 erano stati realizzati 7 cicli applicativi na-zionali e 10 regionali2, con il coinvolgimento di175 realtà3.Nel novembre del 2007, in seguito adun accordo con il Ministero della salute, è statoavviato un programma di diffusione della meto-dologia nel servizio sanitario nazionale, sorrettodal perfezionamento dell’impianto metodologi-co e dalla messa a punto dei necessari supportitecnici e informatici.L’assetto tecnico e organizzativo è stato com-pletato4 ed è stata adeguata anche la struttura ge-nerale dell’Audit civico. È in corso di conclu-sione anche una riflessione più generale sull’as-setto “disciplinare” della valutazione civica e sulcontesto in cui essa si colloca, della quale si an-ticipano, in forma necessariamente schematica,alcuni contenuti utili. Le brevi considerazioni fi-nali riportano ai temi dell’empowerment dei cit-tadini.
L’AUDIT CIVICO
di AlessioTerziPresidente nazionale Cittadinanzattiva
1 Cittadinanzattiva è una organizzazione non governativa fondata nel 1978 con il nome di Movimento federativo democratico che opera nell’ambito della tutela dei diritti deicittadini e della promozione della partecipazione civica. E’ presente su tutto il territorio nazionale con circa 300 sedi. Per la tutela del diritto alla salute ha fondato, nel 1980, ilTribunale per i diritti del malato. Nel 2001, ha istituito il network Active citizenship (ACN) con l’adesione di 70 organizzazioni civiche di 30 paesi membri o candidati dell’U-nione europea. ACN nel 2002 ha elaborato la Carta europea dei diritti del malato, provvedendo negli anni successivi al regolare monitoraggio della sua applicazione in 15paesi membri dell’Unione europea.
2 Il primo partner è stata l’Assr dell’Emilia-Romagna, nel 2004, ad essa hanno fatto seguito, dal 2005 al 2009, l’Assessorato alla trasparenza e alla cittadinanza attiva e l’Ares dellaRegione Puglia, gli Assessorato alla salute della Regione Lazio,della regione Umbria e della Provincia autonoma di Trento, le Agenzie sanitarie regionali dell’Abruzzo, del FriuliVenezia Giulia e del Piemonte.
3 Nel numero sono comprese aziende precedentemente indipendenti e poi accorpate per effetto dei piani regionali di riassetto, numerose aziende hanno partecipato a più diun ciclo.
4 Nel sito http://www.cittadinanzattiva.it/progetti-salute/audit-civico.html (ultima visita aprile 2010) sono disponibili alcune informazioni generali, le èquipe locali inoltre possonoaccedere ad un’area riservata che permette lo svolgimento via web di varie operazioni (caricamento dati, validazione dei piani locali, consultazione Faq, dialogo con l’équipecentrale, ecc.). La costruzione del sito è stata coordinata da Michela Liberti e Rosapaola Metastasio con il supporto dei consulenti informatici.

LA STRUTTURA DELL’AUDIT CIVICOL’Audit civico5 è una procedura pubblica, soste-nuta da una metodologia elaborata da Cittadi-nanzattiva, nella quale le funzioni dell’auditor so-no svolte da una équipe mista locale costituita dacittadini volontari e da operatori designati dalladirezione aziendale6. Questa è una caratteristicapeculiare e irrinunciabile che garantisce il carat-tere civico della valutazione e la distingue dallealtre metodologie.Per garantire a tutti i cittadini interessati la possi-bilità di partecipare, la decisione di avviare l’Au-dit civico è accompagnata dall’emissione di unbando pubblico. Le risposte finora ottenute sonostate consistenti7, tant’è che nel corso degli annisi può stimare che almeno 3.000 cittadini abbia-no partecipato ad almeno un ciclo di valutazio-ne. L’équipe locale, così costituita e debitamenteformata con l’assistenza della sede nazionale e del-le sedi regionali, provvede a:� redigere il piano locale di applicazione;� rilevare i dati;� redigere un verbale di valutazione sulla base del-l’analisi dei dati;
�proporre un Piano di eliminazione delle nonconformità rilevate;
�concordare con la direzione aziendale un Piano
di azioni correttive;�comunicare gli esiti alle strutture interessate ealle comunità locali, raccogliendo eventuali os-servazioni.I gruppi locali adottano una struttura di valuta-zione unificata, costruita per dare una rispostaobiettiva a tre domande:1) “Quali sono le azioni promosse dalle aziende sa-nitarie per mettere concretamente i cittadini e le loroesigenze al centro dell’organizzazione dei servizi sa-nitari?”
2)”Quale priorità assumono nell’azione delle azien-de sanitarie alcune politiche di particolare rilievo sa-nitario e sociale, come il risk management, il painmanagement e il sostegno ai malati cronici?”
3)“La partecipazione dei cittadini è considerata dalleaziende sanitarie una risorsa essenziale per il mi-glioramento dei servizi sanitari o viene promossa(quando lo è) solo come un adempimento burocrati-co previsto da alcune leggi?” (vedi fig. in basso)
Nelle realtà locali, l’Audit civico può essere l’oc-casione per rispondere anche ad una quarta do-manda - “Quali risposte ha fornito l’azienda sanita-ria ad un problema ritenuto urgente dalla comunità lo-cale?” che, per sua natura, non può essere sup-portata da un approccio unificato.La struttura di valutazione si articola, quindi, in
IL SISTEMA SANITARIO E L’EMPOWERMENT
132
IQU
AD
ERN
IDI
5 Per una descrizione puntuale degli aspetti metodologici e degli esiti, cfr. Lamanna A.,Terzi A.- La valutazione civica della qualità e della sicurezza nelle strutture sanitarie: i pro-grammi “Audit civico e Ospedale sicuro – in Banchieri G. (a cura di) – Confronti: pratiche di benchmark nella sanità pubblica italiana – Italpromo , Roma 2005 e Lamanna A.,Terzi A.- “Audit civico il punto di vista del cittadino – in Bocci F., Miozzo A. (acura di) – La Balanced scored orientata dalla mission - Il Sole 24 ore, Milano 2006
6 Nella maggior parte dei casi l’intervento della componente aziendale è affidato all’Urp, è frequente anche la presenza degli uffici qualità e di esponenti della direzione sanitaria.7 Nelle ultime applicazioni regionali si sono registrate 430 adesioni in Piemonte, oltre 200 in Lazio e in Abruzzo, circa 60 in Umbria e circa 40 in Friuli Venezia Giulia.8 La versione qui descritta è stata aggiornata nel 2008 sulla base dell’esperienza maturata nei cicli precedenti da Alessandro Lamanna, con la collaborazione di Michela Liberti eRosapaola Metastasio e il contributo di un gruppo tecnico costituito da Andrea Gardini, Gabriele Calizzani,AnnaVittori, Sara Baruzzo, Rosanna Cerri, Carolina Devardo eGiorgio Simon. La nuova articolazione è stata validata da un Comitato paritetico con Giovanni Nicoletti e Alessandro Ghirardini in rappresentanza del Ministero della salute ela consulenza di Piera Poletti.
La struttura di valutazione dell’audit civico8
3 COMPONENTI NAZIONALI + 1 COMPONENTE LOCALEA SCELTA(orientamento ai cittadini; impegno dell’azienda a promuovere politiche di rilievo sociale e sanitario; coinvolgimento
delle organizzazioni civiche; capacità di risposta dell’azienda a un problema urgente per la comunità)
12 FATTORI DIVALUTAZIONE
380 INDICATORI[livello aziendale, assistenza ospedaliera, cure primarie (distretto-poliambulatorio-CSM/Sert)]

tre componenti (una per domanda) omogenee alivello nazionale:1. l’orientamento ai cittadini, cioè l’attenzio-ne dimostrata dall’azienda per ambiti spessoproblematici per gli utenti dei servizi sanitari;
2. l’impegno dell’azienda nel promuoverealcune “politiche” di particolare rilievo so-ciale e sanitario;
3. il coinvolgimento delle organizzazioni ci-viche nelle politiche aziendali.
Questa omogeneità permette la comparazione frale diverse realtà. Infatti il benchmarking è unaparte fondamentale della struttura dell’Au-dit civico perché da una parte completa l’infor-mazione messa a disposizione delle équipe loca-li, dall’altra favorisce la disseminazione di “buo-ne pratiche” e permette di condurre analisidi sistema (punti di forza e di debolezza, livellogenerale di attuazione degli standard, individua-zione di aree critiche) che assumono un par-ticolare valore nei cicli applicativi naziona-li e regionali.Le componenti sono articolate in “fattori di va-lutazione” definiti (in piena conformità con ilDPCM del 19/5/95 sulla Carta dei servizi sani-tari) come gli aspetti che caratterizzano il rap-porto dei cittadini con i servizi9, secondo lo sche-ma seguente:Orientamento al cittadino:1. accesso alle prestazioni sanitarie;2. tutela dei diritti e miglioramento della qualità;3. personalizzazione delle cure, privacy e assistenzaai degenti;
4. informazione e comunicazione;5. comfort.
Impegno dell’azienda nel promuovere al-cune “politiche” di particolare rilievo so-ciale e sanitario:6. sicurezza dei pazienti;7. sicurezza delle strutture e degli impianti;
8.malattie croniche e oncologia;9. gestione del dolore;10.prevenzione.
Coinvolgimento delle organizzazioni civi-che nelle politiche aziendali11.attuazione e funzionamento degli istituti dipartecipazione degli utenti;
12.altre forme di partecipazione e interlocuzio-ne cittadini/azienda sanitaria.
Ogni fattore di valutazione, quindi, è collegato aun “grappolo” di indicatori – raccolti in una“matrice per la valutazione civica nei ser-vizi sanitari” – che rilevano fenomeni elemen-tari significativi del modo di essere o di funzio-nare della realtà esaminata e della sua corrispon-denza a norme, regole di buone prassi e ovvia-mente alla tutela dei diritti dei cittadini.La struttura di valutazione dell’Audit civico sicompleta con la definizione dei livelli di appli-cazione, vale a dire gli ambiti del Servizio sani-tario nei quali è effettuata la rilevazione. I livelliprevisti e applicati sono tre:�L1 l’ambito aziendale (l’azienda sanitaria nel suocomplesso);
�L2 l’ambito dell’assistenza ospedaliera;�L3 l’ambito delle cure primarie che com-prende:-L3a l’assistenza sanitaria di base (distretti, me-dicina di famiglia, cure domiciliari),-L3b l’assistenza specialistica territoriale (po-liambulatori),-L3c l’assistenza specialistica territoriale e se-miresidenziale (CSM/Ser.T.).
Le tabelle 1, 2 e 3 illustrano il quadro sinteticodella struttura dell’Audit civico.
L’audit civico
133
IQU
AD
ERN
IDI
9 Ministero della sanità, Come definire e utilizzare gli standard di qualità, in Quaderni della Carta dei servizi pubblici sanitari, 1996

Per la raccolta dei dati sono utilizzate: 5 tipolo-gie di questionari rivolti ai responsabili dellestrutture coinvolte nell’Audit civico e 6 griglieper l’osservazione diretta delle strutture sanitarieda parte degli auditors (cittadini e operatori sa-nitari).Gli indicatori conteggiati nelle tabelle sono tut-ti associati ad uno standard riconosciuto10 ed èquindi possibile calcolare, con semplici accorgi-menti, in ogni livello e per ogni fattore un Indi-ce di adeguatezza degli standard (IAS). Lostudio degli IAS, che è la base del processo loca-le di valutazione ed emissione dei giudizi, sostie-
ne anche il benchmarking e l’analisi di sistema.L’Audit civico, comunque, rileva e prende in con-siderazione anche indicatori non provvisti di stan-dard ma utili al fine della formulazione dei giu-dizi.
LAVALUTAZIONE CIVICACOME DISCIPLINAL’Audit civico si iscrive in un processo di svilup-po della valutazione civica animato dalla cittadi-nanza attiva di dimensioni internazionali11 facil-mente riconoscibile anche in Italia12 che però nonè ancora stato oggetto di uno studio sistematico.
IL SISTEMA SANITARIO E L’EMPOWERMENT
134
IQU
AD
ERN
IDI
TABELLA 1 - Articolazione in fattori e indicatori della componente “Orientamento ai cittadini”
Fattori L1 L2 L3a L3b L3c1.1 -Accesso alle prestazioni sanitarie 5 10 14 6 101.2 -Tutela dei diritti e miglioramento della qualità 8 6 5 5 61.3 - Personalizzazione delle cure, rispetto della privacy,assistenza ai degenti = 38 2 6 81.4 - Informazione e comunicazione = 27 18 9 91.5 - Comfort = 36 9 9 9
(+18 (+ 8 (+ 8 (+ 8eventi particolari) eventi particolari) eventi particolari) eventi particolari)
TABELLA 3 - Articolazione in fattori e indicatori “Coinvolgimento delle organizzazioni civiche nelle politiche aziendali”
Fattori L1 L2 L3a L3b L3c3.11 -Attuazione e funzionamento degli istitutidi partecipazione degli utenti 9 = = = =3.12 -Altre forme di partecipazione dei cittadinie interlocuzione cittadini/azienda 8 = = = =
TABELLA 2 - Articolazione in fattori e indicatori “Impegno dell’azienda nel promuovere alcune politichedi particolare rilievo sociale e sanitario”
Fattori L1 L2 L3a L3b L3c2.6 - Sicurezza dei pazienti 6 24 = = =2.7 - Sicurezza delle strutture e degli impianti 4 7 3 3 32.8 - Malattie croniche e oncologia 12 = = = =2.9 - Gestione del dolore 13 8 = = =2.10 - Prevenzione 18 2 3 2 1
(+8 (+ 4 (+ 4 (+ 4eventi particolari) eventi particolari) eventi particolari) eventi particolari)
10 Le fonti utilizzate per il riconoscimento degli standard sono state le raccomandazioni delle istituzioni internazionali, le indicazioni normative nazionali e regionali, le Carte deiservizi, la Carte dei diritti del malato e le raccomandazioni delle società scientifiche.
11 Una ricerca su Internet ha portato ad identificare numerosi casi di valutazione civica applicata ad un’ampia serie di componenti della vita pubblica (dalla sicurezza urbana aiprogetti di sviluppo fino al comportamento dei rappresentanti eletti) con particolare intensità in Messico, Colombia, Stati Uniti, Canada,Australia e Italia, negli altri paesi euro-pei la frequenza è decisamente più ridotta.
12 Basta pensare, per esempio, alle ricerche, anche teoriche, che hanno accompagnato lo sviluppo di associazioni come Legambiente,Auser e Movi o di una organizzazione comela Caritas che è anche luogo di impegno civico.

Utilizzando i dati dell’esperienza di Cittadinan-zattiva si possono riconoscere tre tappe13. La pri-ma (anni ’80) è improntata alla ricerca di formedi tutela dei diritti adeguate ad un contesto ca-ratterizzato da grandi emergenze naturali (comeil terremoto dell’Irpinia, l’alluvione dellaValtelli-na), istituzionali (come la costruzione del servi-zio sanitario) ed organizzative (come l’emergen-za estate). I cittadini si propongono come soggettiattivi della vita pubblica esercitando direttamen-te azioni di tutela dei diritti e di beni comuni edi informazione civica. Una manifestazione em-blematica di questo approccio è la proclamazio-ne di 70 Carte dei diritti del malato. Gruppi or-ganizzati entrano negli ospedali, osservano le strut-ture e raccolgono migliaia di segnalazioni che per-mettono di identificare le “sofferenze inutili” (nondovute alla malattia, ma a pregiudizi, disfunzioniorganizzative e comportamenti professionali) e didare ai diritti formulazioni concrete e compren-sibili14.La seconda tappa (anni ‘90) è caratterizzata dal-l’emergere di un approccio più consapevole e si-stematico. Le attività tipiche dell’azione civica, inparticolare il monitoraggio e la raccolta delle se-gnalazioni nei centri di ascolto e di tutela, ven-gono progressivamente strutturate fino ad acqui-sire una veste, per così dire, “disciplinare”. Perquanto riguarda la valutazione dei servizi sanita-ri le occasioni più significative sono:� Il rapporto sullo stato dei diritti dei cittadini nelservizio sanitario nazionale (’90-’92), in colla-borazione con il Ministero della sanità, che mo-bilita migliaia di cittadini nel primo tentativo di
dare una forma “scientifica” al loro punto di vi-sta con l’osservazione diretta di oltre 1000 strut-ture e la realizzazione di 16.000 questionari15;
�Le carte dei servizi (’94 - ’98) che tentano diimporre agli enti erogatori di dichiarare gli stan-dard di servizio garantiti in forme verificabili edesigibili da parte degli utenti16.La scuola pilota (’97) di cittadinanza attiva è l’oc-casione per un importante confronto con la let-teratura internazionale ed in particolare con glistudi di Rubin17,Wildavsky18 e Dobson19, che con-fermano l’esistenza di una dimensione discipli-nare dell’attivismo civico. I contenuti elaboratiper la scuola sono la base del “Manuale di Citta-dinanza attiva” pubblicato nel ‘9820. Nello stessoanno si avvia la campagna “Ospedale sicuro” cheè il primo esempio di valutazione civica consa-pevolmente progettata, strutturata e finalizzata chepermette ai cittadini di valutare il livello della si-curezza strutturale del proprio ospedale con la ri-levazione di circa 160 indicatori e il calcolo di 22indici di adeguatezza21.Nella terza tappa (dal 2000 ad oggi) la valutazio-ne civica assume una rilevanza molto superiorealle aspettative, con la diffusione già ricordata del-l’Audit civico, il trasferimento della metodologiaalle scuole con la campagna “Imparare sicuri”22,il monitoraggio della Carta europea dei diritti delmalato23, la realizzazione di due Corsi per esper-ti di analisi e valutazione civica. La necessità, giàricordata, di procedere ad un adeguamento con-cettuale e teorico diviene imprescindibile e im-pone un ampio confronto con la letteratura. Frai contributi acquisiti si ricordano il confronto con
L’audit civico
135
IQU
AD
ERN
IDI
13 Cfr. il “Curriculum vitae” di Cittadinanzattiva http://www.cittadinanzattiva.it/documenti-generale/cat_view/155-documenti-di-identita.html (ultima visita aprile 2010) e A.Terzi“La partecipazione dei cittadini è un lusso del quale è bene non privarsi” in Janus n.31/2008.
14 Moro G., Petrangolini T., Il governo scalzo della salute, in Democrazia diretta n. 4-5, 1987.15 Movimento federativo democratico, Rapporto sullo stato dei diritti dei cittadini nel Servizio Sanitario nazionale, Il Pensiero Scientifico Editore, Roma, 1992.16 Un esempio, fra tanti altri, è descritto in Galizio M.,Terzi A., L'azienda ospedaliera San Giovanni Battista di Torino e gli operatori civici della qualità, in Fondazione Smith Klein, Ten-denze nuove n.2/1999.
17 Rubin H., Rubin I., Community Organizing and Development, Mac Millan Publishing Company, NewYork, 1992.18 Wildavskiy A., Speaking Truth to Power.The Art and Craft of Policy Analysis,Transaction Publisher, New Brunswick, 1993.19 Dobson C., The citizen’s Handbook.A Guide to Building Community in Vancouver,Vancouver Citizen’s Committee,Vancouver 1995.20 Moro G.,Manuale di cittadinanza attiva, Carocci editore, Roma, 1998, il cap. 4 è integralmente dedicato ad una prima sistematizzazione dell’analisi civica.21 http://www.cittadinanzattiva.it/progetti-salute/ospedale-sicuro.html (ultima visita aprile 2010). Cfr. anche Lamanna A.Terzi A., La valutazione civica, cit.,Terzi A., La partecipazionedei cittadini al regime di governo dei rischi, in Snop rivista n. 50, luglio 1999 e Ferla V. (a cura di), L’Italia dei diritti (edizioni 2001 e 2002), Edizioni cultura della pace, Calenzano,2001 e 2002.
22 http://www.cittadinanzattiva.it/imparare-sicuri/archivio.html (ultima visita aprile 2010).23 http://www.cittadinanzattiva.it/diritti-del-malato-acn.html (ultima visita aprile 2010) cfr. anche Petrangolini T., Salute e diritti dei cittadini, Baldini Castoldi e Dalai, Roma, 2007.

l’Associazione italiana di valutazione24, le elabo-razioni del Laboratorio MeS della Scuola Supe-riore Sant’Anna di Pisa25 e il quaderno mono-grafico diMonitor26. Sono state individuate corre-zioni e linee di approfondimento, per esempio inordine alla possibilità di integrare meglio le valu-tazioni locali nei processi aziendali di program-mazione o alla definizione di accorgimenti utiliper migliorare la rappresentatività dei benchmar-king regionali. Si è avuta anche la conferma delfatto che l’Audit civico possiede tutti i re-quisiti di una procedura di valutazione. Sipuò constatare per esempio, che la struttura de-scritta nel paragrafo precedente corrisponde alprocesso descritto da Cislaghi e Braga27.La definizione delle componenti infatti corri-sponde alla nomenclatura, la costruzione dellastruttura di valutazione alla descrizione, la raccoltadei dati al monitoraggio, il calcolo degli IAS allavalorizzazione e i documenti conclusivi prodot-ti preparano una possibile decisione.Il confronto con la letteratura e l’avvio di un pro-gramma sperimentale di valutazione civica dellaqualità urbana in collaborazione con il Diparti-mento della Funzione pubblica, con il Formez econ Fondaca, ha permesso di definire alcuni im-portanti concetti28.
La valutazione civica è stata definita come una ri-cerca-azione di carattere comparativo, sostenuta dametodologie dichiarate e controllabili, realizzata daicittadini per fare valere il proprio punto di vista me-diante l’emissione di giudizi motivati sulle realtà ri-levanti per la tutela dei diritti e per la qualità dellavita.Il ciclo essenziale della valutazione civica com-prende:�una raccolta di dati che possono essere prodot-ti dall’intervento diretto dei cittadini o dalla con-sultazione di altre fonti;
� l’elaborazione di informazioni attraverso il trat-tamento dei dati stessi;
� l’emissione di giudizi fondati sulle informazio-ni e rappresentative del punto di vista dei citta-dini.La valutazione civica assume forme diverse se-condo le situazioni.Dal punto di vista della tipo-logia si può distinguere fra:�evaluation: quando si pone in essere un pro-cesso strutturato mirato a verificare il livello dicorrispondenza della realtà a un insieme di cri-teri predefiniti (è il caso dell’Audit civico);
�assessment: quando l’analisi non è compiuta-mente strutturata, condotta senza criteri prede-finiti, orientata a valutare, per esempio, l’effica-
IL SISTEMA SANITARIO E L’EMPOWERMENT
136
IQU
AD
ERN
IDI
24 In particolare con la partecipazione, nel 2007, al X Congresso dell’Associazione e la presentazione del paper “I cittadini come attori della valutazione dei servizi sanitari” diLamanna A., Liberti M.,Terzi A: e la successiva discussione.
25 Cfr, in particolare Nuti S. – Vainieri M. – Fiducia dei cittadini e valutazione della performance nella sanità italiana – ETS – Pisa 2009.26 I sistemi di valutazione dei servizi sanitari” , supplemento al Quaderno 20/2008 di Monitor – Agenas27 Cislaghi C. – Braga M. – “Criticità metodologiche nei processi di valutazione” – in Monitor, cit. pp. 147-15728 Il contenuto della parte finale di questo paragrafo è ricavato dal paper “Contributo di Cittadinanzatiiva e Fondaca” al Gruppo di lavoro che coordina il progetto.
FIGURA 1 - Come nasce la valutazione

cia e la coerenza degli interventi o la corri-spondenza con la mission, come è avvenuto conle Carte dei diritti del malato.Anche le modalità di conduzione possono esse-re due:�per iniziativa autonoma: quando la valuta-zione viene condotta in tutte le fasi solo dallacittadinanza attiva, come avveniva nel caso diOspedale sicuro;
�partnership: quando il ciclo della valutazioneviene condotto, in tutto o in parte, con formepreventivamente condivise con un interlocuto-re istituzionale, come avviene nell’Audit civicoe nel programma sperimentale di valutazione ci-vica della qualità urbana.In termini operativi il processo di valutazionecivica:�deve essere condotto da una espressione dellacittadinanza attiva:
�dovrebbe essere aperto a tutti i cittadini interes-sati, con forme che possono variare in funzio-ne della realtà coinvolta e dell’oggetto della va-lutazione;
�deve coinvolgere un numero significativo (in re-lazione alle dimensioni o alla natura della que-stione oggetto della valutazione) di cittadini nel-le diverse fasi (definizione dell’oggetto della va-lutazione, possibilità di comunicare dati e in-formazioni, presentazione e discussione degliesiti, ecc.).Il tratto caratterizzante della valutazione civica èla sua capacità di rappresentare il punto di vi-sta del cittadino nella sua complessa articola-zione. Il punto di vista del cittadino infatti è, inprimo luogo, uno standpoint, vale a dire uno spe-cifico punto di osservazione – non un’opinionesoggettiva – che mette in luce aspetti della realtàconsiderata generando informazioni diversamen-te inattingibili. Per esempio, nel caso di un siste-ma di trasporti tale punto di vista è in grado diregistrare il comfort, la puntualità, la qualità del-
l’informazione ecc.,mentre quello dei conducentirileva le condizioni di manutenzione dei mezzi,le condizioni del traffico nelle diverse fasce ora-rie ecc., mentre quello della direzione riguardaprevalentemente i fattori economici e organizza-tivi. In secondo luogo, è la capacità di inter-pretare le informazioni e di formulare, sul-la base di esse, giudizi che esprimono quellepreoccupazioni e quelle priorità dei cittadini chepossono essere sovrapposte a leggi e documentidi policy.In questo quadro, la valutazione civica conferisceal “punto di vista dei cittadini” la necessaria di-mensione tecnica e integra i due significati inquanto:� identifica, formalizza e rende misurabili gli aspet-ti caratteristici dell’esperienza del cittadino;
�definisce un insieme coerente di strumenti tec-nici per la raccolta dei dati e per l’elaborazionedelle informazioni;
� identifica i momenti del processo di valutazio-ne e di decisione in cui i rappresentanti dei cit-tadini devono essere presenti per portare e farevalere la propria interpretazione.Se operativamente il “punto di vista” che vieneespresso e utilizzato nel ciclo della valutazionecivica non sempre riguarda la cittadinanza ingenerale e non può rifletterne interamente ladiversità di status e di condizione, tuttavia il fat-to che cittadini singoli od organizzati si attivi-no attorno a un problema da cui sono investitie che si assumano la responsabilità di contri-buire a valutare rientra sotto il principio di “af-fectedness”, riconosciuto istituzionalmente intutto il mondo come base dei processi di con-sultazione29.
ELEMENTI DI CONTESTONon è ancora disponibile un’analisi adeguata de-gli elementi di contesto che hanno accompagna-to lo sviluppo della valutazione civica ma è pos-
L’audit civico
137
IQU
AD
ERN
IDI
29 Hilson C.,“EU Citizenship and the Principle of Affectedness”, in Bellamy R.,Castiglione D., Shaw J. (a cura) “Making European Citizens. CivicInclusion in a Transnational Con-text”, Palgrave Macmillan, London 2006

sibile individuarne due particolarmente signifi-cativi.Il primo è la crescita esponenziale della do-manda di valutazione prodotta dalle trasfor-mazioni intervenute nei sistemi di governance deiservizi per effetto dei processi di liberalizzazione,federalizzazione e aziendalizzazione. Non si dis-pone dello spazio e, soprattutto, della competen-za per trattare una simile questione. È impossibi-le però non riconoscere la rilevanza assunta dafunzioni strettamente connesse con la valutazio-ne come:� l’accreditamento istituzionale;� la valutazione delle direzioni aziendali sulla ba-se della capacità di raggiungere obiettivi che nondovrebbero riguardare soltanto il bilancio maanche la qualità, la sicurezza e appropriatezza;
� la valutazione contrattuale dei dirigenti e dellestrutture.È un sistema che stenta ad andare a regime, an-che perché è ancora aperto il problema crucialedi garantire l’obiettività e l’indipendenza della va-lutazione. La partecipazione diretta dei cittadinipuò essere una risorsa importante a questo pro-posito. L’Audit civico, per esempio, è stato con-siderato documento rilevante ai fini dell’accredi-tamento in varie regioni e per la valutazione deidirettori generali nel Lazio e nel FriuliVeneziaGiulia.Il secondo dato di contesto è legato alla rap-presentazione del punto di vista del citta-dino. La necessità di disporre di una strumen-tazione a tale proposito è ormai condivisa dallamaggior parte degli esperti.Alcuni, come Sabi-na Nuti, assegnano alla valutazione delle per-formance dei servizi sanitari e dell’opinione deicittadini una funzione essenziale per risponde-re alla crisi di fiducia nei confronti dei servizi
sanitari, registrabile in vari Paesi. A tale propo-sito, propongono anche l’adozione di una stra-tegia di comunicazione e diffusione delle infor-mazioni che interagiscono con la scelta delle di-mensioni e degli indicatori30. La critica della cu-stomer satisfaction tradizionale è stata radicaleed ha portato allo sviluppo di programmi inno-vativi, come quello dell’Osservatorio interre-gionale sulla qualità percepita, con ottimi esiti31.Anche l’Agenzia sanitaria del Veneto, in colla-borazione con il Picker Institute, ha prodottouna significativa rilevazione sul territorio regio-nale32, ma questo non è sufficiente per risolvereil problema. Le metodologie utilizzate, infatti,sviluppano l’ascolto dei cittadini ma non li ri-conoscono come soggetti in grado di produrreautonomamente valutazioni strutturate33. La vo-lontà di superare questo limite può essere unadelle motivazioni che hanno facilitato la diffu-sione dell’Audit civico. Infatti non esiste anta-gonismo fra valutazione civica e rilevazione del-la qualità percepita e gli incontri finora avuti so-no stati fecondi.
CONSIDERAZIONI FINALILa diffusione e il successo della valutazione civi-ca della qualità e della sicurezza e dell’Audit ci-vico in particolare smentiscono, si spera definiti-vamente, le visioni riduttive, tuttora esistenti, checonsiderano i cittadini “privi delle ‘competenze’necessarie ad occuparsi della cosa pubblica per-ché questa richiede saperi per essi inattingibili”34.Al contrario lo sviluppo dell’Audit civico deveessere considerato un caso di applicazione del-l’art. 118 u,c, della Costituzione:“Stato, regioni,province, città metropolitane, comuni favorisco-no l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e as-sociati, per lo svolgimento di attività di interesse
IL SISTEMA SANITARIO E L’EMPOWERMENT
138
IQU
AD
ERN
IDI
30 Nuti S. op. cit.31 Cfr. Cinotti R., Cipolla C.– “La qualità condivisa fra servizi sanitari e cittadini.”. – Franco Angeli, Milano 2003-32 https://www.arssveneto.it/html_pages/QualitaPercepita.php?idm=180 (ultima visita aprile 2010)33 Altieri L. (a cura di) – Ascolto e partecipazione di cittadini in sanità.- Franco Angeli, Milano 2002-34 cfr. Moro G.,Azione civica, Carocci, Roma 2005, pag. 37; Id., “Citizens’ Evaluation of Public Participation”, in Caddy J. (ed.), Evaluating Public Participation in Policy Making,OECD, Paris 2005, pp. 109-126

generale, sulla base del principio della sussidiarie-tà” . La valutazione civica in generale e l’espe-rienza dell’Audit in particolare, sono certamenteanche un esempio di empowerment organizzati-vo praticato sistematicamente che consente ai cit-tadini di intervenire in varie fasi del ciclo dellepolitiche pubbliche.Infatti, dando per scontata l’esistenza di criticitàe di problemi da risolvere, si possono constatareeffetti rilevanti dell’Audit civico in cinque ambi-ti diversi:� le azioni di adeguamento agli standard poste inatto, in seguito alla realizzazione di un’applica-zione di Audit civico;
� le azioni correttive e cioè le correzioni di siste-ma realizzate in seguito all’Audit civico;
� l’impatto culturale e cioè la variazione dei mo-delli cognitivi avvenuti nell’ambito delle azien-de e delle organizzazioni civiche in seguito alpercorso comune realizzato nelle équipe localidi valutazione;
� l’inserimento dell’Audit civico e/o dei suoi esi-ti nelle politiche istituzionali;
�gli effetti sulla governance delle aziende.Le azioni di adeguamento e le azioni correttivesono qualitativamente e quantitativamente rile-vanti35, in particolare la Asl di Nuoro ha ottenu-to, per il programma “Involving citizens in mo-nitoring health services”, fondato sull’Audit civi-co, un premio europeo nella 5QC 5th QualityConference for public administration in EU te-nuta a Parigi il 20-22 ottobre 200836.In questa sede sembra opportuno concentrare l’at-tenzione sulle politiche di empowerment che so-no un campo privilegiato di valorizzazione del-l’Audit civico. Nella presentazione pubblica delsettembre 2009 del censimento delle esperienzein atto presso le Regioni e le aziende sanitarie,condotto da Agenas, su 19 pratiche di empower-
ment organizzativo individuate, quattro pratiche(Regione Abruzzo,Regione FriuliVenezia Giu-lia, Asl di Reggio Emilia,Azienda ospedaliera diReggio Emilia) erano applicazioni dell’Audit ci-vico di Cittadinanzattiva, una quinta applicazio-ne (Regione Umbria) è stata presentata, per que-stioni organizzative, nella sessione dell’empower-ment individuale37.Come ha rilevato uno studio dell’Agenzia so-ciale e sanitaria dell’Emilia Romagna, con il la-voro comune all’interno delle équipe “i cittadi-ni hanno imparato a conoscere meglio l’orga-nizzazione sanitaria e gli operatori hanno avu-to un’occasione non conflittuale di confrontocon il punto di vista dei cittadini stessi”38. Lacreazione di un clima favorevole è stata accom-pagnata, da una parte e dall’altra, dalla “scoper-ta delle tecnologie della partecipazione” in quan-to i referenti civici e aziendali hanno imparatoche cosa bisognava concretamente fare perché ilprocesso andasse a buon fine. Nella Asl RME,tali funzioni sono state formalizzate e il docu-mento può essere considerato una vera e pro-pria linea guida a tale proposito39. Si tratta diun’acquisizione tutt’altro che banale in quanto,come dimostrano le rilevazioni dello stesso Au-dit civico, le disposizioni sulla partecipazione deicittadini restano inapplicate per la mancanza delnecessario know how.Nel caso delle applicazioni regionali della Pugliae dell’Abruzzo, la realizzazione dell’Audit civicoha accompagnato esplicitamente due importantipolitiche di adeguamento dell’organizzazione,cioè l’insediamento degli URP nel primo caso edegli Uffici qualità nel secondo.Nell’applicazio-ne regionale tuttora in corso in Umbria, i datidell’Audit civico saranno utilizzati per formaliz-zare uno schema regionale per la redazione del-la terza sezione delle Carte dei servizi.
L’audit civico
139
IQU
AD
ERN
IDI
35 Cfr, la nota sugli esiti dell’Audit civico in http://www.cittadinanzattiva.it/progetti-salute/audit-civico/rapporti-e-documenti-audit-civico.html (ultima visita aprile 2010)36 (http://www.5qualiconference.eu/bp.php?l=2&bp=286&p=18&c=1&t=0&k=)(ultima visita aprile 2010)37 http://www.assr.it/primo_piano/In_corsia_cittadino.pdf (ultima visita aprile 2010)38 Assr Emilia Romagna – Dossier 180- “La sperimentazione dell’audit civico in Emilia-Romagna:riflessioni e prospettive”39 Paper consegnato alla sede nazionale da De Roberto L, (Cittadinanzattiva) e Bazzoni A. (Asl RME)

Il livello tutto sommato soddisfacente di empo-werment organizzativo non trova un riscontroadeguato nelle governance aziendali e regionalie non soltanto per la presenza di un numero (pe-raltro ridotto) di casi di scarso impegno delle di-rezioni aziendali.Anche nei casi migliori, infatti,la valutazione civica stenta a trovare una colloca-
zione stabile: le ricognizioni condotte hanno mes-so in evidenza uno scarso collegamento con glialtri processi di valutazione presenti nelle azien-de e nelle amministrazioni regionali. È una criti-cità di non poco conto che deve essere risolta per-ché limita sensibilmente il pieno sviluppo dellepotenzialità dell’Audit civico.
IL SISTEMA SANITARIO E L’EMPOWERMENT
140
IQU
AD
ERN
IDI