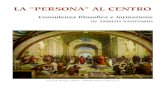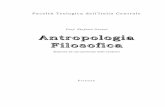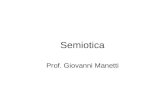Il Problema Di Dio Nella Riflessione Filosofica Contemporanea
-
Upload
mario-di-febo -
Category
Documents
-
view
20 -
download
0
description
Transcript of Il Problema Di Dio Nella Riflessione Filosofica Contemporanea

IL PROBLEMA DI DIO NELLA RIFLESSIONE FILOSOFICA CONTEMPORANEA
Filosofia= pratica linguistico-discorsiva (Socrate, Dialoghi, ecc.) ⇓ Linguaggio: strumento filosofico per eccellenza
CONOSCENZA ⇒ Problema fondamentale della filosofia classicaa) sensibile/direttab) filosofica/indiretta ⇒ soggetto / oggetto
l'oggetto sono i concettimeccanismo= riflessione /allontanamento /riavvicinamentonon nasce come conoscenza diretta
Regimi Totalitari Identificazione del Popolo con il Capo. Adesione irriflessiva.del '900 L'adesione è lecita solo dopo una riflessione (iniziale presa di distanza).
Genesi 1,3 Creazione della distanzaIl serpente induce l'uomo al peccato; per dargli la conoscenza lo induce non alla distanza ma alla contrapposizione con Dio. Ogniqualvolta la distanza/differenza si tramuta in conflitto noi perpetuiamo il peccato. Il diverso come nemico.Il MALE è interpretare la distanza come conflitto.
Gli storici periodizzano e solitamente trascurano i primi 10 anni di ogni secolo; questo non si può fare per il novecento. Storia Concettuale ⇒ eventi vs concettiNel 900 Filosofia e Teologia concordano su come periodizzare le concettualizzazioni:
Inizio: avvio della prima guerra mondiale ] 900 SECOLO BREVEFine: caduta del muro di Berlino ] Eric J. Hobsbawm, storico inglese
Più precisamente, Hobsbawm divide il secolo in fasi distinte:1. Età della catastrofe, dal 1914 al 1945, paragonabile al periodo della guerra dei trent'anni,
caratterizzata dalle due guerre mondiali, dalle crisi che le seguirono, e dal dissolvimento di tutti gli imperi millenari (russo, tedesco, austriaco e ottomano);
2. Età dell'oro, dal 1946 al 1973. Fine del colonialismo, scoperte in campo medico, scientifico e tecnologico, crescita dell'economia basata tanto su un liberismo di stampo occidentale quanto sul sistema economico comunista (boom economico);
3. La Frana, dal 1973 al 1989 (9 novembre caduta del muro) e poi al 1991 (26 dicembre crollo dell'URSS) e la conseguente fine della Guerra Fredda e delle ideologie politiche totalitarie.
L'imponente progresso civile, economico, scientifico che si è avuto nell'800 viene considerato, all'epoca, come un dono/grazia di Dio all'uomo. L'uomo è benedetto, le sue opere sono in continuità con il volere di Dio. Dio è in continuità con la natura umana.
Due correnti teologiche si confrontano:
1. I teologi liberali (Harnack, Troeltsch) asseriscono una continuità tra Dio e l'uomo,
considerando la fede come un elemento dell'interiorità psicologica dell'uomo e la teologia
come l'analisi storico-critica della Scrittura.
2. Karl Barth sviluppa una teologia che riafferma la relazione "dialettica", paradossale,
inconcepibile, di "rottura" tra Dio e il mondo (l'uomo, la cultura, la storia).
Teologia liberale e scuola di Tubinga
Già a partire dal 1800 la teologia classica di derivazione medioevale deve fare i conti con il radicale
mutamento economico e sociale che sta portando l'occidente verso la modernità. Aumento
generale del tenore di vita e atteggiamento scientifico sono eventi così eclatanti che non possono
non produrre strappi anche nel modo di intendere il rapporto con il divino.
Il problema di Dio nella riflessione filosofica contemporanea pag. 1

Il protestantesimo produce la teologia liberale, la quale afferma da un lato il valore supremo della
fede cristiana, dall'altro si fa portatrice dei valori del liberalismo ottocentesco. Secondo questa
corrente teologica, la fede, in quanto sentimento che si pone a fondamento e giunzione tra i diversi
aspetti della cultura occidentale, è garante dei valori di libertà propri del pensiero liberale. La
teologia liberale tenta di far vedere come il cristianesimo non sia contrario alla modernità la quale
nasce addirittura dal suo interno. Le maggiori innovazioni apportate dalla teologia liberale e
affermatesi nel XX secolo sono:
la demitizzazione dei racconti biblici kerigmatici,
l’avvio dell’interpretazione storico-critica delle Scritture. Tale metodo, pur apprezzabile,
applicato sino alle estreme conseguenze portava a negare la storicità dei miracoli dei
Vangeli, che sarebbero stati il frutto dell’ingenua credenza dei primi Cristiani negli eventi
soprannaturali, e a ritenere che i dogmi, non voluti da Gesù, fossero nati per l’influenza della
filosofia ellenistica sul Cristianesimo.
la ricerca del «Gesù storico» oltre quello della fede.
Così facendo si tentava di trovare la continuità e la razionalità del fenomeno religioso, riducendolo
tuttavia da trascendente a immanente. I suoi maggiori esponenti furono A. Ritschl, A. Von Harnack
e E. Troeltsch.
“Quelli di noi che sono dotati di sensibilità più acuta e quindi profetica non
guardano più al regno della pace e dell'amore come ad una sterile utopia”
A. Von Harnack
Ne L’essenza del Cristianesimo (1899-1900) Harnack precisa ulteriormente il concetto, affermando
che il fondamento del Cristianesimo (l’”essenza”, appunto) va individuato nel Discorso della
Montagna, laddove si proclama l’avvento del Regno di Dio e il comandamento dell’amore; tutto il
resto (elaborazioni teologiche e dogmatiche come le istituzioni ecclesiastiche) è qualcosa di
posteriore e non fondamentale. Sotto questo aspetto Harnack si inserisce nella tradizione
protestante, che si opponeva ad “ogni autorità esterna e formale in religione, dunque, contro
l’autorità dei concili, dei preti e di tutta la tradizione della Chiesa. La sola autorità valida è quella
che viene dall’interno e porta libertà, dunque solo il Vangelo”
Un'altra importante corrente teologica ottocentesca è la scuola di Tubinga (Ratzinger e Kung vi
hanno insegnato); essa opera un'analisi dei tratti essenziali della fede al fine di comprendere lo
sviluppo storico-dialettico del messaggio cattolico. Al fondo c'è l'idea di poter condurre l'indagine
sul significato della fede per mezzo dello strumento razionale, soprattutto secondo una logica
dialettica di stampo idealista, in cui si vede la storia del cristianesimo come il frutto di diverse
correnti di pensiero in opposizione tra loro, in senso produttivo. Il cristianesimo si evolve
dinamicamente con l'evolversi dello sviluppo umano, il cristianesimo rappresenta lo spirito stesso
dello sviluppo umano (secondo logiche hegeliane).
La crisi della teologia liberale
Negli anni della prima guerra mondiale comincia a delinearsi un'irresistibile crisi della teologia
liberale. I drammatici eventi bellici e il correlativo crollo di tutto un preciso mondo spirituale
sollecitano anche teologi e uomini di chiesa a prendere coscienza della problematicità di tante
"sicurezze" precedenti: la fede nella ragione, il primato della prospettiva umanistico-storicistica,
Il problema di Dio nella riflessione filosofica contemporanea pag. 2

l'esistenza di valori etici universali e oggettivi.
In ambito religioso, questa fase di profonda crisi induce molti a considerare superficiale e
ottimistica la teologia liberale e a riproporre con nuova drammaticità la limitatezza e la
peccaminosità del mondo terreno, l'irriducibilità della trascendenza all'immanenza, la distanza tra
l'umano il divino. Gli orrori della guerra “mondiale” fanno decadere il concetto che Dio è in
continuità con la natura umana.
Barth: Dio come il “totalmente Altro”
Protagonista della reazione alle idee della Teologia Liberale fu Karl Barth, in particolare nel
Commento alla Lettera ai Romani di San Paolo (1919; II ediz. 1922) che lo qualifica come grande
esponente della cosiddetta Kierkegaard-Renaissance in ambito teologico.
NOTA
La Lettera ai Romani è la più lunga e più densa teologicamente dell’intero epistolario paolino. Venne scritta
a Corinto nel 57-58 e si articola in due parti, una teologica (cap. 1-11) e l’altra pastorale-esortativa (cap.
12-15). L’occasione della Lettera fu il problema dei rapporti tra i cristiani di origine ebraica e quelli
provenienti dal paganesimo; i temi affrontati nella prima parte sono quelli della salvezza offerta agli Ebrei e
ai Pagani, della giustificazione divina come indispensabile condizione della salvezza e in rapporto alla fede,
della funzione della Legge dell’Antico Testamento, del rapporto tra fede ed opere, del Battesimo, della
debolezza morale dell’uomo. Nella seconda parte prevale l’invito alla carità, ad un amore disinteressato
aperto a tutti, compresi i nemici. La Lettera ai Romani, studiata con particolare attenzione sin dai primi
secoli del Cristianesimo, è stata al centro della riflessione degli Evangelici a partire dal XVI secolo: nel
Commento redatto da Lutero nel 1515-16, un classico della teologia protestante, vengono elaborate le idee
fondamentali della salvezza come frutto della giustizia di Dio (intervento gratuito di Dio che rende giusto
l’uomo peccatore) mediante la fede e della svalutazione delle opere.
Il punto di partenza è la “differenza qualitativa infinita” che intercorre tra Dio e l’uomo affermata da
Kierkegaard. In radicale disaccordo con la tendenza della Teologia Liberale a ridurre il Cristianesimo
ad un’espressione dell’intelligenza umana, Barth, recuperando in pieno il concetto di trascendenza,
sostiene che Dio non è riconducibile alla ragione e alle sue elaborazioni: la cultura, la filosofia, la
religione stessa.
Egli è “Totalmente Altro” in quanto disomogerneo rispetto a qualunque realtà umana: “Dio è il Dio
sconosciuto.
La ribellione contro il Dio che è frutto di una religione che, come quella liberale, tramuta Dio in un
idolo [cioè realtà creata dall’uomo, n.d.r.] è perciò legittima.
Essa però non tocca Dio ma soltanto la sua umana caricatura”. La fede dunque non può nascere
dalla ragione, ma dall’irruzione di Dio nella vita dell’uomo, che ad essa aderisce con una scelta che
supera o addirittura contraddice ogni logica umana. Il concetto è quello dell’istante di Kierkegaard,
del passaggio decisivo in cui il singolo improvvisamente incontra Dio che gli si rivela e Lo accoglie,
come fece Abramo di fronte alla sconvolgente manifestazione divina.
Da ciò deriva la denominazione che assume la corrente teologica fondata da Barth. E’ detta
“Dialettica” perchè rileva l’abisso, il “crepaccio di ghiaccio”, la “linea di morte” che separa Dio e
uomo a livello ontologico, ritenendolo assoluto e irriducibile.
Il termine dialettica non va quindi inteso in senso hegeliano di conciliazione di tesi e antitesi in una
sintesi comune, bensì al contrario nel suo originario significato neoplatonico, tipico della teologia
Il problema di Dio nella riflessione filosofica contemporanea pag. 3

negativa, basato sul criterio della polarità e della reciproca opposizione. Barth sottolinea
l'inadeguatezza di tutti i sistemi filosofici immanenti, a partire da Hegel fino alla teologia liberale,
che ritenevano di poter comprendere l'Assoluto all'interno di categorie umane, sulla base di una
presunta accordabilità tra Dio e i nostri schemi mentali.
"Dio è il Dio sconosciuto. Come tale egli dà a tutti la vita, il fiato e ogni cosa. Perciò la
sua potenza non è né una forza naturale né una forza dell'anima, né alcuna delle più
alte o altissime forze che noi conosciamo o che potremmo eventualmente conoscere,
né la suprema di esse, né la loro fonte, ma la crisi di tutte le forze, il totalmente Altro,
commisurate al quale esse sono qualche cosa e nulla, nulla e qualche cosa, il loro
primo motore e la loro ultima quiete, l'origine che tutte le annulla, il fine che tutte le
fonda. L'uomo si trova in questo mondo in prigione. Una riflessione alquanto profonda
non può concedersi nessuna incertezza sulla limitazione delle nostre possibilità che
sono qui e ora a nostra disposizione. Ma noi siamo più lontani da Dio, la nostra
decezione da lui è più grande e le sue conseguenze sono sempre ancora più vaste di
quante ci permettiamo di pensare. L'uomo è signore di se stesso”.
(Epistola ai Romani)
Solo con la completa negazione di tutto ciò che è umano, cioè con l’annullamento di uno dei due
termini dell’antinomia, si apre l’opportunità della salvezza, esclusivamente dovuta all’intervento di
Dio che si accosta all’uomo per offrirgli la Sua grazia. Del pari tra la religione, frutto del tentativo
dell’uomo di avvicinarsi a Dio con le proprie forze e di sottometterLo in qualche modo alle proprie
esigenze, e la rivelazione, dono liberissimo di Dio che vuole salvare l’uomo, esiste una dicotomia
insuperabile. La religione assume così una connotazione negativa, diventa quasi paradossalmente il
frutto del peccato più profondo dell’uomo, quello di volersi costruire una propria divinità, cioè
dell’idolatria. La salvezza è possibile solo con il “salto nell’incerto” della fede, che porta ad aderire
alla rivelazione divina.
La teologia di Barth è definita anche “della Crisi” perché quando l’uomo comprende che tutti i suoi
sforzi di giungere a Dio sono vani, sperimenta una crisi, suscitata da Dio stesso con la Sua grazia,
che lo dispone ad accogliere la salvezza che solo direttamente da Lui può ricevere.
La critica della metafisica classica
Dio non costituisce, come per la metafisica classica, la genesi e il fondamento delle cose.
Il suo essere sta infatti "al di là" di tutte le forze, le origini e i fini. La sua "potenza" è
"autosufficiente, incondizionata e in sé vera": essa è "l'assolutamente nuovo".
Cercare Dio nelle sue creazioni, presumere di salire a lui lungo gli "itinerari" descritti dalla teologia e
dalla morale antica e moderna è pura follia: anche perché "concepire questo mondo nella sua unità
con Dio è colpevole di arroganza religiosa".
La fede come unica salvezza
Dinanzi a questo Dio "totalmente Altro", Barth sostiene che l'uomo non può affidare le sue
possibilità di salvezza né alla conoscenza razionale né al progresso storico, bensì solo alla fede,
sulla quale egli ha scritto alcune delle pagine più intense del Novecento:
"La fede è questo: il rispetto dell'incognito divino, l'amore di Dio nella coscienza della
Il problema di Dio nella riflessione filosofica contemporanea pag. 4

differenza tra Dio e l'Uomo, tra Dio e il mondo, l'affermazione del 'No' divino in
Cristo, il fermarsi, turbati, davanti a Dio. La fede è la conversione, il radicale nuovo
orientamento dell'uomo che sta nudo davanti a Dio, che per acquistare la perla di
gran prezzo è diventato povero e che per amore di Cristo è pronto a perdere la sua
anima. La fede non è mai compiuta, mai data, mai assicurata, è sempre e sempre di
nuovo, dal punto di vista della psicologia, il salto nell'incerto, nell'oscuro, nel vuoto.
Non vi è nessuna presupposizione umana (pedagogica, intellettuale, economica,
psicologica, ecc..) che debba essere adempiuta come preliminare della fede. La fede
è sempre l'inizio, la presupposizione, il fondamento. Si può credere come Galileo e
come Greco, come fanciullo e come vegliardo, come uomo colto o come ignorante,
come uomo semplice e complicato, si può credere nella tempesta e nella bonaccia,
si può credere a tutti i gradini di tutte le immaginabili scale umane. L'energia della
fede interseca trasversalmente tutte le differenze della religione, della morale, della
condotta e dell'esperienza della vita, della penetrazione spirituale e della posizione
sociale. La fede è per tutti altrettanto facile e altrettanto difficile."
Il ruolo della comunità/Chiesa
Negli anni seguenti Barth temperò le proprie posizioni: pur non rinunciando al principio della
trascendenza divina e della condanna di ogni antropocentrismo in campo filosofico-teologico aprì
qualche strada nuova all'impegno storico-razionale dell'uomo e della Chiesa.
Nella sua Dogmatica Ecclesiale (1932) che ha esercitato una profonda influenza nel mondo
cristiano, egli riconosce la possibilità di forme di mediazione tra l'umano e il divino, il peccato e la
grazia, la finitudine e l'infinito.
Già nel settembre 1933, reagendo all'introduzione del paragrafo sull'arianità con il quale gli ebrei
battezzati venivano dichiarati non ariani e si decretava che fossero espulsi dalla Chiesa Evangelica,
alcuni parroci, fra i quali Martin Niemöller e Dietrich Bonhoeffer, formarono un gruppo che dichiarò
l'incompatibilità del suddetto paragrafo con la fede cristiana e che organizzò l’assistenza alle
persone colpite dalle misure razziali.
Tale gruppo confluì insieme alla Jungreformatorische Bewegung (Movimento Neoriformatore) nella
Chiesa Confessante, nata ufficialmente nel sinodo del 29/31 maggio 1934 a Wuppertal-Barmen. In
tale occasione Barth con la Dichiarazione Teologica di Barmen (Barmer Theologische Erklärung) ne
delineò il fondamento teologico.
Noi crediamo che Gesù Cristo, così come ci viene attestato nella Sacra Scrittura, sia
l’unica parola di Dio.
Ad essa dobbiamo prestare ascolto; in essa dobbiamo confidare e ad essa dobbiamo
obbedire in vita e in morte.
Noi crediamo che, come Gesù Cristo rappresenta la grazia senza condizioni, il perdono
di tutti i nostri peccati,così, con uguale serietà, egli sia l’espressione della forte
pretesa che Dio fa valere nei confronti di tutta la nostra vita.Per mezzo suo ci accade
di sperimentare una felice liberazione dagli empi legami di questo mondoper un
libero, riconoscente servizio alle sue creature.
Noi crediamo che la chiesa cristiana sia la comunità di fratelli e sorellein cui Gesù
Cristo, nella parola e nel sacramento mediante lo Spirito Santo,agisce in modo
Il problema di Dio nella riflessione filosofica contemporanea pag. 5

presente come il Signore.Essa è soltanto sua proprietà e desidera vivere soltanto della
sua consolazione e della sua direttiva,nell’attesa della sua manifestazione.
Noi crediamo che i diversi ministeri nella chiesanon legittimino alcuna supremazia
degli uni sugli altri,bensì siano alla base dell’esercizio del servizio affidato e
comandato a tutta la comunità.
Noi crediamo che la chiesa faccia appello al regno di Dio, al suo comandamento e alla
sua giustizia,e perciò debba ricordare ai governanti e ai governati le loro
responsabilità.Essa si affida ed obbedisce alla potenza della parola mediante la quale
Dio regge ogni cosa.Noi crediamo che il compito della chiesa, fondamento della
libertà,consista nel rivolgere a tutto il popolo la notizia della libera grazia di Dio
(Dichiarazione teologica di Barmen, maggio 1934)
La dichiarazione ribadiva la centralità di Cristo quale fondamento della fede della Chiesa e
respingeva quindi criteri e istanze estranee ai principi cristiani e quindi le pretese totalitarie del
regime nazista nonché il tentativo di appropriarsi del messaggio evangelico per scopi politici. Dopo
il sinodo andarono costituendosi molte comunità legate alla Chiesa Confessante che rifiutarono di
sottomettersi alle gerarchie ufficiali della Chiesa. Questa resistenza non fu inizialmente tanto
motivata politicamente, quanto piuttosto fondata sulla volontà di opporsi all'interno della Chiesa ai
Deutschen Christen.
L'agire umano, crudele e responsabile di atrocità, trova un critico fondamentale in Dietrich
Bonhoeffer che nel 1933, dai microfoni della Berliner Funkstunde, sull'idea di Führer, dichiarò:
«se il capo permette al seguace che questi faccia di lui il suo idolo,
allora la figura del capo si trasforma in quella di corruttore. Il capo
e la funzione che divinizzano se stessi scherniscono Dio»
Bonhoeffer fu interprete di un inaudito spirito di rinnovamento della fede. Oppostosi alla Chiesa
ufficiale del Reich venne interdetto dall'insegnamento, partecipò alla resistenza antinazista, venne
imprigionato e poi giustiziato a Flossenburg.
Nell'opera RESISTENZA E RESA sono raccolti i pensieri e le lettere che Bonhoeffer spediva dal
carcere a un amico, testimonianza di un pensiero sofferto e tenace.
Secondo Bonhoeffer Dio non è più tra gli uomini, l'uomo stesso è divenuto adulto e ha imparato a
fare a meno di Dio (il mondo è ormai secolarizzato, l'uomo riesce a badare a se stesso). La religione
non deve fare leva sulle debolezze degli uomini in modo tale da fare spazio a un Dio che consola e
che riempie i vuoti dell'uomo, la fede matura (ormai priva di religiosità) auspicata da Bonhoeffer
mette invece di fronte l'uomo alla verità che Dio è ormai impotente nel mondo ed è proprio per
questa sua condizione di debolezza che aiuta l'uomo nei momenti più estremi donandogli la fede.
Quello di Bonhoeffer è un tentativo limite di fondare la fede partendo dall'irrimediabile morte della
religione: da un lato l'uomo deve vivere come se Dio non ci fosse, dall'altro sentirsi al cospetto di
Dio. Questi due atteggiamenti sono senz'altro contraddittori, ma è in questa sfida che l'uomo pone
Dio "al centro" e non "ai lati" della sua esistenza, in quanto da un lato demitizza agli estremi il
messaggio cristiano, e dall'altro recupera, ormai mondato dagli aspetti accessori e mondani,
l'autentico senso della fede in Dio.
Dalla posizione di Bonhoeffer parte il tentativo di fondare una nuova teologia, la Teologia Della
Il problema di Dio nella riflessione filosofica contemporanea pag. 6

Secolarizzazione che, accettando in toto il percorso della filosofia contemporanea e dello sviluppo
scientifico-tecnologico moderno, svaluta la metafisica e toglie alla fede qualsiasi segno di sacralità.
Questo difficile tentativo parte dal presupposto che solo accettando pienamente la secolarizzazione
della Chiesa (privandola di ogni significato mitico-metafisico e della sua pretesa teologico-
epistemica di vincolare l'uomo al soprannaturale) si può riaprire finalmente un orizzonte autentico
entro il quale sviluppare un rapporto più genuino tra Dio e l'uomo.
Controcorrente
http://www.lanuovavia.org/confutazioni-bonhoeffer.html
Spesso Dietrich Bonhoeffer viene citato da pastori e predicatori evangelici, anche pentecostali,
prendendolo come un esempio di ‘eroe cristiano’.
La cosa sconcertante però è che Dietrich Bonhoeffer professava parecchie eresie.
Eccone alcune, così come le trovo nell’articolo ‘Beware of Dietrich Bonhoeffer’ (‘State attenti a
Dietrich Bonhoeffer’) scritto dal predicatore battista fondamentalista David Cloud sul suo blog
(http://www.practicalbible.com/content/beware-dietrich-bonhoeffer)
1. Nega l’ispirazione verbale e plenaria della Scrittura, credendo che la Bibbia sia soltanto un
‘testimone’ della Parola di Dio e diventi la Parola di Dio solo quando essa ‘parla’ ad un individuo;
altrimenti, essa è semplicemente la parola di uomo (Testimony to Freedom, pp. 9, 104;
Sanctorum Communio, p. 161).
2. Nega l’Iddio biblico, credendo che il concetto di Dio come un ‘Essere supremo, assoluto in
potenza e bontà, sia una ‘falsa concezione di trascendenza’, e che ‘Dio come una ipotesi
operante nella morale, nella politica e nella scienza … dovrebbe essere abbandonata, o nei
limiti del possibile eliminata’ (Letters and Papers from Prison, S.C.M. Press edition, Great Britain:
Fontana Books, 1953, pp. 122, 164, 360).
3. Mette in dubbio la nascita verginale di Cristo (The Cost of Discipleship, p. 215).
4. Nega la divinità di Cristo, sostenendo che ‘Gesù Cristo Oggi’ non è una persona reale o un
essere reale, ma una ‘presenza corporativa’ (Testimony to Freedom, pp. 75-76; Christ the
Center, p. 58).
5. Nega che la natura umana di Cristo fosse senza peccato ed inoltre mette in dubbio che il Suo
comportamento terreno fosse senza peccato (Christ the Center, pp. 108-109).
6. Nega la resurrezione fisica di Cristo, credendo che la resurrezione corporale sia nel ‘regno
dell’ambiguità’, e che fu uno degli elementi ‘mitologici’ del Cristianesimo che ‘deve essere
interpretato in una tale maniera da non rendere la religione una pre-condizione della fede’. Egli
crede anche che cose come i miracoli e l’ascensione di Cristo siano ‘concezioni mitologiche’
(Christ the Center, p. 112; Letters and Papers from Prison, S.C.M. Press edition, Great Britain:
Fontana Books, 1953, pp. 93-94, 110).
7. Crede che Cristo non sia la sola via che mena a Dio (Testimony to Freedom, pp. 55-56).
8. E' un evoluzionista (No Rusty Swords, p. 143) e crede che il libro della Genesi sia
scientificamente ingenuo e pieno di miti (Creation and Fall: A Theological Interpretation of
Genesis 1-3).
9. Aderisce alla teologia e alla terminologia neo-ortodossa concernente la salvezza (Testimony
to Freedom, p. 130), è un sacramentalista (Life Together, p. 122; The Way to Freedom, pp. 115,
153), crede che il battesimo dei bambini rigeneri (Letters and Papers from Prison, Macmillan,
Il problema di Dio nella riflessione filosofica contemporanea pag. 7

pp. 142-143), come anche quello degli adulti (The Way to Freedom, p. 151), equipara
l’appartenenza alla Chiesa alla salvezza (The Way to Freedom, p. 93), e nega una salvezza
personale/individuale (Letters and Papers from Prison, Macmillan, p. 156).
Che dire? Avrà pure fatto talvolta anche delle affermazioni bibliche nella sua vita, questo
Bonhoeffer, ma certamente i suoi scritti sono pieni di eresie, cioè di veleno mortifero, e quindi
costui va rigettato e i suoi libri non devono trovare posto negli scaffali delle case dei santi. Chi
ha orecchi da udire, oda.
La sua teologia
Gianfranco Ravasi così sintetizza il pensiero di Bonhoeffer:
“Egli esaltava la necessità dell’impegno del cristiano nelle “realtà penultime”, cioè in quelle
della storia e dell’azione sociale e politica, per poter accedere alle “realtà ultime” della fede e
della pienezza di vita in Dio. Egli sentiva fortemente l’importanza di un confronto col mondo
diventato “adulto” e secolare, e questo dialogo doveva avvenire attraverso un cristianesimo
“non religioso”, cioè ripensato in una nuova forma, non più sacrale(1). Queste ed altre tesi,
alcune di forte impronta mistica, altre di tonalità esistenziale, contenevano reazioni e fremiti
legati alla sua esperienza e al contesto di quel tempo e sono poi state sottoposte a critica”.
(1) Distinzione tra le cose pure e impure. Gesù supera la religione (in senso
tecnico): Dio non è giudice ma padre
Dio non è un tappabuchi
Dio si rivela nella categoria della debolezza (la sua morte in croce è il suo trionfo)
Dio non è venuto a rispondere alle nostre domande di senso
Il senso del cristianesimo è la sequela
Dio è stato ridotto allo stato umano esaltandone tutte le facoltà (umane). Egli sarebbe:
Infinitamente buono
Onnipotente
Misericordioso
Onniscente
ecc.
Prima Barth e poi Bonhoeffer ci dicono invece che DIO è ALTRO, Egli sfugge a qualsiasi tentativo di
comprenderlo (sic!) o di conoscerlo riducendolo in categorie umane:
“l'infinita differenza qualitativa tra Dio e
l'uomo”
Kierkegaard
“Dobbiamo vivere come se Dio non ci fosse”
Bonhoeffer, 16 luglio 1944
SHOAH = CATASTROFE
Olocausto (holo’caustos in greco) è un aggettivo e significa tutto bruciato; è il sacrificio previsto
nella Torah in cui c'è l'offerente, la vittima e il destinatario.
Il problema di Dio nella riflessione filosofica contemporanea pag. 8

Razionalità tecnica impiegata per produrre la morte
La Shoah è una politica d’esclusione pianificata e razionale, ma è appunto questa razionalità
tecnica sottostante allo sterminio a risultare peculiare della Shoah. “I mezzi dello sterminio non
sono stati, in ultima istanza, né militari, né polizieschi ma industriali. Beninteso l’esercito e la polizia
erano indispensabili: per le ricerche, le scorte, l’amministrazione dei campi ed anche per una parte
delle carneficine. Ma nel suo aspetto ‘finale’, l’annientamento non conservava più nessuno dei tratti
della figura classica o moderna dell’oppressione sistematica.” Gli ebrei erano trattati come si
trattano i rifiuti industriali o la proliferazione dei parassiti. Le macchine utilizzate a questo fine
(macchine adattate, non inventate come lo era stato ad esempio la ghigliottina) erano i macchinari
che costituivano le zone industriali. Questa operazione di igiene e sanità che senza alcuna ritualità
sviluppava un’offensiva industriale non ha nessun corrispondente nella storia.
*** ***
Adorno Theodor Wiesengrund(Francoforte sul Meno 1903 - Zermatt 1996) Padre ebreo madre genovese
1924Laurea in filosofia a FrancoforteTesi: La trascendenza del cosale e del noematico nella fenomenologia di Husserl
1931Libera docenza in filosofia a Francoforte. Prolusione: L'attualità della filosofia
1936Condirettore della rivista dell'Istituto per la Ricerca Sociale
1947Dialettica dell'Illuminismo ( c/Horkheimer )
La sua critica e la sua proposta filosofica sono intrecciate con la teoria critica della società
Dialettica dell'Illuminismo: si può considerare come una critica assai decisa della modernità ed in
particolare dello scientismo moderno
L'Illuminismo si teorizza esplicitamente e si realizza con la coincidenza di sapere e potere, e cioè
l'asservimento della conoscenza alla logica del dominio
Critica dell'Illuminismo e della Modernità fondata sull'analisi delle conseguenze sociali
disumanizzanti di una razionalità asservita alla logica del dominio.
L'Illuminismo, nato dall'impulso di autoconservazione dell'io, e quindi da un atto di
autoaffermazione dell'uomo, ma sempre più accecato dalla chiusura egocentrica e dalla logica
del potere, si rovescia significativamente in un risultato opposto al suo principio originario:
l'autodistruzione dell'uomo.
La civiltà, al culmine del suo sviluppo, si rovescia in barbarie ( Shoah, Auschwitz, Nazismo ). Mia
Nota: gli eventi da cui Adorno parte per la sua critica risentono in misura troppo marcata del
suo ebraismo. Le considerazioni sono giuste ma le sue lagne sui poveri ebrei puzzano troppo di
propaganda per dare dignità di speculazione al suo ragionamento; in altre parole perché
Adorno pensa che la Shoah sia stato un crimine speciale?. Se è vero che durante la II Guerra
Mondiale, tutti i contendenti si macchiarono di colpe infami (Bombe atomiche americane,
bombardamenti sui civili, ecc.) A titolo d'esempio Wikipedia sviluppa in ben 64 pagine la voce
"Crimini perpetrati durante la seconda guerra mondiale".
Di fronte alla shoah (sic) si infrangono tanti miti, primo fra tutti quello illuministico del progresso
naturale, necessario e irreversibile dell'umanità.
Il problema di Dio nella riflessione filosofica contemporanea pag. 9

La barbarie di Auschwitz ha dimostrato il fallimento della cultura.
La via della salvezza è da ricercarsi nell'autoriflessione dell'uomo su se stesso, sulla propria
cultura, sulla propria storia e sulla propria società.
Società Industriale Avanzata: nasce ispirandosi ai principi del liberismo economico.
Principio di scambio: tutto è scambiabile. Lavoro con denaro ⇒ sfruttamento/alienazione.
Le condizioni di qualunque scambio non sono mai eque perché riflettono i rapporti di forza nella
società. Mia Nota: la probabilità che uno scambio sia equo è nulla. Quindi la non equità non si
può far discendere causalmente dai rapporti di forza nella società.
*** ***
LA MODERNITÀ
Ambiti della filosofia
1. Conoscenza
2. Agente / Morale
3. Giudizio
4. Relazioni / Politica
Antichità: Platone, Aristotele, Agostino, Tommaso | Che idea hai tu di Soggetto(*)
Modernità: Cartesio(**) | (def. Antropologica di UOMO)
(*) Soggetto
1. di conoscenza
2. di azione
3. che giudica
4. che vive in un contesto politico
(**) La razionalità non riflette l'ordine delle cose bensì l'ordine delle rappresentazioni proprie della
mente umana: COGITO ERGO SUM.
Il soggetto che è in grado di riflettere sulla realtà esterna, riesce a fondare la sua stessa esistenza,
a riconoscere il suo stesso essere.
Il pensiero è una proprietà interna al soggetto stesso
L'uomo riesce ad essere certo della sua esistenza soltanto nella consapevolezza del suo pensiero;
nella consapevolezza di riuscire a riflettere sul suo pensiero.
Il soggetto cartesiano è completamente trasparente a se stesso; può essere conosciuto nei suoi
anfratti più reconditi. E quindi vi è la pretesa di poter conoscere pienamente il soggetto che riflette.
Cartesio fonda la soggettività in quanto categoria filosofica
⇓
capacità potenziale del soggetto di conoscere completamente se stesso.
Il soggetto è semplice (sine plica)
Nel 900 questo concetto comincia ad andare in crisi. La sintesi principale della riflessione critica si
deve a Paul Ricoeur.
Paul Ricoeur nasce a Valence nel 1913. Studia filosofia all'Università di Rennes
e alla Sorbonne. Dal l945 al l948 insegna al Collège Cévenol di Chambon-sur-
Il problema di Dio nella riflessione filosofica contemporanea pag. 10

Lignon, poi Filosofia morale all'Università di Strasbourg e dal 1956 Storia della
filosofia alla Sorbonne. Nell'85 ha ricevuto il premio «Hegel» a Stuttgart. E'
direttore del Centro di ricerche fenomenologiche ed ermeneutiche.
Ricoeur pone la sua attenzione su tre figure chiave della riflessione filosofica del nostro
secolo:Marx, Nietzche e Freud, essi convergono nella ricerca dell'autentico significato dei fenomeni
culturali, e nel mettere in evidenza la struttura profonda della realtà, criticano l'idea di un
"soggetto" assoluto razionalmente orientato e di una coscienza razionale trasparente a se stessa
(come nella tradizione cartesiana).
La differenza tra loro sta nella diversa individuazione di questa struttura profonda che risiede
secondo Marx nella struttura economica, per Nietzsche nella volontà di potenza e per Freud
nell' inconscio.
In questa scoperta di un livello profondo di significato, prerazionale e inaccessibile alla coscienza
dello stesso autore di un testo, consiste il messaggio più importante di Marx, di Nietzche e di Freud.
Ricoeur per questo li chiama i "maestri del sospetto", per sottolineare la loro comune attitudine a
ricercare l'autentico significato dei fenomeni culturali in una struttura profonda nascosta alla
coscienza del soggetto. Ricoeur però se da una parte condivide la critica di questi pensatori all'idea
di una coscienza razionale trasparente a se stessa e fonte di ogni certezza, d'altro lato non ritiene
che il semplice richiamo a una struttura profonda possa esaurire e risolvere i problemi
dell'interpretazione.
Marx, Freud e particolarmente Nietzsche, mettono in risalto la crisi di un ordine costituito e le
conseguenti trasformazioni della società nel corso degli anni e, soprattutto, nei primi decenni del
XX secolo. Sono pensatori che mettono in crisi e scardinano dall'interno la struttura sociale,
economica e culturale in cui vivono.
MARX (1818-1883)
La conoscenza soggettiva è il riflesso delle strutture materiali e tende a ridurre l'individuo a puro
prodotto di rapporti di classe/potere. Mette in crisi la struttura economica esistente e pone le basi
per la successiva affermazione di diversi modelli di vita e di interpretazione dell'economia e della
società.
NIETZSCHE (1844-1900)
L'identità del soggetto è una maschera illusoria avente la funzione di fissare la molteplicità delle
espressioni della vita tramite una rassicurante parvenza di stabilità e continuità.
L'individuo è fiume di emozioni, sentimenti, pulsioni e dunque di molte identità.
E' necessaria una stabilità che lo fissi ad una sola identità = maschera
FREUD (1856-1939)
Scava nella psiche umana, dando un ordine a ciò che fino ad allora non era altro che una serie di
intuizioni che spesso avevano preso le mosse da antichi miti o da paure ataviche e che, altrettanto
spesso avevano finito con il degenerare in paure ancestrali da cui erano scaturiti inutili pregiudizi.
Freud dà un metodo e una regola a questa miriade di elementi elevandoli al rango di una nuova
scienza che chiama "psicologia" e che permetterà di disarticolare l'uomo in quanto monolite,
mettendo in evidenza le cause più profonde da cui nascono le pulsioni che guidano l'istinto e
l'azione degli individui e la cui interpretazione fino ad allora era lasciata al caso o alla tradizione.
Il problema di Dio nella riflessione filosofica contemporanea pag. 11

E' dei tre, l'autore più complesso anche perché la sua opera è stata molto manipolata da sua sorella
che ne utilizzò gli scritti per dare un substrato culturale e filosofico al nazismo di cui era fervida
sostenitrice. In realtà gli scritti nietzschiani mettono in crisi la morale così come si era codificata nei
secoli precedenti all'autore. Una morale non più basata su riferimenti etici, così come la Riforma
protestante e Kant avevano insegnato, ma che si basa su un ritorno del "mito della volontà". Una
morale in cui la libertà non si manifesta più quando, come in Kant, si è "liberi da", ossia quando si
agisce indipendentemente e non condizionati da passioni, pulsioni e egoismi di cui si conosce a
priori l'errore, ma quando si agisce secondo la propria morale intima che corrisponde poi con quella
universale. Con Nietzsche la vera morale è la rottura della morale tradizionale con l'affermazione di
chi sa andare "oltre l'uomo", ossia chi sa proporre se stesso e le proprie ambiziose pulsioni come
regolo della propria esistenza e, quindi di conseguenza, elemento condizionante della società e
dell'umanità stessa.
Quindi: rottura del quadro socio-economico, rottura dell'equilibrio interno all'uomo e rottura della
morale. E' proprio la parola "rottura" ciò che assimila Marx, Freud e Nietzsche cui segue una
trasformazione/instabilità dell'esistente. Sono questi, in sintesi, gli elementi comuni ai tre autori
presi in considerazione: il cogito ergo sum non ha più validità. L'identità personale si configura al di
fuori dell'individuo
GLI AUTORI DI RIFERIMENTO: Adorno, Levinas, Weil
Tutti di origine ebraica
Caratteristiche dell'ebraismo, religione abramitica (Hans Küng)
L'ebraismo non è:
1. stato (mia contestazione)
2. nazione
3. razza
4. comunità linguistica
5. comunità religiosa
EBRAISMO = RELIGIONE ANTIDOLATRICA
Abramo (76 anni) > Ur/Canaan > padre fabbricatore di idoli
Il problema di Dio nella riflessione filosofica contemporanea pag. 12