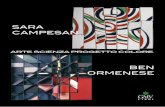Il problema della definizione dell’arte nella teoria ...estetica/dottoratoestetica/download/2009 -...
Transcript of Il problema della definizione dell’arte nella teoria ...estetica/dottoratoestetica/download/2009 -...
Università degli Studi di Palermo
Dipartimento di Filosofia, Storia e Critica dei Saperi Dottorato di ricerca in Estetica e Teoria delle arti – XX ciclo
Settore scientifico disciplinare: M-Fil/04 Coordinatore: Prof. Luigi Russo
Il problema della definizione dell’arte nella teoria
storico-intenzionale
Tesi di: Filippo Focosi
Tutor: Ch. mo Prof. Luigi Russo Co–tutor: Ch. mo Prof. Salvatore Tedesco
INDICE
Introduzione ...................................................................................................................... 1
1. Definire l’arte storicamente: la teoria di Jerrold Levinson ......... 10 1.1 I fondamenti teorici della definizione storica dell’arte .................................. 10 1.2 La definizione storico-intenzionale di Levinson: prima, seconda e terza versione.............................................................................................................................. 13 1.3 Storicità e continuità dell’arte.............................................................................. 19 1.4 I problemi di una definizione storico-intenzionale.......................................... 21
2. Obiezioni e repliche............................................................................................... 25 2.1 Risposte convincenti................................................................................................ 27
A) I POLLI DI JONES E I FILMATI DI MARIETTE................................................................. 28 B) INTENZIONE CATEGORIALE E INTENZIONE SEMANTICA............................................. 30 C) FALSI PROBLEMI, FALSI D’AUTORE E FALSI ARTISTI...................................................32
2.2 Risposte incerte......................................................................................................... 37 A) NON BASTA IL PENSIERO............................................................................................. 38 B) LA QUESTIONE DELLA CORRETTEZZA E DELLA COMPLETEZZA DEI MODI DI CONSIDERAZIONE ARTISTICI............................................................................................ 41 C) MARS ATTACKS ........................................................................................................... 45 D) OPERE D’ARTE E ARTEFATTI....................................................................................... 47
2.3 No comment............................................................................................................... 49 2.4 Risposte deboli.......................................................................................................... 50
A) IL PROBLEMA DELLE PRIME OPERE D’ARTE................................................................ 51 B) TRADIZIONI REMOTE, MONDI LONTANI ...................................................................... 53 C) LO SCOPO DELL’ARTE.................................................................................................. 57 D) NELLA MENTE DELL’ARTISTA ..................................................................................... 58
2.5 Processo alle intenzioni.......................................................................................... 61 2.6 E allora?..................................................................................................................... 69
3. Le teorie storiche dell’arte di Carroll, Carney e Stecker............... 71 3.1 La teoria delle narrazioni storiche di Noel Carroll........................................ 72
A) CHE COSA E’ ARTE?..................................................................................................... 72 B) ARTE COME CONVERSAZIONE..................................................................................... 74 C) IL METODO DELLE NARRAZIONI STORICHE................................................................. 75 D) IL PROBLEMA DELLE ORIGINI...................................................................................... 79
3.2 La teoria stilistica di James Carney.................................................................... 81 A) STILE E PROPRIETA’ ESTETICHE.................................................................................. 81 B) STILE GENERALE E STILE INDIVIDUALE...................................................................... 82 C) LA TEORIA STILISTICA DELL’ARTE .............................................................................. 85
D) ALCUNE OBIEZIONI ..................................................................................................... 86 3.3 Carroll, Carney e Levinson.................................................................................... 88 3.4 Il funzionalismo storico di Robert Stecker......................................................... 93
A) HA ANCORA SENSO CERCARE DI DEFINIRE L’ARTE?...................................................93 B) LA NOZIONE DI FUNZIONALISMO ................................................................................ 97 C) LA DEFINIZIONE STORICO-FUNZIONALE DELL’ARTE................................................ 101
3.5 Perché la definizione di Stecker non funziona................................................ 103 A) I PROBLEMI DELLA DEFINIZIONE STORICO-FUNZIONALE DELL’ARTE ...................... 103 B) FRANKENSTEIN JUNIOR............................................................................................. 106 C) COSA CI INSEGNA DAVVERO LA STORIA?.................................................................. 107
4. Ritorno alle origini ............................................................................................... 109 4.1 Il centro naturale dell’arte................................................................................... 110 4.2 L’arte in una prospettiva transculturale.......................................................... 113 4.3 Liste, griglie, grappoli........................................................................................... 117 4.4 Le origini dell’arte................................................................................................. 125
5. L’essenza estetica dell’arte.............................................................................. 142 5.1 Le proprietà estetiche............................................................................................ 143
A) LA NATURA DELLE PROPRIETA’ ESTETICHE............................................................. 143 B) LO SPETTRO DELLE PROPRIETA’ ESTETICHE............................................................. 148
5.2 Esperienza, piacere, valore.................................................................................. 153 A) I PRINCIPI DELL’ESPERIENZA ESTETICA.................................................................... 153 B) LA DUPLICE NATURA DEL PIACERE ESTETICO.......................................................... 159 C) VALORE ESTETICO E VALORE ARTISTICO................................................................. 163
5.3 Definire l’arte dal punto di vista estetico......................................................... 168 A) I DESIDERATA DI UNA DEFINIZIONE ESTETICA DELL’ARTE....................................... 168 B) RICHARD & RICHARD................................................................................................. 172
5.4 I dilemmi di una definizione estetica dell’arte................................................ 176 A) TROPPO INCLUSIVA O TROPPO ESCLUSIVA?.............................................................. 176 B) DUCHAMP: DENTRO O FUORI?................................................................................... 182 C) OGGETTIVITA’ O SOGGETTIVITA’ DELLE PROPRIETA’ ESTETICHE?.......................... 186
6. Giudicare l’arte storicamente....................................................................... 197 6.1 Dalla storia all’opera............................................................................................ 198 6.2 Dall’opera alla storia............................................................................................ 202
A) RIMODELLARE L’ESPERIENZA................................................................................... 202 B) ESTENDERE L’ESPERIENZA........................................................................................ 204 C) INNALZARE L’ESPERIENZA........................................................................................ 212 D) R. S. V. P..................................................................................................................... 216
Bibliografia ..................................................................................................................... 219
1
Introduzione
Uno dei principali problemi intorno ai quali l’estetica analitica anglo-americana ha dato un
contributo teoretico particolarmente cospicuo e originale è quello della definizione dell’arte.
La tradizione estetologica occidentale infatti, pur non trascurando del tutto la questione, non
ne ha fatto un campo privilegiato di riflessione, né le ha riservato uno specifico ambito di
indagine. Trascurando le riflessioni sull’arte che sono state prodotte prima della costituzione
dell’estetica come disciplina autonoma, possiamo infatti dire che dal Settecento in poi c’è
stata un’unica definizione dell’arte in Occidente, vale a dire quella formulata da Batteux nel
1746 e che identifica l’arte con “l’imitazione della bella natura” 1. Ciò non significa che non
siano state proposte altre teorie sul significato dell’arte; la storia della filosofia dimostra
piuttosto una grande mobilità di idee al riguardo. Tuttavia ogniqualvolta ciò è stato fatto, la
dimensione definitoria dell’arte non ha assunto uno spazio specifico, ma è stata inscritta in un
contesto più ampio non solo del problema della classificazione delle opere d’arte (il quale è
stato collegato alle questioni relative alla verità dell’arte, allo statuto ontologico delle opere,
ecc.), ma anche dell’arte stessa (la quale è solo una parte, seppure esemplare, dell’estetica
intesa come disciplina che studia le condizioni di possibilità di una conoscenza sensibile).
L’estetica analitica ha invece trattato il problema della definizione dell’arte separatamente
dagli altri problemi, cercando di articolare delle risposte il più possibile plausibili alla
domanda su cosa sia un’opera d’arte, ovvero su come facciamo a distinguere un’opera d’arte
dagli altri prodotti dell’agire umano. Tale insularità della ricerca estetica dei filosofi inglesi e
americani può essere vista come una caratteristica negativa del metodo analitico, in quanto
indice di un riduzionismo limitante e parcellizzante − l’estetica si riduce a filosofia dell’arte,
la quale a sua volta si riduce allo studio di settori (la definizione dell’arte, le caratteristiche
specifiche delle singole discipline artistiche, le proprietà estetiche di un oggetto, e via
dicendo) ciascuno dei quali viene trattato a parte e isolatamente dagli altri. In tal modo la
filosofia analitica rischia di perdere il nesso che collega tra loro le varie problematiche
1 Charles Batteux, Les Beaux-Arts Reduits a un meme principe (1746), trad. it. (a cura di E. Migliorini, I. Torrigiani, F. Vianovi) Le belle Arti ricondotte ad unico principio, Aesthetica, Palermo 2002 (la prima ed. it. è del 1983), p. 35.
2
inerenti all’arte e più in generale all’estetica, con ciò privandosi della possibilità di una loro
vera e approfondita comprensione 2.
Lo stesso fenomeno presenta però anche degli aspetti indubbiamente positivi. Innanzitutto,
concentrandosi di volta in volta su oggetti specifici e applicando ad essi il metodo dell’analisi
logica, i filosofi analitici riescono a decifrare aspetti degli oggetti e del nostro modo di
relazionarci ad essi ai quali altrimenti non presteremmo attenzione. In secondo luogo, con
l’aver preso come oggetto privilegiato (sebbene non unico) della loro indagine il problema
della definizione dell’arte, i filosofi analitici si sono mostrati estremamente ricettivi nei
confronti della realtà artistica del XX secolo. A partire dalla fine dell’Ottocento e fino a buona
parte del Novecento (soprattutto la prima metà) una serie di fattori − il profondo rivolgimento
che ha attraversato tutte le forme artistiche e che ha avuto il suo culmine nelle Avanguardie di
inizio secolo, la comparsa di nuove forme d’arte come la fotografia e il cinema, la progressiva
costituzione della critica d’arte come disciplina di primaria importanza − ha rimesso in
discussione alcune delle categorie filosofiche tradizionali (come quelle di imitazione, di
bellezza, di gusto) sulle quali la tradizione estetologica si è eretta, o quantomeno ne ha messo
in discussione la possibilità di utilizzo in ambito artistico. La filosofia analitica ha raccolto il
guanto di sfida lanciato dalle arti, e ha intrapreso, per mano di un numero consistente di
autori, prevalentemente inglesi e americani, il compito di cercare di ri-definire il concetto di
arte alla luce degli stravolgimenti dell’epoca contemporanea. Il primo autore ad aver
proposto, all’interno di tale tradizione di pensiero, una definizione moderna di arte è stato
Clive Bell, il quale rimase profondamente colpito dall’avvento dell’arte astratta (come pure il
suo amico Roger Fry, col quale condivise la duplice attività di critico e filosofo) e pubblicò
nel 1914 un testo intitolato Art, contenente una definizione formalista di arte secondo cui un
oggetto è un’opera d’arte se e solo se possiede la proprietà della forma significante 3. Bell
aveva in mente principalmente le opere d’arte visiva, e per forma significante egli intendeva
quindi quell’insieme di relazioni di linee e colori tale da produrre nello spettatore un tipo
particolare di emozione, da lui chiamata emozione estetica 4. Tale teoria aveva il merito di
catturare il significato dell’arte astratta, ma presentava due evidenti difetti. In primo luogo,
2 Di questo avviso è Stefano Velotti, come si evince da S. Velotti, Estetica analitica: un breviario critico, Aesthetica Preprint, Palermo 2008. 3 Clive Bell, Art, Chatto & Windows, London 1914. 4 Nel formulare la sua teoria formalista dell’arte, Bell fu sicuramente influenzato dalle analoghe riflessioni contenute in Roger Fry, “An Essay in Aesthetics” (1909), trad. it. “Un saggio di estetica”, in F. Di Giacomo, C. Zambianchi (a cura di), Alle origini dell’opera d’arte contemporanea, Laterza, Roma-Bari 2008, pp. 5-18. Fry riteneva che l’opera d’arte (visiva), attraverso l’unità e la varietà dei suoi elementi formali (linea, massa, spazio, chiaroscuro, colore), fosse in grado di comunicarci emozioni diverse (ovvero le emozioni estetiche) da quelle ordinarie e tali da trasportarci dal piano della vita reale a quello della vita immaginativa.
3
essa è circolare, in quanto la forma, per poter essere descritta come significante, rimanda alla
nozione di emozione estetica, la quale a sua volta è descritta da Bell come la reazione
appropriata alla percezione della forma significante stessa. Inoltre, essa è palesemente
restrittiva, dal momento che esclude dal novero delle opere d’arte (visiva) tutti i dipinti
figurativi (o nel caso migliore ne decreta l’artisticità per il solo effetto delle proprietà formali
possedute e indipendentemente, anzi nonostante, il loro contenuto rappresentativo).
Circa vent’anni dopo la pubblicazione di Art un altro filosofo inglese, Robin G.
Collingwood, elaborò nei suoi The Principles of Art una definizione di arte che cercava di
superare le aporie contenute nella teoria del suo predecessore 5. Secondo Collingwood lo
scopo dell’arte è l’espressione di emozioni, dove per espressione egli intende il processo
attraverso il quale l’artista rende chiara, a sé e al pubblico che contempla l’opera, le proprie
particolari emozioni. Tale teoria ha il merito di dar conto di movimenti artistici (come
l’espressionismo, ma non solo) che non si lasciano ridurre all’astratta realizzazione e
percezione di pure composizioni formali, ma risulta anch’essa troppo restrittiva (dal momento
che non tutte le opere d’arte esprimono emozioni, o nascono per questa esigenza), se non
eccessivamente audace − Collingwood arrivò a sostenere, in sintonia con Croce (al quale la
sua teoria rimanda in più punti), che l’opera d’arte è un’entità che esiste solo
nell’immaginazione, e che le opere concrete non sono che una semplice traccia di cui
possiamo servirci per ricostruire mentalmente la vera opera d’arte; ipotesi, questa, quanto
meno dubbia e decisamente poco condivisa. Ma la vera svolta si ebbe nel 1956, quando con la
pubblicazione di The Role of Theory in Aesthetics Morris Weitz mise in discussione la
legittimità dell’idea stessa di definire l’arte 6. In disaccordo con quanto dichiarato da Bell,
secondo il quale “o tutte le opere d’arte visiva possiedono qualche qualità comune, oppure
quando parliamo di opere d’arte farfugliamo” 7, Weitz sostenne che non esistono proprietà
comuni a tutte le opere d’arte, visiva e non; ciò significa che non esistono condizioni
necessarie e sufficienti all’artisticità. Tale affermazione venne presentata non come
un’inferenza induttiva ricavata dal fallimento delle teorie tradizionali, ma come una verità
logica: l’arte è indefinibile in quanto essa è un concetto aperto, che deve includere in se stesso
la possibilità dell’innovazione e della creatività, che sono caratteristiche costitutive del
concetto di arte e che sarebbero inibite qualora si cercasse di chiudere tale concetto entro un
numero limitato e fisso di condizioni. Come facciamo allora a stabilire se un oggetto è o meno
5 Robin G. Collingwood, The Principles of Art (1938), Oxford University Press, Oxford 1958. 6 Morris Weitz, “The Role of Theory in Aesthetics” (1956), ora in A. Neill e A. Ridley (a cura di), The Philosophy of Art: Readings Ancient and Modern, McGraw-Hill, New York 1995, pp. 183-92. 7 Clive Bell, Art, cit., pp. 7-8.
4
un’opera d’arte? La risposta di Weitz è contenuta nella teoria delle somiglianze di famiglia
(ripresa da Wittgenstein), secondo cui esistono tra le opere d’arte dei “fasci di somiglianze”
che si intersecano e si sovrappongono, allo stesso modo in cui i membri di una famiglia
rimandano ad altri per alcune caratteristiche (ad es. gli occhi), ad altri membri per altri tratti
somatici (la forma del viso), e via dicendo, senza che vi sia un tratto posseduto da tutti e soli i
membri di tale famiglia 8. Non si tratta allora di applicare un criterio predeterminato per
stabilire l’artisticità di un oggetto, ma di “prestare attenzione e vedere” se esso possiede o
meno un numero soddisfacente di caratteristiche rilevanti e possedute da opere d’arte
considerate paradigmatiche e indiscusse, e di decidere in base a tali somiglianze se l’oggetto
possa o meno essere considerato un’opera d’arte 9.
Sulla scia dell’articolo di Weitz, anche altri autori si convinsero dell’impossibilità
(teoretica) e dell’inutilità (pratica) del progetto definitorio: secondo questi autori, le
definizioni tradizionali possono essere usate solo come indicazioni circa quali aspetti vanno
tenuti in considerazione, accanto ad altri, nella classificazione delle opere d’arte, la quale
rimane un’operazione fondamentalmente intuitiva (ovvero non guidata da regole ferree) 10.
Nonostante l’iniziale successo, anche la teoria di Weitz prestò il fianco a numerose (e per lo
più inconfutabili) critiche. Innanzitutto, Weitz sembra confondere il piano dell’arte in quanto
attività con quello dell’arte in quanto insieme dei prodotti di tale attività, ovvero delle opere
d’arte: dall’eventuale chiusura di queste ultime in un concetto definito, ovvero in un insieme
di condizioni necessarie e sufficienti, non deriva logicamente l’impossibilità dell’innovazione
e della creatività dell’operare artistico. Riguardo poi alla teoria delle somiglianze di famiglia,
due punti vanno sottolineati. Il primo è che se non si specificano quali e quante siano le
somiglianze (con le opere paradigmatiche del passato) rilevanti ai fini dell’identificazione di
un’opera d’arte, quest’ultima operazione rischia di sconfinare nell’arbitrarietà. Il secondo e
decisivo punto è stato rilevato da Maurice Mandelbaum nel 1965 in un articolo altrettanto
importante e influente, dal titolo Family Resemblances and Generalizations Concerning the
Arts 11. In quest’articolo Mandelbaum accusò Weitz di aver male interpretato l’idea
wittgensteiniana delle somiglianze di famiglia. Ciò che infatti ci permette di stabilire se una
certa persona è un membro di una data famiglia non è tanto il fatto che egli possieda o meno
8 M. Weitz, “The Role of Theory in Aesthetics”, cit., pp. 187-8. 9 Ivi, p. 187. 10 Vedi William E. Kennick, “Does Traditional Aesthetic Rest on a Mistake?”, Mind 67 (1958), pp. 317-34; P. Ziff, “The Task of Defining a Work of Art”, Philosophical Review 62 (1953), pp. 58-78; W. B. Gallie, “Art as an Essentially Contested Concept”, Philosophical Quarterly 6 (1956), pp. 97-114. 11 Maurice Mandelbaum, “Family Resemblances and Generalisations Concerning the Arts” (1965), ora in A. Neill e A. Ridley (a cura di), cit., pp. 193-201.
5
lo stesso taglio degli occhi e la stessa forma della bocca del padre o di un fratello
(caratteristiche, queste, che egli potrebbe condividere anche con persone con lui in nessun
modo imparentate), quanto piuttosto il fatto di possedere lo stessa origine genetica, ovvero lo
stesso DNA. Tradotto in termini artistici, ciò significa che, pur non essendoci proprietà
manifeste comuni a tutte le opere d’arte, possono esistere delle proprietà non manifeste che
fungano da nucleo condiviso e imprescindibile di ogni oggetto che si vuole classificare come
opera d’arte. Tali proprietà possono essere di vario tipo; ciò che conta è che esse sono di tipo
relazionale, ovvero riguardano la relazione tra le opere d’arte e determinate caratteristiche non
esibite ma egualmente reali (come l’intenzione dell’autore, le istituzione sociali, la tradizione
storica, e via dicendo).
L’articolo di Mandelbaum non fu meno influente di quello di Weitz, in quanto fu capace di
ridar vigore al progetto definitorio, facendolo rinascere su direttive diverse da quelle su cui si
erano poggiate le teorie tradizionali: mentre queste si basavano sulla presunta esistenza di
caratteristiche intrinseche e manifeste, ovvero direttamente osservabili, comuni a tutte le
opere d’arte, i nuovi difensori di tale progetto si misero alla ricerca di proprietà comuni ma
nascoste, in quanto costituite dalla relazione delle opere con elementi non direttamente
osservabili ma rilevabili per mezzo di una conoscenza sociale, culturale e storica. Il primo a
muoversi in questa direzione fu Arthur C. Danto, il quale nell’ormai noto The Artworld
scrisse che per riconoscere che un oggetto è un’opera d’arte abbiamo bisogno di un “qualcosa
che l’occhio non può cogliere − un’atmosfera di teoria artistica, una conoscenza di storia
dell’arte: un mondo dell’arte” 12. Danto giunse a tale conclusione dopo essersi posto la
domanda su come possiamo distinguere un oggetto comune da un’opera d’arte; domanda
sollecitata da un numero consistente di opere d’arte del Novecento. Se Fountain di Duchamp
o i Brillo Boxes di Warhol erano percettivamente indiscernibili da dei comuni orinatoi o dalle
scatole di pagliette saponate che si usano per pulire le pentole, ciò che rendeva le prime delle
opere d’arte non poteva infatti che essere un elemento non percettivo, e quindi, in accordo con
Mandelbaum, non manifesto, che Danto identificò col “mondo dell’arte”, termine destinato ad
avere una gran fortuna negli anni a venire. Danto non fornì però indicazioni sufficienti circa
l’esatta natura del mondo dell’arte (che per lui comprendeva a vario titolo la storia, la critica e
la filosofia dell’arte), e ciò non gli permise di formulare una vera e propria definizione
dell’arte (il che peraltro non era nemmeno nelle sue intenzioni). Tale compito venne assunto
invece da un altro autore, George Dickie, il quale caratterizzò in termini marcatamente sociali
12 Arthur C. Danto, “The Artworld” (1964), ora in A. Neill e A. Ridley (a cura di), The Philosophy of Art: Readings Ancient and Modern, McGraw-Hill New York 1995, p. 209.
6
il mondo dell’arte, che venne da lui concepito come una vera e propria istituzione,
comprendente un certo numero di persone (artisti, critici, galleristi, curatori di mostre,
appassionati) e regolata da un insieme di procedure storicamente sedimentate di presentazione
di un dato oggetto (l’opera) a determinate persone (il pubblico) per conto di certi individui (i
galleristi, i curatori e soprattutto gli artisti stessi). I ready-made duchampiani o le scatole
Brillo di Warhol hanno mostrato come la presentazione di un oggetto da parte di persone
deputate a farlo, secondo una serie di procedure standard e entro un contesto adeguato,
fossero caratteristiche essenziali al conferimento dello status di artisticità all’oggetto stesso.
Su tale base Dickie ritenne quindi di poter formulare una definizione compiuta di arte, che
prende il nome di definizione istituzionale, secondo cui “un oggetto è un’opera d’arte in senso
classificatorio se e solo se (1) è un artefatto (2) a un insieme di aspetti del quale è stato
conferito lo status di candidato all’apprezzamento da parte di una o più persone le quali
agiscono per conto di una determinata istituzione sociale (il mondo dell’arte)” 13.
La teoria istituzionale sancì il cambio di rotta, prefigurato da Mandelbaum, della ricerca
filosofica di una definizione dell’arte. Essa tuttavia non si mostrò in grado di condurla
all’approdo finale e decisivo. Più di un problema ne minò infatti sin da subito la validità, e
uno in particolare risultò decisivo in tal senso. Dickie definisce infatti l’opera d’arte nei
termini di una istituzione (il mondo dell’arte), la cui identità è definita dal potere di conferire
ad un oggetto lo status di opera d’arte: i due concetti (opera d’arte e mondo dell’arte) si
richiamano a vicenda, e la definizione risulta essere circolare. Egli è in realtà disposto a
concedere che la sua definizione sia accusata di circolarità, a patto che si specifichi che non si
tratta di circolarità viziosa, dal momento che la descrizione del mondo dell’arte contiene una
quantità di informazioni che non rimandano al concetto di opera d’arte. Anche questo punto è
però piuttosto discutibile. Le persone che compongono il mondo dell’arte sono individuabili
in quanto hanno il potere di conferire lo status di candidato all’apprezzamento a un oggetto;
tale atto non è però formalizzato in una serie di norme o codici precisi, ma si riduce al
generico atto di presentazione di un’opera ad un pubblico. Tali descrizioni non ci permettono
dunque di distinguere l’istituzione artistica da altri tipi di istituzioni sociali (come lo stato, il
diritto o la chiesa, le quali peraltro sono più rigidamente strutturate); a tal fine è necessario
rimandare all’oggetto del conferimento di status, vale a dire all’opera d’arte, il che non
permette di far uscire la definizione istituzionale da una circolarità che si rivela
irrimediabilmente viziosa. Inoltre, se non si specificano i criteri che guidano la presentazione
13 George Dickie, Art and the Aesthetic: An Institutional Analysis, Cornell University Press, Ithaca (N.Y.) 1974, p. 34.
7
dell’opera o il tipo di apprezzamento richiesto (Dickie ci tiene a specificare che si tratta di un
generico apprezzamento che non va confuso con la valutazione estetica), l’atto di
conferimento di status appare arbitrario (qualsiasi oggetto può divenire in tal modo un’opera
d’arte, indipendentemente dalle sue proprietà intrinseche) ed elitario (ciò che conta ai fini
della classificazione delle opere d’arte è in ultima analisi il potere che una ristretta cerchia di
persone possiede in virtù del loro status sociale).
Le difficoltà incontrate dalla teoria istituzionale hanno portato alcuni a riprendere il
sentiero tracciato dalle teorie tradizionali dell’arte. Tra questi spicca il nome di Monroe C.
Beardsley, uno dei più importanti filosofi analitici in ambito estetico. Beardsley, che nei suoi
primi lavori si è mostrato non particolarmente interessato al problema della definizione
dell’arte, ha proposto agli inizi degli anni Ottanta una definizione che possiamo chiamare
estetico-funzionale, la quale afferma che un oggetto è un’opera d’arte se è stato prodotto “con
l’intenzione di renderlo capace di soddisfare un interesse estetico”, ovvero l’interesse per il
carattere estetico dell’esperienza che tale oggetto (in virtù delle sua costituzione intrinseca)
produce nello spettatore 14. La definizione appena enunciata è estetica, in quanto il termine
‘estetico’ compare esplicitamente; il che la differenzia in parte dalle definizioni tradizionali,
nelle cui enunciazioni primarie tale termine non è presente, sebbene esso sia necessariamente
implicato (l’imitazione ha per oggetto la bellezza, che è una proprietà estetica; la forma
diviene significante se è in grado di procurare un’emozione estetica in chi la percepisce; la
stessa emozione che l’artista vuole esprimere diviene un’emozione estetica una volta che il
processo di chiarificazione artistica è completo). Inoltre essa è funzionale, in quanto la
condizione che ci permette di classificare un oggetto come opera d’arte è che esso soddisfi (o
meglio, sia inteso per soddisfare) una determinata funzione, vale a dire la produzione di
un’esperienza estetica soddisfacente. La definizione di Bearsdley riporta l’attenzione
sull’opera d’arte, sulle sue proprietà intrinseche e sull’esperienza che in base a queste essa è
in grado di produrre; il che le permette di evitare le problematiche legate al concetto di mondo
dell’arte. Essa però non è al riparo da possibili obiezioni fino a che non si dia una valida
caratterizzazione del concetto di esperienza estetica (senza la quale si rischia anche qui di
incorrere in un circolo vizioso); compito, questo, che non è meno difficile di quello di definire
i concetti di bellezza e di emozione estetica. Se anche ciò fosse possibile (come lo stesso
Bearsdley ritiene, sulla base delle ricerche da lui stesso effettuate a più riprese
sull’argomento), rimarrebbe comunque sempre il problema della ristrettezza di una
14 Monroe Beardsley, “An Aesthetic Definition of Art” (1983), in H. Curtler (a cura di), What is Art?, Haven, New York 1983, p. 21.
8
definizione basata su concetti chiusi (come quello di esperienza o interesse estetici) i quali
fanno appello a proprietà manifeste dell’oggetto.
Di fronte alle difficoltà incontrate dalla teoria istituzionale ci sono stati però anche autori
che, piuttosto che tornare sui sentieri già battuti delle teorie estetiche, hanno cercato di
elaborare definizioni basate ancora su proprietà di tipo relazionale (come suggerito da
Mandelbaum e Danto). Affinché le suddette difficoltà fossero superate era necessario però
cambiare i termini delle relazioni essenziali. Ciò è quanto ha fatto Jerrold Levinson, il quale a
partire dalla fine degli anni Settanta si è impegnato nella messa a punto di una definizione in
cui l’opera d’arte fosse individuabile attraverso la relazione non già con una istituzione
sociale (il mondo dell’arte), quanto con la storia dell’arte passata e recente. Levinson sostiene
infatti che un oggetto è un’opera d’arte se è stato creato per essere percepito e valutato nello
stesso modo in cui precedenti e riconosciute opere d’arte sono state percepite e valutate. In
altre parole, ciò che è arte oggi non può prescindere da ciò che è stato considerato come arte
(nel passato), ma anzi è legato ad esso da una relazione di continuità che ne giustifica
l’attribuzione dello status di artisticità. La sua definizione, detta storico-intenzionale,
rappresenta una terza via, a metà tra le teorie istituzionali e quelle estetiche. Delle prime essa
riprende l’idea che l’arte debba essere definita attraverso il ricorso a proprietà relazionali; con
le seconde condivide l’attenzione per i modi appropriati di fruizione delle opere d’arte, che
sono più importanti delle procedure che attribuiscono loro un determinato status sociale. A
dire il vero Levinson non intende specificare quali siano tali modi appropriati, come fanno
invece Beardsley (il quale li identifica con l’interesse estetico) o i suoi predecessori (Bell e
Collingwood); pertanto la definizione storico-intenzionale pende maggiormente dalla parte
della teoria istituzionale che non verso le teorie estetiche. Ciò non toglie tuttavia che la
proposta di Levinson si differenzi in maniera significativa da quella di Dickie (e
indirettamente di Danto), e parte della differenza sta proprio nel recupero di un contatto con il
nostro concreto rapporto con la storia e con le opere (ovvero con qualcosa che l’occhio può
cogliere, a differenza di quanto sostenuto da Danto).
L’originalità e l’importanza della teoria di Levinson è confermata dal fatto che a partire da
essa sono state successivamente elaborate altre teorie definitorie basate sui medesimi concetti
di storicità e continuità dell’arte. Tali teorie (in special modo quella di Levinson) sono state
inserite in un fitto dibattito di obiezioni e contro-obiezioni tipico della tradizione analitica e
che testimonia di come l’interesse verso di esse sia stato consistente e duraturo. Ciò che
manca è forse una ricognizione del percorso compiuto da tali teorie, che ne metta a fuoco i
rapporti e le differenze con le altre teorie, i relativi pregi e difetti, e in ultimo le capacità
9
esplicative nei confronti della realtà artistica (passata e presente). L’intento del presente
lavoro di ricerca è quindi quello di percorrere fino in fondo la via aperta dalla teoria storico-
intenzionale, analizzandone i fondamenti teorici e tenendo conto anche delle diramazioni che
in tempi più recenti si sono formate a partire dalla direzione principale nonché degli ostacoli
disseminati lungo la via, con la speranza di raggiungere infine l’agognato traguardo di una
definizione coerente ed esaustiva dell’arte.
10
CAPITOLO PRIMO
Definire l’arte storicamente: la teoria di Jerrold Levinson
Jerrold Levinson affronta diffusamente la questione della definizione dell’arte
principalmente in quattro saggi: Defining Art Historically (1979), Refining Art Historically
(1989), Extending Art Historically (1993) e The Irreducible Historicality of the Concept of
Art (2002). Quest’ultimo è più che altro una difesa di quanto esposto nei precedenti articoli,
nei quali l’autore elabora una definizione detta storico-intenzionale dell’arte, formulandola in
maniera chiara e precisa, analizzando i termini che la costituiscono e approfondendo i concetti
filosofici implicati in essa. Inizierò quindi col ripercorrere l’esposizione e l’analisi
terminologica e concettuale della definizione di Levinson contenute nei suddetti articoli,
procedendo però per nuclei tematici anziché in ordine cronologico.
1.1 I fondamenti teorici della definizione storica dell’arte
La domanda su che cosa fa di un oggetto un’opera d’arte è, secondo Levinson, “la più
venerabile in estetica” 15. Tuttavia, come i neo-wittgensteiniani (Weitz, Ziff, Kennick) hanno
a più riprese sottolineato, le risposte che sono state finora fornite a tale domanda hanno tutte
fallito il loro obiettivo, in quanto hanno cercato di definire l’arte in termini di caratteristiche
intrinseche comuni alle opere d’arte, incorrendo alternativamente nelle accuse di “ristrettezza,
tendenziosità, inflessibilità, vaghezza o circolarità” 16. Le osservazioni critiche di Weitz e
compagni non hanno comunque impedito che si sviluppassero nuove definizioni dell’arte, ma
hanno comportato in queste un cambio di direzione: dalla ricerca di proprietà intrinseche e
oggettivamente osservabili si è passati all’identificazione dell’artisticità di un oggetto con il
suo “essere in relazione nel modo corretto con l’attività e il pensiero umani” 17.
15 Jerrold Levinson, “Defining Art Historically” (1979), ora in Id., Music, Art and Metaphysics, Cornell University Press, Ithaca (N.Y.) 1990, p. 3. Dove non è indicato il nome del traduttore, le traduzioni dei testi citati sono mie. 16 Ibid. 17 Ivi, p. 4.
11
La prima e principale teoria che ha compiuto tale inversione di tendenza è stata la teoria
istituzionale dell’arte, adombrata da Arthur Danto e sviluppata da George Dickie. Levinson
ravvisa due problemi fondamentali in questa teoria, che si aggiungono a quelli che abbiamo
sintetizzato nell’introduzione. Innanzitutto, essa considera l’arte esclusivamente nei termini di
un’attività “consapevole di se stessa”, “socialmente collocata” e “dichiarata”, in quanto
implica che il produrre opere d’arte debba necessariamente comprendere una cerimonia
sociale (il conferimento di status di candidato all’apprezzamento da parte del mondo
dell’arte), negando così ad una persona che agisca isolatamente e al di fuori di qualsiasi
contesto sociale la possibilità di essere un artista. Inoltre, la teoria istituzionale specifica solo
“il modo in cui un oggetto debba essere presentato o trattato affinché esso diventi un’opera
d’arte”, ma non ci dice nulla su “cosa l’artista debba prevedere che venga fatto col suo
prodotto da parte di potenziali spettatori”, ovvero non chiarisce in che modo l’artista richiede
che il suo oggetto venga considerato e apprezzato. La sfida consiste quindi, secondo
Levinson, nel trovare una definizione che, pur mantenendo il presupposto da cui muove la
teoria istituzionale, ovvero che le condizioni necessarie e sufficienti all’artisticità siano da
ricercare in proprietà relazionali anziché intrinseche, sappia risolvere i problemi in cui tale
teoria inevitabilmente incorre, ovvero sappia dar conto tanto della possibilità dell’esistenza di
un’arte isolata dalle pratiche e dalle istituzioni sociali, quanto dell’importanza dei modi di
considerare e di apprezzare l’opera richiesti dal suo autore, senza che vi sia con ciò bisogno di
fornire un elenco finito e qualificato di tali modi − questo tentativo, come è stato notato, è
destinato al fallimento, data “l’impossibilità di individuare una singola e unitaria attitudine o
modo di considerazione estetico comune a tutte le maniere in cui ci accostiamo alle opere
d’arte” 18.
“Il concetto di arte”, sostiene Levinson, “è diverso dal concetto di qualsiasi altro tipo di
oggetto che ci circonda (ad es. automobili, sedie, persone)”, in quanto esso non è definibile in
termini di “caratteristiche intrinseche, nemmeno flessibili” 19. Ciò è particolarmente evidente
se si riflette sulla varietà delle produzioni artistiche della seconda metà del Novecento: dopo
le esperienze dell’arte concettuale, del minimalismo e di performance di vario genere, si può a
ragione affermare che oggi “ogni cosa può essere arte” 20. Tuttavia, “questo non vuol dire che
oggi ogni cosa è arte” 21: è sempre possibile individuare un “qualcosa in comune” tra opere
(come le Demoiselles d’Avignon di Picasso, la sinfonia Eroica di Beethoven o le Odi di Saffo)
18 Ivi., pp. 5-6. 19 Ivi, p. 7. 20 J. Levinson, “Refining Art Historically” (1989), ora in Id., Music, Art and Metaphysics, cit., p. 41. 21 Ibid.
12
corrispondenti a concezioni artistiche distanti tra loro, e che ci permetta di tracciare una
distinzione tra ciò che è arte e ciò che non lo è 22. Questo minimo comun denominatore tra le
opere d’arte di epoche, stili e culture differenti è da rintracciare, secondo Levinson, nella
connessione con l’arte precedente: “l’arte nuova è arte in virtù della sua relazione con l’arte
del passato non troppo recente, e l’arte del passato non troppo recente è arte in virtù della sua
relazione con l’arte del passato più remoto” 23.
Di che tipo è tale relazione? Secondo Levinson la connessione con l’arte del passato può
essere determinata in tre modi: 1) “creando qualcosa che sia esteriormente simile alle opere
d’arte precedenti”; 2) “creando qualcosa che sia stato inteso per procurare lo stesso tipo di
piacere/esperienza che precedenti opere d’arte hanno procurato”; 3) “creando qualcosa che sia
stato inteso per essere considerato o trattato nel modo in cui sono state considerate o trattate
precedenti opere d’arte” 24. La prima opzione − corrispondente alla teoria delle somiglianze di
famiglia di Weitz − è palesemente inutilizzabile, dal momento che “ogni cosa potrebbe essere
esteriormente simile a qualche opera d’arte del passato sotto qualche aspetto” 25. La seconda
opzione è più promettente, ma anch’essa fallisce in quanto: a) i piaceri/esperienze derivati
dall’arte possono essere procurati anche attraverso esperienze non artistiche (in linea teorica,
il piacere/esperienza che proviamo ascoltando un quartetto di Beethoven potrebbe essere
uguale a quello che ci procura l’ingerimento di una determinata droga); b) ciò che
contraddistingue le opere d’arte è la maniera in cui queste producono i loro piaceri/esperienze,
ovvero le modalità di interazione tra la persona e l’opera. Tale opzione, nel porre l’accento
esclusivamente nel piacere/esperienza procurato dall’opera, evidenzia solo il carattere passivo
della ricezione, laddove è più corretto pensare che l’artista, nel proporre la sua opera a dei
potenziali spettatori, sia intenzionalmente orientato a stimolare una percezione attiva in essi26.
Non rimane quindi che la terza opzione: l’unica connessione possibile con l’arte del
passato è di tipo storico-intenzionale. Il contenuto dell’attuale concetto di arte è nient’altro
che “ciò che l’arte è stata”: pertanto, in una definizione dell’arte dovrà figurare “il corpo
dell’arte del passato” preso come base indiscutibile e “non-problematica” 27. Allo stesso
tempo, dato che l’ “invocazione intenzionale” (esplicita o implicita) all’arte del passato e ai
suoi modi di ricezione è sempre stata (da sola o accanto a caratteristiche funzionali o formali)
22 J. Levinson, “Extending Art Historically” (1993), ora in Id., The Pleasures of Aesthetics, Cornell University Press, Ithaca (N.Y.) 1996, p. 151. 23 J. Levinson, “Defining Art Historically”, cit., p. 6. 24 Ivi, pp. 7-8. 25 Ivi, p. 8. 26 Ibid. 27 Ivi, pp. 6-7.
13
un elemento essenziale dell’arte, dovrà anch’essa necessariamente figurare in una siffatta
definizione 28. Perciò, pur concordando con la teoria istituzionale sul fatto che la proprietà
essenziale dell’arte sia una proprietà relazionale non-esibita, Levinson si propone di cambiare
i termini di tale relazione: laddove quella parla di conferimento di status di candidato
all’apprezzamento all’interno di un contesto istituzionale costituito da più individui, egli pone
l’intenzione di un individuo socialmente indipendente; laddove Dickie fa dipendere tale
conferimento di status dall’esclusivo e oscuro mondo dell’arte, Levinson collega l’intenzione
individuale alla concreta ed evidente storia dell’arte 29.
1.2 La definizione storico-intenzionale di Levinson: prima, seconda e terza
versione
Date tali premesse, Levinson propone di definire l’arte nella seguente maniera:
X è un’opera d’arte se e solo se X è un oggetto che una o più persone, aventi il legittimo diritto di
proprietà su X, intendono fermamente che venga considerato-come-un’opera-d’arte, ovvero
considerato in un qualsiasi modo (o modi) in cui precedenti opere d’arte sono o sono state
correttamente (o uniformemente) considerate 30.
Alcuni termini della definizione richiedono un approfondimento. Innanzitutto, con
l’avverbio “fermamente” Levinson chiarisce che l’intenzione dell’autore dell’opera non può
essere accidentale o momentanea, bensì deve essere stabile e duratura. La condizione del
“diritto di proprietà” impedisce invece ai curatori e agli organizzatori di eventi artistici di
trasformare a loro piacimento oggetti qualsiasi in opere d’arte (il che è invece consentito agli
artisti, ovvero a coloro che operano, anche solo concettualmente, su materiali di loro
proprietà; che poi il risultato di tali operazioni sia classificabile come arte è un qualcosa che
va verificato facendo riferimento alle altre condizioni contenute nella definizione) 31.
28 J. Levinson, “Extending Art Historically”, cit., p. 151. 29 J. Levinson, “Defining Art Historically”, cit., p. 4. 30 Ivi, pp. 8-9. 31 Ivi, pp. 9-11. La condizione del diritto di proprietà segna una prima presa di distanza dalla teoria istituzionale (stando alla quale un gallerista, qualora scoprisse dei dipinti realizzati da una persona che opera al di fuori di qualsiasi cornice istituzionale e li esponesse in una galleria d’arte, con ciò li trasformerebbe in opere d’arte diventando egli stesso − il gallerista, non l’autore − un artista: vedi Dickie, Art and the Aesthetic, cit., pp. 45-6).
14
Il senso del verbo “considerare”, specifica Levinson, comprende anche i verbi “trattare”,
“recepire”, “valutare”, “avere a che fare con” e simili 32. L’avverbio “correttamente” non può
essere sostituito con le espressioni “comunemente” o “in modo soddisfacente”: se così fosse,
infatti, nell’ipotetico caso in cui si scoprisse che alcuni ritratti del Rinascimento possono
efficacemente essere usati come isolatori termici e tale uso si diffondesse, dalla definizione
seguirebbe che qualsiasi oggetto successivamente prodotto che sia stato inteso per essere
usato come isolatore termico sarebbe un’opera d’arte, il che è palesemente assurdo 33. Alcuni
esempi di modi di considerare correttamente un’opera d’arte sono il prestare “attenzione alla
forma”, l’avere “apertura emotiva”, l’essere consapevoli dei significati simbolici 34. Levinson
aggiunge che i modi di considerazione menzionati nella sua definizione devono essere,
oltreché corretti, anche “integrali”, ovvero devono essere insiemi relativamente completi di
tali modi, e non modi singoli e isolati: altrimenti, infatti, perfino dei segnali stradali
potrebbero diventare delle opere d’arte, dal momento che sono stati intesi (anche) per essere
considerati in una delle maniere (come l’attenzione al colore) in cui precedenti opere d’arte
(ad esempio i dipinti impressionisti) sono state correttamente considerate. Data tale
precisazione, appare chiaro che i segnali stradali non possono essere opere d’arte, in quanto
l’attenzione al colore è solo uno dei modi di considerazione che nell’insieme costituiscono un
approccio corretto e adeguato ad un’opera d’arte − in riferimento alle opere pittoriche, tale
insieme dovrebbe comprendere anche l’attenzione ai dettagli, la consapevolezza del
background artistico e culturale, la conoscenza dello stile, la sensibilità alla struttura formale
e all’effetto espressivo, la percezione degli aspetti rappresentativi 35.
Con l’espressione “intendere che” Levinson dichiara di indicare l’atto di “fare, adattare o
concepire allo scopo di”, giustificando in tal modo l’esistenza di molta arte concettuale 36.
L’inclusione dell’intenzione come condizione necessaria in una definizione dell’arte spiega il
motivo per cui “nell’arte ogni cosa passa, ma non ogni cosa assolve la sua funzione” 37 e
32 J. Levinson, “Extending Art Historically”, cit., p. 151. 33 J. Levinson, “Defining Art Historically”, cit., p. 9. 34 J. Levinson, “Refining Art Historically”, cit., p. 39. 35 Ivi, pp. 44-5. 36 J. Levinson, “Defining Art Historically”, cit., p. 9. 37 Ivi, p. 24. Il testo originale è “in art anything goes, but not everything works”. Non è facile tradurre esattamente il termine “works”. Ho optato per un’espressione che collegasse il valore dell’opera (perché è di questo che implicitamente si parla) alla sua capacità di assolvere una specifica funzione (identificata per lo più con la produzione di un’esperienza estetica soddisfacente), come vogliono le teorie funzionali dell’arte, le quali considerano tale assolvimento come una condizione necessaria dell’artisticità di un oggetto. D’altronde, come è stato sottolineato a più riprese da Stephen Davies, tale concezione del valore artistico non è proprio solamente delle definizioni valutative come quelle funzionali (ad esempio Beardsley), ma è condiviso anche da definizioni descrittive (che non includono cioè considerazioni di merito tra le condizioni necessarie e sufficienti
15
chiarisce il carattere descrittivo, ovvero puramente classificatorio e non valutativo, della
definizione storica. Difatti, se da un lato non ci sono limiti riguardo al tipo di oggetto sul
quale una persona possa indirizzare un’intenzione artistica, dall’altro lato l’intenzione non
basta a garantire che tale oggetto si integri nella maniera desiderata con i modi di
considerazione relativi ad opere precedenti alle quali esso rimanda: l’interazione tra le
caratteristiche del presente oggetto e i modi di considerazione propri dell’arte del passato che
sono stati intenzionalmente invocati “talvolta soddisfa immediatamente, talvolta solo dopo un
intervallo. Talvolta siamo scioccati e sconvolti, ma quando ci riprendiamo siamo illuminati.
Talvolta siamo spinti con forza ad adottare nuovi modi di considerazione, e a lasciarci dietro
quelli vecchi. Ma talvolta siamo semplicemente confusi, annoiati, irrimediabilmente
infastiditi. In questi casi abbiamo sì delle opere d’arte, ma queste opere d’arte non operano
come tali” 38.
Vi sono, secondo Levinson, tre tipi di intenzioni che possono realizzare la condizione
(intendere che venga considerato-come-un’opera-d’arte) espressa nella definizione. Il primo
tipo equivale all’intendere consapevolmente che qualcosa venga considerato nello specifico
modo (o modi) in cui alcune determinate opere (o classi di opere) d’arte sono state
correttamente considerate (“specific art-conscious intention”); il secondo tipo equivale
all’intendere consapevolmente che qualcosa venga considerato in uno (o più) qualunque dei
modi in cui una qualsiasi delle opere d’arte del passato è stata correttamente considerata
(“non-specific art-conscious intention”); il terzo tipo equivale all’intendere che qualcosa
venga considerato in uno specifico e particolare modo caratterizzato in termini di proprietà
intrinseche, laddove tale modo risulta in effetti essere uno dei modi in cui alcune opere d’arte
del passato sono state correttamente considerate, sebbene tale coincidenza si verifichi
all’insaputa di chi ha avuto quell’intenzione (“art-unconscious intention”) 39. Quest’ultimo
tipo, che corrisponde ad una interpretazione “trasparente” della nozione di intenzione,
concede la possibilità di essere artisti anche a persone totalmente ignoranti tanto della storia
delle opere d’arte quanto dei movimenti e delle istituzioni artistiche; i primi due tipi sono
accomunati invece in una interpretazione “opaca” della nozione di intenzione 40. Nel caso
dell’interpretazione trasparente, la persona che si rivolge intenzionalmente a un determinato
all’artisticità) come quelle di Dickie e di Levinson ( Stephen Davies, Definitions of Art, Cornell University Press, Ithaca (N.Y.) 1991). 38 J. Levinson, “Defining Art Historically”, cit., pp. 24-25. In questo caso ho preferito tradurre work con operare, allo scopo di rendere il gioco di parole espresso nel testo originale (“in such cases we have artworks, but such works don’t work”). 39 Ivi, p. 11. 40 Ibid.
16
insieme di modi di considerazione senza avere in mente nessuna particolare opera o genere o
movimento artistico, è un artista se tali modi di considerazione si rivelano nei fatti essere gli
stessi modi in cui opere d’arte del passato sono state correttamente considerate: le intenzioni
sono allora dette “intrinseche” 41. Nel caso dell’interpretazione opaca, una persona realizza
un’opera d’arte in quanto si riferisce intenzionalmente ai modi di considerazione relativi a
determinate opere d’arte passate, senza necessariamente specificare tali modi: le intenzioni
sono qui dette “relazionali” 42. Statisticamente parlando, aggiunge Levinson, le intenzioni
intrinseche rappresentano l’eccezione (si pensi ai casi dei pittori naïf, come Henri Rousseau),
mentre per lo più abbiamo a che fare con intenzioni relazionali, in special modo nell’arte
moderna e contemporanea, la quale è profondamente riflessiva e auto-referenziale. Inoltre,
spesso i due tipi di intenzione coesistono: in tal caso, ciò che garantisce all’oggetto la sua
artisticità è l’intenzione relazionale, la quale risulta quindi prevalente su quella intrinseca.
Per chi vede le intenzioni come entità psichiche inafferrabili, una definizione intenzionale
dell’arte può apparire problematica. Tuttavia, secondo Levinson è sempre possibile ricostruire
− sulla base delle caratteristiche esteriori dell’oggetto, del suo contesto di produzione, del
genere a cui appartiene, delle dichiarazioni (sia private che pubbliche) dell’artista, dell’intero
corpus delle opere dell’artista, ecc. − le intenzioni che governano un determinato oggetto e
stabilire se esse sono o meno delle intenzioni artistiche 43. In realtà, anche quando decidiamo
che qualcosa è un’opera d’arte in virtù di determinate somiglianze esteriori e manifeste con
opere d’arte riconosciute del passato operiamo con una nozione intenzionale di arte, in quanto
da queste somiglianze e dalla considerazione del contesto sociale e culturale in cui esse si
presentano inferiamo l’intenzione, da parte dell’autore dell’opera in questione, che la sua
opera venga considerata nello stesso modo in cui tali opere d’arte del passato sono state
correttamente considerate 44. Pertanto, si può formulare il seguente test di artisticità: se il
presunto artista non ammette di avere l’intenzione che la propria opera venga considerata
nello stesso modo in cui precedenti opere d’arte sono state correttamente considerate, e se noi,
in quanto spettatori ai quali l’artista si rivolge, non rintracciamo alcuna base per attribuire
all’autore una siffatta intenzione, allora egli non ha prodotto un’opera d’arte; se invece il
presunto artista non dichiara in alcun modo di fare arte, ma ciononostante intende, in modo
41 J. Levinson, “Refining Art Historically”, cit., pp. 39-40. 42 Ibid. L’intenzione relazionale contempla, come abbiamo visto poc’anzi, anche il caso in cui nemmeno le opere siano specificate: l’importante è che vi sia comunque una consapevolezza dell’autore dell’opera riguardo al fatto che questa sia posta in relazione con opere o modi (non specificati) riconosciuti come paradigmatici per l’arte del passato. 43 Ivi, p. 43. 44 J. Levinson, “Extending Art Historically”, cit., pp. 167-8.
17
opaco o trasparente, che un determinato oggetto venga considerato nella maniera in cui
precedenti opere d’arte sono state considerate, allora egli sta sicuramente creando un’opera
d’arte 45.
Esattamente dieci anni dopo la prima formulazione della definizione storico-intenzionale
dell’arte, Levinson ne elabora una seconda versione, nella quale si fa esplicito riferimento alla
dimensione temporale del concetto di arte:
X è un’opera d’arte al momento t se e solo se X è un oggetto di cui è vero al momento t che una o
più persone, aventi il legittimo diritto di proprietà su X, intendono fermamente che X venga
considerato-come-un’opera-d’arte − ovvero, considerato in uno (o più) qualsiasi dei modi in cui opere
d’arte esistenti in un momento precedente t sono o sono state correttamente (o uniformemente)
considerate 46.
Questa nuova versione permette a Levinson di dar conto di due situazioni altrimenti
difficilmente giustificabili. Innanzitutto, essa concede che un oggetto, pur non essendo
un’opera d’arte al momento della sua creazione fisica, possa diventarlo in un momento
successivo, in virtù del sopraggiungere di un’intenzione artistica che ne modifichi lo statuto
ontologico: è il caso dei ready-made di Duchamp, i quali, come dice la parola stessa, sono
oggetti ‘già fatti’, cioè sono stati materialmente prodotti molto tempo prima del
raggiungimento del loro status artistico − quest’ultimo essendo dovuto all’intenzione che
Duchamp proietta su tali oggetti e che è testimoniata dall’averli esposti in rassegne artistiche.
Inoltre, la seconda versione della definizione storica dell’arte comprende anche il caso,
peraltro abbastanza raro, in cui una persona, nel creare un oggetto Z al momento t, intende
fermamente che Z venga considerato in un modo di considerazione non ancora disponibile, in
quanto non riconosciuto durante il percorso che la storia dell’arte ha compiuto fino a t;
secondo la nuova versione della definizione, Z, pur non essendo un’opera d’arte al momento
t, può diventare un’opera d’arte in un momento t2 successivo a t se al momento t2 si verifica
che i modi di considerazione richiesti per Z dal suo creatore sono entrati a far parte della
tradizione artistica. Ovviamente, prima del sopraggiungere del momento t2 non si può dire
nulla circa l’artisticità di Z: difatti, un oggetto non può essere dichiarato un’opera d’arte
45 J. Levinson, “Refining Art Historically”, cit., pp. 58-9. 46 J. Levinson, “Defining Art Historically”, cit., p. 12.
18
“semplicemente in virtù della sua futura redenzione da parte dell’evoluzione dell’arte − solo
l’attuale redenzione invertirà la rotta” 47.
Alcuni potrebbero pensare, osserva Levinson, che la definizione da lui fornita sia circolare,
in quanto definisce l’arte in termini di arte. Tuttavia, ad un attento esame tale accusa risulta
essere infondata: infatti è la realtà stessa dell’arte a dimostrarci che, fino a quando non siamo
sicuri su quali oggetti precedenti un dato momento t siano opere d’arte, non siamo nemmeno
in grado di dire quali oggetti siano opere d’arte al momento t. Ma soprattutto, la definizione
non è circolare in quanto ci dice che cosa significhi oggi essere un’opera d’arte ad un dato
momento t, non sulla base di cosa significasse essere un’opera d’arte in un momento t’
precedente t, bensì solo sulla base dell’estensione dell’arte precedente il momento t − la
definizione, in sostanza, ha bisogno solo che vi sia una base garantita di oggetti che siano
incontestabilmente opere d’arte in un momento t’ precedente t, indipendentemente dal
significato del termine ‘arte’ in t’ 48. Lo scopo di Levinson è di chiarire “quale sia il concetto
di arte nel presente − ovvero, cosa significhi oggi, per un oggetto creato in un qualsiasi
momento (passato, presente o futuro), contare come arte in quel momento, anziché cosa ciò
significasse al momento della creazione dell’oggetto” 49. Egli può quindi spiegare, attraverso
la sua teoria, che cosa significhi oggi, per un oggetto creato nel 1777, essere un’opera d’arte
in quel dato momento, mantenendo che l’attuale concetto di arte sia diverso dal concetto di
arte che si aveva nel 1777 − sebbene la differenza tra i due non sia poi così grande, se si
eccettuano i cambiamenti apportati dal movimento dadaista 50. Le precedenti osservazioni
sono sintetizzate nella terza versione della definizione storico-intenzionale:
X è un opera d’arte al momento t se e solo se X è un oggetto di cui è vero al momento t che una o
più persone, aventi il legittimo diritto di proprietà su X, intendono (o hanno inteso) fermamente che X
venga (o venisse) considerato-come-un’opera-d’arte − ovvero, considerato in uno (o più) qualsiasi dei
modi in cui gli oggetti nell’estensione del termine ‘opera d’arte’ precedente t sono o sono stati
correttamente (o uniformemente) considerati 51.
47 Ivi, p. 13. 48 Ivi, pp. 14-5. 49 Ivi, p. 23. 50 Ivi, pp. 23-4. 51 Ivi, p. 15.
19
1.3 Storicità e continuità dell’arte
Levinson descrive la propria teoria come a) intenzionalista − in quanto afferma che un
determinato orientamento intenzionale da parte di un soggetto nei confronti dei prodotti della
sua attività è una conditio sine qua non dell’artisticità; b) storicista − poiché la produzione
artistica corrispondente ad un determinato momento viene fatta logicamente dipendere da un
operare artistico ad essa precedente; c) indicista (“indexicalist”) − limitatamente alle
intenzioni di tipo relazionale, le quali indicano semplicemente il riferimento ad alcune opere
del passato, senza dover specificare i modi di considerazione a queste appropriati; d) non-
istituzionale − poiché, pur riconoscendo che l’arte non può esistere senza la presenza di un
qualche contesto, tale contesto viene identificato non tanto con un’istituzione sociale (come il
mondo dell’arte di Danto e Dickie) quanto con la concreta storia dell’arte 52. Riguardo a
quest’ultimo punto, Levinson evidenzia due ulteriori elementi che distinguono la sua teoria da
quella istituzionale: 1) mentre per quest’ultima l’elemento essenziale dell’arte è il
conferimento esterno di status di candidato all’apprezzamento ad un artefatto, per Levinson
tale conferimento è la conseguenza di un’intenzione interna alla volontà dell’artista; 2) mentre
per Danto e Dickie lo status di candidato all’apprezzamento può essere conferito ad un
artefatto solo da artisti professionisti e socialmente riconosciuti, secondo Levinson la
posizione sociale aiuta il lavoro di un artista, ma non lo esaurisce e non ne è una condizione
necessaria 53.
Riguardo al punto b), Levinson aggiunge che la sua teoria non ha nulla a che fare con la
nozione di storicismo esterno, il quale identifica una determinata categoria culturale in base a
delle caratteristiche esteriori e osservabili che si evolvono nel tempo e che legano insieme
diversi fenomeni: sotto questo aspetto, l’arte non è diversa dalle altre attività culturali,
essendo anch’essa caratterizzata da proprietà caratteristiche (per lo più di tipo funzionale e
formale) che si sono modificate e succedute (alcune sono anche scomparse) col passare degli
anni. Piuttosto, ciò che contraddistingue l’arte dalle altre attività culturali e in generale umane,
è il fatto che essa è definibile solo attraverso il concetto di storicismo interno: l’unico
elemento che accomuna l’arte di tutti i tempi è il riferimento intenzionale, interno al concetto
stesso di arte, alle opere/attività/correnti artistiche precedenti. Levinson distingue tuttavia lo
storicismo interno che è alla base della propria definizione dell’arte dalle seguenti forme di
storicismo (sostenute da vari autori), dalle quali egli prende esplicitamente le distanze: 1) 52 J. Levinson, “Refining Art Historically”, cit., pp. 40-1. 53 J. Levinson, “Defining Art Historically”, cit., pp. 21-3.
20
l’idea che lo status artistico di un oggetto possa subire grandi variazioni nel corso del tempo;
2) l’idea che il contenuto/significato di una determinata opera d’arte, essendo influenzato da
elementi storico-contestuali, possa espandersi e modificarsi nel tempo; 3) l’idea che una
nostra nuova interpretazione o costruzione teorica possa cambiare la storia dell’arte, per come
è stata fino ad oggi tramandata 54. Alla possibile obiezione che anche altre attività umane,
come la filosofia o la scienza, sono definite dalla stessa nozione di storicismo interno,
Levinson ribatte che tali attività sono sì caratterizzabili in tali termini, ma solo in parte, poiché
esse possiedono anche delle caratteristiche intrinseche e funzionali (come la coerenza logica o
la conferma sperimentale) che contribuiscono alla loro definizione; viceversa, l’arte è
definibile esclusivamente nei termini di un’attività storicamente − e intenzionalmente −
costituita 55.
La definizione di Levinson presuppone che l’evoluzione artistica sia determinata da un
parziale ma continuo cambiamento dei modi di considerare l’arte: ogni opera d’arte originale
produce una più o meno sensibile differenza nei modi di considerazione che sono stati desunti
dall’arte del passato, fino talvolta a introdurre dei nuovi modi di considerazione che entrano a
far parte della tradizione artistica e ai quali future opere d’arte faranno riferimento. Vi è
pertanto una profonda continuità nello sviluppo dell’arte, in quanto le opere d’arte di un
determinato periodo, oltreché semplicemente seguire o essere causalmente derivate − in virtù
di influenze stilistiche, formali, semantiche, ecc. − dalle opere precedenti, sono
concettualmente dipendenti da queste − in quanto le opere d’arte del presente devono il loro
statuto artistico all’essere intenzionalmente collegate all’arte del passato 56.
Un siffatto modello di evoluzione artistica, per quanto preveda al suo interno l’esistenza di
opere originali − tra le quali Levinson include anche la maggior parte delle opere realizzate
dai movimenti d’avanguardia del primo Novecento, dato che questi modificano solo alcuni (e
solo in parte) dei modi di considerazione relativi all’arte del passato − sembra poter essere
messo in crisi dalle cosiddette opere rivoluzionarie − le quali richiedono, per volontà degli
stessi artisti che le hanno prodotte, dei modi di considerazione totalmente inediti e che nulla
hanno a che fare con i tradizionali e riconosciuti modi di considerare l’arte del passato 57.
Secondo Levinson è tuttavia possibile leggere anche l’arte rivoluzionaria − che si identifica
soprattutto col movimento Dada e con tutto ciò che ne è seguito − come necessariamente e
intenzionalmente collegata all’arte del passato e ai relativi modi di considerazione. Egli
54 J. Levinson, “Extending Art Historically”, cit., pp. 151-3. 55 Ivi, pp. 154-5. 56 J. Levinson, “Defining Art Historically”, cit., 17-8. 57 Ivi, pp. 15-6.
21
suggerisce a tal proposito di seguire una di queste due strategie: 1) la richiesta di modi di
considerazione radicalmente nuovi può essere interpretata come il risultato dell’inadeguatezza
dei modi di considerazione ereditati dall’arte del passato ad adattarsi alle esigenze e alle
caratteristiche delle opere rivoluzionarie; pertanto, sebbene vi sia l’intenzione, da parte degli
artisti rivoluzionari, di riferire le loro opere a dei modi di considerazione nuovi e senza
precedenti, tale intenzione risulta essere una conseguenza tanto della loro primaria intenzione
di considerare le loro opere negli stessi modi in cui precedenti opere d’arte sono state
correttamente considerate, quanto del fallimento di tale intenzione primaria; 2) il concetto di
“considerare-come-un’opera-d’arte” può essere “liberalizzato” fino a comprendere, oltre ai
modi di considerare correttamente l’arte del passato, anche dei modi di considerazione a
questi diametralmente opposti, ma comunque ad essi legati in virtù della relazione di
contrarietà 58.
1.4 I problemi di una definizione storico-intenzionale
Uno dei principali problemi per una definizione storica dell’arte è che, poiché questa
stabilisce che cosa è arte al momento t in base al riferimento intenzionale a che cosa è stato
riconosciuto come arte in un momento t1 precedente t, procedendo a ritroso si arriva al
momento iniziale t0 corrispondente alle origini dell’arte stessa − ovvero a quelle che Levinson
chiama le “ur-arts” della nostra tradizione − le quali non possono essere definite in base al
modello fin qui analizzato, dato che nel loro caso non vi sono opere d’arte precedenti a cui
fare riferimento 59. Pertanto, per stabilire lo status di arte di tali oggetti abbiamo bisogno,
come lo stesso Levinson ammette, di una definizione alternativa a quella da lui fornita.
Tuttavia, tale definizione non richiede l’individuazione di determinate caratteristiche
funzionali o intrinseche, come taluni vorrebbero, ma è anch’essa formulabile nei termini di un
riferimento storico − sebbene non intenzionale − ad altre opere d’arte − nel caso specifico,
alle opere seguenti, anziché precedenti. Per accomodare l’esistenza delle ur-arts Levinson
elabora una versione alternativa della propria definizione, che egli chiama “ricorsiva”:
58 Ivi, pp. 16-7. 59 Ivi, p. 18.
22
Passo iniziale: gli oggetti delle ur-arts sono opere d’arte al momento t0 (e dopo). Passo ricorsivo:
se X è un’opera d’arte precedente il momento t, allora Y è un’opera d’arte al momento t se è vero al
momento t che una o più persone, aventi il legittimo diritto di proprietà su Y, intendono (o hanno
inteso) fermamente che Y venga (o venisse) considerato in uno (o più) qualsiasi dei modi in cui X è o
è stato correttamente considerato 60.
Secondo Levinson, una tradizione artistica nasce quando determinate attività umane
producono i loro oggetti riferendoli intenzionalmente ai modi di considerazione propri di
alcuni oggetti già esistenti (ur-arts), i quali sono stati prodotti senza far riferimento alcuno ad
attività precedenti 61. Gli oggetti delle ur-arts sono quindi arte in un senso diverso da quello in
cui lo sono gli oggetti della tradizione artistica che si è sviluppata in seguito al riferimento
intenzionale ai modi di considerazione relativi alle ur-arts stesse: essi (gli oggetti delle ur-
arts) “sono arte non in quanto modellati sull’arte precedente, ma piuttosto poiché l’arte che si
è affermata in seguito si è sviluppata a partire da essi” 62.
La definizione ricorsiva può apparire incompleta, in quanto non ci dice esattamente quali
oggetti costituiscano le ur-arts. In effetti, l’identificazione delle ur-arts sembra un’operazione
assai ardua, ma non è, in linea teorica, impossibile: se si sceglie un vasto campo di opere
d’arte recenti e paradigmatiche, suddivise in insiemi costituiti sulla base di affinità interne, e
se si ricostruisce a ritroso − rintracciando le influenze stilistiche, semantiche e storiche, dalle
quali sia possibile inferire un riferimento intenzionale delle opere più recenti ad opere del
passato − l’evoluzione artistica che ha portato a tali insiemi di opere, è possibile approdare ad
un nucleo di oggetti che sono situate alle origini dell’arte occidentale. Arrivati a questo punto
è lecito, secondo Levinson, specificare, all’interno della definizione ricorsiva, l’espressione
ur-arts nei termini delle caratteristiche intrinseche comuni alle opere originarie che sono state
rinvenute attraverso un’ “investigazione archeologica” del tipo appena delineato. Ad ogni
modo è importante notare che la definizione ricorsiva non serve a chiarire il nostro concetto di
arte: essa piuttosto rivela − attraverso un metodo che “illumina il reale processo storico
dell’evoluzione artistica” − l’estensione del termine ‘arte’, da cui la definizione storico-
intenzionale − la quale, sola, è in grado di catturare il nostro concetto di arte e, insieme, il
significato del termine ‘opera d’arte’ − prende le mosse 63.
60 Ivi, pp. 18-9. 61 Ibid. 62 J. Levinson, “Extending Art Historically”, cit., p. 169. 63 J. Levinson, “Definig Art Historically”, cit., pp. 19-21. La distanza tra i due tipi di definizioni non è in realtà così grande: come si può facilmente vedere, la differenza principale sta nel fatto che nella definizione storico-intenzionale non si fa riferimento alle prime opere d’arte. Per il resto, esse sono alquanto simili, e si può parlare
23
Levinson aggiunge che, dato che le ur-arts sono arte in un senso diverso − in quanto
definite in modo diverso − da quello in cui lo sono le opere d’arte successive, lo statuto delle
“prime opere d’arte” − ovvero le prime opere d’arte ad essere state prodotte in virtù di un
riferimento intenzionale ad opere precedenti − è a sua volta differente tanto da quello delle ur-
arts quanto da quello delle opere successive. Le cosiddette first-arts, infatti, pur essendo
definite dal metodo storico-intenzionale, sono state intenzionalmente collegate non a
precedenti opere d’arte definite dallo stesso metodo, bensì alle ur-arts, le quali, si è visto,
sono definite dal metodo ricorsivo: pertanto, le prime opere d’arte “sono arte in un senso
vicino ma non identico a quello che si applica a tutte le opere successivamente classificabili
come arte” 64.
A questo punto è lecito porsi la seguente domanda: qual è, o meglio, “di chi è”, il concetto
di arte che si è cercato di descrivere nella definizione storico-intenzionale fin qui analizzata?
Levinson risponde che si tratta, “abbastanza naturalmente, del nostro concetto”, ovvero del
concetto di arte alta (o colta) che si è sviluppato in Occidente a partire dal Rinascimento 65.
Ciò pone in linea di principio due ulteriori problemi alla definizione storico-intenzionale:
come può essa comprendere le arti di culture geograficamente e temporalmente distanti da
quella occidentale e post-rinascimentale? E in che modo dobbiamo considerare le forme
d’arte ‘basse’ (o extra-colte) come l’arte popolare, l’arte commerciale e le creazioni
artigianali? Alla prima questione Levinson risponde che la definizione da lui fornita è in
grado di giustificare e comprendere anche le arti provenienti da culture a noi lontane, a patto
però di valutare in che modo ed entro quale estensione il nostro concetto di arte,
preliminarmente ed attentamente esaminato, possa accordarsi con − e magari illuminare − gli
elementi che definiscono l’arte nelle altre culture: in breve, “se un’altra cultura ha l’arte, deve
averla nel nostro senso, più o meno” 66.
Riguardo alla seconda questione, Levinson propone due possibili soluzioni. La prima
consiste nel concedere lo status di arte ai prodotti artigianali, popolari, commerciali o simili
solo nel caso in cui questi siano stati intenzionalmente collegati (dai loro legittimi proprietari,
ovvero perlopiù dai loro autori) ad almeno una parte dell’insieme totale dei modi di
considerazione propri dell’arte colta occidentale. D’altronde, quando si deve decidere
della definizione storico-intenzionale anche come di definizione ricorsiva (in quanto lega il presente concetto di arte al passato della storia dell’arte); ciò è quanto faremo nel corso del lavoro, dove la definizione di Levinson sarà alternativamente chiamata ‘storico-intenzionale’ o ‘ricorsiva’ (termine, quest’ultimo, che in matematica definisce quella successione di funzioni in cui ciascuna funzione è ricavata dalla precedente). 64 J. Levinson, “Extending Art Historically”, cit., p. 169. 65 Ivi, pp. 153-4. 66 Ibid.
24
dell’artisticità di un oggetto non si tratta di scegliere tra “tutto-o-niente” 67, e un oggetto di
artigianato può essere legittimamente considerato un’opera d’arte se, oltre ad essere
funzionale allo scopo per il quale è stato progettato, esso esibisce anche proprietà come la
ricerca formale o la cura del dettaglio, le quali evidenziano l’esistenza di un riferimento
intenzionale ad alcuni dei modi di considerazione propri dell’arte alta. La seconda soluzione
consiste invece nel concedere lo status di arte ai prodotti artigianali, commerciali o popolari
se essi esibiscono la stessa struttura di riferimento intenzionale che si è visto
contraddistinguere la tradizione artistica occidentale; in tal senso, tali prodotti sono artistici se
sono intenzionalmente connessi ad alcuni dei modi di considerazione propri di precedenti
prodotti dello stesso genere (ovvero artigianale, commerciale o popolare) 68.
67 “arthood is not an all-or-nothing thing” (Ivi, p. 170). 68 Ibid., pp. 170-1.
25
CAPITOLO SECONDO
Obiezioni e repliche
Nel primo capitolo ho cercato di ricostruire nel modo più dettagliato possibile la genesi
della definizione storica dell’arte di Jerrold Levinson, per come è stata esposta dallo stesso
autore nei tre saggi ad essa specificatamente dedicati, ovvero Defining Art Historically,
Refining Art Historically e Extending Art Historically. Nel far ciò ho individuato dei concetti
guida ai quali ho ricondotto diversi passi ripresi dai tre articoli; da tale sorta di vivisezione
sono però rimasti fuori due ulteriori elementi di discussione, che saranno l’oggetto del
presente capitolo e del prossimo. Il primo di tali elementi è costituito dalle obiezioni rivolte
alla teoria di Levinson e dalle repliche da questi elaborate. Infatti negli articoli citati
Levinson, oltre a delineare la sua definizione, risponde alle critiche che potenzialmente
potrebbero essere rivolte ad essa nonché a quelle realmente avanzate da altri autori di ambito
analitico. A queste ultime Levinson fornisce delle repliche sia nel secondo e nel terzo degli
articoli citati, sia in vari articoli pubblicati perlopiù negli anni Novanta. Inoltre egli nel 2002
ha scritto un articolo intitolato The Irreducible Historicality of the Concept of Art, nel quale
sintetizza e coordina una larga parte dell’insieme di obiezioni e di repliche che circonda la sua
teoria, seguendo uno schema che verrà in parte ripreso più avanti. Il secondo elemento di
discussione lasciato fuori dal primo capitolo riguarda invece la differenza tra la definizione
storica dell’arte di Levinson e le definizioni storiche proposte da altri filosofi americani
contemporanei (ovvero Noel Carroll, James Carney e Robert Stecker), dalle quali Levinson
prende esplicitamente le distanze in Extending Art Historically e che sarà oggetto di
discussione nel prossimo capitolo.
Tornando all’oggetto del presente capitolo, ovvero al problema delle critiche rivolte alla
definizione storica dell’arte di Levinson e alle risposte da questi fornite, è doveroso fare un
breve preambolo prima di addentrarci in un’analisi dettagliata delle diverse posizioni. In una
recente introduzione all’estetica analitica, Simona Chiodo ha sottolineato come la moltitudine
e la diversità delle voci che si esprimono nei vari articoli e saggi scritti dai filosofi di matrice
analitica (prevalentemente anglosassoni) costituiscano tanto una ricchezza − poiché alla
quantità numerica corrisponde una pluralità di punti di vista, dotati ciascuno di una
indiscutibile qualità argomentativa − quanto un difetto − individuabile nella mancanza di un
riferimento storico e genetico che sappia ricondurre ad unità questa moltitudine altrimenti
26
dispersiva di posizioni differenti 69. In effetti quanto rivelato dalla Chiodo corrisponde
esattamente all’effetto che una visione panoramica del dibattito analitico relativo a problemi
di natura estetica produce: si assiste a un continuo proporre nuove teorie, criticare le stesse,
rispondere alle critiche e correre eventualmente al riparo. La prassi che viene di volta in volta
seguita è più o meno la stessa: ogni nuova teoria proposta da un dato autore viene sottoposta
ad un’attenta e scrupolosa analisi da parte degli studiosi e dei sostenitori di teorie concorrenti,
e da tale analisi risulta spesso una serie di obiezioni e di critiche con le quali il sostenitore
della teoria in questione deve fare i conti.
Se tutto ciò può sembrare senza dubbio dispersivo, dato che non è affatto facile ricondurre
ad unità i vari interventi − costituiti principalmente da saggi di lunghezza relativamente breve
che vengono pubblicati nelle più importanti riviste di estetica analitica, tra cui occupano un
posto privilegiato il Journal of Aesthetics and Art Criticism e il British Journal of Aesthetics −
incentrati su un dato problema, si può allo stesso tempo vedere in questo procedimento una
ricchezza costruttiva. L’estetica analitica può infatti essere letta come una sorta di grande
sforzo collettivo − il che corrisponde peraltro all’idea di filosofia che aveva un importante
storico delle idee come Wladimir Tatarkiewicz − all’interno del quale i diversi autori,
nell’ordine: analizzano le teorie più importanti concernenti un preciso problema di natura
estetica; esaminano i pregi e i difetti di ciascuna teoria; elaborano una propria teoria in merito
al problema trattato; prendono in considerazione le critiche che vengono loro indirizzate dai
sostenitori delle teorie rivali; reagiscono a tali critiche elaborando delle contro-obiezioni o
modificando la propria teoria sulla scia delle indicazioni contenute in alcune delle critiche
ricevute. La definizione storica dell’arte proposta da Levinson non fa eccezione a tale
procedimento: il compito dei primi due capitoli della presente ricerca è proprio quello di
mostrare come tale definizione emerga da un intenso dibattito relativo al problema della
definizione dell’arte, si proponga come seria alternativa alle teorie che la precedono e si
confronti con queste attraverso un fitto dialogo di obiezioni e repliche.
In questo capitolo mi propongo quindi di ricostruire il dibattito di obiezioni e repliche che
ha circondato e che circonda tuttora la definizione storica dell’arte di Jerrold Levinson in tutta
la sua ampiezza di significati vicendevolmente connessi e di ricondurlo ad un insieme
coerente e ordinato. Ad agevolare questo compito, insieme logico e cronologico, provvederà
lo stesso Levinson, il quale, come già detto in precedenza, in The Irreducible Historicality of
the Concept of Art sente la necessità di fare il punto della situazione relativamente alla
69 Simona Chiodo (a cura di), Che Cosa è Arte: la filosofia analitica e l’estetica, Introduzione, UTET, Torino 2007.
27
ricezione che la sua teoria ha avuto a partire dal 1979 (anno di pubblicazione di Defining Art
Historically), prestando particolare attenzione alle diverse tipologie di critiche che da più parti
e a più riprese gli sono state rivolte. Il modo in cui procederò è però diverso da quello seguito
da Levinson nel suddetto articolo. Infatti, piuttosto che seguire un ordine convenzionale −
determinato dalla sequenza cronologica delle obiezioni oppure dall’elenco degli autori di tali
obiezioni − o un ordine concettuale − dato dai principali nuclei tematici ai quali le diverse
critiche possono essere ricondotte − tenterò una terza via, la cui direzione verrà stabilita sulla
base del diverso grado di efficacia delle risposte elaborate da Levinson per ripararsi dalle
critiche di cui la sua teoria è stata oggetto.
L’ordine che seguirò partirà allora dalle risposte di Levinson che a me sembrano più
convincenti; proseguirà attraverso quelle incerte, che lasciano dietro di loro qualche dubbio
residuo; approderà alle repliche a mio avviso più deboli (o addirittura assenti) e si soffermerà
sulle concessioni che Levinson deve fare alla sua teoria per preservarne la validità teoretica.
Un siffatto procedimento ci condurrà direttamente al terzo capitolo, in cui verranno prese in
esame le definizioni storiche alternative a quella di Levinson e che prendono in parte le mosse
proprio dai punti deboli di quest’ultima. Ovviamente l’ordine da me proposto non è
totalmente scindibile dall’ordine convenzionale − difatti cercherò comunque di raggruppare il
maggior numero possibile di critiche intorno a un cerchio limitato e significativo di autori e
testi di riferimento − e soprattutto da quello concettuale − sia in quanto le critiche verranno
comunque suddivise per affinità tematiche, sia poiché le risposte di Levinson sono esse stesse
raggruppabili in determinati nuclei argomentativi, e il loro grado di credibilità è direttamente
proporzionato al grado di validità di questi ultimi.
2.1 Risposte convincenti
Il primo insieme di critiche che prenderò in esame comprende quelle critiche che
presentano minori problemi per la definizione storica dell’arte di Levinson, in quanto
derivano alternativamente: A) dall’ignoranza di alcuni aspetti di tale definizione; B) da
un’incomprensione del significato globale o parziale della definizione; C) da una discutibile
interpretazione della stessa. In ognuno di questi casi le repliche di Levinson assumono le vesti
di una chiarificazione della sua definizione e delle sue parti più trascurate o fraintese.
28
A) I POLLI DI JONES E I FILMATI DI MARIETTE
La prima obiezione che analizzerò è opera di Noel Carroll ed è senz’altro la più
paradossale che ci si possa immaginare, in quanto taccia di astoricità la definizione dell’arte di
Levinson − la quale individua le condizioni necessarie e sufficienti all’artisticità di un oggetto
proprio nel riferimento storico-intenzionale di tale oggetto a modi di considerazione relativi
all’arte del passato. Carroll motiva la sua accusa sostenendo che Levinson non tiene conto del
fatto che i modi di considerare le opere d’arte non sono eternamente validi: alcuni di essi
perdono la loro importanza nel tempo e diventano obsoleti, e quindi non sono più in grado di
fungere da base per il conferimento di artisticità ad un oggetto creato in un’epoca più recente.
Carroll illustra la sua obiezione con degli esempi. Si supponga che Jones sia una persona
dotata di una discreta conoscenza della storia dell’arte e consapevole quindi del fatto che in
passato le opere d’arte erano sovente usate per invocare divinità di vario grado. Jones è anche
il proprietario di una fattoria, e ad un certo punto esprime l’intenzione di creare un’opera
d’arte; a tal fine egli uccide un gran numero di polli della sua fattoria per propiziare una
qualche divinità (Jones è anche un sincero credente). Infine egli presenta il massacro così
compiuto come un’opera d’arte, invitando più persone ad osservarlo e ad apprezzarlo in
quanto sacrificio compiuto per propiziare le divinità 70.
Si consideri ora quest’altra situazione. Mariette è in vacanza con la famiglia e porta con sé
una videocamera con l’intenzione di realizzare un filmato-ricordo della sua vacanza e di farlo
successivamente vedere ad amici e parenti. Entrambi gli esempi presentano delle significative
somiglianze tra di loro e soddisfano le condizioni che caratterizzano la definizione di
Levinson. Infatti tanto Jones quanto Mariette sono i legittimi proprietari rispettivamente dei
polli e del filmato amatoriale; la loro intenzione circa la destinazione di questi è ferma e
consapevole; i modi di considerazione ai quali i loro oggetti sono rivolti − ovvero
l’invocazione della divinità e l’attenzione alla verosimiglianza − sono senza dubbio modi di
considerare l’arte universalmente accettati e riconosciuti in passato. Tuttavia, né il massacro
di polli compiuto da Jones né il video di Mariette sono opere d’arte, e questo perché né la
propiziazione delle divinità né la ricerca della verosimiglianza sono attualmente riconoscibili
come modi appropriati di considerare l’arte. In virtù di tutto ciò la definizione di Levinson
risulta essere troppo comprensiva − infatti esempi simili a quelli ora esposti possono essere
70 Noel Carroll, “Identifying Art”, in Robert J. Yanal (ed. by), Institutions of Art: Reconsiderations of George Dickie’s Philosophy, Pennsylvania State University Press, University Park 1994, pp. 33-35.
29
moltiplicati all’infinito − e la art-regard condition non può costituire una condizione
sufficiente all’artisticità di un oggetto 71.
In risposta all’obiezione di Carroll, Levinson si limita a ricordare che nella sua definizione
non si fa riferimento a singoli e isolati modi di considerazione appropriati alle opere d’arte del
passato, bensì a insiemi integrali e relativamente completi di tali modi di considerazione.
Pertanto, tornando agli esempi di Carroll, anche riconoscendo che l’asservimento di una
funzione religiosa o l’attenzione alla verosimiglianza sono modi superati di guardare l’arte, la
definizione di Levinson non corre il rischio di divenire onnicomprensiva, in quanto non vi è
alcuna possibilità di connettere i polli massacrati da Jones o il video di Mariette con opere
d’arte del passato che pure condividano con questi oggetti i suddetti modi di considerazione.
Difatti mentre i protagonisti degli esempi di Carroll vogliono che i loro prodotti vengano
considerati secondo un unico e per giunta antiquato modo di considerazione appropriato ad
opere del passato, i veri artisti esigono che le loro opere siano considerate anche per altri
fattori artisticamente rilevanti (come l’attenzione agli aspetti emotivi dell’opera, alle sue
proprietà formali, agli aspetti simbolici, ecc.); e se i singoli modi di considerare l’arte possono
talvolta entrare in disuso, viceversa “gli insiemi integrali dei modi di considerazione
appropriati alle opere d’arte del passato non diventano in realtà mai obsoleti” 72.
In On Defining Art Historically Graham Oppy rivolge una lunga serie di obiezioni a
Levinson. Una di queste è incentrata sulla tesi secondo cui la definizione di Levinson
implicherebbe che vi sia “uno sviluppo parallelo dell’arte e del concetto di arte”: tale tesi è
confermata secondo Oppy dal fatto che chi intende consapevolmente che la propria opera sia
considerata nei modi in cui precedenti opere d’arte sono state correttamente considerate deve
per forza anche possedere il concetto di cosa significhi essere un’opera d’arte. Questo non è
tuttavia sempre possibile, e si possono trovare numerosi esempi che lo dimostrano: come può
Levinson spiegare il fatto che i dipinti del Quattrocento fossero arte al momento della loro
creazione se, come è storicamente accertato, a quell’epoca gli artisti non possedevano ancora
il nostro concetto di arte? 73
Levinson risponde sottolineando che la sua teoria non implica in alcun modo che gli artisti
debbano essere sempre coscienti e consapevoli della relazione delle loro creazioni con le
71 Noel Carroll, Philosophy of Art: A Contemporary Introduction, Routledge, London and New York 1999. 72 Jerrold Levinson, “The Irreducible Historicality of the Concept of Art” (2002), in Id., Contemplating Art, Clarendon Press, Oxford (NY) 2006, pp. 15-17. Levinson aveva peraltro già risposto nella stessa maniera ad accuse analoghe in “Refining Art Historically”, cit., pp. 44-45. Si veda al proposito il primo capitolo del presente lavoro. 73 Graham Oppy, “On Defining Art Historically”, British Journal of Aesthetics 32 (1992), p 158.
30
opere d’arte del passato. D’altronde egli aveva già specificato che le intenzioni dell’artista
possono essere tanto opache, ovvero consapevoli del riferimento ad opere d’arte preesistenti,
quanto trasparenti, ovvero indirizzate a modi di considerazione che all’insaputa dell’artista
risultano essere gli stessi che hanno caratterizzato la ricezione dell’arte nel passato 74.
Quest’ultimo tipo di intenzioni concede la possibilità di essere artisti anche a persone
ignoranti della storia dell’arte. Inoltre egli aveva chiarito anche che la definizione storico-
intenzionale si propone di spiegare “quale sia il concetto di arte nel presente − ovvero, cosa
significhi oggi, per un oggetto creato in un qualsiasi momento (passato, presente o futuro)
contare come arte in quel momento, anziché cosa ciò significasse al momento della sua
creazione” 75. Pertanto la premessa da cui muove la critica di Oppy, ovvero l’affermazione
secondo cui la definizione storica di Levinson implichi uno sviluppo parallelo della storia e
del concetto di arte, si basa sull’ignoranza di due aspetti fondamentali di tale definizione, ed è
quindi facilmente rigettabile. Un dipinto del Quattrocento può tranquillamente essere stato
arte al momento della sua creazione senza venire contemporaneamente giudicato come tale,
dato che per ipotesi (condivisa dallo stesso Oppy) il moderno concetto di arte occidentale si è
formato solo dopo il Rinascimento 76.
B) INTENZIONE CATEGORIALE E INTENZIONE SEMANTICA
Secondo Stephen Davies, Levinson attribuisce un peso eccessivo alle intenzioni
dell’artista. Davies sostiene infatti che “chiunque definisca l’arte con un riferimento alle
intenzioni dell’artista debba anche credere che le intenzioni dell’artista determinino le
interpretazioni, o l’insieme di interpretazioni, adatte a comprendere e apprezzare le loro
opere”. Tuttavia secondo lui ciò che in ultima analisi determina l’interpretazione corretta e il
giusto apprezzamento di un’opera d’arte non è tanto l’intenzione dell’artista, quanto l’insieme
delle proprietà estetiche e artistiche dell’opera stessa 77. La risposta diretta a questa critica
viene non da Levinson, bensì da Noel Carroll, anch’egli sostenitore di una teoria storica
dell’arte. Carroll contesta a Davies il fatto di presentare la connessione tra l’intenzionalismo
relativo alla definizione dell’arte e l’intenzionalismo riguardante l’interpretazione di un’opera
d’arte come una necessità logica, quando è invece logicamente possibile che qualcuno, pur
sostenendo che l’attribuzione di una certa intenzione all’artista sia necessaria per stabilire lo
status di artisticità dell’oggetto da lui creato, allo stesso tempo ritenga che l’individuazione di
74 J. Levinson, “Defining Art Historically”, cit., p. 11. 75 Ivi., p. 23. 76 J. Levinson, “Art Historically Defined: Reply to Oppy”, British Journal of Aesthetics 33 (1993), p. 33. 77 Stephen Davies, Definitions of Art, cit., p. 172.
31
una data intenzione non sia rilevante ai fini di una corretta interpretazione delle opere d’arte.
Il fatto poi che Levinson sia un intenzionalista sia riguardo alla definizione che riguardo
all’interpretazione dell’arte è solo un fatto storico e contingente, non una necessità logica 78.
In seconda istanza è doveroso richiamare alla mente la distinzione che Levinson introduce
in Intention and Interpretation in Literature tra intenzione categoriale − la quale è costituita
dall’intenzione dell’autore che la sua opera sia classificata entro un determinato genere o una
determinata classe (la più generale è ovviamente la classe delle opere d’arte) − e intenzione
semantica − ovvero l’intenzione, da parte dell’autore, che la sua opera abbia un certo
significato, comunichi un determinato contenuto, abbia un valore espressivo o simbolico: in
breve, che venga interpretata in una data maniera. Levinson sostiene che solo la prima è reale,
e che si basa principalmente su elementi esteriori all’opera e al suo processo di produzione
(essa è deducibile ad esempio dal comportamento dell’autore o da indicazioni sussidiarie
come i diari dell’artista, le note critiche, le interviste rilasciate). L’intenzione categoriale
determina direttamente l’attribuzione dello status di artisticità ad un’opera o la sua
classificazione entro un determinato genere, mentre influenza a un livello basilare e indiretto
il significato dell’opera stessa, il quale può essere elaborato solo ipoteticamente − esso
coincide con la miglior ipotesi possibile circa l’intenzione semantica dell’autore, formulata da
un pubblico preparato e dotato di un’adeguata conoscenza delle caratteristiche intrinseche
all’opera e del contesto storico-culturale di provenienza della stessa 79.
78 N. Carroll, “Historical Narratives and the Philosophy of Art”, Journal of Aesthetics and Art Criticism 51 (1993), p. 323. 79 J. Levinson, “Intention and Interpretation in Literature” (1992), in Id., The Pleasures of Aesthetics, cit., pp. 188-190. La descrizione dell’intenzione categoriale non è però completa se non si ricorda il fatto che secondo Levinson l’intenzione categoriale di una persona può essere dedotta dall’ “aspetto esteriore” dell’oggetto da lui prodotto e dal suo “contesto di creazione”, ovvero dalle medesime caratteristiche che stanno alla base dell’intenzione semantica (v. Id., “Refining Art Historically”, cit., p. 43); senza tale aggiunta la definizione storica incorrerebbe fatalmente in un circolo vizioso (allo stesso modo della teoria istituzionale). Che cosa differenzia allora i due tipi di intenzione? Probabilmente questo: per attribuire l’intenzione categoriale a un autore laddove questi non si sia pronunciato espressamente sul modo in cui la sua opera debba essere considerata, è sufficiente che l’opera abbia delle proprietà estetiche (che fanno parte dall’aspetto esteriore dell’opera) e artistiche (le quali dipendono anche dal suo contesto di produzione), indipendentemente da quante e quali esse siano; per attribuire un’intenzione semantica ad un artista occorre invece tener conto delle diverse tipologie delle proprietà esibite dall’opera (specificando le proprietà formali, espressive e simboliche possedute) e dei rapporti che intercorrono tra di esse. L’aspetto dell’opera e il suo contesto influiscono in maniera più superficiale − e quindi più immediata − nella determinazione delle intenzioni categoriali (per le quali basta che un’opera dia l’impressione di essere realizzata con una certa cura formale, con un non meglio specificato intento comunicativo, e via dicendo), mentre incidono in maniera più profonda − e perciò mediata in una forma ipotetica − nella determinazione dell’intenzione semantica. Se è vero quindi che l’intenzione categoriale influisce indirettamente, come sostenuto da Levinson, sul significato dell’opera, è altrettanto evidente che anche l’intenzione semantica influisce, sempre in maniera indiretta (attraverso cioè l’emergere di un’apparenza di significato, più che di un significato vero e proprio), sulla collocazione dell’opera entro un dato genere o classe, in special modo entro la classe delle opere d’arte.
32
Pertanto non solo, in generale, il problema della definizione dell’arte va tenuto distinto da
quello dell’interpretazione delle singole opere; ma quand’anche un autore sostenesse la
medesima posizione − nella fattispecie intenzionalista − riguardo ad entrambi i problemi,
occorre esaminare se il concetto di intenzione adoperato sia o meno lo stesso nei due diversi
casi. Dato che nella teoria di Levinson il concetto di intenzione impiegato in ambito
definitorio non coincide con quello utilizzato in campo interpretativo, a maggior ragione
l’obiezione di Davies risulta infondata 80.
C) FALSI PROBLEMI, FALSI D’AUTORE E FALSI ARTISTI
Le obiezioni di Davies non si fermano a quella appena esposta. Nel suo importante libro
Definitions of Art egli ritiene anche che Levinson, dal momento che non considera l’artisticità
come uno status sociale, non sia in grado di dimostrare come un’opera d’arte (con ogni
probabilità concettuale) possa acquisire proprietà estetiche che un oggetto percettivamente
indistinguibile da essa non possiede. Più in particolare, Levinson si troverebbe in difficoltà,
secondo Davies, a distinguere i seguenti casi: a) quello in cui un artista crea un’opera d’arte
nel modo indicato dalla definizione storico-intenzionale; b) quello in cui un artista intende che
un oggetto sia visto come un’opera d’arte (e quindi vuole realizzarne una) quando in realtà
esso lo è già, sebbene a sua insaputa; c) quello in cui l’artista vuole che noi consideriamo
qualcosa come un’opera d’arte solo perché egli crede che lo sia già; d) quello in cui l’artista
vuole che noi consideriamo come opera d’arte qualcosa che secondo lui non lo è; e) quello in
cui l’artista vuole che noi consideriamo come opera d’arte qualcosa che secondo lui non lo è,
ma che ciononostante egli potrebbe trasformare in opera d’arte pur senza volerlo 81.
Jerrold Levinson dichiara di considerare l’artisticità come status, ma non alla maniera
sottintesa da Davies, ovvero come status sociale conferito in modo pubblico, bensì, in un
senso forse più debole, come status culturale: intendere che un oggetto venga considerato
80 L’ ‘intenzionalismo’ di Levinson è definibile come ‘realista’ in ambito definitorio, mentre è ‘ipotetico’ in ambito interpretativo (laddove altri autori sostengono il realismo dell’intenzione anche per il significato di un’opera d’arte, oltre che per la sua classificazione). Sul dibattito tra intenzionalismo realista e ipotetico in ambito interpretativo, vedi: N. Carroll, “Interpretation and Intention: The Debate Between Hypotetical and Actual Intentionalism”, Metaphilosophy 31 (2000), pp. 75-95; G. Iseminger, “Actual Intentionalism vs. Hypotetical Intentionalism”, Journal of Aesthetics and Art Criticism 54 (1996), pp. 319-26; J. Levinson, “Hypotetical Intentionalism: Statement, Objections and Replies” (2002), in Id., Contemplating Art, cit., pp. 302-311; J. Levinson, “Intention and Interpretation in Literature” (1992), in Id., The Pleasures of Aesthetics, cit., pp. 175-213; W. Tolhrust, “On What a Text Is and How It Means”, British Journal of Aesthetics 19 (1979), pp. 3-14). 81 Stephen Davies, Definitions of Art, cit., pp. 159-161. Davies riprende qui il famoso argomento dell’ “identità degli indiscernibili” avanzata da Arthur Danto, il quale sosteneva che un oggetto può essere un’opera d’arte anche se risulta percettivamente indistinguibile da un oggetto comune e non artistico, in virtù dell’ “atmosfera di teoria” artistica che lo circonda – esempi eminenti sono la Fontana di Duchamp e i Brillo Boxes di Wharol (v. A. Danto, “The Artworld”, cit.).
33
nello stesso modo in cui precedenti opere d’arte sono state considerate significa anche
conferire a quell’oggetto un’identità culturale. Pertanto attraverso la definizione storico-
intenzionale è possibile distinguere i casi elencati da Davies (contrariamente a quanto
sostenuto da questi) dal momento che solo nel primo l’intenzione è costitutiva dell’identità
culturale dell’oggetto in questione, poiché determina la categoria alla quale esso appartiene
(nella fattispecie si tratta della categoria delle opere d’arte), mentre nei restanti casi
l’intenzione dell’artista si limita ad accettare e tuttalpiù a discutere delle categorizzazioni già
stabilite e assegnate. Il secondo caso merita però secondo Levinson un’ulteriore
considerazione. Occorre infatti specificare che se l’operazione dell’artista è di tipo
concettuale, allora egli può legittimamente realizzare un’opera d’arte senza compromettere
l’identità culturale dell’oggetto su cui opera; se invece l’artista intende dare all’oggetto una
nuova identità culturale, allora egli deve esserne il legittimo proprietario 82.
Nel primo dei sei saggi supplementari contenuti in Art and Its Objects Richard Wollheim
mette seriamente in crisi la validità della teoria istituzionale dell’arte proposta da George
Dickie attraverso una serie di obiezioni sequenzialmente articolate. Jerrold Levinson ritiene
che tali obiezioni siano rivolgibili anche alla sua teoria, che da quella di Dickie prende le
mosse pur distanziandosene in alcuni significativi punti, e cerca quindi di fornire ad esse delle
adeguate risposte, non prima di averle separate e riadattate alla propria definizione. A due di
queste critiche egli riesce a replicare abbastanza agevolmente. Innanzitutto, Wollheim
contesta alla definizione istituzionale dell’arte (e indirettamente a quella storica) il fatto di
violare l’intuizione comune e diffusa secondo cui l’arte è un’attività importante nella vita
dell’uomo 83. Levinson ritiene a tal proposito che l’arte sia importante per motivi diversi dalle
sue condizioni di definizione – noi apprezziamo l’arte per il suo continuo ricercare nuove
possibilità interne al proprio sviluppo, nonché per l’aprire inedite prospettive nell’esistenza
dei singoli individui. Ad ogni modo la definizione da lui proposta ammette implicitamente
82 J. Levinson, “Extending Art Historically”, cit., pp. 159-161. Credo sia necessario chiarire il caso b) elencato da Davies e discusso da Levinson attraverso un esempio. Si pensi a un artista concettuale che inviti il pubblico a considerare una scultura (di cui egli ignora lo statuto artistico) come un’opera concettuale, magari presentandola con un titolo criptico e spiazzante (spesso l’arte concettuale si riduce a questo). In tal caso una nuova identità viene aggiunta all’oggetto in questione senza che la sua precedente identità artistica, sebbene non avvertita dall’artista concettuale, venga cancellata. Un siffatto esempio mi suggerisce però anche un’altra considerazione: se l’artista concettuale non si accorge che l’oggetto su cui opera è una scultura, i casi sono due: o la scultura è talmente mal riuscita da risultare irriconoscibile, e quindi anche difficile da classificare tra le opere d’arte; oppure l’artista è talmente insensibile da non accorgersi di essere di fronte a una vera scultura. Ma allora ci si deve chiedere: come può una persona così ignorante e insensibile realizzare un’opera d’arte? In virtù di queste riflessioni, la situazione descritta nel caso b) mi sembra francamente poco plausibile. 83 Richard Wollheim, Art and Its Objects, 2nd ed, Cambridge University Press, Cambridge 1980, pp. 163-164.
34
l’importanza dell’arte, in quanto l’arte, proprio in virtù della natura relazionale che la
definizione storica le riconosce, viene inserita in quella rete di attività umane caratterizzate
dall’accumulazione di conoscenze, dalla preservazione della tradizione, dall’intreccio di
comunità e continuità, che insieme costituiscono la nostra cultura 84.
Wollheim osserva anche che la definizione istituzionale attribuisce un’eccessiva
importanza all’arte di Duchamp in quanto la considera un fenomeno centrale della nostra
storia artistica, laddove andrebbe invece vista come un’eccezione rispetto a ciò che
normalmente classifichiamo come arte. L’arte di Duchamp dovrebbe costituire una sfida per
definizioni già esistenti − come ad esempio per le definizioni estetiche, le quali si trovano nel
difficile ma non impossibile compito di dar conto delle proprietà ironiche e provocatorie dei
cosiddetti ready-made − anziché fungere da base per la costruzione di nuove definizioni
dell’arte, come appunto quella di Dickie 85. Secondo Levinson sia la propria definizione che
quella di Dickie considerano Duchamp come un’eccezione, e ammettono che l’arte sia
normalmente contraddistinta da proprietà che i ready-made non possiedono (abilità tecnica,
espressività, capacità di risolvere problemi estetici, comunicazione di particolari punti di vista
sulla società, ecc.). Allo stesso tempo però entrambe le definizioni riconoscono a Duchamp
una centralità nella storia dell’arte contemporanea, dovuta al fatto innegabile che l’artista
francese con i suoi ready-made ha reso le proprietà sopraelencate non più irrinunciabili per
l’arte, come lo erano invece in passato; in tal modo egli ha sollecitato l’elaborazione di
definizioni che cercassero le condizioni necessarie e sufficienti all’artisticità non più in
proprietà intrinseche ed esibite bensì in proprietà di tipo relazionale. Inoltre, aggiunge
Levinson, il rilevamento delle proprietà ironiche e provocatorie dei ready-made compete più a
una teoria generale dell’arte − la quale si serve degli strumenti di studio propri delle singole
forme artistiche e della loro storia − e non già ad una definizione dell’arte − alla quale si può
tuttalpiù chiedere di essere compatibile con la teoria artistica 86.
Robert Stecker ritiene che uno dei problemi più evidenti che una definizione storica deve
affrontare sia costituito dal fatto che l’incertezza che può circondare l’artisticità di alcune
opere del passato (in particolare le più remote) determina inevitabilmente un’incertezza
riguardo all’artisticità delle opere attuali. Tale incertezza è costitutiva di una teoria come
84 J. Levinson, “Refining Art Historically”, cit., pp. 53-54. D’altronde si è detto pocanzi che l’intenzione artistica è, nella definizione storico-intenzionale, un’intenzione di tipo categoriale attraverso la quale l’artista conferisce all’oggetto da lui creato un’identità culturale, in quanto lo connette a pratiche diffuse e riconosciute della nostra tradizione artistica. 85 R. Wollheim, Art and Its Objects, cit., pp. 165-166. 86 J. Levinson, “Refining Art Historically”, cit., p. 54.
35
quella di Levinson (la quale definisce cioè ciò che è arte oggi in relazione a ciò che è stato
identificato come arte in passato), ed è particolarmente evidente quando ci si trova di fronte
ad oggetti di difficile classificazione (come i prodotti artigianali o talune forme d’arte
popolare), per i quali è difficile rinvenire una chiara ascendenza artistica 87. Levinson ribatte
ricordando a Stecker anzitutto che i prodotti artigianali o le arti popolari rappresentano
un’eccezione rispetto all’insieme generale e riconosciuto delle opere d’arte, e non meritano
pertanto una particolare attenzione. L’incertezza che poi Stecker attribuisce alla definizione
storica è in realtà costitutiva di tutta l’arte in generale (indipendentemente da quale
definizione sia più o meno adeguata a catturarne il concetto), essendo questa un’attività che
non procede attraverso l’applicazione di regole scientifiche e precostituite. Laddove non
superi un certo livello minimo (oltre il quale si rischierebbe di sfociare nell’indeterminatezza),
tale incertezza può anzi essere letta come un’ulteriore elemento che accomuna le opere d’arte
del passato a quelle del presente, e che contribuisce quindi a preservare la continuità della
storia dell’arte, che poi è il punto di partenza della teoria di Levinson 88.
Crispin Sartwell elabora contro la teoria di Levinson il seguente contro-esempio.
Supponiamo che un individuo realizzi una copia esatta di un dipinto di Rembrandt e riesca ad
esporlo al Metropolitan Museum senza essere scoperto. Di certo egli vuole che la propria
opera venga guardata dagli spettatori negli stessi modi in cui si guarda una vera opera d’arte
(nella fattispecie, nei modi in cui si guarda un dipinto di Rembrandt). Stando alla definizione
storico-intenzionale, il falso Rembrandt dovrebbe essere classificato tra le opere d’arte; ciò
appare però alquanto contro-intuitivo. Tale esempio, secondo Sartwell, riflette il seguente
problema generale, che Levinson non sembra essere in grado di fronteggiare: un oggetto può
essere inteso per essere considerato come un’opera d’arte senza allo stesso tempo riuscire ad
essere tale 89.
Levinson risponde al contro-esempio di Sartwell con tre osservazioni: 1) è pur vero che la
persona che ha realizzato il falso Rembrandt di certo intende che questo sia considerato come
il Rembrandt originale, ma ciò non equivale a dire che ella intende che la propria opera sia
considerata esattamente negli stessi modi in cui l’originale viene considerato; 2) pur
ammettendo ciò, l’insieme dei modi considerazione appropriati al vero Rembrandt è più
ampio dell’insieme dei modi di considerazione appropriati al falso Rembrandt: il primo
87 R. Stecker, “The Boundaries of Art”, British Journal of Aesthetics 30 (1990), pp. 268-69. 88 J. Levinson, “Extending Art Historically”, cit., p. 157. 89 C. Sartwell, “A Counter-Example to Levinson’s Historical Theory of Art”, Journal of Aesthetics and Art Criticism 48 (1990), pp. 157-158.
36
insieme comprende anche quei modi di considerare l’opera da un punto di vista storico-
artistico (come l’interpretare l’opera alla luce dei suoi precursori o sullo sfondo del contesto
socio-culturale ad essa contemporaneo) che necessariamente mancano al secondo − il vero
Rembrandt viene osservato anche in relazione al contesto della pittura fiamminga precedente
e contemporanea a Rembrandt stesso, mentre la copia non viene affatto letta nel contesto in
cui essa è in effetti prodotta, ovvero sullo sfondo del post-modernismo di fine Novecento; 3)
la definizione storico-intenzionale può eventualmente essere ampliata nel modo seguente: X è
un’opera d’arte se una persona avente il legittimo diritto di proprietà su X intende che sia
corretto che X sia considerato nello stesso modo (o modi) in cui precedenti opere d’arte sono
o sono state correttamente considerate. Una tale aggiunta porrebbe fine, secondo Levinson, al
problema dei falsi d’autore, dato che nemmeno l’autore del falso Rembrandt può ritenere
corretto che si guardi alla sua opera come si guarda l’originale, quandanche lo sperasse.
Tuttavia egli dichiara anche che questa aggiunta non è strettamente necessaria e che la sua
definizione è in grado di respingere l’obiezione di Sartwell anche mantenendo la sua forma
originaria, dato che i modi di considerazione storico-artistici di un’opera hanno un peso
importante nella comprensione di un’opera d’arte e sono ciò che in definitiva ci permettono di
distinguere il vero Rembrandt dalla sua copia 90.
Un altro modo per replicare al contro-esempio di Sartwell è suggerito da Graham Oppy, il
quale sostiene che in generale le falsificazioni possono essere considerate come opere d’arte:
un falso Rembrandt non è un dipinto di Rembrandt, ma è comunque un dipinto
(indipendentemente dal suo valore artistico) 91. Oppy sottopone però a Levinson un altro
90 J. Levinson, “A Refiner’s Fire: Reply to Sartwell and Kolak”, Journal of Aesthetics and Art Criticism 48 (1990), pp. 231-32. 91 G. Oppy, “On Definig Art Historically”, cit., pp. 159-60. Sulla questione della distinzione tra proprietà artistiche e proprietà estetiche torneremo più avanti. Mi sembra invece opportuno riflettere ancora sul problema dei falsi d’autore. Di tale problema si è occupato ampiamente Nelson Goodman, il quale nega che un falso possa essere un’opera d’arte anche qualora esso risultasse identico all’originale, in quanto si possono comunque rilevare delle “sottili differenze percettive” tra le due opere se si prendono in considerazione fattori non percettivi come la conoscenza delle relazioni tra l’artista e la scuola (o il periodo) di appartenenza. Tali conoscenze possono secondo Goodman influenzare le nostre capacità percettive e renderci in grado di distinguere l’originale dalla contraffazione “semplicemente guardandoli” (v. N. Goodman, Languages of Art: An Approach to a Theory of Symbols (1968), trad. it. I Linguaggi dell’Arte, NET, Milano 2003, pp. 91-110). Eddy Zemach sostiene invece che l’identità di un dipinto non coincida con l’identità del supporto materiale (pur non diventando con ciò una pura idea, alla maniera di Croce o di Collingwood): essa è piuttosto costituita da quella particolare combinazione di linee e di colori, che può manifestarsi in più supporti materiali. Questo non significa, come vorrebbero i formalisti, che la comprensione di un’opera d’arte sia indipendente dal suo contesto socio-culturale di appartenenza. Tuttavia quando cerchiamo di comprendere nel giusto modo la copia di un dipinto antico realizzata oggi, noi dobbiamo mettere in relazione la copia con il contesto socio-culturale relativo all’originale, e non a quello relativo alla copia e a noi contemporaneo (v. Eddy Zemach, “No Identification Without Evaluation”, British Journal of Aesthetics 26 (1986), pp. 239-251). Stando a tali considerazioni e tornando all’esempio di Sartwell, si dovrebbe quindi leggere il falso Rembrandt in relazione alla pittura
37
contro-esempio con cui confrontarsi, imparentato in qualche modo con quello di Sartwell.
Egli immagina un artista che, pur eccellendo nell’esecuzione, non sia altrettanto bravo nella
composizione. Questo artista comincia a dipingere con l’idea che produrrà un oggetto di
valore, ma a metà del lavoro realizza che l’idea che aveva in mente era pessima, e in uno
sfogo di rabbia distrugge quanto aveva creato. Sicuramente il nostro artista aveva l’intenzione
che la sua opera venisse considerata nello stesso modo in cui precedenti opere d’arte sono
state considerate; altrettanto sicuramente tale intenzione è venuta a mancare nel momento in
cui egli ha iniziato a distruggere la sua tela. Secondo la definizione di Levinson l’artista non
ha prodotto alcuna opera d’arte, mentre sarebbe più ragionevole concludere, secondo Oppy,
che egli abbia comunque prodotto un’opera d’arte, sebbene di scarso valore 92.
In risposta al contro-esempio di Oppy, Levinson chiarisce che le intenzioni, nella sua
teoria, sono costitutive (nel senso precedentemente chiarito) solo se riferite ad oggetti
completi e finiti; se invece si fermano per così dire a metà strada, perdono il loro potere
determinativo (non sono più in grado cioè di dare un’identità culturale all’oggetto). Inoltre
non vi è nulla di irragionevole e contro-intuitivo, aggiunge comprensibilmente Levinson, nel
non considerare la tela distrutta né una cattiva opera d’arte né tantomeno un’opera d’arte a
pieno titolo, ma piuttosto nel ritenerla un semplice esercizio artistico, qualcosa di
propedeutico cioè all’arte vera e propria 93.
2.2 Risposte incerte
Il secondo gruppo di critiche riguarda, come detto, quelle alle quali Levinson ha risposto in
maniera puntuale e coerente con le proprie idee, ma allo stesso tempo non totalmente
risolutiva. La non definitività delle repliche dipende a mio avviso da diversi fattori: alcune di
esse respingono validamente solo una parte dell’obiezione; altre respingono l’obiezione nella
sua interezza, ma in modo non del tutto convincente; altre ancora controbattono l’obiezione
nella sua interezza e senza lasciare dubbi residui, ma lo fanno con l’ausilio di argomenti che
apriranno a loro volta il campo a ulteriori obiezioni, alcune delle quali risulteranno fatali per
la definizione dell’arte di Levinson, come vedremo più avanti. Ho deciso di dividere questo
fiamminga del Seicento e non all’arte post-moderna. Sulla questione delle falsificazioni artistiche Levinson si muove sulla linea tracciata da Goodman, mentre la posizione di Oppy è più vicina a quella di Zemach. 92 G. Oppy, “On Defining Art Historically”, cit., pp. 158-59. 93 J. Levinson, “Art Historically Defined: Reply to Oppy”, cit., pp. 384-85. Levinson non intende qui escludere la possibilità che vi sia una cattiva arte (bad art), ma vuole solo negare che l’esempio di Oppy ricada in tale categoria. D’altronde la sua è una definizione di tipo classificatorio e non valutativo.
38
insieme di critiche in quattro gruppi, che tratterò separatamente e che vertono sui seguenti
temi: A) l’insufficienza della condizione di intenzionalità; B) la questione della correttezza e
della completezza dei modi di considerazione; C) la contingenza della condizione storica; D)
il parallelo con la definizione storica degli artefatti.
A) NON BASTA IL PENSIERO
Molti estetologi analitici ritengono che la definizione storico-intenzionale non sia in grado
di fornire condizioni sufficienti all’artisticità. Secondo Oppy, le intenzioni dell’artista sono
condizioni deboli per stabilire l’artisticità di un oggetto e necessitano quindi dell’aggiunta di
ulteriori condizioni; altrimenti ogni cosa può essere trasformata in opera d’arte, basta volerlo! 94 Analogamente Noel Carroll ritiene che la definizione di Levinson rischi di diventare troppo
comprensiva, in quanto i modi di considerazione ai quali l’intenzione dell’artista fa
riferimento, pur essendo correttamente ricavati da opere del passato, possono essere applicati
correttamente anche ad oggetti che non sono opere d’arte − tanto il muro di un’abitazione
quanto un quadro esposto al Metropolitan Museum possono infatti essere stati dipinti per
procurare piacere visivo, ovvero per essere guardati nel modo in cui vengono guardate le
opere d’arte del passato, ma solo il secondo è un’opera d’arte 95.
Levinson controbatte affermando che le intenzioni dell’artista non sono affatto condizioni
deboli, in quanto hanno il potere di attribuire ad un oggetto un nuovo status, ovvero una
nuova identità culturale. Inoltre non bisogna dimenticare che le restrizioni richieste
esplicitamente da Oppy e implicitamente da Carroll sono già presenti nella definizione
storico-intenzionale, e sono la condizione del diritto di proprietà sull’oggetto in questione e la
completezza dei modi di considerazione ai quali l’artista riferisce intenzionalmente il suo
oggetto: entrambe queste condizioni verranno discusse in seguito 96.
Robert Stecker prende in esame i seguenti due casi. Si consideri anzitutto un poema scritto
con la “giusta” intenzione da una persona totalmente incompetente in materia e che quindi
non riesce a donare al suo prodotto nessuna proprietà degna di nota. Si prenda poi un
compositore preparato tecnicamente ma totalmente ignorante della storia della musica
moderna; si supponga che egli scriva nel 1989 un brano in perfetto stile mozartiano. Secondo
94 G. Oppy, “On Defining Art Historically”, cit., p. 154. 95 N. Carroll, Philosophy of Art, cit., pp. 247-48. 96 J. Levinson, “Art Historically Defined: Reply to Oppy”, cit., pp. 380-81. Bisogna aggiungere che Levinson aveva preventivamente risposto a un’ipotetica obiezione simile a quella rivoltagli da Carroll già in “Defining Art Historically”, dove egli specifica che i modi di considerazione a cui l’artista si riferisce devono formare un insieme relativamente completo (si veda il primo capitolo della presente ricerca).
39
Stecker, il quale pure ammette la possibilità dell’esistenza di una cattiva arte, le due opere
così prodotte non rappresentano arte alcuna, né cattiva né tantomeno buona; tuttavia la
definizione di Levinson sembra essere disposta a concedere il contrario 97.
Secondo Levinson i due casi ipotizzati da Stecker non sono fondamentali per una
definizione dell’arte, in quanto ricadono nel labile e probabilmente indefinibile confine che
divide la cattiva arte dalla non-arte. Ad ogni modo egli fornisce una risposta per entrambi, e
osserva che nel secondo caso “sarebbe perverso negare che il brano scritto sia musica”;
tuttalpiù si può negare ad esso un “alto valore artistico”, data l’ignoranza del compositore
circa gli ultimi due secoli di evoluzione musicale (ignoranza che gli impedisce di scrivere
qualcosa di originale e autentico), ma non si può legiferare contro la semplice esistenza di
“completi epigoni nell’arte”. Nel primo caso, invece, Levinson ritiene che sia utile classificare
il poema così malamente scritto come un’opera d’arte (sebbene ovviamente di scarso valore),
in quanto in tal modo lo si separa da altri artefatti verbali ai quali esso non è riconducibile 98.
La distinzione tra l’aspetto classificatorio e l’aspetto valutativo della nozione di arte aiuta
quindi Levinson a ribattere ai contro-esempi di Stecker, ma quando sarà proprio tale
distinzione ad essere a sua volta messa in discussione la difesa risulterà assai meno agevole.
Stephen Davies sottopone a Levinson un contro-esempio ancora più paradossale e
provocatorio di quelli fin qui esaminati. “Non c’è niente”, afferma Davies, “che possa
impedire a una guida turistica dotata di sensibilità estetica di mostrare ai partecipanti del giro
turistico da lei organizzato un qualche scenario naturale, ad esempio il Grand Canyon, e di
prefiggersi lo scopo di far sì che essi lo guardino nel corretto modo in cui si guarda un
qualche tipo di arte, ad esempio una scultura fatta di terra (in uno stile impressionista).
L’intenzione della guida non è una vana speranza, poiché lo scenario invita ad essere guardato
in quel modo. Tuttavia non saremmo inclini a dire che la guida turistica esteticamente
sensibile ha trasformato il Grand Canyon in un’opera d’arte” 99.
Davies immagina anche i possibili argomenti che Levinson potrebbe usare contro tale
esempio, e li respinge preventivamente nel modo che segue. Levinson potrebbe anzitutto
negare che l’intenzione della guida sia ferma e stabile: ma questa è una condizione troppo
vaga per essere seriamente tenuta in considerazione. Levinson potrebbe poi sottolineare che la
97 Robert Stecker, “The Boundaries of Art”, cit., p. 268. 98 J. Levinson, “Extending Art Historically”, cit., pp. 156-57. 99 S. Davies, Definitions of Art, cit., p. 174. L’esempio è plausibile, in quanto la maggior parte delle opere d’arte concettuali si basa su operazioni che mirano a trasfigurare l’identità di un oggetto senza intervenire materialmente su di esso.
40
sua definizione richiede che l’intenzione della guida sia rivolta a un insieme completo e non
parziale di modi di considerazione: ma nell’esempio riportato la guida turistica invita gli
spettatori ad osservare tutti gli aspetti percepibili del paesaggio che hanno di fronte secondo
tutte le modalità di approccio che un dipinto o una scultura impressionista richiedono.
Levinson potrebbe infine porre l’accento sul fatto che la guida non ha il legittimo diritto di
proprietà sul Grand Canyon. Davies, come molti altri autori, contesta duramente la
proprietary-right condition. Senza entrare nel merito della validità o meno di tale condizione
(cosa che faremo in seguito), Levinson sembra ad ogni modo impigliarsi in un dilemma: o
accetta che sia il possesso del diritto di proprietà su un oggetto a permettere a un artista di
trasformare il suo oggetto (che potrebbe essere anche il Grand Canyon) in un’opera d’arte e
contemporaneamente a impedire alla nostra guida turistica di fare altrettanto − ma allora si
ricade nella teoria istituzionale (che secondo Davies è l’unica teoria che nel caso specifico
può spiegare il perché la guida non ha trasformato il Grand Canyon in opera d’arte), in quanto
ciò che determina la differenza tra un oggetto comune e un’opera d’arte si riduce, in ultimo, a
una differenza di status sociale − oppure annulla la proprietary-right condition, e concede che
la guida possa trasformare il Grand Canyon in un’opera d’arte − ma così facendo la sua
definizione diviene “troppo liberale per essere plausibile” 100.
Levinson ribatte colpo su colpo alle osservazioni di Davies. Innanzitutto egli ribadisce che
la richiesta della stabilità dell’intenzione è una condizione seria e non labile. Ma soprattutto,
egli si dichiara in disaccordo con Davies, dal momento che non ritiene possibile che la guida
turistica sia in grado di affrontare fino in fondo un parallelo tra il Grand Canyon e una
scultura impressionista: “Può ella”, si domanda retoricamente Levinson, “richiedere che si
presti attenzione allo stile dell’opera? Può volere che si considerino sia i segni dell’attività
dello scultore sia ciò che può essere visto dentro e attraverso essi? Può pretendere che
l’oggetto sia letto in relazione ai suoi precedenti artistici?” Il motivo per cui bisogna
rispondere negativamente a tali domande sta nel fatto che “intendere che un oggetto venga
considerato come un X, o come diversi X sono stati considerati, non è esattamente la stessa
cosa dell’intendere che tale oggetto sia considerato come se fosse un X”: nel secondo caso c’è
un elemento di supposizione che manca nel primo 101.
Anche Davies è disposto a concedere che “l’intenzione di un artista e quella di una guida
turistica abbiano effetti differenti in quanto sono intenzioni differenti”: un artista può avere
l’intenzione di incorporare il Grand Canyon all’interno di un lavoro concettuale e quindi
100 Ivi, pp. 174-78. 101 J. Levinson, “Extending Art Historically”, cit., p. 162.
41
richiedere che il Grand Canyon sia visto come parte di un’opera d’arte, laddove la guida
turistica può solo invitare gli spettatori a guardare il Grand Canyon come se fosse un’opera
d’arte 102. Mentre però per Levinson la differenza tra i due tipi di intenzioni è una differenza
cognitiva − la guida turistica non ha la stessa capacità immaginativa né la stessa conoscenza
della storia dell’arte che un’artista possiede − per Davies essa è una differenza di status
sociale − la guida turistica non ha la stessa autorità che l’istituzione del mondo dell’arte ha
conferito all’artista e che permette a quest’ultimo di trasfigurare artisticamente il Grand
Canyon. Come si vede si tratta di due interpretazioni diverse di uno stesso principio, ed
entrambe sono a mio avviso in parte convincenti e in parte discutibili. Sulla base di cosa
stabiliamo che la guida turistica sia meno preparata e dotata di immaginazione di un artista?
Fino a che punto il ruolo sociale di una persona può determinare la sua capacità di creare
oggetti culturali, nella fattispecie opere d’arte? La soluzione sta forse nello spostare
l’attenzione dalle intenzioni private e dalle istituzioni pubbliche e nel ridirigerla verso le
concrete opere dell’agire umano.
B) LA QUESTIONE DELLA CORRETTEZZA E DELLA COMPLETEZZA DEI MODI DI
CONSIDERAZIONE ARTISTICI
Una delle nozioni cruciali della definizione proposta da Levinson è quella di “modi corretti
di considerare l’arte” (correct ways of art-regards). Essa è però tanto cruciale quanto
problematica. Come distinguere infatti un modo corretto di considerare un’opera d’arte da
uno non corretto? Secondo Monroe Beardsley, nel fronteggiare questa domanda Levinson va
incontro a un dilemma insuperabile: o egli dà una caratterizzazione del concetto di correttezza
in termini estetici (e quindi rimane vincolato a una definizione funzionale dell’arte), oppure
costruisce una lista di tutti gli specifici modi di considerazione che sono stati adottati nel
passato; ma essendo tale lista indefinitamente ampia, essa permetterà in futuro ad ogni
oggetto di diventare un’opera d’arte, e in tal modo renderà la definizione storico-intenzionale
inutilizzabile 103.
Riguardo al primo corno del dilemma, Levinson riconosce l’importanza e la difficoltà dello
stabilire quali siano i modi “corretti” (ovvero “ammissibili, validi, appropriati”) di considerare
l’arte in un dato momento. Tuttavia egli ritiene che caratterizzare tali modi in termini
unicamente estetici, come vorrebbe Beardsley, sarebbe alquanto riduttivo: i modi di
relazionarsi a un’opera d’arte e di interagire con essa “variano ed evolvono da un periodo 102 S. Davies, Definitions of Art, cit., pp. 177-78. 103 Monroe Beardsley, “Redefining Art”, in M. Beardsley, The Aesthetic Point of View, Cornell University Press, Ithaca (NY) 1982, pp. 301-2.
42
all’altro, da una forma d’arte all’altra, da un genere a un altro”, e non possono certo essere
circoscritti all’apprezzamento estetico. Ma soprattutto, Levinson ribadisce che non è né
compito né interesse della sua definizione lo specificare quali siano i modi corretti di
considerare l’arte. Alla definizione storico-intenzionale è sufficiente presupporre che in ogni
periodo storico vi sia una verità circa quali oggetti sono opere d’arte e circa quali sono i modi
corretti di considerarli; a partire da tale dato di fatto relativo all’arte del passato e in relazione
ad esso, la definizione storica ci dice che cosa è arte successivamente a tale periodo.
Ovviamente “più è confuso tale dato di fatto in un determinato periodo, più sono confusi i
limiti relativi a ciò che si può considerare come arte in un periodo successivo”: ma questa è
una conseguenza accettabile, in quanto rispecchia “il modo in cui stanno le cose”. Già in
precedenza Levinson aveva affermato che il concetto di opera d’arte in un momento t deve
essere spiegato in relazione all’estensione dell’espressione ‘opera d’arte’ in un momento t’
precedente t; ora egli aggiunge, in seguito alle critiche di Beardsley (che si rivelano in tal
senso costruttive), che tale estensione riguarda non solo l’insieme delle opere prodotte in t’
sul cui status artistico c’è un consenso generale, ma anche l’insieme dei relativi e appropriati
modi di considerazione 104.
Riguardo al secondo corno del dilemma, Levinson concorda con Beardsley sul fatto che
una lista di tutti gli specifici modi corretti di considerare l’arte del passato sarebbe assai
difficile da costruire. Tuttavia, di nuovo, la definizione storica non necessita che tale lista sia
determinata ed esaustiva; piuttosto essa presuppone che vi sia una lista potenziale di tali modi,
dalla quale partire per catturare il concetto di arte nel presente. Inoltre non si corre il rischio
che in futuro ogni cosa potrà diventare un’opera d’arte, in quanto (come già detto) i modi di
considerazione vanno presi nel loro insieme (relativamente completo) e non isolatamente.
Infine, dovendo affrontare la questione generale, sollevata da Beardsley, dell’utilizzabilità di
una definizione dell’arte, Levinson sostiene che l’uso pratico ha poco a che fare con le
definizioni filosofiche: una definizione dell’arte non è un vademecum con cui stabilire se un
dato oggetto sia o meno un’opera d’arte. Se poi alle regole astratte fornite dalla definizione si
uniscono delle conoscenze storiche, contestuali e intrinseche relative all’oggetto in questione,
allora ogni definizione dell’arte sarà utilizzabile nel senso inteso da Beardsley, ovvero sarà in
grado di permetterci di stabilire se il dato oggetto rientra o meno nel campo delle opere d’arte.
Se invece più correttamente si identifica l’utilizzabilità di una definizione con la sua fertilità
104 J. Levinson, “Refining Art Historically”, cit., pp. 48-50.
43
teoretica, allora in tal senso la definizione storico-intenzionale deve ancora essere messa alla
prova 105.
Sempre intorno alla questione della correttezza dei modi di considerazione, Stephen Davies
osserva che Levinson, dal momento che si rifiuta di identificare i modi corretti di considerare
l’arte con i modi di apprezzamento estetici indicati da Beardsley (per il quale l’arte è
contraddistinta dalla capacità di produrre delle esperienze estetiche di un certo livello), e non
potendo allo stesso tempo identificare i modi corretti con i modi più adatti a capire e
apprezzare l’arte (pena la circolarità della definizione), di conseguenza si trova costretto ad
ammettere che lo standard di correttezza è socialmente determinato, con ciò ricadendo in
quelle teorie istituzionali da cui egli prende esplicitamente le distanze 106. Levinson conviene
con Davies nel ritenere che una teoria storica dell’arte non possa fare a meno di riconoscere la
dimensione sociale dei modi corretti di percepire e apprezzare, oltreché di produrre, l’arte.
Tuttavia questo non significa che esistono delle regole universali socialmente (cioè in termini
di procedure istituzionali, come vorrebbe Davies) o intrinsecamente (ovvero in termini
estetici, come vorrebbe Beardsley) determinate e tali da stabilire lo standard di correttezza;
esistono solo, secondo Levinson, dei modi di considerare l’arte corretti in quanto storicamente
riconosciuti e affermatisi come tali, e questo dato di fatto rappresenta l’unica dimensione
sociale che la definizione storica riconosce all’arte 107.
La questione non è però ancora del tutto risolta. Levinson afferma infatti a più riprese che i
modi di considerazione ai quali l’intenzione dell’artista è diretta, oltreché essere corretti,
devono anche formare un insieme relativamente completo. Ma come possiamo determinare
tale completezza? Graham Oppy propone tre possibili soluzioni al problema, ciascuna delle
quali è però a suo avviso destinata al fallimento. Si può innanzitutto ipotizzare che un insieme
relativamente completo dei modi di considerazione sia formato da un sufficiente numero dei
singoli modi in cui le opere d’arte sono state fino ad oggi considerate. Come stabilire però con
esattezza tale numero? Inoltre, anche un fenomeno naturale come le nuvole, alle quali
possono essere attribuiti senza dubbio numerosi (e quindi probabilmente sufficienti) predicati
estetici, sarebbe in grado di soddisfare una siffatta condizione di completezza dei modi di
considerazione: ma non per questo le nuvole diventerebbero delle opere d’arte! Si potrebbe
105 Ivi., pp. 50-52. Questo è quanto sosteneva Levinson nel 1989. Oggi, a quasi vent’anni di distanza da tale affermazione e a quasi trenta dalla pubblicazione di “Defining Art Historically”, è ormai possibile valutare la fertilità teoretica (e quindi anche l’utilizzabilità) della definizione storico-intenzionale dell’arte: il che è proprio l’obiettivo primario del presente lavoro di ricerca. 106 S. Davies, Definitions of Art, cit., pp. 173-74. 107 J. Levinson, “Extending Art Historically”, cit., pp. 161-62.
44
allora supporre che un insieme relativamente completo sia costituito dai modi “cruciali” in cui
le opere d’arte sono state finora considerate. Ma come dar conto allora dell’Arte Concettuale,
la quale ha fatto totalmente a meno dei modi di considerazione da tutti ritenuti cruciali per le
opere del passato? Non rimane quindi che provare con una definizione formale di
completezza: l’insieme relativamente completo dei modi di considerazione è un insieme
strutturato di tali modi, e non coincide con la mera somma di essi. Ma, di nuovo, l’arte
concettuale difficilmente può soddisfare tale condizione di completezza: un’opera come
Fountain di Duchamp sfugge a qualsiasi insieme dei modi (siano essi sufficienti, cruciali o
strutturati) di considerare l’arte del passato (remoto e recente) 108.
Levinson concorda con la terza delle soluzioni proposte da Oppy: un insieme relativamente
completo è “un insieme strutturato e interrelato dei singoli modi di considerazione che sono
stati accordati, nella loro totalità, ad alcune opere d’arte o ad alcuni generi artistici del
passato”. Tuttavia Levinson ritiene anche che tale soluzione non incorra nel problema posto
dall’arte concettuale; problema che egli ha già affrontato e a suo parere risolto
precedentemente, laddove ha specificato che le forme d’arte rivoluzionarie in genere (e quella
concettuale in particolare) intrattengono anch’esse una relazione con l’arte del passato,
sebbene si tratti di una relazione negativa, ovvero di contrasto, piuttosto che positiva, ovvero
di evoluzione 109.
Riassumendo, Levinson sembra fornire delle risposte adeguate ai problemi tra loro
collegati della correttezza e della completezza dei modi di considerazione. A una più attenta
analisi si può però rilevare come le soluzioni del filosofo americano inneschino degli ulteriori
problemi che saranno ancor più difficili da risolvere. Riguardo alla questione della correttezza
dei modi di considerazione, Levinson risponde che tale correttezza è un dato di fatto, una
verità storica, e non un criterio definibile in termini estetico-funzionali o istituzionali. Così
facendo egli espone però la sua teoria a un’ulteriore critica, che alcuni autori articoleranno in
maniera più dettagliata, e che mette in dubbio la legittimità di fondare una definizione
filosofica dell’arte su un elemento contingente come la storia dell’arte. Riguardo alla
questione della completezza dei modi di considerazione, pur accettando la giustificazione che
Levinson dà dell’arte concettuale e rivoluzionaria (sulla quale comunque torneremo ancora),
ciò che appare problematico è a mio avviso la connotazione formale che egli attribuisce (sulla
scorta dei suggerimenti di Oppy) alla condizione di completezza. Un insieme strutturato e
interrelato di modi di considerazione, presi nella loro totalità non sommativa, altro non è che
108 G. Oppy, “On Defining Art Historically”, cit., pp. 155-57. 109 J. Levinson, “Art Historically Defined: Reply to Oppy”, cit., pp. 382-83.
45
un insieme organico, e l’organicità è un concetto estetico: lo spettro del funzionalismo allora,
sebbene allontanato dalla definizione storica fino a ché essa deve rispondere solo della
correttezza dei modi di considerazione dell’arte del passato presi separatamente, ritorna
minacciosamente allorquando si passa alla descrizione della struttura delle connessioni tra i
modi di considerazione stessi. Inoltre ogni insieme organico prevede una gerarchia interna che
stabilisce un ordine tra le parti costituenti (nel nostro caso, i modi di considerare l’arte del
passato) in base alle loro specifiche funzioni: ciò significa che tra i correct art-regards ve ne
sono alcuni più “cruciali” di altri. Il problema allora non è risolto, ma solo rimandato.
C) MARS ATTACKS
Il nodo lasciato irrisolto dalla questione della correttezza dei modi di considerazione è
stato ripreso da Gregory Currie, il quale sostiene che “le teorie storiche falliscono in quanto
considerano come essenziale per l’arte ciò che invece è contingente”, ovvero la storia dell’arte
della nostra civiltà. A sostegno di tale tesi Currie cita il seguente esempio: “Supponiamo di
trovare, tra i resti di una civiltà marziana scomparsa, degli artefatti molto simili ad alcune tra
le più radicali e innovative opere d’arte del nostro attuale secolo. Supponiamo anche che tali
oggetti siano stati considerati e usati dai marziani all’incirca negli stessi modi in cui noi
consideriamo e usiamo la nostra arte. Essi dovrebbero essere annoverati come arte. Lo sono
però secondo una teoria storica pura?”. Per rispondere affermativamente a tale domanda,
Levinson dovrebbe ammettere che un oggetto possa essere un’opera d’arte anche quando
venga intenzionalmente e correttamente collegato a successive (anziché a precedenti) opere
d’arte della nostra civiltà. Tuttavia, pur facendo questa concessione, si dovrebbe ritenere che
“i marziani non avrebbero potuto sapere che i loro oggetti erano opere d’arte fino a quando gli
esseri umani non avessero raggiunto il giusto risultato”, ovvero fino a quando l’arte non
facesse la sua comparsa nella nostra civiltà e non avesse raggiunto la sua fase più evoluta e
sperimentale; il che, secondo Currie, è palesemente contro-intuitivo 110.
Levinson ammette di dover “liberalizzare” la sua teoria per far sì che essa possa dar conto
anche del caso presentatogli da Currie; tuttavia il tipo di liberalizzazione acconsentita è
diversa da quella suggeritagli da quest’ultimo. Secondo Levinson si può a ragione ritenere
che, nel caso sopra esposto, le opere dei marziani fossero arte al momento dello loro
creazione, ma non in virtù di un loro riferimento intenzionale al futuro (ovvero alle opere
d’arte di una civiltà, la nostra, che è venuta dopo la loro), bensì attraverso un loro riferimento
intenzionale ad oggetti ad essi precedenti e facenti parte della medesima tradizione (il che 110 G. Currie, “Aliens, Too”, Analysis 53 (1993), pp. 116-18.
46
equivale a dire che le opere d’arte marziane moderne sono arte in quanto collegate
intenzionalmente ad opere d’arte marziane ad esse precedenti), oppure in quanto sono state
create per essere considerate in un modo assai simile a quello in cui le opere della nostra
tradizione artistica sono considerate. Pur facendo tale liberalizzazione, rimarrebbe il fatto, non
gradito a Currie, che i marziani non sarebbero stati coscienti di aver prodotto arte nel nostro
senso. Tuttavia, specifica Levinson, essi sarebbero comunque stati coscienti di aver prodotto
*arte*, ovvero arte nel loro senso − la quale ha in comune con la nostra arte la stessa struttura
di riferimento storico-intenzionale ed è probabilmente anche simile ad essa in molti aspetti.
Ciò che una teoria storica richiede ai propri oggetti affinché siano definibili come artistici non
è che essi stiano effettivamente in relazione con alcuni oggetti della nostra tradizione artistica,
ma solamente che siano relazionabili con questi − laddove la relazionabilità è ascrivibile a una
identità strutturale (entrambi gli insiemi di oggetti sono definiti da un medesimo processo di
riferimento storico-intenzionale al passato della tradizione di appartenenza) o a una
somiglianza sostanziale (ovvero alla somiglianza tra i modi di considerazione relativi agli
oggetti delle rispettive tradizioni) 111.
A quanto detto da Levinson si può aggiungere anche, come fa Stecker, che il fatto che i
marziani non fossero consapevoli che gli artefatti da loro creati erano già opere d’arte nel
momento in cui venivano prodotte, non è poi così contro-intuitivo: infatti “sotto questo
aspetto essi non sarebbero diversi dagli antichi Egizi o dai Greci, i quali pure non erano
capaci di applicare alle loro opere il nostro concetto di arte” 112. Levinson sembra quindi al
riparo da quelli che, prendendo a prestito il titolo di un noto film di Tim Burton, ho chiamato
‘attacchi dei marziani’: tuttavia, come osserva ancora Stecker sulla scia di alcune
considerazioni di S. Davies, oltre alla tradizione marziana, che rimane nel campo della pura
ipotesi speculativa, la definizione storica deve dar conto soprattutto delle varie tradizioni
artistiche che si sono sviluppate nel nostro mondo pur provenendo da origini differenti l’una
dall’altra. Levinson deve ancora dimostrare che la sua teoria è in grado di spiegare che cos’è
che unisce queste diverse tradizioni e fa sì che esse siano tutte parimenti delle tradizioni
artistiche.
111 J. Levinson, “The Irreducible Historicality of the Concept of Art”, cit., pp. 19-21. 112 R. Stecker, “Alien Objections to Historical Definitions of Art”, British Journal of Aesthetics 36 (1996), p. 306.
47
D) OPERE D’ARTE E ARTEFATTI
In Intention, History, and Artifact Concepts, Paul Bloom elabora una teoria degli artefatti
molto simile alla teoria dell’arte di Levinson. Bloom non muove quindi nessuna critica alla
definizione storico-intenzionale, ma cerca anzi di estenderne la validità anche al di fuori
dell’ambito artistico. In questo tentativo si nasconde però un pericolo piuttosto serio, che lo
stesso Levinson non esita a riconoscere: se infatti la definizione storica dell’arte diventasse
così ampia da abbracciare qualsivoglia tipo di artefatto, “cosa rimarrebbe della speciale
storicità del concetto di opera d’arte, in quanto opposta a quella di sedia, di penna, di casa o di
altri artefatti tipici?” 113
Il parallelismo tra le due teorie è rilevabile a partire dalle rispettive genesi, che presentano
delle forti analogie tra di loro. Come Levinson prende le mosse dalla svolta anti-essenzialista
degli anni Cinquanta condotta da Weitz e compagni − i quali per primi misero in discussione
la possibilità di definire un concetto aperto come quello di arte facendo appello ad alcune
proprietà esibite comuni a tutti gli oggetti artistici (come volevano invece le teorie estetiche
tradizionali) − così Bloom cerca un’alternativa alle teorie prototipiche − le quali inferiscono
l’appartenenza di un oggetto a un determinato concetto di artefatto dalla condivisione di
proprietà osservabili (quali l’assolvimento di una data funzione, l’uso corrente e l’apparenza
esteriore). E come le teorie funzionali sono state messe in crisi da opere d’arte radicali e ‘di
confine’ come i ready-made, così le teorie prototipiche hanno incontrato delle serie difficoltà
nel dar conto di alcuni casi limite − Bloom fa l’esempio di un orologio rotto, il quale pur non
essendo in grado di assolvere la funzione per la quale è stato creato (ovvero quella di segnare
il tempo) e che, secondo le teorie prototipiche, determina la classe di artefatti alle quali esso
va ricondotto, ciononostante viene comunemente percepito come un orologio e non come
qualcos’altro.
Bloom cerca allora di seguire una strada alternativa a quella segnata dalle teorie
prototipiche e, prendendo spunto dalla definizione storica dell’arte di Levinson, propone la
seguente definizione di artefatto: “l’estensione dell’artefatto di tipo X è costituita da tutte
quelle entità che sono state con successo create con l’intenzione di farle rientrare nello stesso
tipo di presenti e passati X”. Non vi sono quindi, secondo Bloom, caratteristiche esteriori o
proprietà funzionali che siano essenziali alla definizione degli artefatti; piuttosto, dalla
conoscenza di “come determinati oggetti tipicamente appaiono o tipicamente sono utilizzati”
possiamo solo inferire una determinata intenzione da parte di chi li ha creati, e in virtù della
relazione tra l’intenzione dell’artefice e il risultato della sua attività produttiva possiamo (o 113 J. Levinson, “The Irreducible Historicality of the Concept of Art”, cit., p. 30.
48
meno) definire gli oggetti dati come artefatti di uno specifico tipo. La definizione storico-
intenzionale degli artefatti permette a Bloom di dar conto dei casi atipici rappresentati da
quegli oggetti che, pur rispondendo alla stessa funzione assolta da oggetti appartenenti allo
stesso tipo di artefatti X, differiscono esteriormente da questi: tali oggetti sono da considerare
come appartenenti alla classe di artefatti X se vengono percepiti (in virtù di fattori come
appunto l’assolvimento di una funzione o il loro uso corrente) in continuità con oggetti
presenti e passati appartenenti alla classe X − se vengono percepiti cioè come “versioni
futuristiche plausibili” di oggetti precedentemente costruiti e appartenenti alla stessa classe di
artefatti. Ciò che in ultimo distingue la teoria prototipica degli artefatti da quella storico-
intenzionale è il fatto che per la prima la similarità, funzionale o fisica, è importante di per sé,
mentre per la seconda tale similarità conta solo in quanto base da cui inferire una relazione di
continuità e di evoluzione (in termini di perfezionamento, o più in generale di mutamento,
della struttura fisica o della capacità di assolvere una funzione) tra gli oggetti appartenenti allo
stesso insieme di artefatti 114.
Come si può facilmente vedere, i punti di contatto tra la teoria di Bloom e quella di
Levinson sono davvero molti, e quindi il rischio che la specificità del concetto di storicità
delle opere d’arte si perda e si confonda con la nozione storica degli artefatti è concreto e
insidioso. Tuttavia tra le due teorie esistono anche delle sensibili differenze, puntualmente
sottolineate da Levinson. La prima differenza salta immediatamente agli occhi osservando da
vicino la due definizioni: quella di Bloom contiene infatti una “condizione di successo
minimo” che non compare in quella di Levinson. Secondo questi un’opera d’arte non
necessita, per essere tale, che l’intenzione del suo artefice sia realizzata con successo (e in ciò
sta la possibilità che si dia una “cattiva” arte); viceversa un oggetto, per essere classificato ad
esempio come un orologio, deve segnare correttamente lo scorrere delle ore e dei minuti. Un
orologio rotto (per tornare a un esempio precedente) è comunque un orologio in quanto è
percepito come la trasformazione di un oggetto che al momento della sua creazione assolveva
la sua funzione originaria del segnare il tempo; viceversa, una “cattiva” opera d’arte è arte
anche se non è in grado di soddisfare, né ora né mai, alcuna funzione estetica. La seconda e
forse più importante differenza consiste nel fatto che la produzione di un artefatto di un certo
tipo presuppone anche che ci sia un concetto sostanziale di ciò che deve essere prodotto:
ovvero, affinché un oggetto diventi un artefatto di un certo tipo occorre che esso sia creato
con l’intenzione di rispettare determinate caratteristiche rilevanti e sostanziali che
114 Paul Bloom, “Intention, History and Artifacts Concepts”, Cognition 60 (1996), pp. 1-25.
49
costituiscono il corretto concetto del tipo di artefatto che si vuole creare. A ciò si potrebbe
controbattere che anche nell’arte (quantomeno in quella tradizionale) ci sono dei concetti
sostanziali di ciò che si vuole creare − quasi sempre l’artista già in partenza conosce quali
tecniche dovrà utilizzare in relazione al materiale adoperato e si prefigge determinati scopi da
raggiungere (che nella maggior parte dei casi sono la verosimiglianza, la bellezza, o
l’espressione di emozioni). Tuttavia i concetti di cui si serve l’artista sono, secondo Levinson,
“relativamente insostanziali” se paragonati a quelli che guidano la produzione di artefatti
come le sedie, gli orologi, ecc., in quanto condizionano in maniera minima l’operare
dell’artista, il quale procede senza un’idea precisa circa quale forma o scopo o contenuto la
sua opera dovrà avere. L’arte è un’attività, insieme creativa e critica, aperta e indefinita, nel
corso della quale si succedono senza soluzione di continuità fasi alterne di “realizzazione e
valutazione”, o di “fare e disfare”. Per questo motivo solo l’arte, conclude Levinson, è
definibile attraverso una relazione storico-intenzionale pura, ovvero non contaminata da
considerazioni di carattere funzionale 115.
La definizione storica dell’arte di Levinson non è quindi totalmente assimilabile alla
definizione storica degli artefatti di Bloom. Fino a che punto però essa può dirsi al riparo dalla
deriva funzionalista verso la quale l’analogia con la teoria degli artefatti poteva trascinarla?
Per rispondere a questa domanda devono ancora essere prese in esame altre pressanti
obiezioni, di fronte alle quali la definizione storico-intenzionale dell’arte rischierà di
naufragare, trascinando con sé anche la sua figlia legittima, ovvero la definizione storica degli
artefatti.
2.3 No comment
La parte forse più stravagante della definizione di Levinson è costituita dalla proprietary-
right condition, di cui non c’è traccia in nessun’altra definizione dell’arte di tradizione
analitica. Secondo Levinson, per poter creare un’opera d’arte bisogna innanzitutto essere i
legittimi proprietari del materiale su cui si lavora. Che questa possa essere una condizione
necessaria all’artisticità è stato messo in discussione da più autori attraverso una serie di
contro-esempi difficilmente respingibili. Si prenda ad esempio la cosiddetta graffiti art: gli
autori dei graffiti di certo non possiedono le mura sulle quali dipingono, e sovente non hanno
nemmeno un permesso pubblico che consenta loro di fare quel che fanno: questo tuttavia non
115 J. Levinson, “Artworks as Artifacts”, in Id., Contemplating Art, cit., pp. 27-37.
50
impedisce loro di dar vita a delle opere d’arte, talvolta anche di buon livello (Jean Michel
Basquiat né è la prova). Si potrebbe però replicare che Basquiat rappresenta un caso atipico e
non racchiudibile nella graffiti art (il che probabilmente è vero), e ritenere che i cosiddetti
graffitari non abbiano intenzioni artistiche serie, i loro disegni essendo solo la manifestazione
di un disagio sociale e il tentativo di una ribellione all’ordine costituito (il che è molto più
discutibile). Ma, si chiede Noel Carroll, che cosa diremmo se Picasso fosse stato un graffitaro
e avesse dipinto il suo celebre Ritratto di Dora Maar sullo sportello di una metropolitana? Di
certo saremmo ancora di fronte a un’opera d’arte, anche se non di proprietà del suo autore 116.
La verità è che, in generale, “le questioni di legalità sono indipendenti dallo status artistico” 117. Inoltre la condizione del diritto di proprietà, oltre ad essere irrilevante, talvolta è anche
difficile da verificare. “Un compositore può scrivere una sinfonia e quindi possederne lo
spartito, i diritti di produzione e di utilizzo dello spartito, e via di seguito”, osserva Davies,
“ma al di là di questo in che senso possiamo dire che il compositore possiede il materiale di
cui la sinfonia è costituita?” 118
Levinson non risponde né a questi né ad altri contro-esempi, e forse tacitamente acconsente
a rinunciare del tutto alla proprietary-right condition.
2.4 Risposte deboli
Della condizione del diritto di proprietà si può tranquillamente fare a meno. Il cuore della
definizione di Levinson è altrove, e sta nell’intenzione dell’artista che il proprio oggetto sia
considerato negli stessi modi in cui precedenti opere d’arte sono state correttamente
considerate. La maggior parte degli attacchi che sono stati indirizzati a Levinson hanno
cercato di colpire al cuore la sua definizione. Alcuni sono stati respinti o schivati, altri l’hanno
colpito solo di striscio. Altri ancora però, come vedremo fra poco, hanno centrato il bersaglio.
A questi ultimi Levinson ha opposto una strenua difesa, ma le ferite procurate non erano
ormai più rimarginabili. Levinson ha allora cercato di modificare la sua definizione in modo
da renderla immune a qualsiasi tipo di critica, ma l’operazione non è stata indolore. Il cuore
ha ricominciato a battere, ma il paziente, al risveglio, non è stato più in grado di riconoscersi.
Dividerò quest’ultimo gruppo di critiche in due insiemi: il primo contesta la sufficienza
della condizione storico-intenzionale, che secondo la definizione di Levinson garantisce
116 N. Carroll, Philosophy of Art, cit., p. 245. 117 N. Carroll, “Identifying Art”, cit., p. 32. 118 S. Davies, Definitions of Art, cit., p. 176.
51
l’artisticità di un oggetto; il secondo ne mette in dubbio la necessità. In questo paragrafo mi
occuperò del primo insieme di critiche, le quali prendono le mosse dalla seguente domanda:
può il riferimento intenzionale di un oggetto alla storia dell’arte essere sufficiente a fare di
esso un’opera d’arte? La ricerca di una condizione sufficiente è la ricerca di un motivo, di una
ragione che sia in grado di spiegare perché una determinata cosa è definibile in quella precisa
maniera, senza che si debbano cercare ulteriori motivi o ragioni. La definizione storico-
intenzionale non sembra in grado di fornire spiegazioni esaustive al fenomeno artistico
allorquando il nostro campo di indagine si sposti dalla tradizione artistica occidentale post-
rinascimentale (che costituisce la base della definizione di Levinson e, insieme, il suo
territorio eletto di applicazione) e risalga alle origini della nostra tradizione artistica, si
estenda fino ad abbracciare le tradizioni artistiche a noi lontane (in quanto non occidentali,
remote o anche solo immaginate) e infine si restringa all’operare individuale dell’artista. La
definizione storico-intenzionale non riesce a fornire delle ragioni sufficienti a catturare il
concetto di arte in nessuno di questi campi, e ci obbliga a cercare delle motivazioni ulteriori
che giustifichino l’applicazione di tale concetto. La ricerca di una motivazione non può che
assumere una forma interrogativa, e ci si chiede allora: A) perché le prime opere d’arte sono
arte? B) perché tradizioni artistiche aventi origini indipendenti sono artistiche? C) perché
l’intenzione di una persona è artistica? D) perché l’artista ha quella specifica intenzione?
A) IL PROBLEMA DELLE PRIME OPERE D’ARTE
Uno dei principali problemi per una teoria ricorsiva come quella di Levinson, la quale
afferma cioè che un oggetto è un’opera d’arte in virtù della relazione che intrattiene con opere
d’arte del passato, è rappresentato dalle prime opere d’arte, le quali devono essere arte per una
ragione diversa dalla relazione con l’arte precedente − dato che per definizione non c’è alcuna
opera d’arte che le possa precedere. Stephen Davies è l’autore che meglio di tutti ha esposto il
problema. Affinché un oggetto sia una prima opera d’arte, esso deve innanzitutto essere arte
al momento della sua creazione (se così non fosse, la definizione storica, dato che attribuisce
lo status di artisticità a un oggetto in virtù del suo riferimento intenzionale ad opere d’arte del
passato unanimemente riconosciute, sarebbe inutilizzabile); inoltre in tale momento non
devono esistere opere d’arte create precedentemente. Le prime opere d’arte vanno quindi
distinte tanto dai progenitori dai quali esse derivano (nonostante l’inevitabile similarità e
continuità con questi) quanto dalle cosiddette “mid-life arts”, ovvero da quelle opere il cui
status artistico viene conferito retrospettivamente (esse sono arte al momento del loro
riconoscimento, e non della loro creazione). Ovviamente anche le prime opere d’arte, per
52
essere riconosciute come tali, necessitano che la pratica e la conoscenza artistica siano
sufficientemente sviluppate; tuttavia il loro status artistico deve essere già presente prima
ancora di essere rilevato pubblicamente. “Riconoscere la prima arte come arte”, spiega
Davies, “è una questione che riguarda lo scoprire che cosa essa è (o è stata), e non di decidere
cosa essa sarà d’ora in avanti” 119.
Come affronta Levinson il problema delle prime opere d’arte? Innanzitutto egli fa una
certa confusione, rilevata da Davies, tra “first arts” (le prime opere d’arte) e “ur-arts” (ovvero
i progenitori non artistici della nostra tradizione artistica). Talvolta le tiene distinte, e sostiene
che le first arts sono arte “in un senso vicino ma non identico a quello attribuibile a tutto ciò
che successivamente è stato riconosciuto come arte, in quanto la loro artisticità consiste
nell’essere proiettate verso una considerazione che è stata correttamente accordata a
precedenti ur-arts (anziché a precedenti oggetti artistici)” 120. Ciò significa che le first arts e
le ur-arts invitano a modi di considerazione analoghi: ma allora per quale motivo, si domanda
Davies, bisogna sostenere che solo le prime sono state proiettate per tali modi di
considerazione, quando “l’intenzione proiettiva” viene dedotta da proprietà simili a quelle
esibite dalle seconde? 121 Quando invece Levinson identifica le prime opere d’arte con le ur-
arts, egli sostiene che esse meritino lo statuto di arte “non in quanto sono modellate sull’arte
precedente ma in quanto l’arte successiva e riconosciuta si è sviluppata a partire da esse”. Se è
così, obietta Davies, vuol dire che lo status delle prime opere d’arte viene stabilito a posteriori
e dipende dal futuro sviluppo della storia dell’arte: ma ciò negherebbe una delle condizioni di
definizione delle prime opere d’arte, e con essa annullerebbe anche la possibilità di una
definizione ricorsiva dell’arte, come precedentemente chiarito. Levinson aggiunge però
un’altra possibilità: le prime opere d’arte (ancora identificate con le ur-arts) sono arte anche
in quanto sono state create con lo scopo di sollecitare modi ricettivi ed esperienziali che si
riveleranno normativi per l’arte successiva. Tali modi sembrano consistere principalmente,
secondo Levinson, nell’attenzione alla finezza di esecuzione e nella valutazione della potenza
espressiva possedute da determinati oggetti. Davies sostiene che qui Levinson si avvicina alla
soluzione del problema: a definire le prime opere d’arte sono determinate proprietà che le
distinguono dai loro progenitori non artistici e che si sono perpetuate e perfezionate in
successivi oggetti, determinando così la formazione della nostra tradizione artistica. Davies
contesta a Levinson solo la scelta delle proprietà discriminanti: infatti tanto la finezza
119 Stephen Davies, “First Art and Art’s Definition”, Southern Journal of Philosophy 35 (1997), pp. 19-20. 120 J. Levinson, “Extending Art Historically”, cit., p. 169. 121 S. Davies, “First Art and Art’s Definition”, cit., p. 23.
53
esecutiva quanto l’espressività possono caratterizzare anche attività non artistiche (ovvero
sociali e soprattutto religiose) precedenti le prime opere d’arte 122.
In seguito alle osservazioni di Davies, Levinson ha ritenuto opportuno rimodellare la sua
definizione dotandola di una forma disgiuntiva tale da permetterle di dar conto anche dello
statuto delle prime opere d’arte. La definizione storica dell’arte così riformulata afferma che:
qualcosa è arte se e solo se a) soddisfa la definizione di base, oppure b) è un esempio di prima arte
− ovvero se è uno di quegli oggetti dai quali tutta l’arte rimanente, quella cioè che soddisfa la
definizione di base, ha origine 123.
Non è qui importante stabilire se le proprietà che definiscono le prime opere d’arte siano
quelle indicate da Levinson (finezza di esecuzione ed espressività) o se invece siano di altro
tipo. Ciò che invece bisogna sottolineare è il fatto che nella definizione dell’arte di Levinson
si è aperta una prima crepa, che si allargherà non appena l’orizzonte di indagine si aprirà
all’arte di altri mondi culturali, reali o immaginari.
B) TRADIZIONI REMOTE, MONDI LONTANI
Il problema delle origini dell’arte si moltiplica quando si volge l’attenzione alle diverse
tradizioni artistiche che si sono sviluppate nel nostro mondo a partire da basi differenti. La
definizione di Levinson si propone di catturare, per ammissione dello stesso autore, solamente
il nostro concetto di arte, ovvero il concetto di arte occidentale e post-rinascimentale. Pertanto
se un’altra tradizione culturale è artistica, essa deve esserlo nel nostro senso. Stephen Davies
si dichiara d’accordo su questo punto, ma aggiunge che, se non ulteriormente elaborata, la
posizione di Levinson rischia di arroccarsi su un pericoloso relativismo. Levinson infatti
relativizza il concetto di arte a ciò che Arthur Danto ha chiamato “mondo dell’arte”: tuttavia
ci possono essere “tanti mondi dell’arte indipendentemente generati quante sono le diverse
culture” esistenti nel nostro pianeta. Bisogna allora porsi la seguente domanda: come stabilire
se un’altra cultura è artistica nel nostro senso, ovvero se possiede il nostro concetto di arte? 124
Levinson ha risposto in questa maniera: un oggetto è un’opera d’arte in una cultura non
occidentale se risponde alla stessa “struttura di connessione” che contraddistingue e definisce
la nostra tradizione artistica − ovvero se è stato inteso dal suo creatore per essere considerato
122 Ivi., pp. 23-24. 123 J. Levinson, “The Irreducible Historicality of the Concept of Art”, cit., p. 18. 124 S. Davies, “Non-Western Arts and Art’s Definition”, in N. Carroll (ed. by), Theories of Art Today, University of Wisconsin Press, London 2000, pp. 210-213.
54
negli stessi modi in cui precedenti oggetti della stessa tradizione sono stati correttamente
considerati 125. La soluzione avanzata da Levinson non soddisfa però Davies, in quanto
esistono numerose attività umane non artistiche che procedono attraverso la medesima
struttura storico-intenzionale che caratterizza l’attività artistica. Occorre quindi ancora
specificare “che cosa fa dei vari mondi dell’arte dei mondi dell’arte” 126, ovvero, per usare le
parole di Stecker, “che cosa distingue le tradizioni artistiche dalle altre pratiche culturali
storicamente continue” 127. Victor Haines è ancor più radicale al proposito: una tradizione
culturale definita unicamente in relazione alla propria struttura di riferimento intenzionale
ricorsiva ed estrinseca (che non specifica cioè i modi di considerazione appropriati agli
oggetti di tale tradizione) non è solamente indistinguibile da altre tradizioni culturali continue
non artistiche. “Se una tradizione è teoreticamente vacua”, ovvero “se non contiene alcun
reale motivo per procedere da un elemento della tradizione a quello successivo”, allora “essa
non è neppure una tradizione” 128.
Prima ancora che venissero formulate tutte queste critiche, Levinson aveva in realtà già
ammesso che la soluzione ‘strutturalista’ fosse piuttosto debole, e che per giustificare
l’artisticità di alcuni oggetti appartenenti a tradizioni culturali non occidentali e extra-colte
non bastasse rilevare una similarità tra le intenzioni che guidano l’atto produttivo: ciò che più
conta è la somiglianza tra gli effettivi modi di considerazione ai quali tali oggetti sono
destinati e i modi di considerazione propri delle opere d’arte colte occidentali. Ora, sollecitato
dalle osservazioni di Davies, Stecker e Haines, egli si spinge ancora più in là e riconosce che
ci deve essere una base comune a tutte le tradizioni artistiche, occidentali e non: ciò significa
che le prime opere d’arte di ciascuna tradizione sono state create per essere considerate negli
stessi modi, e quindi per assolvere le stesse funzioni 129. Levinson può quindi rispondere alla
questione sollevata inizialmente da Davies solo pagando l’ “elevato costo” di ammettere
“l’esistenza di una condizione aggiuntiva per l’artisticità”, laddove tale condizione è di tipo
funzionale 130.
Il problema delle origini dell’arte diventa ancora più pressante se si prendono in
considerazione non solo le diverse tradizioni artistiche del nostro mondo, ma anche le
125 J. Levinson, “Extending Art Historically”, cit., p. 171. 126 S. Davies, “Non-Western Arts and Art’s Definition”, cit., p. 212 (corsivo mio). 127 R. Stecker, “Alien Objections to Historical Definitions of Art”, cit., p. 306. 128 V. H. Haines, “Recursive Chaos in Defining Art Recursively”, British Journal of Aesthetics 44 (2004), pp. 74-75. 129 J. Levinson, “The Irreducible Historicality of the Concept of Art”, cit., pp. 21-22. 130 R. Stecker, “Alien Objections to Historical Definitions of Art”, cit., p. 306.
55
tradizioni artistiche che potrebbero esistere in altri mondi possibili. Gregory Currie, che aveva
già affrontato la questione in Aliens, Too, la riprende e la approfondisce in un successivo
articolo intitolato A Note on Art and Historical Concepts. Egli osserva innanzitutto che le
definizioni storiche dell’arte sostengono non solo che l’applicazione del nostro concetto di
arte dipende da fattori storici e contingenti − il che non rappresenterebbe una vera alternativa
a quanto sostenuto dalle tradizionali teorie dell’arte − ma soprattutto che “la vera identità del
nostro concetto di arte dipende dalla storia”, e che “se avessimo avuto una differente storia
dell’arte, avremmo avuto un differente concetto di arte” − il che è invece piuttosto
problematico. Per poter sostenere che l’arte è un concetto storico in quest’ultimo “forte”
senso, una definizione storica come quella di Levinson necessita: a) di “un concetto di arte
che sia il nostro effettivo concetto, dove l’essere il nostro concetto dipende da qualche fattore
contingente della storia”; b) di “alcuni concetti (di arte) che avremmo potuto avere, se la
storia dell’arte fosse stata differente”; c) di “un concetto superiore che li leghi tutti insieme −
che mostri che essi sono tutti, di fatto, dei concetti di arte” 131.
Currie cerca di chiarire il significato di tali affermazioni con un esempio proveniente dalle
scienze naturali piuttosto che dalla cultura umanistica. Il nostro effettivo concetto di acqua è
determinato da fattori contingenti (sebbene non di natura storica) verificabili a posteriori: esso
dipende cioè dal fatto che la nostra “sostanza acquea” risulta composta da H2O. In un altro
mondo possibile la sostanza acquea potrebbe però essere composta da XYZ, piuttosto che da
H2O; in questo mondo vi sarebbe pertanto un concetto di acqua diverso dal nostro. Per poter a
questo punto affermare che si tratta in entrambi i casi di concetti di acqua e non di
qualcos’altro, occorre che esista un concetto di “sostanza acquea” determinato a priori da
caratteristiche generali e osservabili (quali ad esempio “l’essere senza sapore”, “l’essere
bevibile”, “il riempire laghi e fiumi”, ecc.), al quale ciascun differente concetto di acqua possa
far riferimento. Analogamente, se si sostiene che il concetto di arte è un concetto storico in
senso forte, allora dobbiamo supporre, oltre al fatto che il nostro concetto di arte (così come
quello di altri mondi possibili) sia determinabile a posteriori da fattori contingenti (che nel
nostro mondo sono di tipo storico), anche che esista un meta-concetto di arte (che possiamo
chiamare “artisticità”) parallelo al concetto di “sostanza acquea” e come questo determinabile
a priori, al quale i singoli concetti di arte dei diversi mondi reali o immaginari possano far
riferimento affinché possano tutti essere legittimamente considerati dei concetti di arte.
Ovviamente questo meta-concetto di arte (o artisticità) deve essere diverso dal particolare
131 G. Currie, “A Note on Art and Historical Concepts”, British Journal of Aesthetics 40 (2000), pp. 186-87.
56
concetto di arte del nostro mondo, altrimenti l’intero ragionamento sarebbe inutile. Le
difficoltà per la teoria di Levinson sono a questo punto evidenti. Se così stanno le cose, la
definizione storica dell’arte dovrebbe infatti ammettere un meta-concetto di arte determinato a
priori: ma ciò è proprio quanto gli storicisti negano, dal momento che prendono le mosse
proprio dal presunto fallimento di ogni tentativo di definire l’arte in termini di caratteristiche
esibite, stabilite a priori e comuni a tutte le opere d’arte. Inoltre, se tale concetto di
“artisticità” è necessario e fondante, non sarebbe più logico identificare con esso il nostro
concetto di arte e abbandonare quindi del tutto l’idea di definire l’arte storicamente? 132
Levinson ritiene che Currie faccia erroneamente dipendere il concetto di arte di un dato
mondo dalla storia dell’arte in altri mondi possibili, laddove il concetto di arte non dipende
affatto dall’effettivo corso della storia dell’arte. Ciò che la teoria di Levinson riconosce è
solamente la dipendenza della possibile estensione delle opere d’arte al momento t dalla
effettiva estensione delle opere d’arte al momento t’ precedente t. Ciò significa che in mondi
diversi possono essere classificati come opere d’arte oggetti differenti, e ciononostante il
concetto di arte rimanere lo stesso, essendo esso determinato in ognuno dei vari mondi dal
medesimo processo di riferimento storico-intenzionale al passato. Pertanto l’analogia con il
concetto di acqua non funziona, poiché se in un altro mondo diverso dal nostro la sostanza
acquea fosse formata da XYZ anziché da H2O, noi non la considereremmo acqua nel nostro
senso; viceversa, se in un altro mondo fossero compresi tra le opere d’arte oggetti del tutto
diversi dalle nostre opere d’arte, noi gli attribuiremmo comunque l’appellativo di arte, a patto
che siano stati creati con l’intenzione di essere considerati negli stessi modi in cui precedenti
oggetti dello stesso mondo sono stati considerati. A questo punto però emerge un problema
del tutto simile a quello rilevato in precedenza da Davies: come facciamo a riconoscere negli
altri mondi possibili quali oggetti sono opere d’arte? Ovvero, come facciamo a identificare le
attività artistiche di un ipotetico mondo diverso dal nostro e distinguerle dalle attività non
artistiche dello stesso mondo caratterizzate da un analogo procedimento ricorsivo e
storicamente continuo? Levinson riconosce che ciò è possibile solo se i modi di
considerazione ai quali determinate attività di tale ipotetico mondo riferiscono
intenzionalmente i loro prodotti sono gli stessi che si sono affermati come normativi per la
nostre attività artistiche (ovvero i modi estetici, formali, espressivi, comunicativi). Affinché si
possa quindi affermare che un altro mondo possieda una propria tradizione artistica, occorre
che oltre ad una somiglianza strutturale con la nostra tradizione artistica vi sia anche una
132 Ivi., pp. 187-190.
57
somiglianza sostanziale 133. Ciò significa ribadire, anche se Levinson stenta ad ammetterlo,
che il puro riferimento storico-intenzionale non è una condizione sufficiente all’artisticità, in
quanto ad esso va affiancata una base normativa, ovvero una nozione qualitativa di artisticità.
Come ha suggerito Currie, la definizione storica dell’arte si rivela quindi “più dipendente da
criteri valutativi” di quanto Levinson sia disposto a riconoscere 134.
C) LO SCOPO DELL’ARTE
Torniamo, per così dire, con i piedi per terra − la nostra, cioè il mondo in cui viviamo − ed
escludiamo per ora dal nostro orizzonte tutto ciò che non rientra nella tradizione artistica
occidentale post-rinascimentale. Può l’intenzione rappresentare una condizione sufficiente
all’artisticità limitatamente a questo ambito?
Paul Bloom ha affrontato tale questione relativamente alla sua teoria degli artefatti, che
come abbiamo visto è molto simile alla definizione storica dell’arte di Levinson. Bloom si
trova a dover fronteggiare il seguente contro-esempio. Si immagini un uomo totalmente pazzo
che si mette ad ammucchiare con cura dell’immondizia pensando con ciò di aver realizzato
una sedia. Per quanto le intenzioni dell’uomo possano essere serie, non per questo
considereremo il mucchio di immondizia una sedia. Ma gli esempi possono essere tratti anche
dal mondo reale, compreso il mondo dell’arte. Nel 1972 l’artista concettuale Chris Burden si è
chiuso in un sacco e si è disteso su un’autostrada della California. Egli ha intitolato la sua
performance Deadman, presentandola a tutti gli effetti come un’opera d’arte: di certo però
molti di noi sarebbero restii a considerarla tale. Questi (ed altri) esempi hanno suggerito a
Bloom l’idea che per attribuire a qualcuno l’intenzione di creare un artefatto di un certo tipo è
necessario che vi sia una “significativa sovrapposizione concettuale” tra chi crea il presunto
artefatto e chi invece ne osserva le caratteristiche esterne e su queste riflette. Bloom esplicita
così la sua idea: “noi attribuiamo a qualcuno l’intenzione di creare un artefatto di tipo X solo
se assumiamo che le sue esperienze con oggetti del tipo X e le sue credenze relative alla
natura degli oggetti appartenenti al tipo X siano in larga parte coincidenti con i nostri”. In
altre parole, chi produce l’oggetto e chi lo giudica devono avere un simile schema concettuale
relativamente a una dato tipo di artefatti X, affinché sia possibile classificare tale oggetto tra
gli artefatti del tipo X. Nei due esempi sopra citati questa condizione non si verifica:
difficilmente si può parlare di opera d’arte nel secondo caso o di sedia nel primo 135.
133 J. Levinson, “The Irreducible Historicality of the Concept of Art”, cit., pp. 22-25. 134 G. Currie, “Aliens, Too”, cit., p. 118. 135 P. Bloom, “Intention, History and Artifacts Concepts”, cit., pp.19-20.
58
Ciò che è vero per Bloom lo sarà ancor di più per Levinson, la cui definizione dell’arte è
maggiormente legata (rispetto alla definizione storica degli artefatti) a una condizione di tipo
intenzionale. Se traduciamo allora le riflessioni di Bloom in termini artistici, otterremo la
seguente ulteriore condizione, dalla quale la condizione intenzionale non può prescindere: non
possiamo attribuire alcuna intenzione artistica a un dato individuo se non siamo d’accordo
con lui su che cosa significhi essere un’opera d’arte e su quali esperienze siano definibili
come artistiche. Ciò significa che la definizione storica di Levinson deve riconoscere al
concetto di arte anche una base sostanziale e qualitativa (costituita da una nozione funzionale
di arte, ovvero da un insieme di credenze condivise circa quali scopi l’arte debba assolvere e
in che modo essa sia in grado di assolverli) che sola può rendere possibile l’accordo
concettuale tra l’artista e lo spettatore e permettere a quest’ultimo di attribuire al primo
un’intenzione artistica. Non solo quindi l’intenzione non è una condizione sufficiente
all’artisticità in quanto necessita dell’aggiunta di una condizione funzionale-qualitativa, ma da
questa in ultimo dipende.
D) NELLA MENTE DELL’ARTISTA
La dipendenza della condizione storico-intenzionale da elementi qualitativo-funzionali non
è un’ipotesi così azzardata come a prima vista potrebbe apparire. Se restringiamo ancora di
più l’obiettivo e ci concentriamo sull’atto creativo del singolo artista, vedremo che è lo stesso
Levinson ad affermare quanto è stato da noi appena sostenuto.
In Refining Art Historically, come si è iniziato a vedere in precedenza, Levinson risponde
ad alcune obiezioni che Wollheim muove alla teoria istituzionale dell’arte e che, leggermente
modificate, possono essere rivolte anche contro la definizione storico-intenzionale. La più
importante di queste obiezioni afferma che la definizione istituzionale dell’arte (per la quale,
lo ricordiamo, un oggetto è un’opera d’arte se è stato proposto come candidato
all’apprezzamento da parte di esponenti del mondo dell’arte) si trova in un vicolo cieco di
fronte alla domanda se gli esponenti del mondo dell’arte abbiano o meno delle buone ragioni
per proporre un artefatto come candidato all’apprezzamento del pubblico. Se la risposta è
affermativa, tali ragioni dovranno essere esplicitate nella definizione: ma allora saranno esse a
costituire le condizioni di definizione dell’arte, e il conferimento di status di candidato
all’apprezzamento a un oggetto si ridurrà a un semplice atto di conferma di uno status già
stabilito. Se la risposta è negativa, ciò significa che gli esponenti del mondo dell’arte agiscono
senza alcun motivo: su quali basi possiamo allora ritenere che un esponente di tale mondo
(critico, gallerista, artista o altro), mentre compie l’atto di dirigere la nostra attenzione verso
59
un dato artefatto, stia proponendo tale artefatto per l’apprezzamento, se non possiamo
attribuirgli “una qualche idea su quali aspetti dell’artefatto dovremmo apprezzare” e non
possiamo credere che sia in virtù di tali aspetti che egli dirige la nostra attenzione verso di
esso? In parte connessa a tale obiezione c’è anche l’ulteriore accusa indirizzata da Wollheim
alla teoria istituzionale di violare l’intuizione comune secondo cui il valutare come buona
un’opera d’arte dipende dal classificarla come tale 136.
Tradotta nei termini della teoria di Levinson, la prima delle questioni poste da Wollheim
(che per la teoria di Dickie risulta fatale) assume la seguente forma: è necessario che una
persona (nella fattispecie il presunto artista) abbia delle buone ragioni per intendere che un
oggetto venga considerato come un’opera d’arte (ovvero negli stessi modi in cui precedenti
opere d’arte sono state considerate), affinché tale oggetto possa essere definito come artistico?
Secondo Levinson tali ragioni vi sono, anche se sono nascoste nella mente dell’artista; esse
consistono nella convinzione implicita dell’artista che, considerando un dato oggetto nel
modo da lui inteso, gli spettatori potranno provare un’esperienza di un certo valore. La
domanda diventa allora: è necessario che questa convinzione sia esplicitamente menzionata in
una definizione dell’arte? Da un lato, risponde Levinson, una tale specificazione appare
inutile, dal momento che l’arte, in quanto attività culturale, è fondamentalmente razionale, ed
è pertanto difficile pensare che un artista possa agire senza motivo alcuno. Inoltre spesso
l’avere un determinato effetto da parte di un’opera d’arte rientra nei modi di considerazione
intesi dal creatore dell’opera stessa. In altre parole, “intendere che qualcosa venga trattato
come precedenti opere d’arte sono state adeguatamente trattate equivale ad intendere che ci si
accosti a tale oggetto in determinati modi”, capaci di ripagare la nostra attenzione
procurandoci “determinate ricompense”. Tali ricompense, che sono ovviamente di tipo
esperienziale (come il ricavare piacere nel lasciarsi trascinare dalla successione dei diversi
motivi di un brano musicale, o il comprendere nuovi elementi della realtà nel seguire lo
svolgimento di un film), costituiscono una parte integrante dei modi in cui l’artista intende
che la propria opera venga considerata dal pubblico 137. Dall’altro lato però, visto che non tutti
i modi di considerazione rispondono a motivazioni di tal genere, può essere utile rendere
esplicita la sottintesa razionalità dell’agire artistico. La definizione va allora modificata nel
modo che segue:
136 R. Wollheim, Art and Its Objects, cit., pp. 157-66. 137 J. Levinson, “Refining Art Historically”, cit., pp. 54-55.
60
Un’opera d’arte è un oggetto che è stato seriamente inteso per essere considerato come un’opera
d’arte − ovvero per essere considerato (trattato, ecc.) in uno dei modi in cui precedenti opere d’arte
sono o sono state correttamente considerate, in modo tale che un’esperienza di un certo valore sia così
ottenuta 138.
L’ultima parte della definizione può essere sostituita con una più specifica, che Levinson
aggiunge in una nota: si avrà allora che un’opera d’arte è un oggetto che è stato seriamente
inteso … per essere considerato in uno dei modi in cui precedenti opere d’arte sono state
correttamente considerate, “in modo tale che un’esperienza dal valore in qualche modo simile
a quello offerto dall’arte precedente sia così ottenuta” 139. Con tale ulteriore “liberalizzazione”
della sua definizione, Levinson conferma quanto è stato a più riprese sottolineato: l’intenzione
non è una condizione sufficiente all’artisticità. Affinché un oggetto sia un’opera d’arte,
occorre infatti che l’intenzione di chi crea tale oggetto (o in generale di chi agisce, anche solo
concettualmente, su di esso) sia diretta alla produzione attraverso esso (attraverso cioè le sue
proprietà) di una determinata esperienza, ovvero alla produzione di un determinato effetto
(non meglio specificato da Levinson) nello spettatore. L’esperienza procurata deve essere “di
un certo valore”, ovvero di un “valore in qualche modo simile a quello offerto dall’arte
precedente”: è indubbio a questo punto che la definizione storica dell’arte non può fare a
meno di criteri valutativi. Levinson ricompone così quella cesura tra valutazione e
classificazione che era stata aperta dalla teoria istituzionale, ma al prezzo di trasformare la
propria definizione storica in una definizione proto-funzionale. Accanto, anzi al di sotto, della
condizione storico-intenzionale − l’intendere che un oggetto sia considerato come precedenti
opere d’arte sono state correttamente considerate − egli pone ora un’altra condizione per
l’artisticità, dalla quale la prima dipende. Si tratta abbastanza evidentemente di una
condizione funzionale-qualitativa − in quanto richiede che un oggetto procuri un’esperienza
di un certo valore − e solo indirettamente storico-relazionale − il valore dell’esperienza
procurata dall’oggetto in questione deve essere misurato in relazione al valore dell’esperienza
procurata dall’arte precedente: ma come determinare quest’ultimo, se non ricorrendo a criteri
funzionali, ovvero a ciò che Levinson voleva a tutti i costi che non rientrasse in una
definizione dell’arte?
138 Ivi, p. 56 139 Ibid.
61
2.5 Processo alle intenzioni
A questo punto è lecito chiedersi: se l’intenzione non è una condizione sufficiente
all’artisticità, e se per di più essa è subordinata a una condizione di tipo qualitativo-
funzionale, non potremmo considerare quest’ultima come l’unica condizione che debba
comparire in una definizione dell’arte e rinunciare del tutto alla prima? Detto in altro modo:
l’intenzione è davvero una condizione necessaria all’artisticità?
La questione è stata posta in maniera paradigmatica da Daniel Kolak in Art and
Intentionality, dove l’autore mette seriamente in crisi la capacità della definizione di Levinson
(e in generale di tutte le definizioni relazionali dell’arte, come anche quella istituzionale) di
fornire condizioni necessarie all’artisticità. Il perno della critica di Kolak è costituito da un
fatto realmente accaduto e riguardante nientemeno che il grande scrittore tedesco Franz
Kafka. E’ infatti noto che Kafka, nei suoi ultimi anni di vita, lasciò istruzioni scritte al suo
amico nonché curatore della pubblicazione delle opere postume, Max Broad, di bruciare tutti i
suoi manoscritti non ancora pubblicati. Tra questi vi erano Il Processo e Il Castello. Di sicuro
quindi Kafka non aveva l’intenzione che tali racconti fossero considerati nello stesso modo in
cui precedenti opere letterarie sono state correttamente considerate. Nonostante ciò, essi sono
sopravvissuti alle richieste del suo autore e ora fanno parte del patrimonio letterario
occidentale. Da questo episodio Kolak trae la seguente conclusione: l’intenzione di una
persona che un determinato oggetto sia considerato come un’opera d’arte non è una
condizione necessaria all’artisticità dell’oggetto. Il Castello e Il Processo sono opere d’arte
non per effetto delle intenzioni del loro autore, ma nonostante esse 140.
Come replicare a un’obiezione così forte e insieme fondata? Levinson ammette che si tratta
della critica più interessante che è stata mossa alla sua teoria, ed elabora una risposta
articolata in più punti, ciascuno dei quali viene però ribattuto con sicurezza da Kolak, il quale
farà arretrare ancora di più, come vedremo, la teoria di Levinson verso posizioni
funzionaliste. La prima replica poggia sul fatto che “si può osservare che senza dubbio vi era
un’intenzione artistica in diversi momenti prima, durante e dopo il periodo della
composizione”, e che non è detto che si debba automaticamente dare la priorità alle intenzioni
finali espresse dall’autore per decidere dell’artisticità della sua opera. Kolak ha alcune
considerazioni da fare al proposito. Innanzitutto, Levinson può solo presupporre che Kafka
abbia avuto delle intenzioni artistiche prima, durante e dopo la stesura dei racconti in
140 D. Kolak, “Art and Intentionality”, Journal of Aesthetics and Art Criticism 48 (1990), p. 158.
62
questione: pertanto egli risponde con degli argomenti ipotetici ad un esempio reale e concreto.
Inoltre, cosa vuol dire Levinson quando usa l’espressione “osservare che vi è un’intenzione”?
Non è affatto chiaro, secondo Kolak, come si possa “osservare” che un’artista abbia
un’intenzione. Se “osservare” viene usato nel senso di “notare”, allora dall’esame dei diari di
Kafka si possono “notare” solo affermazioni che suggeriscono come spesso egli scrivesse i
suoi racconti senza avere scopi letterari, bensì seguendo impulsi liberatori (di carattere
psicologico-esistenziale). Infine, come possiamo interpretare le intenzioni di artisti che, come
Kafka, sono sovente confusi circa quale sia la loro reale intenzione o sono addirittura
inconsapevoli di averne una? Levinson sostiene anche che Kafka potrebbe essere stato
internamente combattuto tra intenzioni e desideri contrastanti; oppure potrebbe aver destinato
alcune sue opere ad un pubblico di lettori ideali, ma vedendo che siffatti lettori non esistevano
al suo tempo e credendo che difficilmente sarebbero comparsi in futuro, egli espresse la
volontà di gettare tra le fiamme i suoi scritti. Anche questa risposta pecca però secondo Kolak
di ipoteticità, in quanto Levinson altera surrettiziamente un esempio reale per renderlo
compatibile con la sua teoria 141.
Levinson si avvicina alla soluzione del problema con la sua terza risposta, ma lo fa
pagando un dazio molto alto, come vedremo subito. Egli propone infatti di considerare il caso
dei racconti postumi di Kafka come uno di quei “casi anomali dove, per effetto
dell’eccezionale valore letterario potenziale in gioco, riconosciamo alla comunità di lettori e
di critici il potere di appropriarsi legittimamente di determinati testi e di proiettarli per una
considerazione letteraria, annullando così, in modo inusuale, l’intenzione dell’autore. Il testo
diventa allora letteratura, volenti o nolenti”. Si tratta di un’affermazione che rischia di far
saltare le fondamenta della definizione storica dell’arte. Kolak se ne accorge subito, ma prima
di accendere la miccia esplosiva fa due valutazioni preliminari. Egli sottolinea innanzitutto
come Levinson sembri essere prigioniero della sua visione intenzionale dell’arte: laddove non
è presente l’intenzione dell’artista, questa viene subito rimpiazzata dall’intento proiettivo del
pubblico. Inoltre, una volta che è stata riconosciuta la legittimità dell’intenzione del pubblico,
perché minarne la credibilità affiancandovi l’espressione “volenti o nolenti”, quando spesso in
realtà è l’intenzione degli artisti (che sono persone il più delle volte volubili, eccentriche e
inaffidabili) ad essere incerta? Ma tornando al nocciolo del problema, la risposta di Levinson
è secondo Kolak adeguata e credibile, ma porta con sé anche la negazione del perno della
definizione storica dell’arte. Con la risposta sopra citata, Levinson ammette infatti
141 Ivi., pp. 158-60. (Le citazioni di Levinson sono tratte da “Refining Art Historically”, cit., pp. 56-58, e sono riportate fedelmente nell’articolo di Kolak al quale facciamo riferimento)
63
esplicitamente che alcuni oggetti possono essere opere d’arte in funzione dell’effetto che essi
provocano nel pubblico per mezzo delle loro proprietà intrinseche e indipendentemente
dall’intenzione dell’artista, la quale non è più una condizione necessaria all’artisticità.
Levinson aggiunge anche che alla comunità di lettori è consentito scavalcare l’intenzione
dell’autore quando il testo è “disordinatamente apprezzabile come opera letteraria”, “inadatto
a qualsiasi altro impiego” (diverso dalla sua fruizione estetica) e “difficilmente non
considerabile come letteratura”. Ma cos’è che produce il valore letterario disordinato ma
eccezionale di un testo? A cosa si deve il suo (per usare le parole di Kolak) “sorprendente
potere estetico”? Non all’intenzione dell’autore o agli occhi degli spettatori, e nemmeno alle
decisioni delle istituzioni artistiche, bensì alle “qualità intrinseche esibite” del testo stesso:
sono esse che, sole, ci spingono, anzi ci costringono a definire il testo come un’opera d’arte
letteraria. E a nulla vale, secondo Kolak, il fatto che Levinson aggiunga ancora che il valore
letterario di opere come Il Castello o Il Processo di Kafka è solo “potenziale”, e che diventa
effettivo solo quando esse sono riconducibili a una qualche intenzione (dell’autore o del
pubblico). Nessuno infatti, conclude Kolak, leggendo un libro direbbe: “ciò che sto leggendo
è potenzialmente destabilizzante, potenzialmente evocativo, potenzialmente divertente … Gli
oggetti potenzialmente divertenti non fanno ridere, solo quelli reali ci riescono. Nell’esempio
de Il Processo è troppo tardi per gli effetti potenziali. L’effetto reale è già trapelato. Non è più
quindi un effetto potenziale ma uno reale”. La miccia è stata accesa 142.
L’accusa di Kolak è piuttosto forte, e Levinson si sente in dovere di tornare sul problema,
per nulla risolto con la prima risposta da lui elaborata e contenuta in Refining Art Historically.
Egli scrive quindi un altro articolo (A Refiner’s Fire: Reply to Sartwell and Kolak) dove tenta
di porre fine alla questione attraverso una serie di argomentazioni che analizzerò e
commenterò separatamente. La prima replica è di tipo filologico. Levinson, riprendendo in
mano alcune delle lettere contenenti dichiarazioni di Max Broad, vi scorge dei significativi
indizi che fanno seriamente pensare che Kafka avesse intenzioni letterarie, e non solamente
psicologico-esistenziali, riguardo ai suoi ultimi racconti come Il Processo e Il Castello.
Levinson arriva a queste conclusioni in particolare leggendo un documento in cui Broad
afferma che Kafka fosse assolutamente consapevole del fatto che Broad stesso non avrebbe
mai rispettato l’intenzione dello scrittore tedesco di far bruciare i suoi ultimi racconti.
Pertanto, “se egli avesse veramente voluto che questi desideri fossero esauditi, avrebbe
142 Ivi, pp. 160-61.
64
assunto un altro editore per le opere postume” 143. Sebbene queste dichiarazioni giochino
indubbiamente a vantaggio di Levinson, mi sembra tuttavia che si rimanga ancora nel
territorio dell’ipoteticità: di certo c’è solo che Kafka espresse formalmente la sua intenzione
di gettare alle fiamme i suoi ultimi scritti, al di là di eventuali e temporanei ripensamenti, ed è
su questo, credo, che si deve discutere.
La seconda replica si limita a recuperare una delle soluzioni già discusse in Refining Art
Historically ma colpevolmente trascurata da Kolak. Tale soluzione consiste nel proporre una
nozione secondaria (rispetto alla definizione storica) di arte, incentrata non già sull’aspetto
ricettivo quanto sul processo creativo dell’attività artistica, e stante alla quale “qualcosa è arte
se la sua realizzazione è il risultato di una delle classi di impulsi identificati come artistici, o
se la sua realizzazione si è risolta nel raggiungimento di certi stati o nella liberazione di
determinate energie da parte dell’autore” 144. In tal senso testi come Il Processo o Il Castello
di Kafka possono essere considerate opere d’arte letterarie in quanto, nonostante la rinuncia
del loro autore ad ogni interesse relativo alla loro diffusione e ricezione, essi sono comunque
“il frutto di processi psicologici caratteristici di molta arte riconosciuta”, “riflettono l’influsso
di molta letteratura precedente” e sono state realizzate in un modo “che di solito testimonia un
interesse per la possibilità di un successivo coinvolgimento di altre persone” 145. Tuttavia
questa versione secondaria della definizione della nozione di arte, oltre ad essere l’ennesima
liberalizzazione che Levinson fa della versione primaria della sua definizione e a suonare
come una soluzione ad hoc, non è nemmeno una proposta adeguatamente sviluppata, e nella
forma da lui presentata risulta poco convincente per almeno due motivi, puntualmente rilevati
da Robert Stecker. Innanzitutto risulta piuttosto difficile distinguere un impulso creativo
artistico da un altro tipo di impulso creativo. In secondo luogo, è altrettanto problematico
caratterizzare in modo unitario gli impulsi sottesi all’attività dei diversi artisti, dato che tali
impulsi hanno la loro base nel cervello umano 146.
Levinson non dedica molto spazio alla nozione secondaria di arte appena esaminata, in
quanto essa serve solo a dar conto di alcune eccezioni alla definizione primaria dell’arte, che è
e rimane quella storico-intenzionale. Kolak non si limita però a considerare l’esempio delle
opere postume di Kafka come una semplice eccezione alla teoria di Levinson. Egli ne fa
piuttosto un caso paradigmatico e sintomatico tanto del fallimento della definizione storica e
143 J. Levinson, “A Refiner’s Fire: Reply to Sartwell and Kolak”, cit., p. 234 (le dichiarazioni virgolettate sono in questo caso di Max Broad). 144 J. Levinson, “Refining Art Historically”, cit., p. 58. 145 J. Levinson, “A Refiner’s Fire: Reply to Sartwell and Kolak”, cit., p. 232. 146 R. Stecker, Artworks: Definition, Meaning, Value, Pennsylvania State University Press, University Park 1997, p. 95.
65
delle definizioni relazionali dell’arte in genere, quanto della necessità di trovare una valida
alternativa a tali definizioni. Ma l’alternativa Kolak ce l’ha già in tasca sin dall’inizio. Egli
infatti in Art and Intentionality esordisce con questa sorta di manifesto programmatico:
“alcuni oggetti, in virtù delle loro qualità intrinseche esibite, sono arte − indipendentemente
dall’intenzione dei loro creatori. Quando si vuole definire che cosa è arte, è l’effetto prodotto
dall’artista che conta, non la causa” 147. Queste affermazioni possono benissimo costituire la
base per una definizione dell’arte, che Levinson chiama “la teoria delle qualità esibite
(EQT)”. A questo punto Levinson passa al contrattacco, e critica la EQT in quanto essa: a)
non è in grado di giustificare la differenza tra bello naturale e bello artistico; b) non può dar
conto della cosiddetta cattiva arte; c) non specifica il tipo di spettatore al quale, sotto le
appropriate condizioni, le qualità di un dato oggetto e i relativi effetti saranno manifesti; d)
non riesce a dar conto di opere d’arte paradigmatiche del XX secolo come i ready-made, i
quali possono produrre effetti diversi, e quindi avere uno status ontologico totalmente diverso
da quello posseduto da oggetti percettivamente indistinguibili da essi; e) non può dare alcun
tipo di risposta al problema delle falsificazioni artistiche 148. Per tutti questi motivi, la EQT
appare palesemente fallace e pericolosamente restrittiva. Va però detto anche che, come
Levinson stesso ammette, Kolak non elabora una definizione dell’arte completa e sistematica,
ma ne abbozza solo le fondamenta: pertanto tenderei a considerare le critiche di Levinson
come un utile pro memoria delle difficoltà alle quali una teoria funzionale dell’arte (come
potrebbe essere la EQT) va inevitabilmente incontro, piuttosto che come prova definitiva
della falsità di una teoria che è appena accennata.
Tornando all’esempio delle opere postume di Kafka, l’argomentazione di Kolak si snoda
fondamentalmente in tre passaggi: 1) Il Processo (come anche Il Castello) di Kafka, grazie
alle sue qualità intrinseche esibite, produce in noi (ovvero in chi legge) determinati effetti
(esso, per usare le parole di Kolak, ci “provoca, confonde, stupisce” 149), 2) in virtù dei quali
attribuiamo al testo un alto valore letterario, 3) il quale a sua volta ci spinge a considerare il
testo in questione un’opera d’arte indipendentemente dall’intenzione dell’autore, anzi
nonostante essa (Kafka voleva infatti che Il Processo venisse bruciato dopo la sua morte). Per
respingere una volta per tutte le accuse di Kolak, Levinson deve mostrare l’infondatezza di
ciascuno dei passaggi nei quali l’argomentazione di Kolak si dipana, e questo è proprio ciò
che egli tenta di fare. Vediamo come.
147 D. Kolak, “Art and Intentionality”, cit., p. 158. 148 J. Levinson, “A Refiner’s Fire: Reply to Sartwell and Kolak”, cit., pp. 232-33. 149 D. Kolak, “Art and Intentionality”, cit., p. 161.
66
1) In considerazione unicamente delle proprie qualità intrinseche esibite − come l’essere
scritto in tedesco, il seguire un determinato disegno formale, ecc. − un testo come Il Processo
di Kafka può provocare effetti rilevanti in chi legge, ma non quegli specifici effetti indicati da
Kolak come qualificanti il testo in questione − difficilmente esso sarà in grado di provocarci,
confonderci, stupirci. L’opera produce questi (ed altri) effetti nei lettori in virtù non solo delle
sue proprietà intrinseche esibite (che sono perlopiù formali o estetiche), ma anche di proprietà
relazionali non esibite − come l’appartenere a un determinato genere letterario, l’essere
espressiva di pensieri ed emozioni, l’essere stata creata da una persona che proviene da un
determinato background culturale e che si confronta con i suoi predecessori, e via dicendo.
Un testo non può sprigionare l’intera gamma di effetti per i quali è stato scritto, finché non
viene compreso come “il prodotto di un particolare individuo che si esprime in un linguaggio
letterario sullo sfondo di un determinato contesto culturale, psicologico e religioso” 150.
2) Non solo gli effetti di un’opera d’arte non possono ricollegarsi alle sole proprietà
intrinseche esibite, ma gli stessi effetti, pur considerati nella loro totalità, non esauriscono il
valore dell’opera. Secondo Levinson, l’identificazione tra il valore artistico di un’opera e gli
effetti da essa provocati non regge. Il valore di un’opera d’arte non si riduce infatti agli effetti
che essa è in grado di generare, ma dipende anche dalle cause che producono tali effetti − esso
dipende cioè dalla categoria all’interno della quale l’opera è stata classificata, dal contesto di
produzione e ricezione nel quale è inserita, ecc. In linea teorica, gli stessi effetti generati da Il
Processo di Kafka potrebbero essere provocati in altro modo (ad esempio attraverso
l’assunzione di sostanze stupefacenti). Pertanto “niente è arte solamente in funzione dei suoi
effetti”: ciò che in ultimo ci permette di distinguere l’arte da altri fenomeni ugualmente
coinvolgenti (ovvero capaci di provocare effetti rilevanti per l’uomo) è l’individuazione del
corretto contesto di creazione, ovvero delle intenzioni (categoriali prima ancora che
semantiche) dell’artista e (secondariamente) dei processi formativi caratteristici dell’attività
artistica. Da ciò segue anche che non c’è niente di sbagliato, aggiunge Levinson, nel dire che
un testo ha valore letterario potenziale. Se quanto detto finora corrisponde al vero, allora non
si può attribuire a un testo un valore letterario reale se prima non si attribuisce al suo autore
l’intenzione che il testo da lui scritto sia considerato come un’opera letteraria − la quale
attribuzione dipende da fattori di carattere storico-contestuale e solo indirettamente da
proprietà intrinseche esibite e osservabili 151.
150 J. Levinson, “A Refiner’s Fire: Reply to Sartwell and Kolak”, cit., p. 233. 151 Ivi, pp. 232-34.
67
3) Pertanto, pur ammettendo che in alcuni casi (come quello de Il Processo di Kafka)
classifichiamo un testo come opera d’arte in virtù del suo valore letterario, l’intenzione
dell’autore non esce totalmente di scena. Essa rientra per così dire dalla porta di servizio,
influenzando in modo decisivo la percezione (da parte dei lettori) del valore letterario del
testo. Per apprezzare e giudicare correttamente un’opera d’arte − ovvero rispettivamente per
percepirne tutti gli effetti e per comprenderne il valore artistico − è infatti necessario inserirla
in una “matrice di azioni, pensieri e intenzioni” che le sole proprietà intrinseche esibite non
esauriscono 152. Il Processo di Kafka è classificato tra le opere d’arte per il suo valore
letterario e non per l’intenzione del suo autore; ma se quest’ultima non viene affatto presa in
considerazione, il valore letterario del testo non può essere compreso in tutta la sua pienezza.
Nemmeno in questo caso si può fare a meno dell’intenzione dell’artista per stabilire
l’artisticità dell’oggetto in questione. La tesi di Kolak si rivela in ultima analisi infondata.
Quanto c’è di vero nella conclusione di Levinson? Proviamo a riassumere il procedimento
da lui seguito. Sostanzialmente, Levinson contesta la validità della duplice equazione tra
effetto complessivo di un’opera d’arte e insieme degli effetti causati dalle qualità intrinseche
esibite da un lato, e tra valore artistico dell’opera ed effetto complessivo dall’altro. Egli ritiene
infatti che tanto l’effetto complessivo di un’opera quanto il suo valore artistico non possano
prescindere dal modo in cui l’opera si relaziona con le intenzioni del suo autore e con il
processo di produzione della stessa. Ciò significa che, tornando al nostro esempio, non si può
percepire l’intero effetto di un testo come Il Processo né comprenderne l’alto valore letterario
se prima non si realizza il modo in cui tale testo è stato concepito e creato − il che nel caso
concreto, data l’assenza di un’esplicita intenzione di Kafka (che anzi si esprime in senso
contrario), implica l’appropriazione metaforica del testo da parte di una comunità di lettori e
di critici e la proiezione dello stesso verso modi di considerazione adeguati a un’opera
letteraria. Tornando alle parole usate da Levinson nel passo precedentemente citato e tratto da
Refining Art Historically, si possono ora distinguere retrospettivamente due fasi che a prima
vista potevano sembrare unite. Inizialmente noi (in quanto generici lettori) scorgiamo un
valore letterario potenziale nel testo (ad esempio Il Processo di Kafka): in questa prima fase
gli unici effetti percepiti sono quelli causati dalle qualità intrinseche esibite (potremmo anche
dire dal testo bruto). Tale valore letterario, sebbene potenziale e incompleto (o, come direbbe
Levinson, disordinato), è comunque sufficiente a far sì che una comunità di lettori
(evidentemente preparati e competenti) e di critici si appropri metaforicamente del testo e,
152 Ivi, p. 234.
68
dalla considerazione delle sue proprietà intrinseche e del contesto storico-culturale in cui è
inserito, rilevi un’intenzione artistica dietro la sua realizzazione e lo proietti verso modi di
considerazione artistici. Solo in questa seconda fase la comunità letteraria è in grado di
comprendere e far emergere il reale valore letterario del testo, ed è per effetto di tale valore
che esso “diventa letteratura”, ovvero riceve la qualifica di opera d’arte.
Il ragionamento di Levinson è senza dubbio accurato e coerente, ma non immune da
ulteriori obiezioni, provenienti ancora da Robert Stecker. In che modo infatti, si chiede
Stecker, l’appropriazione metaforica di un testo e la sua proiezione verso modi di
considerazione artistici possono modificare l’effetto complessivo e il valore letterario di tale
testo? Vi sono due possibili risposte a questa domanda. In un primo senso, si può pensare che
l’appropriazione e la proiezione aggiungano delle proprietà (rappresentative, formali,
espressive, ecc.) al testo. Se così fosse, il pubblico di lettori e critici si sostituirebbe in tutto e
per tutto all’artista: ma allora si tornerebbe alla teoria istituzionale, per la quale è il mondo
dell’arte a decidere dello status di artisticità di un oggetto. Di certo non è questo l’intento di
Levinson, il quale con la sua definizione storica ha voluto proprio ridimensionare
l’importanza delle istituzioni sociali per restituirla alla concreta storia dell’arte. Si può allora
ritenere, in un secondo e più probabile senso, che il valore letterario del testo sia latente, e che
solo attraverso l’appropriazione e la proiezione da parte del pubblico esso diventi effettivo.
Ma, osserva Stecker riprendendo Kolak, la distinzione tra latente ed effettivo, ovvero tra
potenziale e reale, non sembra davvero necessaria. Perché non dire semplicemente che la
comunità di lettori e di critici rileva tale valore artistico e dirige l’attenzione di altri lettori
verso le proprietà salienti del testo, le quali considerate nel loro insieme ne determinano il
valore letterario? 153
153 R. Stecker, Artworks: Definition, Meaning, Value, cit., pp. 95-97. La distinzione tra valore letterario potenziale e reale (o attuale) non è solo inutile in quanto poco efficace da un punto di vista esplicativo. Essa può essere a mio avviso anche tacciata di circolarità viziosa. Infatti il valore letterario reale è dato dalle qualità intrinseche esibite (che costituiscono il valore letterario potenziale) e dalle loro cause, ovvero dalle intenzioni dell’artista: tuttavia queste ultime sono dedotte dalle qualità stesse, dato che nel caso in questione le uniche intenzioni esplicite (cioè quelle di Kafka) sono tutto fuorché artistiche. Una possibile risposta a tale accusa consiste nel sottolineare che le intenzioni non sono dedotte solo dalle qualità intrinseche esibite, ma anche dal contesto storico-culturale dell’oggetto in questione. Ma, di nuovo, perché non affiancare le proprietà contestuali alla rilevazione delle proprietà intrinseche, anziché inferire da esse un’intenzione autoriale che appare del tutto superflua? La questione è analoga a quella rilevata in una nota precedente e riguardante il rapporto tra intenzioni categoriali (responsabili della classificazione di un’opera in una data categoria, la più generale delle quali è la categoria delle opere d’arte) e intenzioni semantiche (responsabili del significato dell’opera, ovvero delle sue proprietà rappresentative, espressive, formali, ecc.). Levinson sostiene che è al primo tipo di intenzioni che la sua definizione fa riferimento, e aggiunge che queste condizionano, seppur in modo indiretto, quelle semantiche. Egli aggiunge però ancora che, laddove le intenzioni categoriali non sono esplicite, esse sono inferibili dalle proprietà intrinseche dell’opera (quindi dal suo significato) e da valutazioni di tipo storico-contestuale. Ma se le intenzioni categoriali sono inferite dalle proprietà dell’opera, come possono al tempo stesso condizionarle? In
69
Il motivo è evidente. Levinson vuole a tutti i costi evitare che si riconosca
nell’assolvimento di determinate funzioni (quali ad esempio la produzione di esperienze
estetiche di alto livello attraverso l’esibizione di determinate qualità intrinseche, come sembra
suggerire Kolak) una condizione sufficiente all’artisticità − il che porterebbe all’eliminazione
della condizione intenzionale dalla definizione dell’arte. Tuttavia, nel tentativo di non virare
la barca verso il funzionalismo (rappresentato dalle teorie estetiche dell’arte), egli rischia di
arginarsi contro l’ancor più periglioso scoglio del proceduralismo (rappresentato dalla teoria
istituzionale). Levinson non riesce, in ultima analisi, a rispondere in modo convincente alla
critica di Kolak, con tutto ciò che ne segue.
2.6 E allora?
L’idea che Levinson, per salvare la sua definizione storica dell’arte, dovesse per forza
imboccare le strade del funzionalismo o del proceduralismo era già stata prefigurata da
Stephen Davies. Questi riteneva comunque che la concezione storico-intenzionale dell’arte
potesse preservare la propria identità, pur facendo delle concessioni di tipo funzionale o
istituzionale necessarie a superare le critiche che ne hanno minato la credibilità 154. Di queste
concessioni Levinson ne fa in verità anche troppe. Se dovessimo tener conto di tutte le
modifiche da questi apportate alla sua teoria in risposta alle diverse obiezioni di volta in volta
ricevute, ci troveremmo di fronte, come suggerisce Stecker, alla seguente definizione-
monstre:
O è un’opera d’arte se e solo se (i) O è un oggetto che è stato seriamente inteso per essere
considerato-come-un’opera-d’arte, ovvero, O è stato inteso per un insieme relativamente completo di
modi di considerazione intrinsecamente caratterizzati che eguagliano i modi in cui precedenti opere
d’arte sono o sono state correttamente considerate, oppure O è stato relazionalmente inteso per essere
considerato come qualche particolare opera d’arte del passato è o è stata correttamente considerata e,
nel caso in cui tale intenzione sia relazionale, è anche corretto che O sia inteso in tal modo, e
(preferibilmente) l’autore di O ha il diritto di proprietà su O; oppure, (ii) O è una prima opera d’arte,
ovvero, O è una delle originarie fonti causali e di riferimento intenzionale di attività che
precedenza ho avanzato l’ipotesi che le intenzioni categoriali siano condizionate in modo solo superficiale dal significato dell’opera (ovvero, esse sono deducibili dal semplice fatto che l’opera abbia delle proprietà formali, espressive, ecc., indipendentemente da quali esse siano) e dal suo contesto di produzione. Di nuovo, però, sarebbe sempre il valore – seppure parziale (Levinson direbbe disordinato) e unito a considerazioni contestuali ed estrinseche – a determinare la categoria di appartenenza dell’opera, e non viceversa. 154 S. Davies, Definitions of Art, cit., pp. 179-80.
70
successivamente sono divenute esempi paradigmatici di attività artistiche, oppure O è stato creato per
raggiungere gli stessi effetti e valori della successiva arte paradigmatica; oppure (iii) O è il prodotto di
processi o impulsi artistici interni alla mente del creatore di O; oppure (iv) una comunità del mondo
dell’arte si è appropriata di O e l’ha proiettata per essere considerata come un’opera d’arte 155.
Si tratta ovviamente di una definizione impraticabile, oltre che irriconoscibile. Stecker
propone di snellirla sostituendo ai punti (ii), (iii) e (iv) una singola condizione funzionale
sufficiente, la quale rappresenterebbe la seconda parte di una definizione disgiuntiva dell’arte.
Egli fa quindi proprio il suggerimento di Davies e decide di integrare lo storicismo
intenzionale di Levinson con il funzionalismo. Altri due autori − ovvero Noel Carroll e James
Carney − si sono mossi invece nella direzione opposta ed anziché “allargare” la definizione
storica originaria di Levinson (come fa Stecker, il quale vi aggiunge una condizione
funzionale), hanno pensato di “restringerla” eliminando del tutto la condizione intenzionale
dalla definizione. Sarà compito del prossimo capitolo analizzare le proposte di Carroll,
Carney e Stecker e vedere se e in che modo saranno in grado di mantenere in vita la
possibilità di definire l’arte storicamente − possibilità introdotta e sviluppata soprattutto da
Levinson, ma con esiti che, come abbiamo visto, non sono del tutto soddisfacenti.
Ma c’è anche un altro modo di mantenere viva tale possibilità; un modo che non è stato
ancora adeguatamente sviluppato, ma solo accennato. A suggerirlo è Victor Haines, il quale in
un articolo significativamente intitolato Refining, Not Defining Art Historically sostiene che
“ci si può sempre volgere a una procedura ricorsiva quando qualcosa risulta difficile da
definire all’interno di una cultura” 156. Come a dire che una definizione storico-intenzionale
come quella di Levinson può entrare in gioco in seconda battuta, laddove ci trovassimo in
difficoltà a stabilire l’artisticità di un dato oggetto applicando la definizione primaria dell’arte.
Della percorribilità di una tale soluzione e della ricerca di una definizione primaria non storica
dell’arte mi occuperò più avanti. Per ora è sufficiente aver prospettato un nuovo orizzonte di
possibilità per la nozione storica di arte.
155 R. Stecker, Artworks: Definition, Meaning, Value, cit., p. 97. Nel punto (i) il verbo “eguagliano” (mia traduzione dell’originale “match up with”) sta per “producono gli stessi effetti e raggiungono gli stessi valori”. Con l’espressione “match up with” Stecker vuole dar conto della definizione modificata introdotta da Levinson in “Refining Art Historically” (cit., p. 56), in cui si afferma che un’opera d’arte è un oggetto che è stato seriamente inteso … per essere considerato in uno dei modi in cui precedenti opere d’arte sono state correttamente considerate, “in modo tale che un’esperienza dal valore in qualche modo simile a quello offerto dall’arte precedente sia così ottenuta”. 156 V. H. Haines, “Refining, Not Defining Art Historically”, Journal of Aesthetics and Art Criticism 48 (1990), p. 237.
71
CAPITOLO TERZO
Le teorie storiche dell’arte di Carroll, Carney e Stecker
Jerrold Levinson è il primo e più importante filosofo analitico ad aver proposto una
definizione storica dell’arte. Egli però non è l’unico. Altri autori sono rimasti attratti dall’idea
di definire il concetto di arte attraverso un riferimento ricorsivo alla storia dell’arte. Si tratta,
come detto, di Noel Carroll, James Carney e Robert Stecker. Ognuno di questi autori
condivide con Levinson il punto di partenza iniziale − ovvero l’impossibilità di definire
l’artisticità di un oggetto sulla base delle sue caratteristiche intrinseche esibite o delle
esperienze che tali proprietà provocano su chi le percepisce − e l’idea generale di base −
ovvero la convinzione che vi sia una connessione tra l’attuale concetto di arte e l’estensione
delle opere d’arte e delle attività artistiche unanimemente riconosciute come tali nel corso
della storia. Questa idea generale ha però preso corpo in teorie che, oltre ad essere
sensibilmente diverse l’una dall’altra, si distanziano equamente dalla teoria di Levinson in
alcuni punti decisivi. Le teorie di Carroll e Carney, pur prendendo strade leggermente
differenti, sono accomunabili per il fatto di fare entrambe a meno della nozione di
intenzionalità (così centrale nella definizione di Levinson), e di concentrarsi invece
principalmente sui modi di connessione tra il nostro concetto di arte e la storia dell’arte
passata. Stecker recupera invece il concetto di intenzionalità ma, non ritenendolo una
condizione singolarmente sufficiente all’artisticità, lo integra con una condizione di tipo
funzionale, dando vita così a una definizione disgiuntiva di arte.
Allo stesso tempo però le teorie di Carroll, Carney e Stecker mantengono dei punti di
contatto con la teoria di Levinson, che vanno oltre l’idea storica generale che le accomuna
tutte e che suggeriscono la possibilità di una loro integrazione o, meglio, di una sorta di mutua
assistenza. Si cercherà allora di vedere se e in che modo esse siano in grado di rimediare ai
punti deboli della definizione storico-intenzionale, facendo tesoro del dibattito di obiezioni e
risposte che ha circondato quest’ultima e al quale gli stessi autori appena citati hanno
partecipato attivamente. Nel presente capitolo si darà quindi un’esposizione piuttosto
dettagliata delle definizioni storiche dell’arte elaborate da Noel Carroll, James Carney e
Robert Stecker, e si effettuerà un confronto tra tali teorie e quella di Levinson, al fine di
stabilire se l’idea di definire l’arte storicamente, seriamente messa in crisi dalle critiche
72
esaminate nel precedente capitolo, possa ancora essere sostenuta in modo credibile e
teoreticamente fecondo.
3.1 La teoria delle narrazioni storiche di Noel Carroll
A) CHE COSA E’ ARTE?
La domanda “che cosa è arte?”, che per Levinson è la più venerabile in estetica, è
considerata anche da Noel Carroll come una delle questioni principali affrontate dalla
filosofia analitica nella seconda metà del Novecento. La domanda può però essere interpretata
in modi diversi, a seconda di quale tipo di informazioni venga richiesto attraverso essa.
Carroll individua tre sensi fondamentali in cui la questione dell’arte può essere declinata.
Innanzitutto, essa può rispondere al bisogno pratico, sollecitato in special modo dalle opere
d’avanguardia, di stabilire se tali oggetti siano o meno delle opere d’arte. La domanda “che
cosa è arte?” assume in tal caso la seguente forma: “come stabiliamo che un dato oggetto
(inteso in senso lato e tale da comprendere installazioni, performance, ecc.) è un’opera
d’arte”? Tale domanda si trascina dietro un altro, ancor più pressante, interrogativo: esistono
dei metodi sicuri per identificare qualcosa come opera d’arte? In secondo luogo, la questione
dell’arte può rispondere all’esigenza di trovare delle proprietà condivise da tutte le opere
d’arte (pur ammettendo che tali proprietà possono essere possedute anche da oggetti non
artistici). La domanda diventa allora: l’arte ha un’essenza? Ovvero, esistono condizioni
necessarie all’artisticità? Infine, la domanda “che cosa è arte?” può essere intesa come la
richiesta di una vera e propria definizione. Essa qui diventa: esistono condizioni necessarie e
congiuntamente sufficienti all’artisticità? In realtà, oltre a queste tre primarie declinazioni
della domanda “che cosa è arte?” ne esistono anche altre due, le quali muovono dal
presupposto che non ci si possa domandare che cos’è l’arte senza fornire anche i motivi per
cui consideriamo l’arte un’attività importante per la vita dell’uomo. La questione dell’arte può
quindi voler dire anche: perché l’arte ha valore come attività umana? Qual è il valore
peculiare dell’arte in quanto diverso dal valore attribuibile ad altre attività umane? Queste
cinque diverse questioni, anziché venire trattate separatamente, sono state per lo più
ammassate insieme in un’unica domanda (“che cosa è arte?”) che nasconde il “sogno
filosofico” di racchiuderle tutte in un unico “pacco teoretico” ordinato e completo. La
maggior parte dei filosofi che si sono occupati di tali questioni ha infatti avuto la tendenza a
rispondere affermativamente a ciascuna di esse, in modo tale che ogni affermazione causasse
73
l’affermazione successiva provocando una sorta di reazione a catena. Se ci si limita alle tre
domande primarie, si vedrà come il procedimento appena descritto solitamente comincia con
una risposta affermativa alla seconda domanda. Da qui, cioè dal fatto che l’arte ha delle
caratteristiche essenziali comuni, si passa all’affermazione che tali caratteristiche possono
essere anche congiuntamente sufficienti all’artisticità, e possono quindi costituire le basi per
una definizione dell’arte (terza domanda). Tale definizione funge poi anche da metodo per
stabilire se un oggetto è o meno un’opera d’arte (prima domanda) 157.
Il sogno filosofico appena descritto è stato messo in crisi negli anni Cinquanta del XX
secolo da Morris Weitz, il quale sostenne l’impossibilità di rispondere affermativamente alla
seconda e alla terza domanda: l’arte, secondo Weitz, non ha un’essenza, e non esiste pertanto
alcuna possibilità di fornirne una definizione in termini di condizioni necessarie e sufficienti.
Egli ritenne tuttavia possibile rispondere affermativamente alla prima domanda, e trovare
quindi un metodo per identificare le opere d’arte. Il metodo da lui proposto è quello delle
somiglianze di famiglia: data una base indiscussa di opere d’arte paradigmatiche, un oggetto è
identificabile come opera d’arte se presenta delle somiglianze con alcune delle opere
paradigmatiche della nostra tradizione. La proposta di Weitz si imbatte però subito in
un’obiezione che si presenta nella forma del dilemma. Se non si specifica alcun criterio che
stabilisca un ordine nel rilevamento delle somiglianze, allora, dato che ogni cosa somiglia a
qualcos’altro per qualche aspetto (la mia penna e Les Demoiselles d’Avignon di Picasso
condividono ad esempio il fatto di essere entrambi degli artefatti), si arriverebbe alla sgradita
conseguenza che ogni cosa può essere considerata arte; se invece vengono elaborati alcuni di
questi criteri, allora essi fungerebbero da condizioni necessarie e sufficienti per una
definizione dell’arte, ovvero proprio ciò da cui Weitz prende le distanze. Per non incorrere nei
problemi incontrati dalla teoria delle somiglianze di famiglia di Weitz, alcuni autori hanno di
nuovo intrapreso la strada della ricerca di una definizione dell’arte, cercando però le
condizioni necessarie e sufficienti all’artisticità in proprietà relazionali e non esibite piuttosto
che in qualità intrinseche esibite (come potevano essere la forma significante di Clive Bell o
l’espressione di emozioni di Collingwood). L’esempio più celebre è costituito dalla teoria
istituzionale dell’arte di George Dickie, la quale però incontra dei seri problemi (Dickie non
riesce infatti a difendere la sua teoria dalle accusa di circolarità viziosa e di incapacità a
distinguere l’attività artistica da altre attività umane che presentano un analogo rapporto con
delle pratiche sociali condivise). Al fallimento della teoria delle somiglianze di famiglia si
157 N. Carroll, “Identifying Art”, cit., pp. 1-14.
74
può però reagire anche in modo diverso dal ritorno alla ricerca di una definizione dell’arte in
termini di condizioni necessarie e sufficienti. Si può cioè vedere se esiste un altro metodo che
ci permetta di identificare le opere d’arte e che non ripeta gli stessi errori in cui cade il metodo
elaborato da Weitz. Questa è la strada seguita da Carroll, il quale propone il metodo delle
narrazioni storiche 158.
B) ARTE COME CONVERSAZIONE
Ma che cos’è l’arte per Noel Carroll? L’arte è innanzitutto una “pratica culturale”, ovvero
un “complesso insieme di attività umane interrelate e governate da ragioni interne a tali forme
di attività e alla loro cooperazione” 159. Le attività correlate nella pratica artistica sono
l’attività produttiva degli artisti e quella ricettiva degli spettatori. L’arte è però anche una
pratica pubblica: pertanto le due attività, creativa e ricettiva, devono condividere lo stesso
retroterra comunicativo. Il punto di contatto tra tali attività, come anche l’elemento fondante
di ogni pratica culturale, è la tradizione. L’arte è, sostanzialmente, una “questione di antenati
e discendenti” 160. La tradizione − ovvero il bagaglio di opere, tecniche, regole e valori che si
è sedimentato e consolidato nel corso della storia − è ciò che garantisce l’unità e la continuità
di una pratica culturale. Unità e continuità non vogliono però dire staticità. Piuttosto, una
pratica culturale deve essere sufficientemente flessibile per adattarsi ai cambiamenti che
avvengono nel mondo; di più, essa deve contenere in se stessa i mezzi che le consentano di
modificarsi in relazione all’avvento di nuovi interessi, scoperte e obiettivi, il che è possibile
solo attraverso un “uso creativo della tradizione”. Ciò significa che l’artista, oltre a conoscere
la tradizione − ovvero la storia dell’arte, i rapporti di reciproca influenza tra gli artisti, i generi
e le forme più diffuse, gli scopi di volta in volta perseguiti, le tecniche disponibili e via
dicendo − deve anche possedere i mezzi per cambiare la tradizione stessa e per condurla verso
nuovi traguardi 161. Anche nelle tradizioni artistiche apparentemente più statiche c’è
un’evoluzione. La storia dell’arte può essere letta come un continuum di conservazione e
innovazione, di cambiamenti minimi e di svolte rivoluzionarie. Si può allora interpretare l’arte
come una sorta di conversazione, in cui ogni artista dialoga con i suoi predecessori, li
interroga su alcuni problemi comuni, ascolta le loro risposte e decide se accoglierle in toto o
se proporre soluzioni innovative 162.
158 Ivi, pp. 1-14. 159 N. Carroll, “Art, Practice and Narrative”, Monist 71 (1988), pp. 143-44. 160 N. Carroll, “Identifying Art”, cit., p. 19. 161 N. Carroll, “Art, Practice and Narrative”, cit., p. 143. 162 N. Carroll, Philosophy of Art, cit., pp. 255-56.
75
Si è detto in precedenza che l’aspetto produttivo non può essere separato da quello
ricettivo. Pertanto, come l’artista deve possedere i mezzi per far evolvere la tradizione, così lo
spettatore deve possedere i mezzi per riconoscere le opere create dagli artisti come il risultato
di uno sviluppo interno alla tradizione e coerente con le sue pratiche consolidate.
“Comprendere un’opera d’arte”, sostiene Carroll, significa principalmente “collocarla
all’interno di una tradizione”. Spesso lo spettatore non è del tutto consapevole della
dimensione storica dell’attività ricettiva, dato che le categorie e i concetti di cui egli si serve
per giudicare sono talmente radicati nella nostra formazione culturale da non farci accorgere
della loro presenza. In realtà, già solo per identificare un dramma come shakespeariano o un
film come commedia mettiamo in moto una conoscenza fatta di “confronti, aspettative,
norme”. Vi è quindi una tradizione di ricezione parallela alla tradizione di produzione artistica
e in qualche modo complementare ad essa, dato che spesso gli artisti, oltre ad essere creatori,
sono anche i primi spettatori delle loro opere, e le osservano nella stessa maniera in cui le
altre persone tipicamente le osservano, cercando di conseguenza di far sì che tali opere siano
percepibili e valutabili secondo le comuni norme di ricezione e di giudizio. L’arte ha quindi
una “ineliminabile dimensione storica” in quanto è una pratica culturale con una tradizione.
Non solo: questa tradizione viene anche insegnata storicamente, e come gli artisti studiano i
loro predecessori (e le relative opere, tecniche, strategie, finalità), così gli spettatori imparano
a percepire e interpretare le opere d’arte in termini di periodi, di influenze reciproche, di
“lotte” tra gli artisti e di evoluzione di “soluzioni a problemi preesistenti”, facendo
abbondantemente uso di categorie storiche come “innovativo/conservativo, originale/non
originale, rivoluzionario/retrogrado”. Tornando quindi alla questione iniziale − “che cos’è
l’arte?” − Carroll risponde affermativamente alla seconda delle domande che da questa
discendono − “l’arte ha un’essenza?”. Secondo Carroll l’essenza dell’arte, e quindi anche la
condizione necessaria alla sua esistenza, è la storicità 163.
C) IL METODO DELLE NARRAZIONI STORICHE
Carroll, diversamente da molti dei suoi colleghi, dalla risposta affermativa alla seconda
delle domande primarie sull’arte non deduce un’analoga risposta alla terza domanda, quella
relativa cioè alla possibilità di trovare una definizione dell’arte. Egli non dà in verità
nemmeno una risposta negativa a tale domanda, ma si limita ad osservare che tutte le
definizioni finora proposte si sono rivelate fallimentari. Carroll si ferma quindi un passo
163 N. Carroll, “Identifying Art”, cit., pp. 19-21.
76
prima rispetto a Weitz: mentre quest’ultimo dal fallimento delle definizioni fino ad allora
proposte deduceva l’impossibilità logica di fornire una definizione dell’arte in termini di
condizioni necessarie e sufficienti, Carroll non esclude che in futuro si potrà avere una siffatta
definizione, anche se ciò appare alquanto improbabile visti i risultati dei precedenti
tentativi164.
L’esito positivo della ricerca dell’essenza dell’arte − da lui individuata nella storicità −
aiuta però Carroll a trovare una risposta affermativa anche alla prima delle domande sull’arte,
quella cioè che si chiede se esista un metodo per distinguere ciò che è arte da ciò che non lo è.
Il problema dell’identificazione delle opere d’arte è diventato particolarmente urgente nel XX
secolo, in virtù della comparsa di quelle opere d’avanguardia che hanno sorpreso, sconvolto,
ma soprattutto diviso il pubblico. Tali opere (Carroll si riferisce soprattutto a ready-made e
simili) sono definibili come “problematiche” in quanto al momento del loro ingresso nella
scena artistica hanno deluso le aspettative di buona parte degli spettatori, incapaci di trovare
per esse un posto nella storia dell’arte, ovvero di collegarle alle pratiche artistiche
riconosciute. Tornando alla metafora della conversazione, si può dire che le opere
d’avanguardia hanno creato (e creano tuttora) un vuoto nella conversazione tra gli artisti, i
loro predecessori e il pubblico degli appassionati e degli esperti. Al di là dell’originalità, tali
opere sembrano non condividere nulla con la nostra tradizione artistica. Il problema diventa
allora: come si può colmare tale vuoto? 165
Secondo Carroll, quando si deve decidere dello status artistico di un oggetto, la risposta
non la si trova in una definizione, bensì in una spiegazione che assume la forma della
narrazione storica. Chi propone il conferimento di status artistico (per usare un terminologia
dickiana) ad un oggetto, deve “raccontare una storia” che mostri come tale oggetto sia il
risultato dell’evoluzione di determinate e riconosciute procedure artistiche e sia quindi capace
di ampliare le domande poste dalla tradizione artistica precedente e insieme di sviluppare le
risposte in questa contenute 166. Nel caso di un’opera problematica (nel senso
precedentemente chiarito), il vuoto nella conversazione può essere colmato elaborando delle
“strategie narrative” che mostrino come tale opera intrattenga delle relazioni con la tradizione
artistica di produzione e di ricezione ad essa precedente. Tali relazioni sono riconducibili ai
seguenti tipi fondamentali: 1) l’opera in questione può essere vista come una ripetizione delle
forme, delle figure e dei temi propri dell’arte precedente. La ripetizione non va però confusa
164 N. Carroll, “Historical Narratives and the Philosophy of Art”, cit., pp. 314-15. 165 N. Carroll, Philosophy of Art, cit., pp. 255-56. 166 Ivi, p. 252-56.
77
con l’esatta duplicazione. Nel caso delle opere di narrativa, ad esempio, si ha una ripetizione
quando, pur modificando i caratteri, gli eventi e i luoghi narrati, le tecniche narrative e le
convenzioni legate al determinato genere letterario di riferimento rimangono pressoché
intatte. 2) L’opera può essere il risultato di un’amplificazione, ovvero di una modifica formale
dei mezzi usati da artisti precedenti al fine di raggiungere degli specifici obiettivi connessi a
determinati generi o forme d’arte. La continuità dell’opera in questione con le opere della
tradizione è garantita dal fatto che essa propone delle soluzioni inedite (anche se non del tutto)
a un particolare problema estetico già affrontato dai suoi predecessori, tali soluzioni essendo a
loro volta il risultato dell’evoluzione di soluzioni preesistenti. L’amplificazione è senza
dubbio la relazione più diffusa all’interno della storia dell’arte occidentale, dall’antichità ai
nostri giorni, passando anche attraverso la maggior parte dei movimenti d’avanguardia del
Novecento. 3) Alcuni di questi movimenti sfuggono però alla descrizione appena fornita
dell’evoluzione della tradizione artistica. E’ il caso delle cosiddette opere rivoluzionarie
(appartenenti a movimenti come Dada, Arte Concettuale, ecc.). La relazione che intercorre tra
tali oggetti e la tradizione artistica occidentale è inscrivibile nella categoria del ripudio.
L’opera rivoluzionaria rimane in contatto con la tradizione in quanto essa prende luogo
alternativamente da un aperto e dichiarato contrasto con gli stili e i valori associati all’arte
degli immediati predecessori o dal recupero di elementi appartenenti a tradizioni artistiche
remote o lontane 167.
Solitamente tali strategie narrative vengono elaborate (dai critici e talvolta anche dagli
artisti) solo dopo che un dato oggetto è stato realizzato e consegnato alla pubblica fruizione.
Tuttavia talvolta esse possono anche precedere la realizzazione e la fruizione dell’opera: in tal
caso esse assumono la forma di manifesti programmatici (come accadde per molte delle
Avanguardie del primo Novecento). Ciò conferma indirettamente che le narrazioni storiche
non hanno nulla a che fare con il valore di una particolare opera: il loro scopo è infatti solo
quello di stabilire se tale opera sia o meno collegabile a una determinata tradizione artistica168.
Il metodo delle narrazioni storiche presuppone ovviamente che vi siano delle opere e delle
pratiche artistiche riconosciute e indiscusse. Per Carroll questo non rappresenta un problema,
innanzitutto in quanto la sua teoria non è una definizione, ma solo un metodo di
identificazione delle opere d’arte, e non può quindi essere accusata di circolarità. Inoltre tale
presupposto è comune anche alle definizioni dell’arte (e non solo a quella di Levinson), le
quali sono comunque costrette a ricorrere ad una base artistica condivisa per risolvere i casi
167 N. Carroll, “Art, Practice and Narrative”, cit., pp. 145-49. 168 N. Carroll, “Historical Narratives and the Philosophy of Art”, cit., pp. 316-18.
78
critici o per rispondere alle obiezioni più incalzanti. Certo, nella teoria di Carroll il
riconoscimento di opere, forme e stili artistici paradigmatici ha un ruolo più centrale in quanto
su di esso si fonda il metodo per l’identificazione delle opere d’arte. Ciò può suggerire un
pericoloso parallelo con la teoria di Weitz − pericoloso in quanto quest’ultima è andata
incontro ad obiezioni insormontabili, come si è visto. In realtà il parallelismo tra le due teorie
è valido solo fino a un certo punto. Infatti, mentre Weitz va in cerca di somiglianze esteriori e
generiche di un dato oggetto con le opere paradigmatiche per scoprire se esso è collocabile tra
le opere d’arte, il metodo di Carroll mira a rinvenire delle connessioni di tipo genetico col
passato: le narrazioni storiche sono infatti costruite sui rapporti di causa e effetto tra le opere
di epoche diverse e sulle linee di influenza che fanno derivare determinati oggetti del presente
da opere appartenenti alla tradizione. Tale metodo presenta piuttosto, secondo Carroll, delle
interessanti affinità con la teoria darwiniana dell’evoluzione della specie: infatti per Darwin
l’appartenenza di un organismo a una data specie non è determinata dal possesso di una o più
caratteristiche esteriori condivise da altri membri della stessa specie, bensì dalla discendenza
da un comune ceppo originario. L’arte, come la scienza, è una questione di discendenza
storica più che di somiglianza esteriore 169.
Ovviamente non ogni narrazione storica ci permette di identificare correttamente le opere
d’arte. Affinché ciò sia possibile occorre che essa sia esplicativa e coerente, il che significa
anzitutto che gli eventi o stati di cose di cui ci si occupa devono essere narrati in maniera
accurata e veritiera e nel pieno rispetto dell’ordine temporale. Inoltre la narrazione deve
concentrarsi su un unico soggetto, costituito dalla produzione di un oggetto di cui si deve
spiegare come esso possa far parte di una tradizione artistica riconosciuta. Ma soprattutto la
narrazione deve seguire una struttura ben precisa, che consta di un inizio, una complicazione e
una fine. L’inizio consiste nella descrizione di un contesto storico-artistico riconosciuto −
secondo Carroll è sempre possibile trovare un qualche periodo storico in cui sia rilevabile un
consenso generale su quali opere e quali pratiche possono essere definite come artistiche. La
complicazione, che è anche la fase più importante in quanto attraverso essa si cerca di rendere
intelligibile l’operare dell’artista presentandolo come un continuo sforzo teso a modificare la
tradizione artistica esistente, si articola a sua volta in tre fasi distinte. Nella prima si tenta di
spiegare il perché l’artista si ponga lo scopo di modificare il contesto artistico descritto
all’inizio della narrazione, chiamando in causa i bisogni e le tensioni interni all’artista, i
problemi connessi al mondo dell’arte, o le sollecitazioni culturali provenienti da altri contesti.
169 N. Carroll, Philosophy of Art, cit., pp. 256-57.
79
Nella seconda fase si cerca di mostrare come i mezzi che l’artista sceglie di utilizzare siano
adeguati al suo scopo, data la gamma di tecniche e di procedure a sua disposizione e gli
esperimenti da lui precedentemente condotti. Nella terza fase della complicazione si dimostra
che tanto l’interpretazione che l’artista dà del contesto storico-artistico da modificare quanto
la scelta delle modifiche che egli intende apportare sono in accordo con alcuni degli scopi
riconosciuti e tuttora operanti nella nostra tradizione artistica (Carroll cita ad esempio lo
scopo che l’arte sia espressiva, che sia portatrice di nuovi valori, ecc.). La fine della
narrazione consiste nel descrivere la realizzazione dell’oggetto in questione come il logico
risultato dell’inizio e della complicazione. Carroll aggiunge che le narrazioni storiche possono
essere applicate tanto alle singole opere quanto a interi movimenti artistici. Se si applica il
metodo delle narrazioni storiche seguendo correttamente la procedura esposta e rispettando le
condizioni di veridicità e di accuratezza storica e cronologica, risolvere il problema
dell’identificazione delle opere d’arte sarà più facile del previsto 170.
D) IL PROBLEMA DELLE ORIGINI
Alcune delle obiezioni che sono state rivolte alla teoria di Levinson possono essere
indirizzate anche verso la teoria di Carroll, in virtù del concetto di storicità dell’arte che le
accomuna. Innanzitutto Carroll deve rispondere alla seguente domanda: cos’è che fa di una
pratica culturale una pratica culturale artistica? Egli ritiene che la sua teoria riesca a fornire
una risposta esauriente a tale domanda. Non occorre infatti far ricorso a condizioni funzionali
per marcare la specificità di una pratica culturale artistica. A tal fine è sufficiente indicare
delle strategie narrative che descrivano la pratica artistica come un processo storico integrato
e unitario, dove passato e presente siano reciprocamente collegati in modo coerente e dove la
conoscenza dell’uno illumini la conoscenza dell’altro, senza con questo precludere la
possibilità dell’innovazione artistica − non si può infatti predire quali aspetti di una data
tradizione saranno ripetuti, amplificati o ripudiati 171.
L’unitarietà del processo artistico non è però così “pura” e indiscutibile se si ridiscende alle
sue origini. E’ infatti unanimemente riconosciuto che le prime forme d’arte sorsero dalla
fusione di attività eterogenee, alcune delle quali oggi non sono più riconoscibili come
artistiche (le prime opere d’arte rispondevano spesso a bisogni religiosi o sociali). A tal
proposito, Carroll osserva anzitutto che ogni pratica culturale nasce in tal modo: ciò che ne
garantisce l’unità e insieme l’identità è la consapevolezza delle regole interne alla pratica e il
170 N. Carroll, “Identifying Art”, cit., pp. 21-31. 171 N. Carroll, “Art, Practice and Narrative”, cit., pp. 150-51.
80
loro raffinamento da parte dei produttori e dei fruitori di tale pratica. In secondo luogo, la
fusione delle diverse attività operanti all’inizio di una pratica culturale il più delle volte non è
casuale, bensì segue una logica funzionale. Nel caso dell’arte, si può ragionevolmente
supporre che le attività operanti all’inizio della pratica culturale artistica (ovvero,
sintetizzando un po’ grossolanamente, le attività rappresentative, espressive, decorative e
comunicative) fossero intimamente connesse e reciprocamente dipendenti − ciò che un
oggetto rappresentava, determinava in buona parte il suo contenuto espressivo, e le proprietà
espressive, unite a quelle formali-decorative, permettevano la trasmissione di un determinato
messaggio. Carroll è quindi disposto ad ammettere una spiegazione diversa dalle narrazioni
storiche per quanto riguarda le prime opere d’arte: “quando ci avviciniamo ai confini della
tradizione, la nostra caratterizzazione della sua intelligibilità ci conduce verso considerazioni
di tipo funzionale” 172.
Carroll è costretto a ricorrere a considerazioni funzionali anche per spiegare l’arte di
tradizioni culturali non occidentali o remote. Per stabilire infatti se tali civiltà hanno delle
tradizioni artistiche, è necessario che siano riscontrabili delle analogie tra alcune delle loro
pratiche culturali e le pratiche interne alla nostra tradizione artistica. Tali analogie vengono
eventualmente rilevate attraverso un confronto tra le origini delle diverse tradizioni: è qui che
si scopre se le opere delle tradizioni “aliene” soddisfano le stesse funzioni (rappresentativa,
espressiva, decorativa, ecc.) assolte dalle nostre prime opere d’arte, e se tali tradizioni sono
quindi definibili come artistiche 173. Il ricorso forzato a considerazioni funzionali non mina,
secondo Carroll, la validità della sua teoria. Egli ammette che in determinate situazioni −
circoscritte ai primi stadi delle tradizioni artistiche − il rilevamento di particolari proprietà
funzionali rappresenti la strategia migliore per identificare determinati oggetti come opere
d’arte. Ciò non toglie tuttavia che nei suoi movimenti successivi, una pratica culturale sia
identificabile come artistica preferibilmente attraverso l’applicazione del metodo delle
narrazioni storiche precedentemente esposto 174.
172 Ivi., pp. 152-53. 173 N. Carroll, Philosophy of Art, cit., pp. 263-64. 174 N. Carroll, “Art, Practice and Narrative”, cit., pp. 155-56.
81
3.2 La teoria stilistica di James Carney
A) STILE E PROPRIETA’ ESTETICHE
Morris Weitz criticava le definizioni tradizionali dell’arte in quanto riteneva che,
diversamente da quanto sostenuto da queste, non vi fossero proprietà intrinseche comuni a
tutte le opere d’arte. Pertanto né le proprietà formali (difese da Clive Bell) né quelle
espressive (favorite da Collingwood) possono costituire delle condizioni necessarie e
sufficienti all’artisticità, in quanto l’arte è un concetto aperto e non racchiudibile in una
definizione. La critica di Weitz può essere estesa a tutte le definizioni funzionali dell’arte, le
quali identificano l’artisticità di un oggetto con la sua capacità di soddisfare una specifica
funzione − che nel caso delle teorie estetiche (come quella di Bearsdley) coincide con la
produzione di un’esperienza estetica di un certo livello attraverso il possesso di determinate
proprietà estetiche (che possono essere formali, espressive, rappresentative, simboliche, ecc.).
Anche James Carney contesta la pretesa di validità delle teorie tradizionali e in genere di
quelle funzionali dell’arte, ma per motivi diversi da quelli indicati da Weitz. Carney ritiene
infatti che le proprietà estetiche di un’opera dipendano dallo stile che viene assegnato
all’opera stessa. Lo stile di un oggetto è ciò che determina se esso possieda o meno delle
proprietà estetiche e se tali proprietà siano formali, espressive, rappresentative, simboliche o
altro ancora. Non è pertanto possibile attribuire lo status di artisticità a un oggetto senza prima
aver fatto delle considerazioni di tipo storico che ci aiutino a inquadrare tale oggetto
all’interno di una determinata scuola, di un particolare periodo, di una poetica comune
all’intero corpus creativo dell’artista: in altre parole, senza aver stabilito lo stile dell’oggetto.
Carney approfondisce la questione principalmente in merito alle proprietà formali dei dipinti.
E’ infatti opinione diffusa, tanto in estetica e nella critica d’arte quanto tra gli artisti stessi, che
ogni opera d’arte visiva (dipinto, scultura o altro) possieda delle proprietà formali, rilevabili
con l’osservazione diretta e senza l’ausilio di alcun tipo di conoscenza relativa alla storia di
produzione dell’opera stessa. Egli sostiene invece al proposito la seguente tesi: “F è una
proprietà formale di un’opera d’arte visiva quando lo stile presupposto per tale opera
costringe lo spettatore a percepire F come F”, ovvero come proprietà formale. La tesi
enunciata da Carney ha due importanti conseguenze, che marcano il suo distacco dalle teorie
formaliste dell’arte. La prima è che le proprietà formali sono proprietà relazionali. La seconda
è che non tutte le opere d’arte visive possiedono proprietà formali 175.
175 J. Carney, “Style and Formal Features”, Southern Journal of Philosophy 29 (1991), p. 431.
82
Per sostenere la fondatezza della sua tesi Carney elabora il seguente esempio. Si
considerino due dipinti fisicamente identici, costituiti semplicemente da una superficie
completamente nera. L’uno, realmente esistente, è stato dipinto dall’artista americano Ad
Reinhardt negli anni Sessanta, ed è intitolato Number 33. L’altro, che chiameremo Black on
Black, si suppone per ipotesi che sia stato dipinto dall’artista russo Kasimir Malevich
(l’ipotesi, pur essendo il frutto dell’immaginazione di Carney, è comunque verosimile, dal
momento che Malevich dipinse quadri di simile fattura significativamente intitolati White on
White). Nonostante non sia rilevabile alcuna differenza a livello percettivo tra i due dipinti,
essi ciononostante sono interpretabili in maniera alquanto differente. Number 33 è
classificabile come dipinto minimalista: pertanto il nero che ricopre la tela non rappresenta o
simbolizza alcunché, ma va contemplato come pura forma. Black on Black è invece
identificabile come dipinto suprematista, e dato che il Suprematismo è una corrente pittorica
che si serve di forme geometriche astratte per rappresentare oggetti liberamente gravitanti
nello spazio, il colore nero verosimilmente rappresenta qualcosa. Il primo dipinto possiede
proprietà formali, laddove il secondo possiede proprietà rappresentative, pur essendo
percettivamente indistinguibili tra loro: ciò è ascrivibile alla differenza di stili
(rispettivamente minimalista e suprematista) presupposti per i due dipinti. Secondo Carney,
tale esempio dimostra come il possesso, da parte di un’opera, di determinate caratteristiche
intrinseche ed esibite, sia una condizione necessaria ma non sufficiente all’attribuzione a tale
opera di determinate proprietà estetiche. L’artista non è l’unico responsabile del carattere
estetico di un’opera. Se un’opera possiede o meno proprietà estetiche, e se tali proprietà siano
formali, rappresentative, espressive o altro ancora, ciò dipende dallo stile che viene assegnato
all’opera 176.
B) STILE GENERALE E STILE INDIVIDUALE
A questo punto è doveroso porsi la seguente domanda: come si fa a stabilire se
l’assegnazione di uno stile a una data opera d’arte è corretta? Prima di rispondere a questa
domanda, è necessario operare una distinzione tra stile individuale e stile generale di
un’opera. Ma che cos’è lo stile? Lo stile di un’opera d’arte è, secondo Carney, l’insieme delle
proprietà formali o semantiche caratteristiche della produzione artistica riconducibile alla
persona che l’ha creata, al periodo in cui questa si trova ad operare, alla scuola alla quale
appartiene e al luogo da cui proviene. Lo stile di un’opera va inoltre distinto dalla sua
176 Ivi, pp. 432-35.
83
interpretazione, poiché mentre quest’ultima cerca principalmente di capire il significato
trasmesso dall’opera (che viene identificato col suo scopo, rispetto al quale la forma è un
mezzo), le proprietà stilistiche sono trasversali rispetto alla dicotomia forma/contenuto − sia
la forma che il contenuto, reciprocamente connessi, fanno parte dello stile di un’opera 177.
Secondo Carney l’assegnazione di uno stile generale a un dipinto avviene in modo
empirico e non arbitrario. I critici e gli storici dell’arte, nel classificare un’opera d’arte in
termini stilistici, procedono infatti seguendo un preciso schema, riassumibile nei seguenti tre
livelli che rappresentano altrettanto forme di limitazione del loro stesso operato. Il primo
livello consiste nell’identificazione dell’interpretazione unanimemente riconosciuta come
standard per un determinato stile. Senza una classificazione stilistica condivisa non si può
infatti nemmeno operare delle revisioni o introdurre dei nuovi punti di vista. Nel secondo
livello vengono isolati quegli artisti che, in virtù della qualità delle loro creazioni, meglio
esemplificano lo stile standard identificato nel primo livello. Di tali artisti esemplari viene
determinato lo stile individuale. Il terzo livello consiste infine nella formulazione di
un’interpretazione dello stile generale che ci consenta di leggere gli stili individuali degli
artisti esemplari come differenti variazioni dello stile generale, per come questo è stato
interpretato 178.
Rimane ancora da stabilire come avviene l’assegnazione dello stile individuale di un
artista. Anche qui ci sono delle condizioni alle quali il critico o storico deve attenersi.
Secondo Carney, S è lo stile individuale di W (ovvero dell’insieme di opere d’arte realizzate
da un dato artista) se: 1) vi è un consenso tra gli storici d’arte circa la correttezza
dell’assegnazione di S a W; 2) la maggior parte delle caratteristiche che fanno sì che W abbia
le proprietà (formali, simboliche, espressive, ecc.) che gli sono riconosciute, fa parte delle
caratteristiche standard di S; 3) S è in sintonia con gli scopi e le intenzioni dell’artista; 4)
l’assegnazione di S a W ci aiuta a spiegare la relazione tra W e diversi stili generali (passati,
presenti e futuri) meglio di quanto potremmo fare assegnando a W un altro stile individuale
S’; 5) l’assegnazione di S a W ci aiuta a spiegare la relazione tra W e la cultura del suo tempo
meglio di quanto potremmo fare assegnando a W un altro stile individuale S’ 179.
Un esempio potrà aiutarci a comprendere meglio la complessa dinamica della
classificazione stilistica seguita dagli storici e dettagliatamente analizzata da Carney. Si
consideri lo stile generale del Simbolismo. Gli storici solitamente partono dall’interpretazione
177 J. Carney, “The Style Theory of Art”, Pacific Philosophical Quarterly 72 (1991), p. 274. 178 Ivi, p. 275. 179 J. Carney, “Style and Formal Features”, cit., p. 434.
84
standard del Simbolismo (primo livello). Dopodichè essi prendono alcuni tra gli artisti più
rappresentativi di tale movimento, come Odilon Redon e Gustave Moreau, dei quali vengono
identificati gli stili individuali secondo il metodo sopra citato (secondo livello). Pertanto tali
artisti vengono inquadrati all’interno del contesto storico-sociale di provenienza; si mostra
come alcuni soggetti ricorrenti delle loro opere (Salome, Orfeo, ecc.) nonché le tecniche
utilizzate per rappresentarli (come l’insistenza su elementi di tipo decorativo) siano
riconducibili ai loro stili individuali; si studia il modo in cui i pittori interpretarono le loro
opere; si ricollegano i rispettivi stili individuali ad alcuni stili generali precedenti (come
l’Impressionismo o la pittura Pre-Raffaellita) o successivi (come l’Espressionismo); si
portano alla luce i rapporti privati e pubblici che intercorsero tra artisti, critici e uomini di
cultura alla fine dell’Ottocento. Infine, si fornisce un’interpretazione del Simbolismo che ci
permetta di considerare le opere di Redon e Moreau come manifestazioni particolari di tale
stile generale (terzo livello): si può ad esempio definire il Simbolismo come quello stile che
all’oggettività antepose la soggettività, che alla rappresentazione diretta della realtà preferì la
sintesi fantasiosa di alcuni suoi elementi, che predilesse determinati temi e soggetti, e via
dicendo 180.
La descrizione della classificazione stilistica deve ancora essere completata da alcune
osservazioni. La prima riguarda il modo in cui le diverse condizioni che limitano
l’assegnazione degli stili generali e di quelli individuali si rapportano tra loro. Carney sostiene
che nessuna di tali condizioni abbia un ruolo privilegiato sulle altre. Può succedere che in
taluni casi gli storici diano più importanza ad una condizione piuttosto che a un’altra, ma si
tratta di eventi contingenti, e il rapporto di forze può essere tranquillamente ribaltato in altri
casi. Pertanto la migliore interpretazione che gli storici o i critici d’arte possono fornire di uno
stile generale coincide con una “spiegazione olistica che fonde al meglio le condizioni
limitanti” 181. Le classificazioni stilistiche contengono inoltre una “ineliminabile componente
valutativa”, in quanto riflettono “sia i valori e le attitudini degli storici che effettuano la
classificazione sia le teorie funzionali dell’arte preferite dagli storici”. Ai giorni nostri gli
storici danno una particolare importanza ad elementi storici e sociali. Viceversa all’inizio del
Novecento, col formalismo che dominava incontrastato nella teoria e nella pratica artistica, la
tendenza imperante era quella di interpretare gli stili generali unicamente in funzione di
elementi formali e compostivi (indipendentemente dal contesto culturale, dalla vita
dell’artista, ecc.). Non esistono quindi classificazioni uniche e sempre valide. Questo non vuol
180 J. Carney, “The Style Theory of Art”, cit., pp. 275-76. 181 Ivi., p. 276.
85
dire però che non esista alcun modo per separare le classificazioni corrette da quelle non
corrette: un sufficiente grado di oggettività nell’effettuare una classificazione stilistica è
garantito dal rispetto delle condizioni elencate da Carney. Anche laddove non sia possibile
determinare con certezza quale sia lo stile correttamente assegnabile a una determinata opera
d’arte, tali condizioni restringono la scelta a un numero limitato di stili. Normalmente le
classificazioni stilistiche cambiano nel tempo in relazione alle variazioni che interessano tanto
l’estensione di uno stile − ad esempio, il termine ‘classico’ è stato a lungo utilizzato per
descrivere l’arte greca e romana nella sua totalità, mentre ora gli storici tendono a restringere
il classicismo all’arte greca del quinto e del quarto secolo a.c. e a quella romana del periodo
augusteo − quanto la sua interpretazione − l’espressionismo astratto di pittori come Pollock o
De Kooning venne inizialmente letto come lo stile proprio di quegli artisti che volevano
esprimere direttamente le loro emozioni senza la mediazione di elementi formali o
rappresentativi, mentre successivamente fu interpretato da alcuni (Clement Greenberg in
primis) come la versione americana del formalismo europeo 182.
C) LA TEORIA STILISTICA DELL’ARTE
Carney è in grado a questo punto di elaborare la propria teoria dell’arte, che egli chiama
teoria stilistica, e che si articola nei seguenti cinque punti: 1) in ogni momento della storia c’è
un numero finito di oggetti che vengono considerati opere d’arte e che sono classificati dagli
storici in termini di stili generali; 2) sebbene non esista una convergenza assoluta tra le
classificazioni stilistiche effettuate dagli storici, esistono comunque dei limiti che
garantiscono un certo grado di oggettività nelle classificazioni; 3) un oggetto è un’opera
d’arte se e solo se può essere collegato, a vari livelli e in modi diversi, per mano di persone
competenti e informate, a uno stile generale (presente o passato) esibito da precedenti opere
d’arte; 4) la lista dei modi attraverso i quali questo collegamento può essere stabilito è aperta.
I modi più comuni sono la ripetizione, l’amplificazione, il ripudio, la sintesi e la re-
interpretazione di uno o più stili generali; 5) sebbene ogni cosa potrebbe essere un’opera
d’arte in un possibile contesto storico-artistico, alcuni oggetti potrebbero non essere
classificati tra le opere d’arte in determinati periodi della storia dell’arte durante i quali non
disponessimo dei collegamenti con alcuni stili generali, necessari per identificare le opere
d’arte183. Di questi cinque punti, il terzo costituisce una vera e propria definizione dell’arte,
mentre i primi due ne rappresentano le premesse e gli ultimi due sono interpretabili come dei
182 Ivi, pp. 276-78. 183 Ivi, p. 273.
86
corollari alla definizione. Successivamente Carney rielabora tale definizione nel modo che
segue: un oggetto è un’opera d’arte se ha uno stile artistico, ovvero se possiede, in uno dei
modi disponibili (ripetizione, amplificazione, ecc.), alcune delle caratteristiche salienti di
opere d’arte passate e attuali. Volendo utilizzare il modello ricorsivo di Levinson, la
definizione può anche assumere la seguente forma:
passo iniziale: le prime opere d’arte sono opere d’arte; passo ricorsivo: se X è un’opera d’arte
prima del momento t, allora Y è un’opera d’arte al momento t se possiede (condivide, ripudia, ecc.)
alcune proprietà caratteristiche di X 184.
D) ALCUNE OBIEZIONI
Come ogni teoria che si rispetti, anche quella di Carney è coinvolta nel consueto dibattito
di obiezioni e repliche. Le obiezioni più rilevanti sono quattro: le prime due concernono le
premesse da cui la teoria stilistica dell’arte muove, le altre due sono invece le obiezioni
classiche alle quali ogni teoria storica dell’arte deve rispondere.
I) L’idea che le proprietà estetiche di un’opera d’arte siano strettamente dipendenti dallo
stile che è stato ad essa assegnato ha ovviamente suscitato numerose perplessità. Molti
sostengono infatti che non ci possa essere una differenza estetica tra due oggetti senza che vi
sia anche una differenza di ordine percettivo tra di essi: pertanto Number 33 e Black on Black
(ovvero le opere citate nell’esempio precedentemente discusso) non possono avere proprietà
estetiche differenti. Carney si appella allora a un caso paradigmatico della storia dell’arte: i
ready-made di Marcel Duchamp. L’artista francese ha infatti dimostrato con la sua opera che
due oggetti percettivamente indistinguibili possono differire esteticamente in virtù della loro
diversa storia produttiva; chi volesse negare che i ready-made sono arte dovrebbe contestare
tutto l’insieme delle pratiche seguite dal mondo dell’arte, il che è un compito piuttosto arduo.
Carney non vuole con ciò sostenere, come alcuni hanno insinuato, che un’opera d’arte non
coincida con la sua realizzazione fisica. Egli piuttosto afferma che sono solamente le proprietà
estetiche di un oggetto ad essere “culturalmente emergenti” sulle sue proprietà fisiche, e non
l’oggetto nella sua interezza. Un ready-made di Duchamp è quindi identico alla sua
controparte non-artistica, ma rispetto a questa è usato in modo diverso: esso è usato come
“esibitore di uno stile” (come suggerito da Arthur Danto) 185.
184 J. Carney, “Defining Art Externally”, British Journal of Aesthetics 34 (1994), pp. 116-19. 185 J. Carney, “Style and Formal Features”, cit., pp. 440-44.
87
II) Se, come Carney stesso riconosce, le classificazioni stilistiche possono variare a
seconda dei tempi e delle valutazioni degli storici, allora per ogni opera sarà prima o poi
possibile trovare uno stile che ci spinga ad attribuirle determinate proprietà (ad esempio
formali): in tal senso, e contro quanto sostenuto da Carney, si può affermare che ogni opera
d’arte possiede delle proprietà formali (come anche qualsiasi altro tipo di proprietà). Carney
risponde sottolineando che le condizioni da lui indicate limitano la libertà degli storici e
restringono ad ogni modo la scelta dello stile assegnabile a una data opera anche nei casi più
incerti 186.
III) Ogni teoria storica dell’arte, come più volte ripetuto, si imbatte inevitabilmente nel
problema rappresentato dalle prime opere d’arte, le quali non sono definibili attraverso la
procedura ricorsiva che definisce invece, secondo i sostenitori di tali teorie, le opere
successive. Carney si affida alla soluzione inizialmente proposta (ma successivamente
rigettata) da Levinson, stante alla quale le prime opere d’arte sono tali in virtù del loro
collegamento con opere ad esse successive e unanimemente riconosciute come artistiche.
Carney aggiunge solo che tale collegamento è di tipo causale e riguarda lo stile delle opere in
questione: pertanto le prime opere d’arte sono tali in quanto hanno stilisticamente influenzato
opere d’arte successive e unanimemente riconosciute. Lo statuto ontologico delle first arts è
quindi per Carney del tutto identico a quello delle mid-life arts (come la graffiti art, la folk
art, ecc.), ovvero di quegli oggetti che, pur muovendosi all’interno di forme e pratiche
artistiche sin dal momento della loro realizzazione, diventano opere d’arte solo in un
momento successivo, ovvero solo quando è possibile stabilire una connessione stilistica che le
colleghi ad opere o generi artistici riconosciuti 187.
IV) L’altro problema classico che una teoria storica deve affrontare è quello posto dall’arte
rivoluzionaria. Come si può infatti rilevare una connessione stilistica tra oggetti come i ready-
made e qualsivoglia opera d’arte riconosciuta (precedente o contemporanea ad essi), dato che
l’intento del loro autore era proprio quello di rompere con ogni tradizione artistica esistente e,
quindi, anche con tutti gli stili generali entro i quali le opere d’arte sono state di volta in volta
classificate? La soluzione di Carney si distingue stavolta da quella di Levinson, il quale
ritiene che i ready-made siano opere d’arte in quanto intenzionalmente riferiti alle opere
d’arte del passato, seppure in maniera negativa, ovvero attraverso il rifiuto di tali opere e dei
modi in cui queste erano e sono considerate. Carney sostiene invece che le opere
rivoluzionarie sono arte non in virtù del disconoscimento volontario della tradizione
186 Ivi, p. 440. 187 J. Carney, “Defining Art Externally”, cit., pp. 119-21.
88
attraverso esse operato, bensì in quanto causalmente collegabili ad opere e stili artistici
successivi e riconosciuti, nella fattispecie l’Arte Concettuale degli anni Sessanta. I ready-
made di Duchamp sono retrospettivamente interpretabili come opere pre-concettuali: essi non
sono quindi arte al momento della loro realizzazione fisica, ma lo diventano successivamente,
grazie a un riferimento retroattivo analogo a quello occorso alle prime opere d’arte. Il
paradosso apparente per cui le opere rivoluzionarie sono arte pur non avendo uno stile si
risolve ammettendo che, contrariamente a quanto sostenuto di solito, esse hanno uno stile,
sebbene questo venga assegnato loro retrospettivamente. D’altronde, conclude Carney, anche
se si volesse dare una giustificazione ricorsiva delle opere rivoluzionarie, tale cioè che lo
status artistico venisse loro attribuito al momento della loro realizzazione e per effetto della
connessione stilistica con opere precedenti (connessione che, come suggerito da Levinson,
non può che presentarsi nella forma del rifiuto degli stili artistici preesistenti), ciò non
costituirebbe un vero problema per la propria teoria. Egli ritiene infatti che tutta la storia
dell’arte del XX secolo sia interpretabile come una sequenza di rifiuti − l’Impressionismo ha
rinnegato l’Accademismo, il Cubismo ha fatto lo stesso nei confronti dell’Impressionismo,
l’Espressionismo ha poi preso le distanze dal Cubismo e dall’Astrattismo, e via dicendo. Il
rapporto che lega l’arte rivoluzionaria alla tradizione artistica precedente non è quindi altro
che l’ultimo della serie di ripudi che legano tra loro i diversi stili artistici che si sono
succeduti nel corso del Novecento 188.
3.3 Carroll, Carney e Levinson
Al termine del secondo capitolo ho accennato al fatto che Stephen Davies avesse
prefigurato la possibilità di preservare la validità della definizione storica dell’arte di Jerrold
Levinson integrandola con alcuni elementi propri delle teorie istituzionali o di quelle
funzionali. Le teorie di Carroll e di Carney appena delineate sono a mio avviso leggibili come
dei tentativi di seguire la prima delle due alternative poste da Davies (si tratta ovviamente
solo di una mia interpretazione, e non della rilevazione di un effettivo scambio di idee tra gli
autori citati).
Entrambe le teorie amplificano infatti la dimensione sociale dell’arte rispetto a quanto
Levinson abbia fatto con la propria definizione. Tanto le narrazioni storiche di Carroll quanto
le classificazioni stilistiche di Carney − ovvero i cardini delle rispettive teorie, gli elementi
188 Ivi, pp. 121-22.
89
che ci permettono di identificare e/o definire le opere d’arte − sono tra le procedure più
seguite dagli appartenenti al mondo dell’arte: esse sono i modi in cui comunemente gli storici,
i critici, i curatori di mostre e talvolta gli artisti stessi identificano le opere d’arte,
attribuiscono loro determinate etichette, ne determinano i rapporti di influenza e le linee di
sviluppo. Per entrambi gli autori il nostro giudizio sull’arte − intendendo con ciò un giudizio
classificatorio e non valutativo − è rimesso nelle mani dei critici e degli storici. Carney lo dice
esplicitamente: per usare correttamente l’espressione “opera d’arte” non abbiamo bisogno di
una particolare conoscenza, ma possiamo semplicemente affidarci al giudizio degli esperti,
ovvero di coloro i quali rilevano con cognizione di causa le connessioni stilistiche tra le opere 189. Carroll evidenzia giustamente che tanto l’attività creativa e produttiva dell’artista quanto
quella ricettiva dello spettatore devono procedere parallelamente, ricostruendo da due punti di
vista complementari il medesimo fenomeno, ovvero l’evoluzione della tradizione artistica nel
suo dispiegarsi di riprese, innovazioni, rivoluzioni e via dicendo. Tuttavia entrambe le attività
rischiano pericolosamente di collassare nella figura del critico. E’ infatti il critico, e non uno
spettatore qualunque (fosse anche preparato e sensibile), a costruire le narrazioni storiche e a
stabilire sulla base di queste che cosa debba rientrare nella famiglia delle opere d’arte.
L’artista stesso può far sì che le proprie opere siano accettate dal mondo dell’arte
semplicemente costruendovi intorno la cornice più adatta, ovvero inserendole all’interno di
una narrazione che risulti convincente in quanto verosimile. Abilità retorica più che perizia
tecnica, furbizia più che talento: questa è a mio avviso una delle pecche di certa arte
contemporanea.
Levinson non si spinge tanto oltre. Egli parla di spettatori qualificati, non di storici o di
critici. E’ consapevole della dimensione sociale della sua definizione, ma la confina a due
settori − la necessità di prendere in considerazione alcuni elementi della vita dell’artista (le
sue dichiarazioni pubbliche, i suoi appunti, etc.) per inferire la sua intenzione e l’ammissione
dell’esistenza di una base condivisa di opere d’arte paradigmatiche − che non esauriscono lo
spazio entro cui lo spettatore si muove per elaborare il proprio giudizio (sempre classificatorio
e non di merito) sull’arte. E’ proprio tale eccedenza del giudizio critico-artistico rispetto a
considerazioni di carattere storico-sociale ad aver creato dei problemi alla definizione di
Levinson. Per definire un oggetto come un’opera d’arte entrano infatti in gioco fattori ulteriori
e non riducibili al riferimento storico-intenzionale dell’oggetto al passato della storia dell’arte
− quali ad esempio le proprietà intrinseche esibite dell’oggetto (da cui nemmeno l’intenzione
189 J. Carney, “The Style Theory of Art”, cit., p. 273.
90
può prescindere, dato che la si inferisce proprio dalla percezione di tali proprietà, in relazione
al contesto di produzione dell’oggetto), o anche la sua capacità di produrre un’esperienza di
grado e di valore pari a quella prodotta da opere d’arte del passato. Ciò ha messo seriamente
in dubbio la possibilità che la definizione storico-intenzionale sia in grado di fornire
condizioni necessarie e sufficienti all’artisticità 190.
Quando scrive Extending Art Historically, Levinson è a conoscenza delle teorie di Carroll
e Carney (almeno nelle loro prime formulazioni). Egli ne condivide ovviamente l’idea
generale, ovvero la nozione storica di arte, e intravede anche la possibilità di un’integrazione
feconda con alcuni elementi presenti nelle suddette teorie. Ciò riguarda principalmente il
concetto di ways of art-regards, ovvero di modi di considerazione artistici, la cui
indeterminatezza ha suscitato da subito numerose perplessità, e che può essere chiarito e
completato facendo riferimento alle relazioni di ripetizione, amplificazione e ripudio
introdotte da Carroll per definire le proprie strategie narrative e riprese da Carney per
sostenere le connessioni stilistiche su cui poggia la sua teoria 191. Tali relazioni ci aiutano a
comprendere meglio anche uno dei presupposti empirici della teoria di Levinson, ovvero la
continuità della storia dell’arte e l’intima causalità sottesa alla sua evoluzione.
Sia l’evoluzione di un determinato genere o forma artistica (Carroll) sia le connessioni
stilistiche che si possono rintracciare tra le opere d’arte (Carney) sono quindi per Levinson
fattori di primaria importanza; tuttavia nessuno dei due può da sé costituire una condizione
sufficiente in una definizione dell’arte 192. Tanto le narrazioni storiche quanto le
classificazioni stilistiche risultano infatti secondo Levinson arbitrarie se non vengono
ricondotte all’intenzione dell’artista, la quale sola è in grado di garantire ad esse coerenza e
unità193. In realtà sia Carroll che Carney forniscono delle condizioni che limitano l’arbitrarietà
rispettivamente delle narrazioni storiche − le quali devono essere veritiere, cronologicamente
ordinate e soprattutto esplicative (il che significa a sua volta che esse devono seguire lo
190 Va detto che, se non si tenesse conto di tutto il dibattito di obiezioni e repliche che ha portato Levinson ad apportare una serie di importanti modifiche alla sua definizione storico-intenzionale, questa si avvicinerebbe maggiormente all’interpretazione in senso istituzionale delle teorie di Carroll e Carney da noi appena fornita, e incorrerebbe quindi nello stesso errore di spostare “il peso della decisione su cosa sia o non sia arte su qualcun altro” (P. D’Angelo, “La definizione dell’arte”, in Id. (a cura di), Introduzione all’estetica analitica, Laterza, Milano-Bari 2008, p. 29). 191 Levinson lo accenna in “Extending Art Historically”, cit., pp. 164-67. In realtà è Noel Carroll a prefigurare la possibilità di una mutua assistenza tra la propria teoria e quella di Levinson in “Art, Practice and Narrative”, cit., p. 155. 192 J. Levinson, “Extending art Historically”, cit., p. 166. Carroll, si è detto, non propone in realtà una definizione dell’arte, ma elabora semplicemente un metodo di identificazione delle opere d’arte. Tuttavia, osserva Levinson in una nota, se le strategie narrative non concorrono anche a fornire una caratterizzazione di ciò che è arte, e non solamente di “ciò che si dice sia arte”, allora il loro interesse filosofico si riduce di molto. 193 Ivi, pp. 166-67.
91
schema precedentemente illustrato e costituito da un inizio, una complicazione e una fine) − e
delle classificazioni stilistiche − le quali devono la loro correttezza al rispetto di una serie di
restrizioni riguardanti tanto gli stili generali quanto gli stili individuali. Entrambi gli autori
ritengono quindi di poter fare tranquillamente a meno della condizione di intenzionalità, che
non viene affatto presa in considerazione da Carroll e che Carney affianca alle altre
condizioni che limitano l’assegnazione di uno stile individuale a un artista, senza con questo
riconoscerle un ruolo privilegiato rispetto alle altre condizioni (data anche la frequente
oscurità e inconsistenza delle intenzioni espresse dall’artista) 194. Vediamo allora più da
vicino se le loro teorie sono in grado di respingere le obiezioni che hanno messo in crisi la
definizione storica di Levinson. Sarà sufficiente limitare la nostra attenzione al problema
classico dello statuto ontologico delle prime opere d’arte.
Carroll affronta tale problema riconoscendo per le prime opere d’arte un criterio di
identificazione diverso da quello costituito dalle narrazioni storiche. Tale criterio è di tipo
funzionale. Se sostituiamo il termine “definizione” al termine “identificazione” otterremo la
soluzione che Levinson adotta di fronte al medesimo problema. Se però ciò apre una crepa
all’interno della definizione di Levinson, Carroll ritiene che la propria teoria non corra lo
stesso rischio, dato che il suo scopo non è definitorio, ma solamente classificatorio. Egli
sostiene che il ricorso a criteri funzionali sia l’unico sistema possibile quando si ha a che fare
con le origini di una tradizione artistica; ciò non toglie tuttavia che per identificare le opere
d’arte successivamente realizzate (quindi la stragrande maggioranza delle opere d’arte in
genere) si debba privilegiare il metodo delle narrazioni storiche. Ma Carroll può veramente
dormire sonni tranquilli? Se infatti le prime opere d’arte vengono individuate attraverso il
ricorso a criteri funzionali, e se la storia dell’arte si evolve in modo continuo e graduale (come
testimoniato dalle stesse narrazioni storiche, che su tale continuità − interpretata
alternativamente nella forma della ripetizione, dell’amplificazione, ecc., del passato − sono
costruite), perché allora non identificare anche le opere successive a quelle originarie per
mezzo degli stessi criteri funzionali utilizzati nei confronti di queste ultime? 195
Se si vuole evitare di ricadere nel funzionalismo, occorre allora cercare una soluzione
diversa da quella adottata da Levinson e Carroll. Questo è quanto si propone di fare Carney
quando sostiene che le prime opere d’arte sono definibili come tali retrospettivamente e per
effetto del loro collegamento a stili artistici successivi e riconosciuti. In tal modo però Carney
194 Carney cita Kasimir Malevich come esempio di artista che espresse le proprie intenzioni artistiche in maniera oscura e contraddittoria (v. J. Carney, “The Style Theory of Art”, cit., p. 276). 195 Questo è anche ciò che Carney domanda a Carroll: “Se la proto-arte può essere individuata funzionalmente, perché non possono esserlo anche gli oggetti successivi?” (J. Carney, “The Style Theory of Art”, cit., p. 284)
92
ricade nelle obiezioni a suo tempo mosse da Stephen Davies a Levinson, laddove questi aveva
avanzato una soluzione (successivamente rigettata) alla quale Carney stesso si ispira. Carney
afferma infatti che le prime opere d’arte acquisiscono le proprietà stilistiche (le quali
permettono a tali opere di essere definibili come artistiche) solo in un secondo momento,
ovvero solo quando vengono realizzate delle opere d’arte (il cui status viene immediatamente
e unanimemente riconosciuto) che presentano delle somiglianze stilistiche con tali opere
originarie. Questa giustificazione è però secondo Davies incompatibile col presupposto che
fonda ogni definizione ricorsiva (compresa quella stilistica) dell’arte, ovvero con l’idea che le
prime opere d’arte siano tali al momento della loro creazione. Se si nega infatti tale
presupposto (ovvero se lo statuto delle prime opere d’arte non è certo e stabile, ma dipende da
eventi futuri e contingenti), allora nessun oggetto potrà essere definito come artistico
unicamente attraverso il riferimento storico (sia esso intenzionale, stilistico o di altro tipo) ad
opere passate, dato che la serie di riferimenti storico-ricorsivi ha inizio proprio dalle prime
opere d’arte. Davies non ritiene in generale plausibile l’idea che il futuro possa modificare
ontologicamente il passato: pertanto non è nemmeno credibile pensare che i ready-made di
Duchamp abbiano dovuto aspettare l’avvento dell’arte concettuale per veder loro riconosciuto
la status di opere d’arte 196.
Si deve quindi concludere che né la teoria di Carroll né quella di Carney riescono a
superare gli ostacoli contro i quali si era impigliata la teoria di Levinson. L’integrazione della
definizione storica dell’arte con elementi di tipo istituzionale e la sostituzione dell’intenzione
dell’artista con la specificazione delle relazioni che uniscono le opere d’arte del presente a
quelle riconosciute del passato, non sono in ultima analisi in grado di sostenere il confronto
col problema delle prime opere d’arte e con tutto ciò che ne segue. Resta ancora da verificare
se l’idea generale secondo cui l’attuale concetto di arte è definibile attraverso il riferimento
storico all’arte precedente, possa mantenere una fertilità teoretica (e quindi anche
un’utilizzabilità pratica) mediante la sua integrazione con elementi di tipo funzionale. Questa
è la strada intrapresa da Robert Stecker: non ci rimane che percorrerla e vedere se la direzione
da lui indicata è quella giusta.
196 S. Davies, “First Art and Art’s Definition”, cit., pp. 21-22. L’idea che i ready-made non fossero arte al momento della loro creazione, oltre ad essere poco credibile da un punto di vista teoretico, è anche storicamente falsa. Dopo aver provocato uno shock iniziale, l’orinatoio di Duchamp venne ben presto accettato come opera d’arte da una buona fetta del mondo dell’arte.
93
3.4 Il funzionalismo storico di Robert Stecker
A) HA ANCORA SENSO CERCARE DI DEFINIRE L’ARTE?
Rispetto agli autori fin qui trattati Robert Stecker è di qualche anno più giovane. La sua
definizione, detta storico-funzionalista, dell’arte è, tra le teorie che in senso ampio possiamo
denominare storiche, la più recente in ordine di tempo. La prima definizione storica dell’arte
risale infatti alla fine degli anni Settanta del secolo scorso (Defining Art Historically di
Levinson è del 1979), mentre la teoria delle narrazioni storiche e quella stilistica dell’arte si
muovono a cavallo fra gli anni Ottanta e Novanta (Art, Practice and Narrative di Carroll è del
1988, The Style Theory of Art di Carney è del 1991). La prima compiuta formulazione della
definizione storico-funzionalista avviene invece a metà degli anni Novanta, con la
pubblicazione nel 1994 dell’articolo di Stecker intitolato Historical Functionalism or the
Four-Factor Theory. Ciò significa che se da un lato Stecker può far tesoro del dibattito che si
è sviluppato intorno alle teorie dei suoi predecessori (dibattito al quale egli stesso ha fornito
importanti spunti di riflessione), dall’altro lato egli si trova ad operare in un clima di
scetticismo che avvolge non solo il circoscritto ambito delle definizioni storiche, ma che
riguarda più in generale il problema stesso della definizione dell’arte, ovvero uno dei temi
centrali dell’estetica analitica. Tale scetticismo è ancora più radicale di quello sostenuto negli
anni Cinquanta dai neo-wittgensteiniani (Weitz, Ziff, Kennick). Difatti mentre
l’antiessenzialismo promosso da tali autori determinò un rifiorire della questione della
definizione dell’arte, se pur affrontata su basi diverse da quelle su cui poggiavano le teorie
essenzialiste classiche, l’apparente fallimento dei tentativi da allora compiuti ha finito per
gettare discredito sulle definizioni elaborate tra gli anni Sessanta e Ottanta e per mettere in
dubbio anche la possibilità di definire l’arte in modo relazionale.
In un siffatto contesto Stecker, oltre ad avvertire l’urgenza di proporre una propria
definizione dell’arte, sente anche la necessità di porsi delle domande circa la legittimità di tale
impresa. Recentemente egli ha scritto un articolo significativamente intitolato Is It
Reasonable to Attempt to Define Art?, che riprende e sviluppa alcuni temi introdotti in un
precedente saggio, all’interno di un capitolo anch’esso dal titolo inequivocabile (Why Should
We Look for a Definition of Art?). Stecker ritiene al proposito che la situazione che si è andata
delineando negli ultimi anni sia piuttosto paradossale: se da un lato si può osservare come le
diverse definizioni dell’arte elaborate dopo la svolta anti-essenzialista sembrino finalmente
trovare dei punti di convergenza, dall’altro lato si assiste a una preoccupante diffusione di
94
sentimenti di sfiducia nei confronti del valore del progetto di definire l’arte e della sua
effettiva praticabilità. Lasciando per ora da parte il primo aspetto, vediamo come Stecker
interpreta questo rinnovato clima di scetticismo.
Rispetto allo scetticismo degli anni Cinquanta − che muoveva da presupposti di ordine
concettuale, in particolare dalla contrapposizione della nozione di arte come concetto aperto e
della teoria delle somiglianze di famiglia da un lato alla definizione del concetto di ‘arte’ in
termini di condizioni necessarie e sufficienti dall’altro − la nuova ondata di scetticismo fa
perno su argomentazioni di carattere meno teoretico e maggiormente empirico. Esse sono
riassumibili in tre punti. Il primo consiste nel cosiddetto argomento induttivo: dato che i
tentativi finora elaborati di definire l’arte hanno mancato il loro scopo, da ciò segue che ogni
analogo tentativo futuro sarà destinato al fallimento. Stecker contesta tanto la premessa di tale
argomento − non è infatti vero che tutti i tentativi definitori sono stati dei fallimenti − quanto
la conclusione − la validità di un ragionamento induttivo dipende infatti dalla sua capacità di
rintracciare regolarità tra i fenomeni indagati, cosa che però non si è verificata per quanto
concerne le definizioni in esame 197.
Un secondo e più raffinato argomento è quello denominato no single-concept argument. A
differenza del ragionamento induttivo, che non mette in discussione il fatto che vi sia un
‘qualcosa (un insieme di proprietà, oggetti e condizioni) da definire’, il no single-concept
argument afferma che non vi sia affatto un ‘qualcosa da definire’, dal momento che sotto il
termine ‘arte’ raggruppiamo condizioni, proprietà e oggetti del tutto eterogenei, e non esiste
quindi un unico concetto di arte. A questa conclusione i sostenitori di tale posizione
pervengono attraverso l’osservazione dell’attuale mondo dell’arte (intendendo la nozione nel
senso più ampio possibile), dove si può riscontrare un disaccordo tra professionisti (artisti e
critici) e tra semplici appassionati circa cosa sia realmente arte; disaccordo che testimonia
l’esistenza di una pluralità di concetti dell’arte, spesso in aperto conflitto tra loro. Secondo
Stecker, anche questa argomentazione parte da premesse tutt’altro che incontestabili.
Innanzitutto, a ciascun termine corrispondono nell’uso comune più concetti, la cui divergenza
può dipendere da fattori di ordine empirico; nel nostro caso, i diversi concetti di arte riflettono
spesso le differenze di conoscenza e sensibilità delle persone, la loro maggiore o minore
familiarità con determinate opere o movimenti artistici, il loro ancoramento a pregiudizi vari,
e via dicendo. Ciò ci porta a fare anche un'altra considerazione, ovvero che non tutti i concetti
di ‘arte’ esistenti meritano la nostra attenzione. Molte concezioni individuali dell’arte sono
197 R. Stecker, Definition, Meaning, Value, cit., p. 24.
95
“preriflessive, insufficientemente informate e prevenute”: pertanto le concezioni dell’arte da
mettere a confronto non sono tutte le concezioni individuali riscontrabili, ma solo quelle
adeguate, ovvero quelle in grado di soddisfare un certo numero di desiderata. Quali e quanti
sono questi desiderata? Secondo Stecker una concezione adeguata dell’arte deve essere ben
informata (ad esempio sulla storia dell’arte), non condizionata da pregiudizi, riflessiva,
coerente, non circolare, capace di catturare l’estensione comunemente accettata del termine
‘arte’ e di dare una giusta collocazione ai cosiddetti casi limite. Il numero delle concezioni
adeguate dell’arte, ovvero di quelle che soddisfano la suddetta lista di criteri, è di gran lunga
inferiore al numero delle concezioni individuali: il mondo dell’arte è quindi assai meno
frammentato rispetto a quanto sostenuto dagli scettici. Certo, non si può negare che le
concezioni adeguate siano più d’una e che vi siano delle differenze evidenti tra le stesse.
Tuttavia tali differenze si producono a partire da una base comune − coloro che affrontano la
sfida di rispondere alla domanda ‘che cosa è arte’ giocano sullo stesso terreno e seguono le
stesse regole − e ciò garantisce un certo grado di affinità tra le concezioni rivali 198.
Vi è infine un argomento politico, stante al quale ogni definizione è per sua natura un
esercizio di repressione, di cui sono state vittime (in quanto escluse dal novero delle opere
d’arte) di volta in volta le arti popolari, quelle socialmente minoritarie o non riconosciute e
l’avanguardia più sperimentale. A tal proposito Stecker sottolinea che ogni definizione deve
di necessità escludere qualcosa dal suo ambito di applicazione; l’eccessività inclusività ne
impedirebbe l’efficacia operativa. Peraltro, le definizioni dell’arte proposte in tempi recenti
(come quelle istituzionali o storiche) si sono distinte per il tentativo di dar conto anche dei
suddetti casi limite (sebbene con soluzioni a mio avviso talvolta artificiose) 199.
Di contro ai dubbi degli scettici, Stecker ribadisce l’importanza del progetto definitorio. La
modernità ha infatti causato tanto un’estensione dell’uso del termine ‘arte’, quanto un
cambiamento nel nostro stesso modo di pensare l’arte. Di fronte a tali sollecitazioni è sorta
l’esigenza nei confronti di uno strumento in grado di distinguere ciò che è arte da ciò che non
lo è (le opere d’avanguardia più radicali hanno in tal senso ridisegnato i confini del territorio
artistico), di capire perché un oggetto simile a un’opera d’arte ciononostante non meriti tale
appellativo ( si pensi di nuovo ai ready-made di Duchamp) e di determinare il nostro attuale
concetto di arte mostrandone le somiglianze e le differenze con le precedenti concezioni.
L’unico strumento con cui possiamo affrontare efficacemente tali problematiche è la
198 R. Stecker, “Is It Reasonable an Attempt to Define Art?”, in N. Carroll (ed. by), Theories of Art Today, cit., pp. 54-56. 199 R. Stecker, Definition, Meaning, Value, cit., pp. 26-27.
96
definizione dell’arte 200. Oltre a tali ragioni di carattere generale, un altro fattore concorre a
motivare la ricerca di una definizione dell’arte. Si tratta, come anticipato in precedenza, della
convergenza che secondo Stecker si è venuta a registrare in tempi recenti tra le due principali
definizioni proposte dopo la svolta anti-essenzialista degli anni Cinquanta, ovvero la
definizione istituzionale e quella storico-intenzionale. Ciò che è particolarmente interessante
notare è che la convergenza si attua principalmente grazie all’integrazione di tali definizioni
con alcuni aspetti della teoria funzionalista dell’arte; integrazione che permette loro di
superare le difficoltà che il dibattito analitico più recente ha a più riprese evidenziato, e su cui
Stecker costruirà (come vedremo poi) la propria definizione dell’arte.
Il primo punto di convergenza riguarda il carattere disgiuntivo, che sarà formalizzato solo
nella teoria di Stecker, ma che è presente più o meno implicitamente anche nelle due
definizioni in questione. Per quanto riguarda la definizione storica, la sua versione principale
non fa riferimento ad alcuna forma di disgiunzione; tuttavia essa nasconde una serie di
disgiunzioni, altrove giustificate da Levinson come corollari alla sua definizione, ma che in
realtà ne costituiscono dei presupposti ineliminabili. Stecker si riferisce qui all’esistenza di
due tipi di intenzioni, l’una relazionale e l’altra intrinseca; di due diverse condizioni
sufficienti all’artisticità, l’una relativa al processo creativo dell’artista e l’altra ascrivibile al
diritto di appropriazione dell’opera da parte del pubblico; e soprattutto di un modo non storico
di definire le prime opere d’arte. E’ stata proprio la presenza di queste ed altre ‘impurità’ nella
definizione di Levinson che ci hanno spinto a cercare soluzioni alternative a quella da lui
fornita. Per quanto concerne invece la definizione istituzionale, a prima vista essa non
presenta alcun elemento disgiuntivo, né implicito né tantomeno esplicito. Stecker ritiene
tuttavia che senza l’aggiunta di una condizione ulteriore e alternativa a quella istituzionale,
tale definizione non sia in grado di dar conto di quelle forme d’arte che si sono sviluppate al
di fuori dei circuiti sociali istituzionalizzati. Il ricorso a una condizione aggiuntiva e diversa
da quella primaria è quindi per entrambe le definizioni una necessità ineludibile 201.
Il secondo punto in cui la definizione storica e quella istituzionale si incrociano è
rappresentato proprio dalla natura della condizione aggiuntiva a cui esse sono costrette a
ricorrere. La questione che maggiormente pressa Levinson, ovvero ‘che cosa fa di una
tradizione una tradizione artistica’, può analogamente essere rivolta a Dickie nella forma ‘che
cosa fa di una istituzione un’istituzione artistica’. In entrambi i casi è possibile trovare una
risposta solo risalendo alle origini delle nostre tradizioni e istituzioni artistiche, ovvero alle
200 Ivi, pp. 14-18. 201 R. Stecker, “Is It Reasonable to Attempt to Define Art?”, cit., pp. 48-9.
97
prime opere d’arte, che sono identificabili per il loro assolvere (in modo eccellente) funzioni
di tipo estetico. La condizione di cui le definizioni in questione hanno bisogno è quindi una
condizione funzionale. Con ciò Stecker non vuol dire però che tutta l’arte debba essere
definita in termini estetici. Le funzioni artistiche, una volta che hanno dato origine a
determinate tradizioni e sono state inserite in determinate cornici istituzionali, si evolvono con
l’evolvere di tali tradizioni e istituzioni. Insieme alla funzione, e oltre all’intenzione e
all’istituzione, l’altro fattore da cui le definizioni dell’arte non possono prescindere è quindi la
storia 202.
Su questo terreno comune − costituito da quattro fattori, ovvero l’intenzione, l’istituzione,
la funzione e la storia − è possibile secondo Stecker costruire una “consensus view” in grado
di soddisfare in pieno i desiderata sopra indicati attraverso una sorta di mutua assistenza: la
definizione istituzionale serve a dare una giusta collocazione alle opere d’arte più radicali e
sperimentali, quella funzionale si applica meglio alle opere tradizionali, e quella storica
stabilisce un collegamento delle une con le altre 203. La definizione alla quale una siffatta
visione d’insieme darà luogo non potrà che avere una forma disgiuntiva. Prima però di
analizzarla da vicino, sarà utile approfondire la nozione di funzionalismo e il suo utilizzo in
ambito artistico.
B) LA NOZIONE DI FUNZIONALISMO
Definitions of Art (1991) di Stephen Davies è un testo importante per la storia dell’estetica
analitica, in quanto per la prima volta viene data una visione generale nonché genealogica del
problema della definizione dell’arte. Prima di dedicarsi a un’esauriente panoramica delle
diverse definizioni proposte nella seconda metà del Novecento, Davies introduce una
distinzione tra definizioni funzionali e procedurali; distinzione che fa capo a sua volta a
un’interessante analisi della nozione di funzionalismo, che ripercorreremo ora brevemente 204.
La natura è secondo Davies interpretabile come una successione continua di enti e di eventi
che differiscono in modo graduale e impercettibile l’uno dall’altro; pertanto ogni
categorizzazione o divisione della natura in classi o tipi dipende dalla nostra struttura o dalle
nostre concezioni del mondo, ovvero dai modi in cui operiamo delle divisioni entro tale
continuum. Le proprietà che costituiscono i concetti entro cui racchiudiamo determinate
porzioni di tale continuum sono quindi relazionali, in quanto definite dalla relazione tra alcuni
202 Ivi, pp. 49-51. 203 Ivi, pp. 59-61. 204 Nel corso del nostro lavoro abbiamo spesso utilizzato i termini ‘funzionale’ e ‘procedurale’, che necessitano quindi di una definitiva chiarificazione.
98
elementi della natura e alcuni elementi dell’osservatore. La relazione sottesa ad ogni proprietà
e ad ogni concetto può tendere alternativamente verso la particolarità (laddove a prevalere
sono le condizioni di osservazione e categorizzazione) o verso l’universalità (laddove le
condizioni di osservazione sono standard, ossia comuni a tutti gli uomini, e quindi la
classificazione rivela maggiormente la realtà osservata piuttosto che quella dell’osservatore).
Davies fa l’esempio della divisione dello spettro sonoro in ottave: la diversità del modo di
dividere il continuum sonoro nelle diverse tradizioni musicali è indice della varietà delle
culture esistenti, mentre il fatto che in tutte queste diverse tradizioni si faccia comunque
riferimento all’ottava come unità di misura rivela qualcosa della struttura del mondo (in
questo caso del suo aspetto acustico). Ad ogni modo, l’ottava non è un concetto naturale, in
quanto dipende dall’incontro di un elemento soggettivo con uno oggettivo 205.
In generale la maggior parte dei concetti di cui facciamo uso è collegata ai nostri bisogni,
interessi, desideri. Ciò vuol dire che i nostri concetti sono perlopiù definiti funzionalmente: in
tal caso, ciò che ci permette di classificare un oggetto sotto il concetto X è il suo asservire lo
scopo sotteso a X, ovvero la sua efficacia funzionale rispetto a tale scopo. Un esempio di
concetto definito funzionalmente è il veleno: infatti ciò che ci permette di identificare un
oggetto come veleno non è tanto la sua costituzione, quanto la sua capacità di provocare un
determinato effetto (in questo caso deleterio), ovvero di assolvere una determinata funzione.
Non tutti i concetti sono però definibili funzionalmente. Uno di questi è il concetto di cibo:
difatti non tutto ciò che può assolvere la funzione del nutrimento è definibile in ogni luogo
come cibo. Un altro esempio è costituito dal concetto di gentilezza: se ci comportiamo
gentilmente per essere gentili, e non per aiutare il prossimo, noi avremo forse realizzato lo
scopo della gentilezza, ma non per questo potremo essere definiti gentili 206.
Gli esempi di concetti non definibili funzionalmente non terminano qui. Davies sottolinea
come spesso le istituzioni e le convenzioni sociali originariamente create per permettere
l’assolvimento di determinate funzioni, sviluppino ad un dato momento la tendenza a vivere
di vita propria e indipendente dalle funzioni alle quali erano legate. La separazione delle
funzioni dalle procedure dipende da vari fattori: la procedura può assolvere delle funzioni
proprie o assolvere contemporaneamente diverse funzioni; si può verificare un gap tra
l’efficacia della procedura e l’effettivo assolvimento della funzione; una volta avviata, la
procedura può assolvere una funzione diversa e talvolta perfino contraria a quella iniziale.
Laddove si verifichino tali circostanze, un concetto inizialmente definito funzionalmente
205 S. Davies, Definitions of Art, cit., pp. 23-26. 206 Ivi, pp. 26-31.
99
tende ad essere successivamente definito proceduralmente, ovvero nei termini delle
convenzioni e delle procedure che lo costituiscono piuttosto che della sua specifica funzione.
Davies fa l’esempio del concetto di proprietà: sebbene sia nato per assolvere la funzione di
garantire la convivenza sociale, esso può portare a conseguenze contrarie a tale funzione (vi
può essere una persona che diventa proprietaria di tutti i beni di una comunità, rendendo in tal
modo impossibile la sopravvivenza degli altri cittadini) e ciononostante mantenere la sua
validità (la persona in questione rimane la legittima proprietaria dei suoi beni in quanto la
procedura da lui seguita per acquisirli è corretta ed è ciò che la comunità stessa riconosce
come costitutiva del concetto di proprietà). Quando si verificano tali circostanze, ovvero
quando la procedura si distacca dalle funzioni − e quindi il concetto non è definibile
contemporaneamente in modo funzionale e procedurale − diviene di primaria importanza
stabilire se tale concetto è funzionale o procedurale, per sapere su quali basi (funzionali o
procedurali) stabilire se un oggetto può rientrare nel concetto considerato 207.
Passando finalmente alle opere d’arte, risulta piuttosto evidente che esse non costituiscono
un continuum naturale, e che non vi sono proprietà intrinseche esibite comuni a tutte le opere
d’arte. Ciò suggerisce che il concetto di arte sia eminentemente relazionale e che esso debba
essere definito dalla relazione tra determinati enti o eventi da un lato e le funzioni che essi
assolvono o le procedure che sono all’origine della loro identificazione dall’altro. In
particolare la situazione dell’arte moderna − nella quale si è verificato un progressivo
distanziamento dello scopo o funzione dell’arte dalle procedure di conferimento di status
artistico − rende secondo Davies impossibile una definizione del concetto di arte che sia
congiuntamente o disgiuntamente funzionale e/o procedurale. La scelta tra una delle due è
inevitabile. Il principale esponente della definizione procedurale dell’arte è, come si sa,
George Dickie, il quale sostiene che, sebbene il raggiungimento di un dato scopo o di una
certa funzione costituisca un fattore importante per il conferimento di status artistico a un
oggetto, ciononostante un oggetto è definibile come opera d’arte se e solo se esso riceve tale
status da chi ha l’autorità per assegnarlo, secondo le procedure adeguate e indipendentemente
dal suo assolvere o meno una funzione artistica. Viceversa i sostenitori della definizione
funzionale (tra cui spicca il nome di Monroe Beardsley) affermano che un oggetto è un’opera
d’arte se e solo se esso assolve la funzione specifica dell’arte, indipendentemente dalle
procedure seguite per il conferimento pubblico di status artistico 208.
207 Ivi, pp. 31-37. 208 Ivi, pp. 37-39.
100
La divergenza tra i due modelli definitori emerge soprattutto in relazione ai famosi casi
limite, ovvero a quelle opere (di cui i ready-made di Duchamp e la musica aleatoria di Cage
sono esempi paradigmatici) che ricadono nello spazio lasciato aperto dalla frattura tra
funzioni e procedure. Secondo la definizione procedurale tali oggetti sono senza dubbio delle
opere d’arte, dal momento che sono state presentate al pubblico seguendo le procedure
accordate e riconosciute dal mondo dell’arte; ad essere in discussione non è tanto il loro status
artistico, quanto piuttosto la status dell’arte in generale, che tali opere interrogano alla radice.
Viceversa secondo la definizione funzionalista è proprio lo status artistico di tali oggetti ad
essere opinabile, mentre lo status dell’arte in generale non risente affatto della loro supposta
carica eversiva. Un altro punto di contrasto è costituito dalla distinzione tra uso descrittivo e
uso valutativo della classificazione delle opere d’arte (ammesso che sia proprio questo lo
scopo di una definizione dell’arte). La definizione procedurale sostiene infatti che una corretta
classificazione delle opere d’arte sia puramente descrittiva: solo dopo che degli oggetti sono
stati identificati come artistici è possibile dar loro una valutazione di merito, sulla base della
diversa capacità di assolvere le funzioni specifiche dell’arte. Secondo la definizione
funzionalista invece lo stesso atto classificatorio è un atto valutativo. Esiste infatti una soglia
di merito, misurato in termini della capacità di servire la funzione dell’arte, che un oggetto
deve raggiungere per poter essere identificato come opera d’arte. A questo punto si può poi
distinguere tra arte buona o meno buona a seconda del maggiore o minore grado di eccedenza
dell’opera rispetto a tale soglia. Infine, la definizione funzionalista pretende anche di dare una
giustificazione del posto preminente che l’arte occupa tra le attività umane, laddove la
definizione procedurale non avanza una siffatta pretesa (il che non è secondo Davies
necessariamente un punto a sfavore di quest’ultima) 209.
Dopo questo excursus daviesiano sul concetto di funzione e sulla genesi delle definizioni
funzionali e procedurali, possiamo finalmente analizzare da vicino la definizione storico-
funzionale proposta da Stecker, il cui punto di partenza, costituito dalla sua personale
definizione di funzionalismo, alla luce di quanto appena esposto non necessita di ulteriori
chiarimenti. “Considero una definizione come funzionalista”, dice Stecker, “se essa cerca di
definire l’arte nei termini delle funzioni delle opere d’arte, delle forme d’arte o dei generi
artistici, o nei termini delle intenzioni di soddisfare tali funzioni” 210.
209 Ivi, pp. 39-47. 210 R. Stecker, Artworks: Definition, Meaning, Value, cit., p. 32.
101
C) LA DEFINIZIONE STORICO-FUNZIONALE DELL’ARTE
Una definizione funzionalista pura (del tipo appena enunciato) va inevitabilmente incontro
a due problemi all’apparenza insormontabili. Innanzitutto, le principali definizioni
funzionaliste (ovvero le definizioni formali, espressive ed estetiche) hanno legato l’arte
all’assolvimento di un’unica funzione (rispettivamente l’esibizione di proprietà formali,
l’espressione di emozioni, la produzione di un’esperienza estetica). Tuttavia, osserva Stecker,
la storia ci insegna che l’arte è stata concepita in termini di funzioni diverse a seconda del
mutare dei luoghi e del succedersi delle epoche. Inoltre se anche tali definizioni indicassero
un numero più ampio di funzioni specifiche dell’arte, esse non sarebbero in grado di
applicarsi all’arte del futuro, la quale potrebbe sviluppare funzioni nuove e non circoscrivibili
a un insieme limitato di funzioni. L’altro problema è rappresentato dalla cosiddetta bad art.
Per una definizione funzionalista un’opera d’arte è tale se assolve la funzione specifica
dell’arte: essa non potrà quindi mai essere scadente. Tuttavia nella realtà abbiamo a che fare
con numerosi esempi di arte scadente, di cui la definizione funzionale non è evidentemente in
grado di dar conto. Stecker si propone di ovviare a tali problemi attraverso l’elaborazione di
una definizione funzionalista impura, secondo cui:
un oggetto è un’opera d’arte al momento t se e solo se a) esso fa parte di una delle forme d’arte
centrali in t ed è stato inteso per soddisfare una delle funzioni che l’arte ha in t, oppure b) esso è un
artefatto che raggiunge l’eccellenza nel soddisfare tale funzione (faccia o meno esso parte di una
forma d’arte centrale o sia o meno esso stato inteso per soddisfare tale funzione) 211.
La forma disgiuntiva della definizione di Stecker rispecchia la duplicità del nostro modo di
classificare le opere d’arte. La maggior parte di esse vengono infatti identificate attraverso la
prima condizione, che è di tipo storico-funzionale: un oggetto è un’opera d’arte in un dato
momento se rientra in una delle forme d’arte centrali riconosciute in tale momento e se è stato
creato con l’intenzione di soddisfare una delle funzioni che le opere appartenenti a tale forma
assolvono. In ogni momento della storia c’è un numero finito di forme d’arte centrali. Stecker
non specifica però tale numero e soprattutto ammette che esso possa variare insieme al
passare del tempo e al mutare del contesto storico-culturale: in tal modo egli riconosce la
possibilità della nascita di nuove forme d’arte (come è successo per la fotografia e il cinema)
e del parallelo sviluppo di nuove funzioni artistiche. Vi sono però anche oggetti che sono stati
211 R. Stecker, “Historical Functionalism or the Four-Factor Theory”, British Journal of Aesthetics 34 (1994), pp. 255-56.
102
creati per assolvere funzioni diverse da quelle riconosciute come artistiche, e che quindi non
rientrano nelle forme d’arte centrali di una tradizione, ma che ciononostante soddisfano
alcune di tali funzioni, e lo fanno in modo eccellente. La seconda condizione della definizione
di Stecker ci permette di considerare anche tali oggetti − che comprendono l’arte primitiva,
popolare e commerciale − come opere d’arte. La forma disgiuntiva consente quindi a Stecker
di ripararsi dall’accusa di ristrettezza che può essere rivolta alle definizioni funzionali pure.
Per ovviare poi al problema della bad art, egli adotta una forma disgiuntiva anche per la
prima condizione: oltre ad appartenere ad una forma d’arte centrale, un’opera d’arte deve
essere anche stata creata con l’intenzione di assolvere una delle funzioni sottese a tale forma.
In questo modo si giustifica l’esistenza di quei dipinti, romanzi, brani musicali e così via, di
mediocre fattura e valore, ma che non possiamo collocare in un ambito diverso da quello
artistico 212.
La definizione di Stecker, nella forma appena esposta, presenta ancora delle lacune.
Innanzitutto, come distinguere le funzioni artistiche da altri tipi di funzioni? Stecker ritiene
sufficiente a tal fine specificare che le funzioni che un’opera d’arte deve soddisfare, o che si
presuppone possa soddisfare (in virtù dell’atto intenzionale che precede la loro produzione),
sono le funzioni standard o correttamente riconosciute come appropriate alle forme d’arte
centrali di una tradizione. Un’ulteriore specificazione è a questo punto richiesta in riferimento
a quelle opere d’arte del passato, le quali sono state create per soddisfare funzioni artistiche
che sono state riconosciute come standard e corrette al momento della loro creazione, ma che
non lo sono più oggi, e che potrebbero tornare ad essere funzioni artistiche standard nel futuro
(in virtù della supposta variabilità delle forme e delle funzioni artistiche nel tempo). Bisogna
allora distinguere due classi di funzioni artistiche: quelle in uso quando l’opera è stata creata e
quelle in uso quando si affronta la questione della classificazione delle opere d’arte. Siano F
l’insieme delle forme d’arte centrali al momento t, S l’insieme delle forme d’arte centrali
quando l’opera w è stata creata, G l’insieme delle funzioni standard o correttamente
riconosciute per gli oggetti appartenenti a F, H l’insieme delle funzioni standard o
correttamente riconosciute per gli oggetti appartenenti a S. La definizione assumerà quindi la
seguente forma: w è un’opera d’arte al momento t se e solo se a) w appartiene a F e l’autore di
w l’ha intesa per soddisfare una funzione di G, oppure b) w appartiene a S e l’autore di w l’ha
intesa per soddisfare una funzione di H, oppure c) w raggiunge l’eccellenza nel soddisfare una
funzione di G 213.
212 Ivi, pp. 257-58. 213 R. Stecker, “The Boundaries of Art”, cit., pp. 270-71.
103
Nemmeno tale riformulazione è adeguata. In uno stesso momento può accadere infatti che
funzioni appropriate ad un particolare genere o forma d’arte non lo siano invece rispetto ad
altri generi o forme: essere una bella rappresentazione di un qualcosa può ad esempio essere
una funzione standard per la pittura (almeno fino all’Ottocento), pur avendo poco a che fare in
genere con la musica o l’architettura. Le funzioni vanno coordinate alle forme d’arte
appropriate. La condizione a) della seconda versione della definizione di Stecker diventa
quindi: … w ha la forma f, che è un membro di F, e l’autore di w l’ha intesa per soddisfare un
sottoinsieme di funzioni g1....gn di G tali che g1….gn sono funzioni di f 214.
La definizione di Stecker è ,come detto, una sintesi delle principali definizioni dell’arte che
sono emerse nel corso del dibattito analitico posteriore agli anni Cinquanta, ovvero la
definizione funzionalista, quella storico-intenzionale e quella istituzionale. Il funzionalismo è
la base da cui parte Stecker; lo storia e l’intenzione si integrano alla funzione nella prima
condizione della definizione, considerata nella sua prima e più semplice versione (la seconda
condizione è invece puramente funzionale). Dove possiamo ravvisare la componente
istituzionale? Stecker ricorre a criteri istituzionali per identificare le forme d’arte centrali: “ciò
che fa di qualcosa una forma d’arte centrale è il suo ottenere uno status nel mondo dell’arte”,
il che significa che “gli oggetti appartenenti a quelle forme tendono ad essere senza difficoltà
presentati secondo determinate procedure a determinati pubblici e ad essere accolti da questi
pubblici in determinate maniere” 215. La sintesi adesso è completa. Vediamo se funziona.
3.5 Perché la definizione di Stecker non funziona
A) I PROBLEMI DELLA DEFINIZIONE STORICO-FUNZIONALE DELL’ARTE
Partiamo dall’ultimo punto. Dato che le forme d’arte centrali sono individuate per mezzo
di criteri istituzionali, la definizione storico-funzionale potrebbe essere ricondotta a una
definizione istituzionale del tipo: w è un’opera d’arte se e solo se w appartiene a una forma
d’arte centrale. Ma allora, oltre a rendere superfluo il ricorso alla nozione di funzione, una
siffatta definizione ricadrebbe nelle ben note aporie che affliggono le definizioni istituzionali.
Stecker risponde sostenendo che il ricorso a criteri funzionali è necessario per risolvere tali
aporie (in primis esso gli permette di dar conto dell’arte prodotta al di fuori dei contesti
istituzionali) e utile a chiarire il concetto di appartenenza a una forma d’arte centrale. La
214 R. Stecker, Definition, Meaning, Value, cit., p. 56. Ovviamente le correzioni apportate alla condizione a) vanno approntate in modo analogo per la condizione b) della definizione. 215 R. Stecker, “Historical Functionalism or the Four Factor Theory”, cit., p. 263.
104
replica di Stecker non mi sembra convincente, in quanto rimane il sospetto che un mancato
ricorso ai suddetti criteri lascerebbe immutata la sostanza del discorso. Ma passiamo oltre.
Quella di Stecker è, come più volte ricordato, una definizione ibrida, in quanto costituita
dalla combinazione di nozioni tratte da altre definizioni dell’arte. Detto della componente
istituzionale, analizziamo ora più da vicino la componente storico-intenzionale. Essa riguarda
unicamente la prima parte della definizione, dove si afferma che un oggetto può essere
identificato come opera d’arte in un dato momento se e solo se esso appartiene a una forma
d’arte riconosciuta come centrale in tale momento ed è stato inteso per soddisfare una
funzione standard e corretta di tale forma. Stecker ammette i suoi debiti nei confronti di
Levinson sia per quanto riguarda l’utilizzo della nozione di intenzione, sia per il collegamento
dell’attuale concetto di arte alle funzioni standard e correttamente riconosciute come
appropriate alle forme d’arte centrali: tali funzioni altro non sono che i ways of art-regard
della definizione di Levinson. A differenza però di quest’ultimo, che confinava i ‘modi
corretti di considerare l’arte’ alle opere del passato, Stecker lega le funzioni artistiche
standard (o corrette) al fattore temporale, e garantisce quindi la possibilità (a suo avviso
testimoniata dalla storia dell’arte, in particolare da quella del Novecento) di un cambiamento
di queste stesse funzioni, che può sfociare anche nella nascita di nuove funzioni artistiche. Ciò
a detta di Stecker costituisce un indubbio vantaggio della sua definizione rispetto a quella di
Levinson; tuttavia le cose cambiano se si prendono nuovamente in considerazione le critiche
che Beardsley rivolse a suo tempo a Levinson. Beardsley affermava infatti che la nozione di
correttezza (riferita da Levinson ai modi di considerare l’arte del passato) fosse piuttosto
vaga, e che senza una chiusura di tale nozione (possibile secondo Beardsley solo facendo
appello alla nozione di funzione estetica) la definizione storica avrebbe corso il rischio di
essere troppo inclusiva, essendo la lista dei correct ways of art-regard indefinitamente ampia.
Lo stesso rischio corre la definizione di Stecker: se le funzioni artistiche standard o corrette
non solo non sono specificate, ma per di più cambiano col passare del tempo, allora davvero
in futuro ogni oggetto potrà diventare un’opera d’arte! Per quanto concerne poi il concetto di
intenzione, vale la pena ricordare come esso sia stata la base delle più feroci e incisive critiche
che hanno seriamente messo in crisi la definizione di Levinson. Ciò significa che anche la
definizione storico-funzionale dell’arte si aggira su un terreno minato.
Delle tre componenti che confluiscono nella consensus view di Stecker, a prevalere è
certamente quella funzionale. C’è però una disparità di trattamento, per così dire, nel modo in
cui le due distinte condizioni che formano la definizione disgiuntiva di Stecker (nella sua
versione più semplice) sono chiamate a rispondere a criteri funzionali. Difatti, mentre a un
105
oggetto che fa parte di una forma d’arte riconosciuta (si pensi a una poesia, a un dipinto o a
una sinfonia) è sufficiente l’attribuzione di un’intenzione artistica (ovvero, dell’intenzione che
esso soddisfi una funzione appropriata a tali forme) per acquisire lo status di opera d’arte, agli
oggetti che si situano al di fuori di tali forme (in quanto provenienti da mondi diversi da quelli
artistici, come l’artigianato, il design industriale, l’intrattenimento, ecc.) è richiesta anche
l’eccellenza nel soddisfare una o più delle funzioni artistiche riconosciute. Ciò significa che
solo nel primo caso si possono avere delle opere d’arte scadenti, mentre nel secondo avremo a
che fare solo con oggetti, seppur ibridi, di indubbio valore artistico (altrimenti non potremmo
usare per loro il termine ‘arte’). Portando agli estremi questa possibilità, ci troveremmo di
fronte ad un mondo popolato da poesie illeggibili, dipinti orrendi e sinfonie inascoltabili,
affiancati da automobili stupende, orecchiabili suonerie per i nostri cellulari e libri di ricette
davvero ben scritti: tutti ammassati nell’unico grande calderone delle opere d’arte. Di certo
non sarebbe il migliore dei mondi (dell’arte) possibili!
Stecker in realtà aveva inizialmente proposto una soluzione che potrebbe scongiurare
questa possibilità: si tratta dell’aggiunta della condizione per cui chi crea l’opera con
l’intenzione che essa soddisfi una funzione standard appropriata ad una determinata forma
d’arte centrale abbia anche una certa competenza in tale forma, di modo che la sua intenzione
possa essere presa sul serio216. Con tale precisazione Stecker ritiene di poter dar conto di
alcune intuizioni comuni, come quella secondo cui l’aspetto descrittivo di una definizione non
può essere separato dall’aspetto valutativo, o come la convinzione diffusa che vuole che
spesso solo le opere mature di un artista meritino di essere considerate come opere d’arte
(come lo stesso operare degli artisti, che talvolta distruggono le loro opere giovanili,
conferma). Tuttavia in un secondo momento Stecker toglie questa condizione dalla sua
definizione e la rende facoltativa, in quanto ritiene che le intuizioni a cui essa rende giustizia
non siano in realtà così diffuse e condivise. Certo, le nozioni di ‘competenza in una forma
d’arte’ e di ‘serietà dell’intenzione’ sono troppo vaghe per poter figurare in una definizione
dell’arte: non si può quindi biasimare Stecker per averne fatto a meno, ma allo stesso tempo
bisogna constatare che egli non dispone di mezzi adeguati per difendersi dalle obiezioni sopra
esposte, siano esse espresse nella forma di intuizioni più o meno diffuse o di previsioni
pessimistiche sul futuro dell’arte.
216 Stecker ne parla in “The Boundaries of Art”, cit., pp. 270-71.
106
B) FRANKENSTEIN JUNIOR
Secondo le parole dello stesso Stecker, a un artefatto si può assegnare la funzione F “se
relativamente a un dato contesto esso ha la reale capacità o abilità di servire lo scopo, per cui
esso è stato progettato e creato, sotteso a F, o se soddisfa tale scopo” 217. Proviamo allora ad
immaginare la definizione di Stecker come una macchina e vediamo se, tenendo a mente il
criterio appena enunciato, essa funziona. Abbiamo appena visto come ciascuna delle tre
componenti che si integrano nella definizione di Stecker − ovvero le componenti funzionale,
storico-intenzionale e istituzionale − contenga in sé dei problemi all’apparenza insolubili. La
meccanica ci insegna che se le singole parti di un congegno sono difettose, difficilmente esso
sarà in grado di assolvere il compito per il quale è stato concepito. Da ciò si deve concludere
che la definizione storico-funzionale dell’arte non ha la capacità di realizzare il suo scopo.
Rimane da verificare se ciononostante la sintesi operata da Stecker riesca a sopperire alla
deficienza dei singoli componenti e sia quindi in qualche misura funzionalmente efficace.
Stecker, vale la pena ricordarlo, aveva criticato Levinson in quanto questi, nel continuo
ricorrere all’aggiunta di correzioni e corollari vari alla sua definizione per difenderla dalle
critiche a più riprese subite, aveva finito per rendere la sua definizione enormemente
complicata, oltreché irriconoscibile (una definizione-monstre, come detto al termine del
secondo capitolo del nostro lavoro), e per ciò stesso inapplicabile. Anche Stecker però, come
abbiamo visto, si è trovato costretto ad apportare numerose modifiche alla versione iniziale
della sua definizione, nel tentativo di risolvere i problemi e le difficoltà a cui essa andava
incontro. Se ora mettiamo insieme tutte queste correzioni ed aggiunte, la definizione storico-
funzionale si presenta nella seguente forma:
Siano F l’insieme delle forme d’arte centrali al momento t, S l’insieme delle forme d’arte centrali
quando l’opera w è stata creata, G l’insieme delle funzioni standard o correttamente riconosciute per
gli oggetti appartenenti a F, H l’insieme delle funzioni standard o correttamente riconosciute per gli
oggetti appartenenti a S; w è un’opera d’arte al momento t se e solo se a) w ha la forma f, che è un
membro di F, e l’autore di w l’ha intesa per soddisfare un sottoinsieme di funzioni g1....gn di G tali
che g1….gn sono funzioni di f , e l’autore di w ha una competenza in f tale che la sua intenzione possa
essere presa sul serio, oppure b) w ha la forma s, che è un membro di S, e l’autore di w l’ha intesa per
soddisfare un sottoinsieme di funzioni h1….hn di H tali che h1….hn sono funzioni di s, e l’autore di w
ha una competenza in s tale che la sua intenzione possa essere presa sul serio, oppure c) w raggiunge
l’eccellenza nel soddisfare una funzione di G.
217 R, Stecker, Definition, Meaning, Value, cit., p. 31.
107
Il mostro è tornato. Da novello dottor Frankenstein, Stecker ha raccolto parti tra loro
eterogenee (la funzione, l’istituzione, l’intenzione e la storia) staccandole dai loro contesti
originari (le definizioni funzionali, storiche e istituzionali), e così facendo le ha snaturate; poi
ha cercato di ricomporle in un nuovo organismo, che manca però di coesione interna e quindi
di efficacia operativa (la definizione che ne risulta è quanto mai laboriosa e labirintica, e
perciò pressoché inutilizzabile). Il mostro fa fatica a muoversi. La definizione storico-
funzionalista dell’arte non funziona.
C) COSA CI INSEGNA DAVVERO LA STORIA?
Le definizioni dell’arte elaborate da Levinson, Carroll, Carney e Stecker hanno come
elemento comune lo storicismo: la condizione necessaria dell’arte, ovvero la sua essenza, è,
come dice Carroll, la storicità. Ciò che è arte oggi (così come ciò che lo sarà nel futuro) non
può quindi prescindere da ciò che è stato arte nel passato − ovvero dai modi in cui l’arte è
stata considerata e recepita, dagli stili in cui si è incarnata, dalle funzioni che è stata chiamata
ad assolvere. La storia ci insegna anche che i modi di considerare e percepire l’arte, come
anche le funzioni e gli stili artistici, nel tempo cambiano, si evolvono e talvolta si trasformano
in nuovi modi, stili e funzioni. Una tradizione artistica è una pratica culturale continua ma non
statica (riprendendo ancora Carroll): essa contiene in sé i mezzi per modificarsi in relazione al
mutare delle condizioni storico-culturali. Nessuno degli autori citati ritiene quindi possibile
dare una precisa descrizione dei modi, stili e funzioni appropriati all’arte del passato − in virtù
della supposta molteplicità di tali modi, stili e funzioni e dell’incertezza che avvolge l’arte più
remota o lontana − né la considera un’impresa meritoria − in quanto ostacolerebbe la
possibilità di cambiamento interno a una tradizione artistica, possibilità che la stessa storia
dell’arte attesta.
Ma cosa ci insegna davvero la storia? Siamo così sicuri che l’individuazione di un nucleo
di modi (di considerazione o ricezione) e di funzioni comuni a tutte le opere del passato
(anche di quello più remoto e lontano) sia impossibile? E se così non fosse, e se quindi, in
virtù della continuità della pratica culturale artistica, tale nucleo fosse il comun denominatore
di tutte le opere d’arte passate, presenti e future: in tal caso sarebbe veramente negata all’arte
qualsiasi possibilità di cambiamento e di evoluzione? Per rispondere seriamente a queste
domande occorre tornare ad interrogare la storia dell’arte, compiendo uno studio tanto
diacronico quanto sincronico. Degli autori di orientamento storico, quello che è andato più
vicino a percorrere questa strada è Jerrold Levinson. Non a caso egli è stato paradossalmente
accusato di astoricità in quanto la sua definizione, a detta dei suoi detrattori (tra cui in questo
108
caso figurano gli stessi Carroll e Stecker), non sarebbe in grado di dar conto del progresso e
dell’innovazione artistica, dal momento che ancora l’arte del presente (e del futuro) a un
insieme teoricamente limitato, ancorché in pratica non specificato, di modi di considerazione
appropriati all’arte del passato. In un passo già citato di Extending Art Historically Levinson
accenna alla eventualità di effettuare una sorta di “investigazione archeologica” per mezzo
della quale si potrebbe risalire alle ur-arts o first-arts (manteniamo qui l’ambiguità originaria
delle due espressioni) della nostra tradizione. Tale investigazione dovrebbe selezionare alcune
opere d’arte paradigmatiche recenti, e partendo da queste dovrebbe ricostruire a ritroso −
rintracciando le affinità e le linee di influenza (stilistica e semantica) tra tali opere e i loro
ascendenti − la nostra evoluzione artistica, sino ad approdare a un nucleo di opere originarie
(ovvero situabili alle origini della tradizione artistica occidentale) di cui si potrebbero a questo
punto identificare i modi di considerazione e ricezione appropriati nonché le funzioni
corrispondenti.
Quello che per Levinson rimane un puro orizzonte teorico, utile solo a garantire la
plausibilità della sua definizione, per altri autori analitici rappresenta un concreto progetto di
ricerca. Autori come S. Davies, D. Dutton e J. Moravcsek hanno cercato di portare avanti una
siffatta indagine archeologica, estendendola anche a tradizioni artistiche non occidentali e
avvalendosi a tal fine degli strumenti dello studio comparato delle culture. I risultati a cui essi
sono pervenuti suggeriscono una risposta alle questioni prima sollevate alquanto differente da
quella fornita da Levinson e compagni e insieme indicano una direzione diversa (anche se non
totalmente nuova, come vedremo) al problema della definizione dell’arte; direzione che
inizieremo a seguire a partire dal prossimo capitolo.
109
CAPITOLO QUARTO
Ritorno alle origini
In un articolo del 1973 intitolato Essentialism and the Definition of Art Thomas Diffey
scrive che “l’arte non ha una essenza reale, in quanto l’arte ha una storia” 218. Nel sostenere
ciò, egli non fa altro che riprendere alcune analoghe considerazioni svolte da Nietzsche (“solo
ciò che non ha una storia può essere definito”) e Ortega Y Gasset (“l’uomo non ha una natura,
ma solo una storia”) ed estenderle all’ambito artistico 219. L’affermazione di Diffey può
sembrare in contraddizione con quanto sostenuto esplicitamente da Carroll ed implicitamente
da Levinson, Carney e Stecker, ovvero col fatto che l’arte ha un’essenza, e che tale essenza è
la sua storicità. La contraddizione è però solo apparente. Diffey distingue infatti tra essenza
nominale − ovvero il criterio di applicabilità di un termine − ed essenza reale − ossia la natura
comune agli oggetti che vengono classificati sotto tale termine. Le definizioni storiche si
occupano solo della prima, la quale è specificata in termini di proprietà relazionali (continuità
tra i modi di considerazione, narrazioni storiche o connessioni stilistiche), mentre lasciano
indeterminata la seconda.
A corollario della sua tesi, Diffey aggiunge che una teoria dell’arte che sia credibile e utile
deve assumere la forma non di una teoria scientifica, bensì di un’insieme di generalizzazioni
storiche. Piuttosto che al lavoro di uno pseudo-scienziato (che, come dimostrano i vari
tentativi di fornire condizioni necessarie e sufficienti all’artisticità, è secondo Diffey destinato
al fallimento), essa deve quindi avvicinarsi alla “diagnosi di uno storico”: ovvero, deve
abbandonare la ricerca di “verità eterne riguardanti la natura di un oggetto chiamato Arte” e
accontentarsi di studiare il modo in cui artisti, critici e storici hanno nel tempo affrontato e
risolto determinati problemi di natura artistica 220. La strada prefigurata da Diffey, il quale su
una base scettica di matrice weitziana innesta il progetto di una concreta indagine storica
dell’arte, è stata solo in parte seguita dai sostenitori delle teorie storiche fin qui analizzate.
Questi infatti, pur condividendo l’anti-essenzialismo (in termini di essenza reale) di base e pur
prendendo le mosse dalla storicità intrinseca al concetto di arte, hanno elaborato delle
definizioni (nominali) che non riescono a catturare il senso più profondo di tale storia, ovvero
non sono in grado di fornire le ragioni che stanno a fondamento tanto della formazione e
dell’evoluzione di una tradizione artistica quanto della creazione di ogni singola opera d’arte.
218 T. Diffey, “Essentialism and the Definition of Art”, British Journal of Aesthetics 13 (1973), p. 117. 219 Ibid. 220 Ivi, pp. 117-8.
110
Ci sono però autori che, in tempi recenti e in sintonia col progetto di Diffey, hanno fatto dello
studio concreto della storia dell’arte e delle sue dinamiche interne la base della loro ricerca
estetica. Tale studio, arricchito dagli strumenti della comparazione culturale e illuminato dalla
riflessione filosofica, si rivelerà, contrariamente a quanto presupposto da Diffey e accettato da
tutti i sostenitori delle definizioni nominali e non reali dell’arte, compatibile con la ricerca di
un’essenza, di un centro, di una verità.
4.1 Il centro naturale dell’arte
Julius Moravcsik ha rilevato come i filosofi analitici siano in maggioranza concordi nel
separare l’estensione del termine ‘arte’ − ovvero il suo campo di applicazione − dalla sua
intensione − ovvero dalle condizioni necessarie e sufficienti all’applicazione del termine nei
diversi casi reali e possibili. Tale distinzione presuppone anche che la prima dipenda dalla
seconda: per stabilire l’estensione del termine è necessario cioè definire preliminarmente la
sua intensione. Recenti studi dimostrano però che questo metodo non riesce a catturare il
significato di molti dei termini generali con cui abbiamo a che fare. Non abbiamo ad esempio
bisogno di esaminare teoreticamente il significato del termine ‘linguaggio’ per classificare il
tedesco, l’italiano o il giapponese come linguaggi, così come non dobbiamo consultare un
manuale di medicina per capire il significato del termine ‘salute’. In ambo i casi il significato
del termine generale in questione, sia esso ‘linguaggio’ o ‘salute’, è in buona parte
determinato da intuizioni pre-teoretiche relative al termine e al suo uso comune; intuizioni che
possono certo essere raffinate e chiarite dall’analisi intensionale del termine, ma non
totalmente smentite o capovolte da quest’ultima. Analogamente possiamo supporre, sostiene
Moravcsik, che anche l’estensione del termine ‘arte’ non dipenda dalla sua intensione. Se così
fosse, prendendo spunto dalle nostre intuizioni pre-teoretiche condivise relative alle forme
d’arte unanimemente riconosciute (come la poesia, la musica, la pittura, ecc.) potremmo
giungere a trarre delle conclusioni circa il significato di ‘arte’ che non coincidono con la
definizione teoretica elaborata dai filosofi. Che una tale possibilità sia legittima è confermata
dal fatto che la storia dell’arte spesso non procede in parallelo con l’elaborazione di una
definizione dell’arte. I Greci ad esempio, pur non possedendo una vera e propria definizione
di arte e pur non disponendo di concetti come gusto o apprezzamento estetico, ciononostante
riconoscevano certi oggetti come propriamente pittorici, musicali o poetici, e si impegnavano
111
in riflessioni filosofiche circa i tratti distintivi di tali oggetti: tutto ciò ci autorizza a parlare
legittimamente di arte greca 221.
A prima vista potrebbe sembrare che tra i filosofi contro cui Moravcsik punta il dito non
rientri Jerrold Levinson, dato che questi, piuttosto che far dipendere l’estensione del termine
arte dalla sua intensione, sostiene esplicitamente e a più riprese proprio il contrario (il che,
come visto, lo mette al riparo dall’accusa di circolarità viziosa). L’attuale concetto di arte
dipende infatti, secondo la formulazione contenuta nella definizione storica di Levinson,
dall’estensione che il termine ‘arte’ ha avuto in un periodo precedente rispetto a quello
odierno. Inoltre egli riconosce, concordemente alla propria teoria e in sintonia con Moravcsik,
che storia e definizione dell’arte possono evolversi in maniera non parallela. Il punto però è
che Levinson considera l’estensione in una maniera alquanto differente da Moravcsik. Per il
primo infatti essa è costituita dalle opere d’arte del passato unanimemente riconosciute come
tali e dai modi di considerazione riconosciuti come appropriati ad esse, senza che sia
necessario dare una specificazione né degli uni né degli altri. La definizione storico-
intenzionale richiede solo che vi sia una siffatta base indiscussa di opere e modi di
considerazione, indipendentemente da quali esse/i siano: la storia è rilevante ai fini della
definizione dell’arte solo in virtù della sua struttura ricorsiva e non delle sue caratteristiche
intrinseche e specifiche. Nel concetto levinsoniano di estensione, l’insieme delle opere,
pratiche e attività (produttive e critiche) artistiche accumulatesi e sedimentatesi nel corso della
storia è come ricoperto da un involucro teoretico: ciò che noi vediamo, e che costituisce il
criterio per la definizione dell’arte, è solo la struttura di tale involucro, non ciò che in esso è
rinchiuso.
Ciò che Moravcsik (insieme ad altri autori che introdurremo fra poco) propone è di
rompere questo involucro e di liberare così la storia dell’arte nella sua nuda verità. Solo così
si potrà comprendere che la continuità che caratterizza l’evoluzione artistica non si riduce alla
sua forma − sia questa costituita dalla struttura ricorsiva suggerita da Levinson o dalle
narrazioni storiche descritte da Carroll − ma trova la sua ragion d’essere nell’esistenza di un
contenuto comune, naturale, universale e trans-culturale. Le opere d’arte e le forme artistiche
sono, secondo Moravcsik, delle “entità storicamente continue” in quanto hanno “una vita
storica che attraversa molti e differenti stadi culturali” 222. Pertanto, per catturare tale vita
storica si debbono studiare le opere e le forme d’arte sia sincronicamente sia diacronicamente,
221 Julius Moravcsik, “Why Philosophy of Art in a Cross-cultural Perspective?”, Journal of Aesthetics and Art Criticism 51 (1993), pp. 425-29. 222 Ivi, p. 429.
112
mirando non tanto a stabilire dei nessi causali tra uno stadio e l’altro quanto a rilevare la
presenza di tratti specifici e comuni alle diverse tradizioni artistiche. Il metodo propugnato da
Moravcsik consiste quindi nel determinare l’estensione del termine arte identificando le opere
e le forme d’arte riconosciute e accettate nelle diverse tradizioni in differenti periodi storici ed
estrapolando dal senso comune le intuizioni pre-teoretiche condivise riguardo a tali opere e
forme 223. Così facendo, ed elaborando poi delle teorie e degli schemi concettuali capaci di
render conto di questa imprescindibile base fattuale, si potrà infine pervenire al vero
significato della parola ‘arte’.
A ben vedere, anche i filosofi criticati da Moravcsik per l’eccessiva astrattezza delle loro
riflessioni sull’arte derivano l’ispirazione per le proprie definizioni da un nucleo concreto di
opere d’arte: si tratta tuttavia di un nucleo dall’estensione alquanto limitata e dal valore
altrettanto dubbio. Come osserva infatti Denis Dutton, a cavallo dei secoli XX e XXI
l’estetica si è venuta a trovare in una situazione paradossale 224. Da un lato gli artisti, i critici e
gli appassionati possono finalmente entrare in contatto (grazie alle librerie, ai musei, a
internet, ai viaggi, ecc.) con una vastità prima impensabile di documenti, oggetti ed
esperienze artistiche provenienti da qualsiasi parte del globo e risalenti alle più diverse epoche
storiche. Dall’altro lato, la riflessione estetica si è concentrata su un nucleo infinitesimale
dell’esperienza artistica, ovvero sui cosiddetti casi-limite (di cui esempi paradigmatici sono
Fountain di Duchamp o 4’33” di John Cage) attorno ai quali è stata prodotta una letteratura
filosofica sterminata, guidata dall’illusione di poter catturare il significato dell’arte
dall’analisi dei suoi esempi più marginali 225. Questa infondata ed assurda illusione ha,
secondo Dutton, portato la riflessione estetica fuori strada. L’ossessione della maggior parte
dei filosofi analitici per i border-line cases ha suscitato un dibattito intellettuale tanto intenso
− come attestato dalla mole dei testi scritti al riguardo e dalla notorietà che circonda le teorie
che da tali opere hanno preso spunto − quanto inutile e fuorviante − “i legislatori sanno che
dai casi difficili possono essere tratte solo cattive leggi” 226. Ciò di cui la filosofia dell’arte ha
bisogno è, secondo Dutton, di ritornare al cuore dell’arte e al suo valore per la vita dell’uomo.
223 Ivi, pp. 429-32. 224 Denis Dutton, “A Naturalist Definition of Art”, Journal of Aesthetics and Art Criticism 64 (2006), pp. 367-8. 225 Di Duchamp si è già detto; per quanto riguarda Cage, il brano a cui facciamo qui riferimento, intitolato 4’33” , consiste anch’esso in un’operazione prettamente concettuale. L’esecuzione del brano consiste infatti nel dedicarsi all’ascolto, per la durata appunto di 4 minuti e 33 secondi, di tutti i suoni e rumori casualmente prodotti all’interno dell’ambiente in cui ci troviamo e a cui normalmente non prestiamo attenzione (il rumore dei clacson, il canto degli uccelli, il tossire delle persone, ecc.). Questi suoni e rumori sono capaci, secondo Cage, di produrre un’esperienza assai vicina a quella dell’ascolto di una composizione musicale, senza che vi sia bisogno dell’intervento attivo del compositore: in questo senso essi sono quindi l’analogo musicale degli objects-trouve duchampiani. 226 Ivi, p. 268.
113
Nella diversità delle tradizioni culturali e nel succedersi dei periodi storici, gli uomini hanno
prodotto un insieme condiviso di pratiche, esperienze e riflessioni relative alla produzione e
alla ricezione delle opere d’arte: è da tale insieme, da tale centro naturale che la filosofia
dell’arte deve ripartire.
4.2 L’arte in una prospettiva transculturale
La prima domanda alla quale uno studio comparativo delle arti deve far fronte è la
seguente: come facciamo a stabilire se l’arte prodotta all’interno di una cultura diversa dalla
nostra è veramente arte? Abbiamo visto come già Levinson, una volta specificato che la sua
definizione cattura il nostro concetto di arte, ovvero il concetto di arte colta sviluppatasi in
Occidente a partire dal Rinascimento, si sia posto il problema di come la sua definizione
potesse giustificare o comprendere l’arte appartenente a tradizioni culturali a noi lontane
geograficamente e temporalmente. La risposta da lui fornita è racchiusa in una formula
efficacemente sintetica: “se un’altra cultura ha l’arte, deve averla nel nostro senso, più o
meno” 227. La questione che ci approntiamo ad affrontare è in realtà il riflesso di un problema
più ampio e comune a qualsiasi tipo di studio comparativo tra culture diverse, ovvero: come
possono i membri di un determinato gruppo culturale comprendere una cultura diversa dalla
loro? Riguardo a questo problema, H. Gene Blocker propone la seguente soluzione 228. Posto
che un gruppo culturale A applichi correttamente il concetto P all’oggetto X, lo stesso
concetto può essere applicato allo stesso oggetto da parte di un altro gruppo culturale B se e
solo se (1) X è correttamente classificato sotto il concetto Q da B e (2) P e Q sono sinonimi
(ovvero hanno un significato analogo). In altre parole, il confronto culturale non si attua
ridefinendo i concetti in modo da renderli capaci di abbracciare anche concetti appartenenti ad
altre culture. Più che di ridefinizione si deve parlare, secondo Blocker, di estensione di
concetti; il che è possibile solo in presenza di una reale e genuina affinità tra i concetti in
questione. Tradotta in termini artistici, la soluzione di Blocker riprende e chiarisce quella di
Levinson: possiamo estendere il nostro concetto di arte ed applicarlo anche ad oggetti
appartenenti a tradizioni culturali diverse dalla nostra solo se tali oggetti sono sussumibili in
un sottoconcetto in buona parte simile a un sottoconcetto interno al nostro concetto di arte. Si
può tutt’al più concedere che tale sottoconcetto non sia quello primario (come potrebbe essere
quello estetico) ma sia secondario; Blocker spiega ad esempio che determinati oggetti 227 J. Levinson, “Extending Art Historically”, cit., p. 154 (vedi anche il capitolo primo della presente ricerca). 228 H. Gene Blocker, “Is Primitive Art Art?”, Journal of Aesthetic Education 25 (1991), pp. 87-97.
114
provenienti da un’altra cultura possono essere compresi sotto il nostro concetto di arte anche
solamente in virtù del loro significato spirituale o del virtuosismo esibito, presi per se stessi.
Nonostante il senso comune attesti un’affinità concettuale tra le diverse tradizioni artistiche
esistenti, vi sono numerosi studiosi (filosofi e antropologi) i quali sostengono fermamente che
le società non occidentali possiedono un concetto di arte radicalmente diverso dal nostro, con
ciò concludendo che non esiste un’arte non occidentale e bloccando quindi in partenza
qualsiasi tentativo di confronto transculturale. Stephen Davies ha riassunto le argomentazioni
di questi studiosi in tre punti e le ha puntualmente e convincentemente confutate 229. Il primo
punto sottolinea come in Occidente l’arte sia sempre stata nettamente separata dall’artigianato
e in generale dalle attività sociali, laddove nelle civiltà non occidentali tutto ciò che viene
prodotto o agito, sia esso artistico o meno, ha una funzione sociale. Davies precisa a tal
proposito che la separazione di cui qui si parla è tipica solo dell’epoca romantica e non di
tutta la tradizione culturale occidentale; basti pensare alla musica di Bach o alle sculture di
Michelangelo per capire come anche in Occidente l’arte abbia ricoperto un ruolo importante
dal punto di vista sociale o religioso. Il secondo argomento è di natura linguistica e afferma
che non esiste nelle culture non occidentali un termine equivalente al nostro ‘arte’. Qui
Davies ha gioco facile nel replicare, in quanto evidentemente una qualsivoglia cultura può
possedere un determinato concetto pur non disponendo di un vocabolario adatto a descriverlo.
Infine, alcuni sostengono che la creazione delle opere d’arte deve essere auto-consapevole;
pertanto, mancando nelle società non occidentali una riflessione sulle loro pratiche culturali,
esse non possono avere un proprio concetto di arte. Solo quando vengono a contatto con la
nostra cultura tali società sono stimolate a riflettere sulle proprie attività: ma allora l’eventuale
classificazione di alcune di queste attività come artistiche sarà condizionata, se non addirittura
imposta, dalla nostra tradizione culturale 230. A quest’ultimo argomento Davies offre una
triplice risposta. In primo luogo egli osserva come una tradizione culturale possa svilupparsi,
stabilizzarsi ed evolversi in maniera autonoma e auto-consapevole pur non esercitando una
riflessione esplicita sulla pratiche che la costituiscono. In secondo luogo, gli studi
antropologici di cui siamo a conoscenza testimoniano la presenza di una auto-riflessione
esplicita e consapevole in diverse tradizioni artistiche non occidentali 231. Infine, se di
229 Stephen Davies, “Non-Western Arts and Art’s Definition”, cit., pp. 199-205. 230 Su quest’ultimo punto si veda Adrian Vickers, Bali: A Paradise Created, Penguin, Victoria 1989. 231 Questo punto è confermato e chiarito da H. G. Blocker, il quale studi alla mano afferma che: tutti i gruppi umani hanno una sensibilità estetica (ovvero una disposizione a reagire in un certo modo a certi oggetti); quasi tutte le società hanno un gusto ben definito (determinato dalla sedimentazione di tali reazioni e preferenze di base) e una terminologia critica per articolarlo; molte società hanno una gerarchia di tali termini critici (che vengono divisi in artisticamente positivi o negativi e che talvolta vengono raggruppati in teorie critiche
115
influenza si deve parlare, è di certo maggiore quella esercitata dall’arte non occidentale su
quella occidentale che non viceversa 232.
Un altro autore che, al pari di Davies, si è impegnato nella difesa della legittimità
dell’estensione del nostro concetto di arte a civiltà e culture non occidentali è Denis Dutton, il
quale sottolinea come i sostenitori del relativismo culturale cadano spesso in errori alquanto
grossolani 233. Il primo bersaglio delle critiche di Dutton è Lynn M. Hart, la quale fa
l’esempio dei dipinti realizzati dalle donne appartenenti alla civiltà Hindu: secondo la Hart
tali dipinti non sono classificabili come opere d’arte, in quanto la loro funzione primaria è
sociale − è infatti storicamente provato che essi sono stati creati per celebrare i matrimoni − e
non estetico-contemplativa 234. L’errore di Hart è secondo Dutton duplice. In primo luogo,
ella non si dimostra capace di riconoscere le qualità estetiche che sono invero presenti in tali
dipinti. Ma soprattutto, Hart sbaglia il termine di paragone: i dipinti delle donne Hindu vanno
infatti messi a confronto con l’arte popolare occidentale, la quale comprende un gran numero
di oggetti anch’essi creati con funzioni non precisamente artistiche ma piuttosto religiose,
sociali o decorative, e che ciononostante sono giustamente considerate opere d’arte in virtù
delle loro qualità intrinseche (formali, espressive o altro).
Un’altra strategia spesso utilizzata per esasperare le distanze che separano la nostra cultura
da quelle non occidentali è quella di evidenziare un solo aspetto dell’arte di tali culture, con
ciò distogliendo la nostra attenzione da altri aspetti altrettanto importanti e qualificanti. Ciò è
quanto fa l’antropologo Alfred Gell, il quale riporta l’esempio delle canoe costruite dagli
abitanti dell’isola Trobraind 235. Tali canoe sono considerate delle opere d’arte da questa
popolazione in quanto esse sono il risultato di un virtuosismo tecnico talmente elevato da
assumere un aspetto quasi magico, del tutto estraneo al nostro modo di pensare. Che la
fusione di tecnica e magia non costituisca un aspetto essenziale nemmeno nelle tradizioni
alternative tra loro); solo alcune hanno una teoria estetica che permette di comparare le diverse teorie critiche esercitate. Ciò dimostra che ogni società (occidentale e non) ha una componente estetica e artistica, sebbene questa possa manifestarsi a livelli differenti, che vanno da quello più basilare a quello più teorico. (H. Gene Blocker, “L’estetica non-occidentale come invenzione coloniale”, in G. Matteucci (a cura di), Elementi di Estetica Analitica, Quodlibet, Macerata 2005. In questo articolo Blocker riprende alcune delle considerazioni e degli studi da lui compiuti in Id., The Aesthetics of Primitive Art, University Press of America, Lanham 1993). 232 A tal riguardo si possono certamente citare gli influssi delle sculture africane sul cubismo (si pensi alle Damoiselles d’Avignon di Picasso) o l’influenza della musica balinese su molta musica del Novecento, da Debussy e Britten fino a Ligeti e Reich. 233 Denis Dutton, “But They Don’t Have Our Concept of Art”, in N. Carroll (ed. by), Theories of Art Today, cit., pp. 217-29. 234 Lynn M. Hart, “Three Walls: Regional Aesthetics and the International Art World”, in G. E. Marcus e F. E. Myers (ed. by), The Traffic in Culture: Refiguring Art and Anthropology, University of California Press, Berkeley 1995, pp. 127-50. 235 Alfred Gell, “The Technology of Enchantement and the Enchantement of Technology”, in J. Coote a A. Shelton (ed. by), Anthropology, Art, and Aesthetics, Clarendon Press, Oxford 1992, pp. 40-63.
116
culturali non occidentali è però facilmente dimostrabile facendo appello a dei contro-esempi.
Tra i tanti a disposizione, Dutton cita quello delle sculture realizzate dalla tribù dei Sepik in
Nuova Guinea, le quali sono apprezzate eminentemente per la loro espressività selvaggia e
potente. Le posizioni di Hart, Bell ed altri ancora rispecchiano un relativismo culturale basato
sull’idea dell’unicità e dell’incommensurabilità delle culture; la quale idea getta in discredito
ogni qualsivoglia tentativo di porre a confronto elementi appartenenti a sistemi culturali
differenti. Ma la rispettabilità di tale posizione è fondata solo sul potere e sul prestigio dei
suoi sostenitori: non appena ci chiediamo se essi sono davvero esperti conoscitori del sistema
culturale di cui stanno parlando, conclude polemicamente Dutton, vengono alla luce una
grossolanità e un pressappochismo (come dimostrato dagli esempi) che inficiano
irrimediabilmente le loro tesi.
La colpa principale degli studiosi dell’arte etnica criticati da Davies e Dutton è quella di
concentrarsi perlopiù su casi ambigui e marginali (peraltro spesso mal interpretati) e di farne
degli esempi paradigmatici di culture non abbastanza conosciute e troppo spesso liquidate
sotto l’etichetta di esotismo. E’ allora più che mai urgente che la riflessione estetica distolga
lo sguardo dai casi marginali e ambigui − siano essi le sopravvalutate opere rivoluzionarie
dell’arte occidentale del Novecento o gli oggetti meno rappresentativi delle tradizioni
artistiche non occidentali ma che più richiamano l’attrazione superficiale per ciò che è diverso
e singolare − e si impegni, attraverso il confronto accurato tra culture occidentali e non
occidentali e per mezzo della rilevazione delle somiglianze (oltreché delle differenze) tra di
esse, nella ricerca di un unico e universale concetto di arte. Come già in parte anticipato e
come vedremo meglio fra poco, non si tratta di una ricerca senza speranza. Ciò che il senso
comune, liberato da inutili farneticazioni intellettualistiche e da facili esotismi, attesta, è che
ci sono pratiche artistiche e forme d’arte condivise dalle diverse culture sin dai tempi più
remoti (si pensi alla danza, alla musica, alla narrazione, alla recitazione e via dicendo) ed
anche che noi occidentali siamo in grado di riconoscere a apprezzare opere d’arte provenienti
da altre società e tradizioni pur senza conoscerne il contesto originario di produzione. Questi
due dati di fatto (o intuizioni pre-teoretiche, per dirla con Moravcsik) reclamano una
spiegazione che una teoria dell’arte può dare solo assumendo una prospettiva transculturale e
realmente storica.
Ovviamente il confronto interculturale non potrà mai essere del tutto avalutativo. Blocker
sottolinea infatti come vi sia sempre un elemento di elogio o di critica nel paragonare gli
elementi caratteristici di società differenti: talvolta, mentre attribuiamo ad oggetti appartenenti
a società meno evolute della nostra lo statuto di opere d’arte, allo stesso tempo le collochiamo
117
un gradino sotto rispetto alle nostre opere d’arte in quanto a valore assoluto 236. Ciò peraltro
può accadere anche per mano dei membri delle società non occidentali nei confronti della
nostra 237. Sotto questo aspetto, il modo in cui ci confrontiamo con tradizioni artistiche a noi
estranee è, secondo Blocker, molto simile al modo in cui ci relazioniamo con altri individui.
Quando vogliamo conoscere una persona, cerchiamo di capire il suo punto di vista, il suo
carattere, i suoi desideri e così via; ma tali elementi vengono inevitabilmente filtrati dalla
nostra esperienza e noi li conosciamo solo nel modo in cui la nostra soggettività ce li
rappresenta. Così facendo probabilmente non conosceremo mai fino in fondo le altre persone,
ma non per questo vorremmo rinunciare a farlo. Nell’uno e nell’altro caso, non disponiamo di
un metodo migliore.
4.3 Liste, griglie, grappoli
Jerrold Levinson ritiene che la somiglianza rilevante al fine di stabilire l’estendibilità del
nostro concetto di arte alle altre tradizioni culturali sia di tipo strutturale. Secondo la sua
teoria, un’altra cultura possiede un concetto di arte analogo al nostro se gli oggetti prodotti
all’interno di tale cultura sono intenzionalmente riferiti (da chi li ha creati) ai modi di
considerazione appropriati a oggetti precedenti e appartenenti alla stessa cultura, così come le
nostre opere d’arte sono tali in virtù di un riferimento storico-intenzionale a precedenti e
riconosciute opere d’arte della nostra tradizione. Si è visto altresì che tale condizione non è
sufficiente e che, come lo stesso Levinson ammette, alla somiglianza strutturale va affiancata,
se non sostituita, una somiglianza sostanziale tra le tradizioni messe a confronto. Solo
esplicitando i modi di produzione e considerazione caratteristici di una determinata tradizione
culturale si può identificarla o meno come artistica, e solo vedendo se tali modi sono
caratteristici anche di altre tradizioni artistiche si può andare alla ricerca di un unico concetto
di arte che le accomuni tutte.
236 H. G. Blocker, “Is Primitive Art Art?”, cit., pp. 95-7. 237 Il compositore John Cage era solito citare divertito quella volta in cui assistette al fianco di un principe africano a un concerto in cui venivano eseguite musiche di Beethoven. Al termine dell’esecuzione il principe esclamò: “Bello! Peccato però che sia così ripetitivo…”. Probabilmente ciò che doveva risultare ripetitivo al principe era l’aspetto ritmico della musica di Beethoven, che può risultare insoddisfacente se paragonato ad esempio alle complesse strutture poliritmiche della musica africana. Quest’ultima d’altronde può risultare eccessivamente ripetitiva dal punto di vista melodico e armonico per l’ascoltatore occidentale. Queste differenze si stanno peraltro sempre più attenuando, vuoi per la diffusione globale di ogni tipo di musica che ci permette di acquisire familiarità anche con generi prima sconosciuti, vuoi per le contaminazioni stilistiche sempre più frequenti nel linguaggio adoperato da molti compositori contemporanei (occidentali e non).
118
Quali sono allora gli elementi comuni alle diverse tradizioni artistiche esistenti? Qual è il
metodo migliore per procedere alla loro identificazione? Dato che la risposta alla prima
domanda dipende necessariamente dalla risposta alla seconda domanda, sarà opportuno dare
la precedenza a quest’ultima e fornire alcune indicazioni metodologiche preliminari. Come
detto sopra, il punto di partenza di uno studio comparato delle culture è rappresentato dal
senso comune, che nel nostro caso comprende quel bagaglio di conoscenze pre-teoretiche
relative alle forme d’arte unanimemente riconosciute come centrali nelle diverse culture (la
musica, la danza, la pittura, la poesia, etc.). Su tale base empirica di conoscenze e credenze si
innesta poi una cornice concettuale, ricavata dall’analisi dei giudizi sull’arte pronunciati dagli
esperti, dai critici e dai filosofi 238. Dall’unione di conoscenze empiriche e schemi concettuali,
entrambi considerati da un punto di vista generale e non tecnico − Dutton parla per le prime di
“caratteristiche di superficie”, così come Gaut si riferisce ai secondi in termini di “giudizi
ordinari”, il che significa che in ambo i casi conta di più la radice abitudinaria (potremmo dire
humiana) delle conoscenze e degli schemi adoperati che non (rispettivamente) la loro
specificità tecnica o il loro grado di elaborazione teoretica − si ricavano dei criteri che
nell’insieme formano il concetto universale di arte. Possiamo a questo punto cercare di
rispondere alla prima domanda e specificare ciò che accomuna le diverse tradizioni artistiche.
Ciascuno degli autori che si è cimentato nell’impresa (ovvero Bond, Gaut, Moravcsik e
Dutton) ha fornito un proprio elenco dei suddetti criteri 239. Data la prossimità quantitativa (il
numero dei criteri è compreso tra le 7 e le 12 unità) e soprattutto qualitativa (talvolta vengono
usati nomi differenti per indicare uno stesso criterio) dei diversi elenchi, piuttosto che esporli
separatamente cercherò di accorparli in un elenco unico. Da questa sorta di crasi si ottengono
i seguenti nove criteri caratteristici delle opere d’arte di tutte le tradizioni artistiche esistenti.
1. Capacità di procurare un piacere diretto in virtù del possesso di proprietà estetiche
come la bellezza, la grazia, l’eleganza e via dicendo. L’esperienza di tali proprietà
richiede un’attenzione particolarmente concentrata e mirata: nessun fattore esterno
238 Non siamo qui lontani da un’idea a suo tempo avanzata da Morris Weitz, il quale al termine del suo celebre articolo “The Role of Theory in Aesthetics” esorta i filosofi ad utilizzare le definizioni dell’arte fino ad allora elaborate (e da lui ritenute fallimentari nel loro primario intento classificatorio) come “raccomandazioni a concentrarsi su determinati criteri di eccellenza nell’arte” altrimenti trascurati (M. Weitz, “The Role of Theory in Aesthetics”, cit., p. 192). Non è necessario adottare l’intero impianto teorico weitziano (che presenta non pochi punti deboli) per accettare invece quello che, limitatamente al nostro presente scopo, può risultare un utile precetto metodologico. 239 Gli articoli ai quali facciamo qui riferimento sono i seguenti: Julius Moravcsik, “Why Philosophy of Art in a Cross-cultural Perspective?”, cit., pp. 425-35; Denis Dutton, “A Naturalist Definition of Art”, cit., pp. 367-77; Berys Gaut, “ ‘Art’ as a Cluster Concept”, in N. Carroll (ed. by), Theories of Art Today, cit., pp. 25-44; E. J. Bond, “The Essential Nature of Art”, American Philosophical Quarterly 12 (1975), pp. 177-183.
119
deve disturbarla o interessarla, e l’esperienza stessa avviene al di fuori della vita
ordinaria − come la collocazione dei dipinti nei musei o l’esecuzione dei concerti nei
teatri dimostra. Il piacere che tale esperienza procura, oltreché essere diretto
(all’oggetto) è quindi anche disinteressato, e costituisce la fonte del valore intrinseco
di un’opera d’arte. Pur essendo diretto, tale piacere può risultare anche dalla somma
di più piaceri distinti, corrispondenti all’esperienza di singole parti dell’opera e
congiunti tra loro in modo coerente e organico.
2. Capacità di esprimere emozioni, le quali sono causate tanto dalla comprensione del
contenuto dell’opera, quanto dall’apprensione del modo in cui il contenuto è
comunicato attraverso l’opera stessa.
3. Esercizio dell’immaginazione creativa, tanto negli artisti quanto nei fruitori
dell’opera. Più grande è tale componente, più elevata sarà la complessità dell’opera.
Nelle opere d’arte più complesse, l’esperienza immaginativa dell’opera non solo ci
trasporta in un mondo fittizio e affascinante, ma coinvolge anche le nostre facoltà
percettive e intellettive in una sorta di sfida che rappresenta un’ulteriore fonte di
piacere.
4. Possesso di proprietà formali come l’unità, la complessità e la coerenza.
5. Capacità di comunicare significati complessi e profondi. Tale capacità è spesso legata
alla presenza nell’opera di un contenuto rappresentativo, il quale connette
l’esperienza immaginativa dell’opera ad eventi e situazioni attinenti alla vita
dell’uomo e favorisce quindi un’interazione vicendevolmente vivificante tra
esperienza dell’opera e vita reale.
6. Espressione dell’individualità dell’artista e comunicazione del suo personale punto di
vista sul mondo. Vale la pena ricordare che l’individualità, che è insieme sinonimo di
originalità e di intenzionalità, non è estranea neppure alle tradizioni culturali non
occidentali (contrariamente a quanto si pensa di solito), dove pure l’arte ha
un’importante funzione sociale e religiosa.
7. Esibizione di una spiccata abilità o virtuosismo tecnico.
8. Appartenenza ad una forma d’arte riconosciuta. Tanto l’identità quanto il valore di
un’opera d’arte dipendono in parte dal suo occupare un determinato posto nella storia
dell’arte. Ogni artista, volente o nolente, si trova (tranne rare eccezioni) ad operare
all’interno di un’istituzione (il mondo dell’arte) e, nell’adottare uno stile, rivela la sua
appartenenza a una particolare tradizione. Ovviamente l’artista non applica
meccanicamente le regole (formali, espressive, rappresentative e via dicendo)
120
codificate dallo stile adottato e sedimentatesi nella tradizione in cui egli si inscrive,
bensì le adatta al caso specifico, le modifica in accordo con le sue esigenze e
seguendo la propria creatività, e talvolta ne crea di nuove, rinnovando la tradizione
stessa − il che ancora una volta è vero anche delle tradizioni non occidentali, spesso
erroneamente concepite come statiche e immutabili.
9. Coinvolgimento di un’attività critica, parallela all’attività produttiva dell’artista e
costituita dai giudizi che gli spettatori più preparati (critici, professionisti, esperti) o
meno qualificati (comuni appassionati) danno delle opere d’arte. La critica d’arte
(sviluppatasi e raffinatasi nella civiltà europea e in quella orientale) si distingue dalle
altre attività critiche umane per il fatto che essa utilizza un criterio di successo,
ovvero un metro di giudizio, particolarmente complesso (se confrontato con quello
adoperato in altri settori).
Alcuni degli autori sopra citati ritengono cha la loro lista possa essere integrata con
l’aggiunta di ulteriori criteri; ad ogni modo ciascuno di essi considera la propria lista come la
più completa ed esaustiva. Se si tiene conto però tanto delle forti affinità tra le diverse
proposte, quanto del fatto che le differenze possono essere colmate con un semplice lavoro di
sintesi, la lista appena esposta può essere ritenuta definitiva, almeno in riferimento alle
intenzioni degli autori considerati e alle analisi da loro compiute 240. Ciò che resta invece da
chiarire è in che modo tale lista possa orientarci e guidarci nella classificazione delle opere
d’arte. E’ abbastanza evidente che un oggetto che soddisfi tutti e nove i criteri debba essere
senza riserve classificato come opera d’arte. I propositori delle diverse liste concordano però
nel sostenere che un oggetto possa essere identificato come opera d’arte anche soddisfacendo
alcuni, e non tutti, dei criteri della lista. Quali siano questi criteri non è specificato; l’unica
certezza è che se un oggetto non ne soddisfa nemmeno uno, allora non può essere un’opera
d’arte. Moravcsik propone allora di concepire la lista come una griglia, in cui ciascun criterio
è affiancato dal segno + o − a seconda della sua presenza o assenza nelle opere d’arte delle
diverse tradizioni. La griglia ci permette però al limite di riconoscere determinate tradizioni
culturali come artistiche, piuttosto che identificare delle singole opere d’arte. A tal fine è più
240 I criteri della lista che più sono il frutto di un mia personale operazione di sintesi sono il primo − dove alla nozione di piacere diretto ho collegato quelle di disinteresse, di valore intrinseco e di special focus −, il terzo − dove ho affiancato immaginazione creativa e sfida intellettuale −, il sesto − dove l’espressione di un punto di vista individuale diviene anche indice di originalità − e l’ottavo − dove figurano insieme appartenenza a una tradizione, rispetto delle convenzioni istituzionali e adozione di uno stile riconosciuto. A suggerirmi questa operazione di fusione concettuale sono state tanto le similitudini riscontrate tra le diverse liste (e talvolta tra i criteri appartenenti a una stessa lista), quanto la storia stessa delle nozioni chiamate in causa dai vari criteri.
121
utile applicare la cluster theory di Gaut, il quale sostiene che i criteri della lista sono tutti
disgiuntamente necessari − un oggetto non può essere un’opera d’arte se non soddisfa almeno
uno di essi − ma nessuno è individualmente necessario − non vi è un criterio che viene
soddisfatto immancabilmente da tutte le opere d’arte esistenti. Pertanto, se un oggetto
soddisfa tutti i criteri della lista, esso è sicuramente un’opera d’arte − i criteri sono
congiuntamente sufficienti all’artisticità. Ma un oggetto può essere un’opera d’arte anche se
soddisfa un sottoinsieme (o cluster, ovvero grappolo) dei criteri della lista. Anche qui
permane un’ineliminabile componente di indeterminatezza, dato che Gaut non specifica quali
sottoinsiemi debbano essere soddisfatti − il che fa affermare all’autore che la cluster theory è
piuttosto una “caratterizzazione” del concetto di arte che non una definizione vera e propria.
A fronte di tale costitutiva indeterminatezza, la cluster theory − che può essere assunta
come paradigma di tutte le altre “caratterizzazioni” del concetto di arte basate su una lista di
criteri la cui soddisfazione (totale o anche solo parziale) ci permette di identificare un oggetto
come opera d’arte − presenta, a detta di Gaut, una serie di vantaggi rispetto alle definizioni
estetiche, istituzionali o storiche che la rendono preferibile a queste ultime 241. Il primo
vantaggio è quello della maggiore “adeguatezza linguistica” di tale teoria alle intuizioni
comunemente diffuse intorno alle opere d’arte. Vi sono infatti delle opere d’arte indiscusse
che non soddisfano tutti i criteri della lista. Les Demoiselles d’Avignon di Picasso, ad
esempio, non procura piacere per la sua bellezza; i dipinti astratti americani degli anni
Sessanta (quelli più geometrici e minimali) non esprimono emozione alcuna; opere come il
dipinto Quadrato nero su tela bianca di Malevich o il film Un cane andaluso di Bunuel e
Dalì non possiedono le proprietà formali classiche rispettivamente della complessità e della
coerenza; le fiabe di Aesop non comunicano significati particolarmente profondi; i ready-
made di Duchamp non esibiscono alcuna particolare abilità tecnica; e via dicendo. Le opere
citate da Gaut, alle quali se ne potrebbero senz’altro aggiungere delle altre, sono opere d’arte
in quanto, conformemente alla cluster theory, pur mancando uno o più dei criteri
sopraindicati, esse soddisfano comunque altri criteri indicati nella lista. Per lo stesso motivo la
cluster theory è in grado di dar conto anche di quelle forme intermedie tra l’arte e altre attività
umane come ad esempio la cucina, la quale soddisfa alcuni dei criteri della lista (il
virtuosismo, il piacere diretto) ma ne manca degli altri (soprattutto l’espressione di emozioni).
Tali attività intermedie mantengono così quell’ambivalenza che è costitutiva della loro natura
(questo è un punto sottolineato tanto da Gaut quanto da Dutton). Il fatto poi che tali criteri
241 Gaut elenca tali vantaggi in Id., “ ‘Art’ as a Cluster Concept”, cit., pp. 30-42.
122
siano presenti, seppur in grado variabile e non sempre in combinazione l’uno con l’altro,
anche in oggetti chiaramente non artistici, dimostra una volta di più (come sottolinea Dutton)
il fatto che l’arte è un’attività naturale che si è sviluppata in continuità con altre attività umane
(come la religione, la politica, la scienza, il gioco, lo sport, e via dicendo).
Il secondo vantaggio della cluster theory è costituito dalla sua maggiore “adeguatezza
normativa”. Secondo Gaut, le varie definizioni dell’arte hanno infatti tutte erroneamente
convertito in norma, ovvero in condizione necessaria e sufficiente all’artisticità, quello che
invece costituisce una caratteristica saliente, ma non esclusiva né imprescindibile, dell’arte (le
teorie estetiche lo hanno fatto con il possesso di proprietà estetiche, quelle istituzionali e
storiche con l’appartenenza a una tradizione riconosciuta). La cluster theory ci permette di
evitare di ricadere nella ristrettezza di tali definizioni, in quanto restituisce a quelle che sono
state ipostatizzate come condizioni uniche e imprescindibili lo statuto di criteri aperti alla
pluralità e alla combinazione con altri criteri. Infine (e questo è il terzo dei pregi elencati da
Gaut) ad essa va riconosciuta una particolare “utilità euristica”, in quanto ben si accorda con
le più diffuse e convincenti teorie sull’interpretazione e sul valore dell’arte, il quale viene
sempre più visto come il prodotto di più valori (ovvero di più criteri) combinati insieme;
laddove le suddette definizioni o non si occupano affatto della questione (come succede per le
teorie istituzionali e storiche), oppure conducono (è il caso delle definizioni estetiche)
all’identificazione di tale valore con la soddisfazione della stessa (e unica) condizione che
permette la classificazione delle opere d’arte.
Gli argomenti usati a sostegno della cluster theory si rivelano in realtà, a una più attenta
analisi, alquanto discutibili. Compierò tale analisi procedendo a ritroso, e partirò quindi
dall’ultimo dei presunti vantaggi di tale teoria rispetto alle varie definizioni dell’arte, ovvero
dall’utilità euristica. Non è infatti in alcun modo dimostrato che tali definizioni non siano in
sintonia con le più convincenti teorie sul valore dell’arte. Per quanto riguarda le teorie
istituzionali o storiche, vale la pena ricordare che esse sono teorie descrittive, che scindono
quindi il problema della classificazione da quello della valutazione delle opere d’arte (sul
quale possono avere anche posizioni diverse da quelle espresse relativamente al problema
della classificazione). Per quanto riguarda invece le definizioni estetiche dell’arte, la
ristrettezza ad esse attribuita da Gaut dipende dalla concezione limitata che lo stesso Gaut
sembra avere delle proprietà estetiche, da lui confinate alle proprietà della grazia, della
bellezza, dell’eleganza e simili. In realtà le proprietà estetiche occupano un territorio assai più
vasto (come vedremo meglio in seguito), che include tanto aspetti formali quanto aspetti
espressivi e semantici. Ciò sembra essere peraltro implicitamente riconosciuto da Dutton,
123
quando afferma che le proprietà estetiche (da lui altrimenti non menzionate nel proprio
elenco) consistono nella combinazione di diversi criteri della lista (virtuosismo,
immaginazione, espressività, ecc.), la quale combinazione è responsabile della produzione del
piacere diretto (che figura come primo criterio tanto nella nostra quanto nella sua lista).
Passando poi all’adeguatezza normativa, S. Davies ha giustamente osservato come anche la
cluster theory dia luogo, a ben vedere, a delle condizioni necessarie e sufficienti all’artisticità 242. Dato infatti che la lista è finita, e che i sottoinsiemi (o grappoli) di criteri da soddisfare
sono anch’essi numericamente finiti, anche il numero delle possibili combinazioni tra i
suddetti criteri sarà finito e formerà quindi un insieme chiuso di condizioni necessarie e
sufficienti (ciascuna delle quali corrisponderà a una determinata combinazione di criteri della
lista). In realtà sia Gaut che Dutton sono disposti a concedere che la loro sia una vera e
propria definizione (seppur complessa e disgiuntiva) dell’arte, con ciò mantenendo che essa
presenta un vantaggio rispetto alle definizioni rivali in virtù della maggiore elasticità e
apertura che la presenza di un ventaglio più ampio di condizioni garantisce. Il problema però
non è semplicemente nominale. Dato infatti che né Gaut né gli altri (Dutton, Moravcsik,
Bond) specificano quanti e quali criteri della lista devono essere soddisfatti, se si tenesse
conto di tutte le possibili combinazioni di sottoinsiemi della lista otterremmo un numero
talmente elevato di condizioni da risultare inverosimile. Come definizione la cluster theory si
rivela quindi inutilizzabile 243.
Se da un lato l’indeterminatezza nella specificazione dei sottoinsiemi di criteri da
soddisfare impedisce alla cluster theory di rappresentare un buon metodo per il
riconoscimento e la classificazione delle opere d’arte, dall’altro lato la stessa indeterminatezza
(o vaghezza) le permette di dar ragione di intuizioni condivise, come quelle relative alla
continuità tra l’arte e le altre attività umane e quelle riguardanti la natura dei cosiddetti casi-
limite: il primo (e più importante) dei vantaggi elencati da Gaut sembra quindi ancora al
riparo. Il problema però è che vi sono anche altre intuizioni condivise, diverse da quelle citate
da Gaut e Dutton, delle quali una teoria dell’arte deve dar conto. Innanzitutto, come
distinguere l’arte dalle altre attività umane alle quali pure essa è collegata da una relazione di
continuità? Perché la cucina è più vicina all’arte dello sport o della filosofia, sebbene tutte e
tre le discipline nominate soddisfino solo alcuni dei criteri caratteristici dell’arte (della cucina
si è già detto; dello sport si può certamente dire che esibisca virtuosismo e che provochi
242 Stephen Davies, “The Cluster Account of Art”, British Journal of Aesthetics 44 (2004), pp. 297-300. 243 Davies ha calcolato che se, per ipotesi, il numero di criteri da soddisfare fosse otto, tenuto conto del fatto che tali criteri non sono specificati e partendo da una lista di dieci criteri (come è quella di Gaut), otterremmo ben 56 condizioni necessarie e sufficienti al’artisticità (“56 diversi modi di essere arte”: davvero troppi!).
124
emozioni, mentre della filosofia si può sottolineare la presenza di proprietà formali come la
coerenza e soprattutto la comunicazione di significati profondi)? L’unico modo per avere una
risposta sarebbe quello di pesare i diversi criteri e di stabilire quindi un ordine gerarchico
interno alla lista 244. In tale direzione sembrano andare alcune osservazioni di Dutton, il quale
cautamente ipotizza che il criterio più importante sia quello dell’esercizio dell’immaginazione
(il terzo nella nostra lista). Parallelamente Gaut nota che alcuni criteri sono più frequenti nelle
opere d’arte che in altri oggetti (il possesso di proprietà formali, l’espressione di emozioni, la
comunicazione di un contenuto profondo, l’appartenenza a una tradizione). Entrambi però si
guardano bene dal fare di tali criteri delle condizioni necessarie e sufficienti all’artisticità.
Tutti i criteri della lista rimangono fondamentalmente sullo stesso piano, e ciò fa sì che sullo
stesso piano stiano anche, loro malgrado, la Critica della Ragion Pura di Kant, la Gioconda
di Leonardo, un piatto di pasta con le sarde e il goal di Zidane nella finale di Champions
League del 2002 245.
Per quel che concerne poi gli esempi riportati da Gaut allo scopo di dimostrare il fatto che
vi sono opere d’arte le quali, pur essendo paradigmatiche, ciononostante non soddisfano tutti i
criteri della lista, le mie intuizioni (e credo anche quelle di molti altri) sono sensibilmente
differenti da quelle di Gaut. Come non ravvisare nelle Demoiselles d’Avignon una particolare
forma di bellezza (lo stesso Picasso diceva di trovare alcune sculture africane, dalle quali egli
trasse chiara ispirazione per il proprio dipinto, più belle della Venere di Milo)? Il senso di
pace interiore che talune opere astratte ci trasmettono in virtù della loro composizione
geometrica ed equilibrata non rappresenta anch’esso una forma (per quanto moderata) di
emozione? Perché il contenuto delle fiabe (e in genere di varie opere d’arte di genere
fantastico) dovrebbe essere liquidato come superficiale o irrilevante, quando l’esperienza (sia
nei bambini che negli adulti) testimonia il contrario? Come può un’opera d’arte essere
totalmente incoerente? Chi mai vorrebbe andare al cinema per vedere un film senza capo né
coda o andare a un concerto di musica in cui si sentono solo suoni e rumori che si succedono
a caso per due ore (almeno John Cage si è fermato a 4 minuti e 33 secondi…)? Perché
dobbiamo a tutti i costi considerare i ready-made delle opere d’arte? Mi sembra che Gaut e
compagni, nel tentativo di difendere le loro teorie, siano incorsi nello stesso errore da loro
giustamente attribuito ad altri autori, ovvero quello di rifugiarsi in casi marginali o discutibili
(talvolta mal interpretandoli) e di perdere di vista l’orizzonte più ampio all’interno del quale
244 Quest’ultima osservazione è ripresa da T. Adajian, “On the Cluster Account of Art”, British Journal of Aesthetics 43 (2003), pp. 379-85. 245 Ho volutamente scelto degli esempi di eccellenza in ciascun settore per sottolineare come qui non sia in gioco un problema di valutazione o di graduatoria di merito, bensì di corretta classificazione.
125
l’arte va considerata. Un’adeguata teoria dell’arte deve saper dar conto di tutte le intuizioni e
conoscenze che una prospettiva trans-culturale ci mette a disposizione, e deve dar forma a dei
principi unificatori capaci di rivelare il centro naturale dell’arte a cui tali intuizioni e
conoscenze attingono. La cluster theory si è rivelata insufficiente a tal fine: come definizione
è troppo complessa, come lista di criteri di riconoscimento è troppo vaga. Il nostro viaggio
verso l’essenza dell’arte non è ancora finito. Dopo esserci spostati di luogo in luogo e di
cultura in cultura, è arrivato il momento di fare un passo indietro nel tempo, alle origini
dell’arte.
4.4 Le origini dell’arte
La comprensione, da parte di chi appartiene alla cultura europea, dell’arte tribale o
primitiva, oltre a presentare il problema sottostante a ogni studio culturale comparativo −
ovvero, come fare a stabilire se un’altra tradizione culturale, da noi lontana geograficamente o
temporalmente, possiede il nostro concetto di arte − pone due ulteriori questioni: come
distinguere le opere d’arte dagli oggetti d’artigianato (utensili o simili) prodotti all’interno
delle stesse società primitive? Come separare l’arte tribale autentica dalle riproduzioni
successivamente realizzate a scopo puramente commerciale? La duplice questione è stata ben
illustrata da Arthur Danto attraverso un efficace esempio di sua invenzione 246. Egli ipotizza
l’esistenza di due tribù primitive limitrofe ma non comunicanti tra loro, la “Pot People” (PP) e
la “Basket Folk” (BF), le quali producono entrambe dei vasi (pots) e dei cesti (baskets)
esteticamente pregevoli e percettivamente indistinguibili (anche da osservatori esperti).
Tuttavia mentre nella PP i vasi, in quanto esprimenti valori religiosi e spirituali, sono
considerati opere d’arte, laddove i cesti vengono usati per scopi artigianali o commerciali,
nella BF per motivi analoghi accade esattamente il contrario, ovvero i cesti sono considerati
opere d’arte e i vasi dei semplici utensili. Poniamo ora che in un determinato momento
riscopriamo tali oggetti e riusciamo ad acquisirli, e decidiamo quindi di esporli al pubblico
per il loro interesse storico e artistico. La domanda che dobbiamo allora porci è: quali di
questi oggetti vanno esposti al Museo delle Belle Arti e quali invece al Museo di Storia
Naturale? La risposta di Danto è del tutto in sintonia con il suo pensiero estetico. Egli ritiene
infatti che la differenza tra le opere d’arte e gli oggetti artigianali sia culturale piuttosto che
percettiva: le prime sono delle incarnazioni di un’idea o di un contenuto spirituale, mentre i
246 Arthur Danto, “Artifact and Art”, contribution to the exhibition catalogue for ART/artifact (New York: Center for African Art, 1988), pp. 18-32.
126
secondi sono dei mezzi concepiti per raggiungere un determinato scopo pratico 247. Se si tiene
conto del contesto sociale e culturale originario, si evince che solo i vasi prodotti nella PP e i
cesti prodotti nella BF incarnano un’idea o un messaggio fondamentale per le rispettive
società: pertanto solo essi andranno esposti nel Museo delle Belle Arti, mentre i cesti della PP
e i vasi della BF finiranno nel Museo di Storia Naturale.
La risposta fornita da Danto non soddisfa Denis Dutton, il quale sostiene al contrario che la
differenza tra opere d’arte e oggetti d’artigianato sia fondamentalmente percettiva e che sia
descrivibile come culturale solo nella misura in cui determinati aspetti di una cultura (nel
nostro caso la spiritualità attribuita ai vasi e ai cesti nelle due diverse tribù) condizionano
l’operare artistico (ovvero l’azione creativa e produttiva di determinati membri di tale cultura)
e conducono alla produzione di oggetti aventi differenze estetiche percepibili 248. Il fatto che,
nell’esempio creato da Danto, né un semplice visitatore di un museo né l’esperto che ha
curato l’esposizione siano stati in grado di scoprire delle differenze esteriori tra i vasi e i cesti
delle due tribù, non implica che non vi sia nessuna persona in grado di rilevarle. La storia
dell’umanità ci insegna infatti che se determinati artefatti rivestono una particolare importanza
per una certa cultura (come i vasi per la PP e i cesti per la BF), essi saranno realizzati
seguendo un canone di eccellenza che li porterà a differenziarsi da artefatti simili ma creati
per scopi meno elevati (come i cesti della PP e i vasi della BF, o anche come le successive
riproduzioni degli stessi da parte di altre società per puro fine commerciale). Pertanto
esisteranno anche degli osservatori che, essendo a conoscenza di tale canone di eccellenza (in
quanto appartenenti alla cultura in cui esso si è sviluppato o in quanto studiosi della cultura in
questione), saranno in grado di distinguere gli artefatti realizzati in osservanza di tale canone
da quelli creati per altri scopi (gli abitanti della PP saranno quindi perlopiù in grado di
distinguere i loro vasi da quelli prodotti dagli abitanti della BF, e viceversa; così come ne sarà
capace anche un osservatore attento e sensibile delle due società, sebbene non appartenente a
esse). La situazione immaginata da Danto è quindi, secondo Dutton, plausibile solo in
riferimento a dei casi individuali − in cui un determinato osservatore, in quanto poco attento o
non qualificato, confonde un’opera d’arte con una sua riproduzione a fini commerciali o con
un oggetto d’artigianato per molti aspetti simile − ma non può ragionevolmente valere per 247 Danto sviluppa il concetto di “significato incorporato” o di “incarnazione di un’idea” in un’opera d’arte − che è la naturale evoluzione di quanto precedentemente sostenuto in “The Artworld” (1964), dove egli afferma che ciò che fa di un oggetto un’opera d’arte è qualcosa che l’occhio non può cogliere, ossia una particolare “atmosfera di teoria” − in vari saggi, tra i quali ricordiamo A. Danto, The Transfiguration of the Commonplace, Harvard University Press, Cambridge 1981, trad. it. (a cura di S. Velotti) La trasfigurazione del banale, Laterza, Roma-Bari 2008, e Id., The Philosophical Disenfranchisement of Art, Columbia University Press, New York 1986, trad. it. (a cura di T. Andina e C. Barbero) La Destituzione filosofica dell’arte, Aesthetica, Palermo 2008. 248 D. Dutton, “Tribal Art and Artifact”, Journal of Aesthetics and Art Criticism 51 (1993), pp. 13-21.
127
interi generi culturali, come quelli rappresentati dalla produzione dei vasi e dei cesti
nell’esempio qui analizzato.
L’errore principale di Danto sta, continua Dutton, nell’aver applicato all’arte tribale o
primitiva una teoria filosofica desunta da opere che con tale arte hanno poco o nulla a che
fare. Ispirato dai ready-made di Duchamp e dai Brillo-boxes di Warhol, Danto arriva a
sostenere che tutte le opere d’arte sono espressioni, o meglio incarnazioni, di un’idea, e che
non sono comprensibili senza che si faccia riferimento al loro contesto teorico e culturale
originario. Sia Fountain di Duchamp che Brillo-boxes di Warhol sono in effetti distinguibili
dalle loro controparti percettivamente indiscernibili del mondo reale − l’orinatoio del bagno di
casa nostra o le scatole di pagliette saponate per pulire le pentole che troviamo nel
supermercato più vicino − solo facendo riferimento al contesto di produzione di tali oggetti.
Solo così possiamo apprendere il significato dei ready-made quali negazioni del canone
estetico comunemente accettato e quello dei Brillo-boxes quali sarcastico commento sul
consumismo della società moderna. Ciò che è fondamentale per l’identificazione e la
comprensione di tali opere (ovvero il riferimento al contesto storico-culturale di appartenenza)
è però per lo più irrilevante per ciò che riguarda l’arte tribale. Quest’ultima viene
comunemente riconosciuta e apprezzata per le sue qualità estetiche, le stesse possedute dalle
sculture africane che tanto affascinarono Picasso e Fry all’inizio del secolo scorso. Pertanto i
vasi della PP e i cesti della BF, per tornare al nostro esempio, sono opere d’arte non in quanto
negazioni di un canone estetico − esse rappresentano semmai l’origine di tale canone o, dal
nostro punto di vista, un’estensione del canone estetico moderno compiuta da artisti come
Picasso e da critici come Fry − o in quanto incarnazioni di una riflessione sulla società − lo
stesso Danto ipotizza che la PP e la BF non fossero a conoscenza l’una dell’altra. Il modo
corretto di guardare all’arte tribale è quindi, secondo Dutton, quello adottato da Picasso e Fry,
i quali hanno scorto, in alcune opere primitive, delle proprietà visive che, pur essendo
l’espressione di un contesto culturale a loro sconosciuto, essi hanno potuto pienamente
apprezzare e rielaborare (dando vita a nuove correnti artistiche o modificando le teorie
critiche correnti). Se invece facciamo a meno di considerare il contesto che ha portato alla
creazione dell’orinatoio o delle scatole di Brillo, probabilmente saremmo portati a servirci
dell’uno o dell’altro nel modo in cui quotidianamente ci serviamo di oggetti simili 249.
249 Ciò che ci frenerebbe dal farlo sarebbe tanto il nostro pudore quanto il controllo della security nei musei dove tali oggetti sono esposti. Nessuno dei due fattori ha però impedito al musicista Brian Eno di orinare nella famosa Fountain di Duchamp, dando vita a una singolare performance nella performance il cui significato è in bilico tra il disprezzo dell’opera dell’artista francese e l’ennesimo gesto di provocazione nei confronti dell’establishment artistico.
128
Queste ultime considerazioni potrebbero indurci a pensare che la conclusione a cui Dutton
perviene derivi da una intenzionale ignoranza dell’aspetto contestuale dell’attività artistica e
che, se prendessimo adeguatamente in considerazione quest’ultimo, forse le nostre
conclusioni sull’arte tribale sarebbero diverse. Per eliminare questo dubbio residuo e per far
compiere un’ulteriore passo in avanti (o meglio all’indietro, visto che siamo alla ricerca delle
origini dell’arte) alle nostre riflessioni sull’arte primitiva, vale la pena richiamare alcune
considerazioni fatte al proposito da Stephen Davies 250. Davies dichiara esplicitamente di
concordare col ragionamento e con le conclusioni di Dutton, pur presentando se stesso come
un contestualista. Il contestualismo è, per definizione dello stesso Davies, la posizione di chi
sostiene che l’identificazione e l’interpretazione di un’opera d’arte dipendano tanto dalla
rilevazione delle proprietà intrinseche dell’opera quanto dalla conoscenza del contesto storico
e culturale di produzione della stessa. Senza quest’ultimo, non saremmo in grado di dire quali
delle proprietà di un oggetto siano rilevanti ai fini sia di una sua classificazione tra le opere
d’arte, sia dell’interpretazione del suo significato. Ora, le prime opere d’arte (ovvero le opere
d’arte primitive o tribali) costituiscono un problema per il contestualismo, dal momento che il
più delle volte non siamo a conoscenza delle circostanze sociali e culturali entro le quali tali
opere sono state create e, di conseguenza, non dovremmo essere nella posizione migliore per
dire quali siano le proprietà artisticamente rilevanti nel loro caso. La nostra ignoranza del
contesto sembra precluderci la possibilità non solo di apprezzare nel modo più appropriato le
prime opere d’arte, ma anche di percepirle come arte. Vi è tuttavia un altro elemento che va
tenuto in considerazione, ed è il fatto che il carattere artistico di tali opere viene comunemente
riconosciuto da persone ignoranti (come lo erano Picasso e Fry e come lo è la maggior parte
delle persone che visitano un Museo delle Belle Arti) del contesto storico-culturale originario.
Ci devono essere quindi, nelle prime opere d’arte, delle proprietà percepibili e apprezzabili da
persone di qualsiasi provenienza geografica, culturale e temporale: tali sono, secondo Davies,
le proprietà estetiche. Le proprietà estetiche (come la bellezza, la grazia, la vivacità, l’unità, la
tensione, ecc.) sono il fondamento transculturale e universale delle opere d’arte, occidentali e
non, ed è grazie alla loro presenza in determinati oggetti primitivi che questi meritano
l’appellativo di opere d’arte.
Davies aggiunge anche che il possesso di proprietà estetiche non è di per sé una condizione
sufficiente all’artisticità, in quanto vi sono oggetti non artistici che hanno delle indubbie
qualità estetiche (si pensi alla bellezza di certi scenari naturali). Ciò vale peraltro anche se si
250 S. Davies, “First Art and Art’s Definition”, cit., pp. 27-34.
129
restringe il campo agli oggetti che sono il prodotto dell’attività umana, poiché anche qui
troviamo un cospicuo numero di contro-esempi non artistici (il sesso, il buon cibo e altro
ancora). Davies afferma allora che un oggetto, ammesso che sia il prodotto di un’attività
umana e che possieda un certo numero di proprietà estetiche, può essere identificato come
opera d’arte (primitiva) se sono soddisfatte le seguenti ulteriori due condizioni: (1) le
proprietà estetiche che tale oggetto possiede devono essere integrali al tutto e (2) (devono
essere) essenziali al raggiungimento della funzione primaria (o delle funzioni primarie)
dell’oggetto stesso 251. Se la funzione primaria dell’oggetto è quella di procurare piacere
attraverso la contemplazione delle proprietà estetiche, allora la teoria di Davies si avvicina
alle teorie estetiche tradizionali, che ben si accordano con la maggior parte delle opere d’arte
prodotte in Occidente, con l’arte giapponese e cinese, e via dicendo. Tuttavia molte opere
d’arte sono state create con fini diversi da quello puramente contemplativo e con lo scopo
invece di intervenire direttamente nella vita sociale e spirituale delle persone (Davies cita le
statue di Michelangelo, i dipinti di Masaccio e le tragedie greche come esempi paradigmatici).
Lo stesso può dirsi delle prime opere d’arte, che sappiamo (sebbene in modo alquanto
generico) essere state create per compiere rituali religiosi, per educare i giovani al rispetto di
determinati valori, per accompagnare la celebrazione dei matrimoni e così via. Ciò che fa di
tali oggetti delle opere d’arte è l’aver conseguito in modo estetico lo scopo primario sotteso
alla loro creazione.
Si potrebbe ancora obiettare a Davies il fatto che, data la nostra riconosciuta ignoranza
circa il contesto in cui le prime opere d’arte sono state create, non possiamo nemmeno essere
sicuri su quale fosse la loro funzione primaria e su quali fossero le proprietà rilevanti ai fini
dell’assolvimento di tale funzione. Questo è in effetti, come riconosce lo stesso Davies, il
motivo della nostra frequente incertezza di fronte all’arte primitiva. Vi è però un contesto al
quale tale arte può essere ricondotta e di cui tutti noi possiamo immediatamente venire a
conoscenza: si tratta di un concetto ampio di contesto, costituito dalle esperienze, dai desideri,
dalle credenze e dalle abitudini dell’essere umano in quanto tale. Quando nel realizzare un
oggetto poniamo una particolare cura per il suo aspetto estetico, ciò significa che tale oggetto
ha un certo valore per noi e che questo stesso valore è in parte subordinato all’aspetto estetico
dell’oggetto. Pertanto, quando in un oggetto primitivo notiamo un effetto estetico che denota
una certa attenzione (da parte di chi l’ha realizzato) per i suoi aspetti percettivi e formali, ciò
significa secondo Davies che le proprietà estetiche dell’oggetto (che, come detto, possono
251 Davies esplicita queste due condizioni tanto in “First Art and Art’s Definition”, cit., pp. 26-33, quanto in “Non-Western Arts and Art’s Definition”, cit., p. 207.
130
essere percepite da qualsiasi persona di ogni epoca) sono essenziali per l’assolvimento della
sua funzione primaria; il che è direttamente deducibile dalla considerazione della naturale
tendenza dell’uomo a lavorare con dedizione a quegli aspetti di un oggetto che sono
funzionali al raggiungimento del proprio scopo. L’ignoranza relativa alle funzioni specifiche
di molti oggetti primitivi (che sappiamo solo genericamente essere stati creati per fini sociali,
religiosi e talvolta contemplativi) rappresenta un ostacolo soprattutto per la piena
comprensione del significato di tali oggetti (ovvero per la loro interpretazione), ma non ci
impedisce di classificarli o meno tra le opere d’arte.
Arrivati a questo punto vale la pena chiedersi: quale conseguenza comporta la descrizione
che Davies dà delle prime opere d’arte per il problema della definizione dell’arte in generale?
Davies si affretta a precisare che le conclusioni alle quali egli è pervenuto non implicano in
alcun modo la preferibilità di una definizione estetica dell’arte. Dato infatti che nel corso della
storia si è avuto un graduale e costante mutamento sia delle funzioni specifiche dell’arte, sia
delle proprietà in virtù delle quali determinate opere sono state in grado di assolvere a tali
funzioni, non vi è ragione di pensare che la caratterizzazione in senso estetico ritenuta
appropriata alle prime opere d’arte debba valere anche per le opere d’arte prodotte in ogni
luogo e in ogni tempo. Ciò che è vero è piuttosto il fatto che non esistono tradizioni culturali
in cui nessuna opera d’arte abbia proprietà estetiche, dal momento che allo stadio iniziale di
ogni tradizione le opere d’arte venivano riconosciute e apprezzate in virtù delle proprietà
estetiche esibite (le stesse che ci permettono a tutt’oggi di apprezzare tali opere e di
riconoscerle come artistiche) e della capacità (di queste stesse proprietà) di contribuire alla
soddisfazione dello scopo sotteso alla realizzazione delle opere stesse. Si può, secondo
Davies, ragionevolmente pensare che senza il fondamento estetico delle prime opere d’arte, la
storia dell’arte non sarebbe esistita nel modo in cui oggi la conosciamo. Il legame dell’arte
con le proprietà estetiche è quindi una “necessità storica”, piuttosto che un elemento che
debba necessariamente comparire in una definizione dell’arte 252.
Escluso quindi un proprio appoggio alle definizioni estetiche, Davies sostiene invece che la
caratterizzazione in senso estetico delle prime opere d’arte da lui elaborata possa fungere da
integrazione e completamento delle definizioni storiche, in particolare di quella di Levinson 253. Abbiamo infatti visto nei capitoli precedenti come la classificazione delle prime opere
252 S. Davies, “First Art and Art’s Definition”, cit., pp. 32-3. 253 Già al termine del secondo capitolo avevamo visto come proprio Davies accennasse alla possibilità di completare la definizione dell’arte con aggiunte di tipo funzionale o istituzionale che ne lasciassero intatta l’identità specifica. Nel terzo capitolo abbiamo analizzato le teorie di Carroll, Carney e Stecker interpretandole nell’uno o nell’altro senso. Ciò che aveva in mente Davies era però diverso: in effetti la sua soluzione comporta
131
d’arte costituisse uno dei principali problemi per tutte quelle definizioni che legano
l’artisticità di un oggetto al suo riferimento (intenzionale o meno) all’arte del passato.
Levinson prima, e Carroll e Stecker poi, sono stati costretti a riconoscere l’esistenza di una
condizione aggiuntiva per quelle opere che, non essendo per ipotesi riconducibili ad opere
precedenti, non potevano essere definite in modo ricorsivo. Questa condizione è stata
identificata da tali autori col soddisfacimento, da parte delle prime opere d’arte, di funzioni
che si sarebbero poi rivelate fondamentali per il successivo sviluppo della storia dell’arte.
Levinson ha anche ammesso la possibilità di dare una descrizione compiuta di tali opere in
termini di proprietà e funzioni, attraverso una sorta di scavo archeologico che però, come
detto, rimane per lui più una possibilità teorica che non un concreto progetto di ricerca. Ora,
grazie alle riflessioni di Dutton e soprattutto di Davies, siamo in grado di fornire una
descrizione delle prime opere d’arte in grado di completare la condizione aggiuntiva
abbozzata da Levinson e compagni. Tale descrizione non avviene però in termini di funzioni
comuni − che per le prime opere d’arte sono incerte e confuse − né in termini di proprietà
genericamente condivise − il che ci porterebbe all’indeterminatezza della teoria weitziana
delle somiglianze di famiglia − bensì nei termini delle proprietà dell’opera che sono essenziali
all’assolvimento della sua funzione specifica. Tali proprietà sono, con ogni probabilità,
estetiche.
Se questo è l’unico progresso che la soluzione del problema relativo allo statuto delle
prime opere d’arte fa compiere al più generale problema della definizione dell’arte, verrebbe
da dire che non ci siamo spostati di molto dal punto in cui eravamo rimasti al termine del
capitolo precedente. Siamo infatti ancora costretti a far ricorso a una definizione disgiuntiva
dell’arte (come quella storica è, implicitamente o esplicitamente) che, pur essendo valida nella
seconda condizione − quella che cattura l’essenza delle prime opere d’arte −, rimane
deficitaria (per i motivi esposti nel secondo e nel terzo capitolo) nella prima condizione −
quella che serve a identificare le opere d’arte prodotte successivamente allo stadio iniziale di
una tradizione. Le due condizioni si mantengono separate, e la riformulazione in chiave
estetica della seconda non può in alcun modo, stando a quanto affermato da Davies,
influenzare e correggere la prima, in quanto le funzioni perseguite dall’attività artistica
cambiano col passare del tempo, così come parallelamente mutano le proprietà che un’opera
deve possedere per assolvere tali funzioni. Le funzioni e le proprietà rilevanti per
un cambiamento marginale nella definizione di Levinson (la quale nella sua parte principale, ovvero nella condizione storico-ricorsiva, è fondamentalmente in sintonia col contestualismo sostenuto da Davies) e si configura come completamento tanto di questa quanto delle teorie di Carroll, Carney e Stecker, come vedremo in seguito.
132
l’identificazione delle prime opere d’arte possono non esserlo più per le opere realizzate
successivamente: questo è un punto condiviso anche dai propositori delle definizioni storiche
dell’arte. Levinson afferma che in ogni momento preciso della storia c’è un nucleo indiscusso
di opere d’arte e di modi di considerazione ad esse appropriati, ai quali ogni opera prodotta
successivamente deve far riferimento per poter essere classificata come arte. Di tali modi non
è però possibile dare alcuna descrizione concreta (al di là dell’indicazione formale relativa
alla completezza dell’insieme dei modi di considerazione), poiché sarebbe secondo Levinson
impossibile (oltreché inutile dal punto di vista della sua teoria) enumerare tutti i modi di
considerazione che si sono avvicendati nel corso della storia dell’arte. Stecker va ancora oltre
e afferma non solo che le funzioni (le quali occupano nella sua definizione lo stesso ruolo
occupato dai modi di considerazione nella definizione di Levinson) proprie delle forme d’arte
centrali di una tradizione cambiano da forma a forma, ma anche che la creazione di nuove
forme d’arte può portare in futuro al riconoscimento della centralità di nuove funzioni per
l’arte. La storia dell’arte sembra essere caratterizzata da una mutevolezza tale da impedire
qualsiasi tentativo di estendere le generalizzazioni riguardanti lo stadio iniziale della
tradizione artistica ai vari stadi successivi.
L’enfasi posta da Levinson e da Stecker rispettivamente sull’ampiezza e sulla mutevolezza
delle funzioni artistiche è però controbilanciata da quanto la storia dell’arte, studiata da una
prospettiva transculturale, realmente attesta. Abbiamo infatti visto (grazie alle ricerche di
autori come Bond, Gaut, Dutton e Moravcsik) che il concetto di arte, in qualsiasi epoca o
tradizione la si consideri, è sempre riconducibile a una lista di nove criteri. Tali criteri sono
interpretabili come altrettante funzioni (o modi di considerazione, stando
all’interscambiabilità dei due termini), a ciascuna delle quali corrisponde un determinato
insieme di proprietà caratteristiche o standard 254 − sintetizzando, possiamo dire che al primo
criterio corrispondono le proprietà più propriamente estetiche, al secondo le proprietà
espressive, al terzo, quarto e settimo le proprietà formali, al quinto e al sesto le proprietà
semantiche, all’ottavo e al nono le proprietà storico-relazionali. Ciascuna funzione può essere
soddisfatta tanto attraverso il possesso delle proprietà caratteristiche o standard, quanto (più
frequentemente) dall’interazione tra queste e le proprietà standard di altre funzioni. Ad
esempio, la comunicazione di significati complessi e profondi (quinto criterio/funzione) viene
perlopiù ottenuta attraverso la combinazione delle proprietà semantiche (rappresentative e
254 Il concetto di proprietà standard rispetto a una categoria artistica (forma, genere, stile, ecc.) è ripreso da Kendall Walton, “Categories of Art” (1970), ora in Neill. A. e Ridley A. (ed. by), The Philosophy of Art: Readings Ancient and Modern, cit., pp. 332-354.
133
simboliche) con quelle formali, espressive e relazionali; l’espressività di un’opera è maggiore
quando le proprietà espressive si fondono con quelle rappresentative, le quali indirizzano
l’emozione verso un contenuto specifico; il virtuosismo è più apprezzato quando non è mero
esercizio tecnico-formale ma si pone al servizio dell’espressività dell’opera e del suo
contenuto; l’importanza storica o istituzionale di un’opera d’arte (dovuta ad esempio alla sua
originalità rispetto a stili e forme preesistenti o alla sua capacità di mettere in discussione le
strutture sociali − musei, gallerie, critici − con cui necessariamente si pone in dialogo) è poca
cosa se il suo contenuto specifico e la forma attraverso cui questo viene comunicato non sono
anch’esse di eguale interesse; il piacere è l’effetto globale dell’interazione tra le varie parti
dell’opera e il soggetto che le percepisce; e via dicendo. La lista dei modi di considerazione
storicamente appropriati all’arte del passato, ovvero delle funzioni appartenenti alle forme
d’arte centrali delle diverse tradizioni artistiche, è quindi temporalmente finita
(contrariamente a quanto sostenuto da Stecker) e numericamente limitata (contrariamente a
quanto sostenuto da Levinson), così come finito e limitato è l’elenco delle proprietà
caratteristiche o standard di tali modi o funzioni, ovvero delle proprietà rilevanti ai fini
dell’assolvimento delle funzioni stesse (sebbene tali proprietà agiscano più spesso in
combinazione le une con le altre). Possiamo allora modificare la prima condizione della
definizione storico-disgiuntiva dell’arte specificando che un oggetto è un’opera d’arte (non
primitiva) se è stato creato per soddisfare una o più delle funzioni sopraelencate e se possiede
le proprietà rilevanti ai fini dell’assolvimento delle stesse (ovvero le proprietà standard o
caratteristiche, da sole o in unione con le proprietà standard di altre funzioni) 255.
Abbiamo in tal modo risolto uno dei problemi della definizione storica dell’arte, quello
relativo alla correttezza dei modi di considerazione. Attingendo alla lista precedentemente
ottenuta, siamo ora in grado di specificare i modi (ovvero le funzioni) corretti in termini dei
criteri della lista e delle proprietà ad essi corrispondenti. Di conseguenza abbiamo una base
sostanziale e non solo strutturale per decidere se una data tradizione è artistica, nonché un
metodo per stabilire il valore delle opere d’arte (essendo quest’ultimo legato al grado di
soddisfacimento delle suddette funzioni in virtù del possesso e dell’interazione delle
corrispondenti proprietà). Rimane però ancora irrisolto il nodo relativo alla completezza degli
insiemi dei modi di considerazione. Levinson, lo ricordiamo, sostiene che un’opera d’arte è
tale se può essere ricondotta a un insieme integrale, ovvero relativamente completo, di modi o
255 La seconda parte di tale condizione contiene un criterio di successo − l’effettivo assolvimento della funzione − che non compare nelle definizioni originarie di Levinson e Stecker, ma che abbiamo visto essere necessario per superare le difficoltà alle quali una condizione puramente intenzionale va inevitabilmente incontro.
134
funzioni propri delle opere e delle forme d’arte centrali e riconosciute. L’indeterminatezza
insita al concetto di “relativamente completo” permane anche dopo che abbiamo specificato
tali modi in termini di criteri e proprietà specifici. Abbiamo visto infatti come la mancanza di
una gerarchia interna alla lista dei criteri caratteristici dell’arte trasformi le teorie che su tale
lista si fondano (che sono formalmente identificabili con la cluster theory) in definizioni
disgiuntive estremamente complesse. Tale complessità aumenta ancora non appena si tiene
conto anche delle diverse possibili combinazioni di proprietà che sono in grado di assolvere i
diversi sottoinsiemi di funzioni a cui la lista può dare origine. Senza ulteriori restrizioni, la
prima e fondamentale condizione di una definizione disgiuntiva dell’arte, desunta da quella di
Levinson e corretta alla luce degli studi sulle diverse tradizioni artistiche e sulle loro origini,
rischia di frantumarsi in una galassia di condizioni finite ma numericamente assai elevate,
ciascuna delle quali consiste nella specificazione di un certo insieme di funzioni e di
proprietà, desunti entrambi dalla lista dei nove criteri precedentemente enumerati e tali da
garantire l’artisticità di un oggetto, laddove questo assolva le funzioni indicate in virtù della
combinazione delle proprietà ritenute rilevanti a tal fine. L’unico sistema che ci rimane per
evitare che tale galassia esploda e conduca al caos assoluto è il recupero di uno dei perni delle
definizioni storiche dell’arte: la nozione di continuità.
Il punto di partenza di tutte le definizioni storiche è che l’arte ha una storia. Ciò significa
che in ogni periodo storico esiste un insieme di funzioni o modi di considerazione condivisi e
riconosciuti come appropriati alle forme artistiche centrali di una certa tradizione, e che ciò
che viene prodotto successivamente può essere definito come arte solo se intrattiene una
relazione con uno di questi insiemi. Ma l’avere una storia significa che tale relazione tra
insiemi di funzioni artistiche è una relazione di continuità, la quale può essere sia diacronica −
con ciò intendendo la continuità che sussiste tra i diversi stadi che una forma artistica
attraversa nel tempo e tra le diverse forme che si succedono nel tempo − sia sincronica −
ovvero tra le diverse forme d’arte presenti in uno stesso periodo storico. Levinson afferma
esplicitamente che “vi è una continuità nell’evoluzione artistica ancor più profonda di quanto
sia generalmente notato” 256, e aggiunge che il passaggio da un insieme di modi di
considerazione ad un altro avviene in modo graduale e progressivo. Carroll riprende questo
punto e lo arricchisce con una serie di nozioni chiarificatrici, prima fra tutte quella di arte
come conversazione, di cui abbiamo già parlato e che ripercorreremo ora nei suoi punti-
chiave. L’arte, sostiene Carroll, è una pratica culturale continua − in virtù dell’esistenza di
256 J. Levinson, “Defining Art Historically”, cit., p. 18.
135
una tradizione di opere, tecniche, regole e valori condivisi e sedimentatisi nel tempo − e al
tempo stesso mobile − in quanto contiene al suo interno gli strumenti per evolversi e adattarsi
alle esigenze che la contemporaneità pone. Ciò che è vero dal punto di vista della produzione
artistica, lo è altrettanto dal punto di vista della ricezione: pertanto un oggetto, per essere
classificato tra le opere d’arte, deve poter essere inserito in una tradizione di regole, valori e
modi di considerazione artistici riconosciuti. Il metodo che ci permette di identificare le opere
d’arte consiste nell’elaborazione di narrazioni storiche che siano in grado di farci capire come
una determinata opera, in virtù del possesso di determinate proprietà e del conseguente
soddisfacimento di determinate funzioni, sia la continuazione di opere d’arte precedenti e
riconosciute con le quali si pone idealmente in uno stato di conversazione.
La relazione sulla quale le narrazioni storiche si fondano può essere di ripetizione (delle
funzioni e dei mezzi, ovvero delle proprietà, atti ad assolvere le funzioni stesse), di
amplificazione (soprattutto dei mezzi rispetto alle funzioni) e di ripudio (di funzioni e mezzi).
L’alternanza di queste tre relazioni garantisce insieme la continuità e lo sviluppo della storia
dell’arte. Tra le tre relazioni, il ruolo principale è svolto secondo Carroll dalla relazione di
amplificazione, la quale corrisponde alla fase centrale (chiamata complicazione) delle
narrazioni storiche: un artista entra a far parte di una tradizione soprattutto in virtù del suo
riprendere e in parte modificare i mezzi ereditati dal passato, al fine di assolvere la funzione o
l’insieme di funzioni specifiche della forma d’arte entro cui egli si trova ad operare. La
continuità diacronica tra i diversi stadi che una forma d’arte attraversa è costituita anzitutto
dal permanere delle funzioni specifiche di tale forma di fronte invece al variare dei mezzi atti
a soddisfarle. Un primo livello di unità al quale riportare le condizioni in cui la prima parte
della definizione storica dell’arte si è disgregata è costituito quindi dalle forme d’arte centrali,
ciascuna delle quali è identificabile con una o più funzioni caratteristiche − lo studio della
storia dell’arte attesta che la pittura ha tradizionalmente assolto la funzione mimetico-
rappresentativa, la musica quella espressiva, la letteratura quella simbolica e così via. Ma la
continuità interna allo sviluppo di una forma artistica non dipende solo dal permanere della
funzione ad essa specifica, ma anche e soprattutto dalla continuità tra i mezzi adoperati dai
vari artisti che operano all’interno di tale forma per raggiungere lo stesso scopo. Vediamo più
da vicino cosa questo significhi.
Nella fase dell’amplificazione, si è detto, l’artista modifica i mezzi ereditati dalla
tradizione, ovvero le proprietà rilevanti per l’assolvimento della funzione precipua della
forma d’arte entro la quale egli opera. Nel far ciò, dice Carroll, egli non stravolge i mezzi
ereditati dal passato, ma opera in continuità con essi. Cosa vuol dire ciò? Poniamo che il
136
riferimento principale di un certo artista sia un’insieme paradigmatico di opere d’arte O1… On
caratterizzato dalle proprietà (a, b, c), le quali corrispondono ai mezzi con cui tali opere
soddisfano le funzioni f1… fn specifiche della forma d’arte F alla quale esse (le opere)
appartengono. Affinché l’opera X creata dal nostro artista possa essere classificata entro F,
essa deve possedere un insieme di proprietà del tipo (a, b, d), oppure (a, c, g), o ancora (a, m,
r), e via dicendo, tali da consentire l’assolvimento delle medesime funzioni f1… fn di F. Ciò
che garantisce allora la continuità tra X e O1… On, ovvero tra le diverse opere appartenenti a
F nei suoi diversi stadi evolutivi, è, insieme al loro servire un identico insieme di funzioni f1…
fn, il condividere almeno una delle proprietà (nel nostro caso la proprietà (a)) grazie alle quali
tali funzioni sono soddisfatte; laddove l’affiancare ad (a) altre proprietà che siano diverse da
quelle possedute da O1… On è ciò che garantisce l’evoluzione di F. Questo aspetto distingue
la nozione di continuità da quelle di “somiglianza di famiglia” e di concetto “a domino”
(elaborate rispettivamente da Wittgenstein e Tatarkiewicz) 257. Queste ultime sono infatti
caratterizzate da relazioni non transitive, in quanto due oggetti X e Y, aventi rispettivamente
le proprietà (a, b, c) e (d, e, f), possono far parte della stessa famiglia o concetto pur non
avendo nessuna proprietà in comune, ma semplicemente in virtù dell’esistenza di oggetti
intermedi − del tipo X’ (a, b, d), X’’ (b, c, e), X’’’ (c, d, e), e via dicendo − i quali possiedono
somiglianze parziali l’uno con l’altro, come i tasselli contigui nel gioco del domino o come i
membri di una stessa famiglia. Viceversa la relazione di continuità è una relazione di tipo
transitivo, in quanto, come abbiamo appena visto, due oggetti X e Y devono essere simili tra
loro per qualche aspetto per poter essere considerati l’uno la continuazione dell’altro, e tale
somiglianza implica la condivisione di una o più proprietà 258.
257 Wittgenstein, come è noto, introduce il concetto di somiglianze di famiglia (poi ripreso da Weitz e applicato all’arte) per spiegare il significato del concetto di giuoco: “Vediamo una rete complicata di somiglianze che si sovrappongono e si incrociano a vicenda. … Non posso caratterizzare queste somiglianze meglio che con l’espressione ‘somiglianze di famiglia’; infatti le varie somiglianze che sussistono tra i membri di una famiglia si sovrappongono e s’incrociano allo stesso modo: corporatura, tratti del volto, colore degli occhi, modo di camminare, temperamento, ecc. ecc. − E dirò: i ‘giuochi’ formano una famiglia” (L. Wittgenstein, Philosophische Untersuchungen, Blackwell, Oxford 1953; trad. it. Ricerche Filosofiche, Einaudi, Torino 1995, §§ 66-67, p. 47). Già nel 1933 però Tatarkiewicz similmente affermava che spesso “il nome di un oggetto viene usato in modo elastico e viene allargato ad altri oggetti, aventi una qualche parziale somiglianza con l’oggetto dato. Per esempio il nome x, spettante agli oggetti che possiedono le caratteristiche a e b, viene a volte dato all’oggetto A perché possiede la caratteristica a, come pure all’oggetto B perché possiede la caratteristica b. Allora gli oggetti A e B hanno un nome comune, ma possono non avere caratteristiche comuni. … Questo modo di procedere … si potrebbe chiamare “a domino”: esso è infatti simile al modo di procedere nel gioco a domino, dove si aggiunge tassello a tassello in base a una somiglianza parziale ottenendo così una serie nella quale i tasselli contigui sono tra loro simili, ma possono non avere nulla in comune con gli altri.” (W. Tatarkiewicz, L’attitude esthetique, poetique et litteraire, Bull. Int. De l’Acad. Polonaise des Sciences et des lettres », Krakow, nn. 1-6, 1933, pp. 123-9, citato da K. Jaworska, Presentazione, in W. Tatarkiewicz, Storia di Sei Idee, Aesthetica, Palermo 1993, pp. 12-3). 258 La caratterizzazione della teoria delle somiglianze di famiglia e del concetto a domino in termini di relazioni non transitive è ripresa da A. Voltolini, Guida alla lettura delle ricerche filosofiche di Wittgenstein, Laterza,
137
L’identità di una forma artistica, ovvero la continuità tra le opere ad essa appartenenti,
sono quindi garantite in ultimo dalla presenza di una o più proprietà costanti grazie alle quali
le opere appartenenti a tale forma, pur nella loro diversità, ne soddisfano la funzione specifica.
Ma la continuità della storia dell’arte non è, come detto in precedenza, solo la continuità tra i
diversi stadi evolutivi di una forma d’arte. Può succedere ad esempio che una forma d’arte, in
risposta al mutare delle condizioni storico-culturali, modifichi la sua funzione primaria nel
tempo. Ciò è quanto avvenuto paradigmaticamente per la pittura. Come Arthur Danto ha a più
riprese sottolineato, la pittura ha da sempre svolto uno scopo imitativo nei confronti della
realtà, evolvendo costantemente le proprie tecniche riproduttive 259. A cavallo dell’Ottocento
e del Novecento essa è stata però superata da nuove forme d’arte come la fotografia e il
cinema, che potevano assolvere lo scopo imitativo assai più efficacemente. Di conseguenza la
pittura ha dovuto modificare la propria funzione e indirizzarsi verso altri scopi, talvolta
desumendoli da altre forme d’arte − si pensi al legame tra l’astrattismo formale e la musica, o
tra la metafisica (e il suo figlio diretto, il surrealismo) e la letteratura −, dando vita così a una
varietà di movimenti o generi pittorici ciascuno con una diversa funzione − oltre a quelli già
citati, pensiamo all’espressionismo, al neoclassicismo, e via dicendo. Dobbiamo allora cercare
di spiegare la continuità tra i diversi generi a cui una determinata forma d’arte eventualmente
dà luogo.
C’è poi da considerare la possibilità che nuove forme d’arte facciano la loro comparsa nel
corso della storia. Si tratta di un’opzione non molto frequente ma comunque non trascurabile.
Un punto va anzitutto chiarito: nuove forme d’arte non significa necessariamente nuove
funzioni e nuove proprietà. Ciò è quanto vorrebbero farci credere i sostenitori delle
rivoluzioni artistiche come l’Arte Concettuale. Levinson, Carney e Carroll hanno affiancato la
relazione di ripudio alle relazioni di ripetizione e di amplificazione per far sì che anche l’Arte
Concettuale, che pure asserisce la propria netta frattura rispetto agli scopi e ai mezzi dell’arte
tradizionale, fosse interpretabile come una continuazione delle forme d’arte già esistenti e
riconosciute. Sulla legittimità di una siffatta soluzione discuterò nel quinto capitolo; per ora
metterò tra parentesi il caso (peraltro unico) dell’Arte Concettuale e cercherò di ripercorrere
brevemente l’analisi compiuta da Levinson circa il modo in cui nuove forme d’arte possono
Roma-Bari 1998, p. 45. Sul rapporto tra Wittgenstein e Tatarkiewicz si vedano anche L. Amoroso, “Somiglianze di famiglia e storie di famiglia nella ricerca di Tatarkiewicz, Rivista di Estetica 46 (1994/95), pp. 79-106, e F. Bollino, “Fra Croce e Wittgenstein: aria di famiglia?”, Studi di Estetica 27 (2003), Clueb, Bologna, pp. 239-289. 259 Si veda a tale proposito, tra gli altri scritti, A. Danto, “Art, Evolution and the Consciousness of History”, Journal of Aesthetics and Art Criticism 44 (1986), pp. 223-33.
138
venire alla luce 260. Secondo Levinson le forme d’arte non ancora esistenti in un dato
momento possono generarsi per giustapposizione, fusione o trasformazione di forme d’arte
già esistenti. In tal modo sono sorte ad esempio la pitto-scultura di Jasper Johns o
l’architettura scultorea di Frank Gerhy; lo stesso cinema può essere interpretato come la
fusione di forme d’arte differenti (teatro, musica, pittura, ecc.), mentre la fotografia è
ricollegabile a innovazioni tecnologiche interne a una forma o genere (la rappresentazione
pittorica) piuttosto che a trasformazioni strutturali della forma stessa. Vi sono secondo
Levinson ancora molte forme d’arte non ancora esistenti che potrebbero venire alla luce
attraverso una ricombinazione di forme già esistenti (tra tali forme futuribili ma non ancora
sperimentate egli menziona la poesia danzante − una forma di poesia che viene recitata
danzando − e la musica visuale − ovvero film costituiti da pure sequenze di colori, che si
succedono come le note in una composizione musicale). L’esistenza di una simile possibilità,
pur essendo coerente con la restrizione di tutte le forme d’arte (presenti, passate e future) ad
un nucleo finito di criteri − le nuove forme derivano infatti dal rimescolamento di forme,
ovvero di proprietà e funzioni, già esistenti e specificate nella nostra lista − rappresenta altresì
un elemento di complicazione nei confronti del concetto continuo e progressivo di storia
dell’arte propugnato da Levinson e compagni − per cui dobbiamo tenere conto di relazioni
ulteriori rispetto a quelle citate (abbiamo peraltro visto come a tal proposito Carney affianchi
a ripetizione, amplificazione e ripudio le relazioni di re-interpretazione e di sintesi). Il
modello sopra fornito dalla relazione di amplificazione ci permette di dar conto almeno in
parte della continuità diacronica tra i diversi stadi evolutivi di una forma d’arte, ma dobbiamo
ancora spiegare la continuità − attestata dalla storia dell’arte e usata da Levinson, Carroll,
Carney e Stecker a fondamento delle loro definizioni − tra le diverse forme d’arte (reali o
possibili) che si succedono nel tempo o tra le varie forme che sono sincronicamente presenti
in uno stesso momento storico.
Il problema, a ben vedere, è simile a quello che ha da sempre costituito una spina nel
fianco per le definizioni storiche − ovvero, come facciamo a stabilire se una tradizione
culturale caratterizzata da uno sviluppo continuo è artistica? La prima e insoddisfacente
risposta di Levinson era quella di puntare sulla somiglianza strutturale delle diverse tradizioni,
ovvero sul loro analogo modo di evolversi continuo e ricorsivo, laddove ciò di cui avevamo
bisogno era una somiglianza di tipo sostanziale. Gli studi compiuti da Dutton, Moravcsik ed
260 Levinson discute il problema delle forme d’arte non esistenti in due articoli: “Hybrid Art Forms” (1984), ora in J. Levinson, Music, Art and Metaphysics, cit., pp. 26-36, e “Nonexistent Artforms and the Case of Visual Music” (1997), ora in Id., Contemplating Art, cit., pp. 109-128.
139
altri ancora ci hanno fornito questa base sostanziale, costituita da un nucleo di nove criteri
comuni alle opere d’arte di qualsiasi tradizione artistica conosciuta. Dato però che tali criteri
possono combinarsi tra loro in vario modo dando vita a diverse forme o generi d’arte, la
domanda alla quale dobbiamo ora rispondere è: come facciamo a stabilire che una data forma
(o genere) culturale caratterizzata da uno sviluppo continuo è artistica? Di nuovo, non
possiamo puntare solo sulla somiglianza strutturale tra le diverse forme d’arte. Adesso
conosciamo però più da vicino tale struttura, almeno nella sua relazione fondamentale, che è
quella di amplificazione, la cui analisi ci ha fornito un modello di comprensione della
relazione di continuità. Grazie a tale modello sappiamo che ciò che garantisce l’unità di una
forma d’arte, ovvero la continuità tra le opere ad essa appartenenti, è il possesso da parte di
queste di almeno una proprietà comune tale da assolvere lo scopo specifico della forma in
questione. A maggior ragione, la stessa proprietà dovrà allora essere posseduta dalle opere
appartenenti ad altre forme d’arte (precedenti, successive o contemporanee) caratterizzate da
funzioni specifiche diverse e dovrà essere rilevante ai fini dell’assolvimento di tali funzioni,
affinché possa sussistere una continuità tra le varie opere e forme d’arte (reali o possibili). La
proprietà che garantisce la continuità tra i diversi stadi evolutivi di una data forma d’arte non
può che essere la stessa proprietà che garantisce la continuità tra le opere e forme d’arte
presenti, contemporaneamente o in tempi diversi, nelle diverse tradizioni culturali.
Ci rimane allora solo il problema di specificare tale proprietà. Stavolta però non dobbiamo
ricorrere a modelli astratti. Ci basta riprendere il ragionamento fatto da Davies a proposito
delle opere d’arte primitive ed estenderlo anche alle opere successive. Quali sono quelle
proprietà che possono essere riconosciute e apprezzate non solo in qualsiasi tradizione, ma
anche in qualsiasi forma d’arte e in qualsiasi momento della storia, indipendentemente dalle
funzioni specifiche delle diverse tradizioni, forme e opere? Da quanto detto in precedenza, è
facile dedurre che tali proprietà sono, abbastanza naturalmente, le proprietà estetiche. Se è
vero, come lo studio della storia produttiva e ricettiva della storia dell’arte conferma, che vi è
una profonda continuità nell’evoluzione tanto delle tecniche e degli scopi perseguiti dagli
artisti quanto dei modi di giudizio critico, allora non deve stupire che la condizione che ci
permette di identificare oggi un oggetto come artistico sia la stessa che ci permette di
classificare come opera d’arte un oggetto primitivo. Le proprietà estetiche sono il sole che
illumina le costellazioni, grandi e piccole, di opere, forme e tradizioni appartenenti alla
galassia dell’arte. La miriade di condizioni in cui la nostra definizione storico-disgiuntiva
dell’arte si era venuta a frantumare viene ora ricomposta in un’unica condizione, che altro non
è che la condizione che definisce anche le prime opere d’arte: un oggetto è un’opera d’arte
140
(tout court) se e solo se le proprietà rilevanti ai fini del soddisfacimento della sua funzione
primaria (o delle sue funzioni primarie) sono estetiche.
Il lungo viaggio che abbiamo intrapreso all’inizio del quarto capitolo e che ci ha portati ad
attraversare culture diverse ed epoche lontane, ci ha condotto infine a una soluzione del
problema della definizione dell’arte alquanto differente da quello prospettato dai sostenitori
delle definizioni storiche. Ciò che per questi ultimi rappresentava una condizione secondaria e
valida tutt’al più per un numero limitato di opere, risulta ora essere la condizione unica di
definizione dell’arte di ogni epoca e cultura; il che non deve sorprendere, se si pensa che gli
stessi Levinson, Carroll e Stecker, indicando da un lato un criterio di classificazione
sostanziale per le prime opere d’arte e dall’altro un criterio strutturale di tipo ricorsivo fondato
sulla continuità tra le opere d’arte, hanno di fatto posto le basi per un’unione delle due
condizioni. Tale unione era quindi già intuibile nelle definizioni di questi autori (vale la pena
ricordare come Carroll apparenti la propria teoria alla teoria darwiniana dell’evoluzione della
specie); ma solo uno studio dettagliato delle affinità reali tra le diverse tradizioni e forme
artistiche, insieme all’analisi del fondamento teoretico di tali affinità (ovvero
l’approfondimento del concetto di continuità), ci hanno permesso di portarla a compimento.
Differente è peraltro anche il modo in cui tale condizione era stata concepita da Levinson,
Carroll e Stecker, per i quali le prime opere d’arte erano identificabili attraverso la
specificazione di un determinato nucleo di funzioni. Secondo la definizione che abbiamo ora a
disposizione, ciò che conta per classificare le opere d’arte, dalle prime alle più recenti, non è
tanto la funzione o l’insieme di funzioni che esse devono soddisfare − essendo questo
impossibile da conoscere a fondo (nel caso delle opere primitive) o essendo soggetto a
variazioni, sebbene numericamente limitate (per quanto riguarda le opere d’arte appartenenti
alle forme d’arte riconosciute e successive allo stadio iniziale di una tradizione) − quanto
piuttosto il fatto che le proprietà dell’opera rilevanti ai fini del soddisfacimento della sua
funzione primaria (o delle sue funzioni primarie) siano estetiche.
La definizione di cui siamo venuti a capo è quindi una definizione estetica. Essa è
ovviamente in grado di risolvere i problemi in cui le definizioni storiche si sono incagliate,
dato che è proprio da tali problemi che essa prende le mosse. Tuttavia nella forma in cui si
presenta − che altro non è che quella applicata da Davies alle opere d’arte primitive e da noi
estesa a tutte le opere d’arte − nemmeno tale definizione è esente da problemi. Innanzitutto
dobbiamo chiederci: a cosa ci riferiamo di preciso quando parliamo di proprietà estetiche?
Davies sembra identificarle principalmente con delle proprietà formali, ma il dibattito
analitico degli ultimi quarant’anni ha dimostrato che le proprietà estetiche occupano uno
141
spazio assai più ampio di quello occupato dalle proprietà formali: occorre allora vedere se e
perché, una volta che si sia considerata la famiglia di proprietà che vanno sotto il nome di
estetiche nella sua completa estensione, le proprietà formali mantengono un ruolo privilegiato
rispetto alle altre, relativamente alla sfera artistica. Inoltre è necessario capire in che modo un
insieme limitato di proprietà possa contribuire a soddisfare funzioni diverse da quella ad esse
corrispondente; il che implica lo studio delle relazioni tra le diverse proprietà che rientrano
nell’ambito estetico, ovvero tra le proprietà formali e quelle espressive, semantiche, e via
dicendo. Ancora: se ogni forma o genere è caratterizzato da una funzione specifica (o da più
funzioni specifiche), perché per la categoria generale dell’arte non avviene lo stesso? Siamo
sicuri che non esista una gerarchia tra le funzioni che tale categoria racchiude, così come c’è
una gerarchia tra le proprietà rilevanti ai fini del loro soddisfacimento (e che assegna un ruolo
privilegiato alle proprietà estetiche)? Se l’arte non è riconducibile a nessuna funzione
specifica, in cosa consiste il valore artistico di un’opera? A queste e ad altre domande
cercheremo di rispondere nel prossimo capitolo, con lo scopo di perfezionare la definizione
estetica a cui siamo pervenuti, sulla base tanto di un’analisi del concetto di proprietà estetiche
nelle sue varie ramificazioni quanto della sua relazione col problema della definizione
dell’arte. Questo vuol dire che dobbiamo percorrere ancora un po’ di strada. Il traguardo che
abbiamo finora raggiunto è comunque già di grande importanza, e ribalta quanto asserito da
Diffey e riportato all’inizio del presente capitolo. L’arte ha un’essenza proprio in quanto ha
una storia, e tale essenza è estetica.
142
CAPITOLO QUINTO
L’essenza estetica dell’arte
Sappiamo che l’essenza dell’arte è estetica e abbiamo un criterio di identificazione delle
opere d’arte basato sul possesso, da parte di queste, di proprietà estetiche tali da soddisfare, da
sole o in unione con altre proprietà, una o più funzioni particolari. Con ciò non abbiamo però
ancora del tutto risolto il problema della definizione dell’arte. Da un lato è necessario infatti
approfondire il concetto di proprietà estetiche, sia dal punto di vista qualitativo (cosa sono le
proprietà estetiche? qual è la loro natura?) che dal punto di vista quantitativo (quante sono?
come sono collegate tra loro?). Dall’altro lato occorre studiare più da vicino il rapporto tra le
funzioni artistiche e vedere se esista tra di esse un ordine gerarchico dal quale derivare il
concetto di valore artistico. L’opera d’arte è racchiusa tra queste due estremità, le proprietà
estetiche e il valore, le quali sono a loro volta collegate tra loro dalle nozioni intermedie di
piacere ed esperienza. Attraverso lo studio di tali nozioni − proprietà, esperienza, piacere,
valore − in vario modo collegate all’ambito estetico, sarà possibile ricavare una serie di
desiderata che una definizione estetica dell’arte deve di necessità soddisfare. Più definizioni
si mostreranno all’altezza, sebbene alcune di esse richiederanno delle parziali modifiche (di
certo lo richiederà la definizione estetica alla quale siamo fin qui pervenuti). Così corrette,
esse verranno infine messe a confronto con alcune delle obiezioni che più comunemente
vengono rivolte alle definizioni estetiche dell’arte. L’ultima obiezione che prenderemo in
esame si rivelerà la più spinosa e richiederà un ritorno a delle considerazioni di carattere
storico, sebbene su un piano diverso da quello definitorio.
Come si vede da questa breve introduzione, le tematiche che affronteremo in questo
capitolo sono talmente importanti da poter costituire ciascuna l’oggetto di un lavoro di
ricerca. Ciò mi suggerisce di utilizzare un metodo diverso da quello fin qui adottato. Piuttosto
che sottoporre le diverse nozioni nelle quali ci imbatteremo (e che vanno dalle proprietà
estetiche al valore artistico) ad un’analisi minuziosa e dettagliata (per quanto ovviamente non
si possa fare a meno di un certo grado di analisi concettuale), cercherò di effettuare una sintesi
tra le posizioni che i principali autori di ambito analitico hanno espresso al riguardo, cercando
di approdare a delle conclusioni soddisfacenti e condivise. Ovviamente il valore di verità di
una siffatta operazione di sintesi non sta solo nel trovare un accordo tra posizioni diverse, ma
sta anche nella sua capacità di catturare il fenomeno estetico e artistico nella sua piena e
complessa realtà, di modo che i vari concetti di proprietà estetiche, esperienza, piacere e
143
valore seguano naturalmente l’uno dall’altro e trovino riscontro in una definizione dell’arte
finalmente coerente ed esaustiva.
5.1 Le proprietà estetiche
A) LA NATURA DELLE PROPRIETA’ ESTETICHE
La definizione che abbiamo ottenuto alla fine del quarto capitolo ci dice che un oggetto è
un’opera d’arte se le proprietà rilevanti ai fini del soddisfacimento delle sue funzioni primarie
sono estetiche. E’ giunto quindi il momento di chiederci: cosa sono le proprietà estetiche? Per
rispondere a tale domanda non si può prescindere dal seminale articolo di Frank Sibley
intitolato Aesthetic Concepts e scritto nel 1959, nel quale l’autore definisce i concetti (ovvero
termini, proprietà, qualità, attributi, aspetti, ecc.) estetici come “taste concepts” 261. Egli
fornisce anche una lista di tali concetti, raggruppando sotto l’etichetta di estetico i seguenti
termini: unificato, bilanciato, integrato, inanimato, sereno, fosco, dinamico, potente, vivace,
delicato, commovente, quieto, sentimentale, tragico. Tale lista non va intesa come definitiva
ma solo come indicativa; inoltre va notato che, sebbene alcuni termini (come unificato o
integrato) siano più specificatamente estetici, altri provengono da ambiti diversi e sono
utilizzabili in un discorso estetico solo in virtù di uno slittamento metaforico del loro
significato (si pensi a ‘tragico’, ‘sentimentale’ o ad altri termini non compresi nella lista). Ciò
che fa di un termine un concetto estetico sta quindi nel fatto che esso, per poter essere
attribuito a un determinato oggetto o evento, richiede l’esercizio del gusto, ovvero di una
particolare forma di sensibilità o percezione, distinta dalla preferenza personale e posseduta
ad un grado elevato e raffinato solo da pochi individui. “Le persone”, sostiene Sibley,
“devono vedere la grazia o l’unità di un’opera, sentire la tristezza o la frenesia nella musica,
percepire lo splendore di una combinazione di colori, avvertire il potere di un racconto o la
sua atmosfera” 262.
L’identificazione degli aesthetic concepts con i taste concepts rischia però di incorrere in
una circolarità viziosa, dato che il gusto stesso viene definito come “la capacità di notare o
vedere o dire che determinati oggetti possiedono determinate qualità” 263, ovvero le qualità
estetiche. Ma Sibley corre subito ai ripari introducendo una distinzione che sarà la base di
261 Frank Sibley, “Aesthetic Concepts” (1959), ora in Neill. A. e Ridley A. (ed. by), The Philosophy of Art: Readings Ancient and Modern, cit., pp. 312-3. 262 Frank Sibley, “Aesthetic and Non-Aesthetic” (1965), in Frank Sibley, Approach to Aesthetics: Collected Papers on Philosophical Aesthetics, Clarendon Press, Oxford 2001, p. 34. 263 Frank Sibley, “Aesthetic Concepts”, cit., p. 314.
144
numerose e importanti riflessioni negli anni a seguire, vale a dire la distinzione tra estetico e
non-estetico. Per proprietà non-estetiche Sibley intende quelle proprietà che per essere
rilevate richiedono non già l’esercizio del gusto, ma solo l’impiego di normali capacità
percettive e intellettive. Esse possono essere costituite dalle linee curve o dall’accostamento
di colori in un dipinto, dalla dinamica di un brano musicale, dal plot narrativo di un romanzo,
e via dicendo. Ora, Sibley sostiene che le proprietà estetiche di un oggetto (1) sono distinte
dalle sue proprietà non-estetiche e (2) dipendono dalle proprietà non-estetiche sia per la loro
stessa esistenza sia per il loro carattere specifico. Tale relazione di dipendenza è oggettiva e
causale, ma allo stesso tempo è di tipo particolare. Difatti, “non esistono proprietà non-
estetiche che fungono in ogni circostanza da condizioni logicamente sufficienti
all’applicazione di termini estetici” 264. Un dipinto può ad esempio possedere tutte le proprietà
non-estetiche solitamente associate al termine ‘grazia’ (come la presenza di linee curve, l’uso
di colori pastello, ecc.) e ciononostante non essere ‘grazioso’ (le suddette proprietà possono
essere controbilanciate da altre proprietà di segno opposto, per cui l’effetto estetico che ne
risulta è di fatto imprevedibile). Pertanto, ciò che definisce i concetti estetici è il loro non
essere in alcun modo governati da condizioni, se non negativamente: ad esempio, un dipinto
contraddistinto da un tratto nervoso e frastagliato e da contrasti cromatici violenti non può
dirsi grazioso. E’ più corretto allora parlare delle proprietà non-estetiche come di proprietà
“caratteristicamente associate” 265 a delle qualità estetiche, piuttosto che di condizioni
sufficienti all’applicazione di tali qualità.
Poniamo però che un oggetto possieda tutte le proprietà non-estetiche caratteristicamente
associate alla qualità estetica della ‘grazia’, e non possieda alcuna proprietà non-estetica ad
essa contraria (poniamo addirittura che non possieda altre proprietà non-estetiche al di fuori di
quelle caratteristicamente associate alla grazia): possiamo da ciò dedurre con certezza logica
che tale oggetto è grazioso? Anche in questo caso la risposta è negativa, dal momento che la
relazione tra proprietà estetiche e non-estetiche è empirica e contingente. Un oggetto è
grazioso non solamente in quanto è curvo, bensì in quanto è curvo in quella particolare
maniera in cui lo è; ovvero, la proprietà estetica della grazia dipende da una proprietà non-
estetica determinata (l’essere curvo in una particolare maniera) e non da una proprietà non-
estetica genericamente determinabile (l’essere curvo) 266. La particolarità o non-concettualità
dei giudizi estetici (ovvero delle attribuzioni di proprietà estetiche a un oggetto), aggiunge
264 Ivi, p. 314. 265 Ivi, p. 317. 266 F. Sibley, “Particularity, Art and Evaluation” (1974), ora in Id., Approach to Aesthetics, cit., pp. 88-103.
145
Sibley, dipende quindi dalla contingenza della relazione tra proprietà estetiche e non-
estetiche, e non dalla (erroneamente) supposta individualità o irripetibilità delle opere d’arte −
quanto detto finora vale anche per gli oggetti naturali o per gli artefatti non artistici che pure
possiedono proprietà estetiche. Inoltre tale particolarità dà ragione (e ciò è un indubbio pregio
dell’analisi di Sibley) di una serie di “luoghi comuni estetici”, ovvero di intuizioni condivise
le quali sostengono che: 1) ogni cambiamento di una parte anche minima di un’opera d’arte
ne modifica il carattere estetico (ciò è vero in quanto tale carattere dipende, per l’appunto, da
una particolare e unica combinazione di proprietà non-estetiche); 2) dobbiamo esperire
(leggere, vedere, ascoltare, ecc.) direttamente un oggetto per poter attribuirgli delle proprietà
estetiche; le due operazioni (esperienza e giudizio) non sono peraltro nettamente distinguibili,
in quanto la percezione delle proprietà non-estetiche e l’attribuzione degli attributi estetici
sono fatti “co-percettivi e co-comprensibili” 267; 3) noi impariamo ad utilizzare e ed assegnare
i termini estetici agli oggetti attraverso l’osservazione di “esempi e modelli” 268 e non per
mezzo dell’osservanza di regole, che sono ottenibili per induzione dagli esempi stessi ma
vanno poi valutate caso per caso, individualmente; esse non esauriscono mai la componente
estetica di un oggetto.
In tempi più recenti diversi filosofi di area analitica hanno ripreso la relazione individuata
da Sibley tra proprietà estetiche e non-estetiche, qualificandola con la nozione di
“sopravvenienza”. In breve, secondo i sostenitori della dottrina della sopravvenienza estetica
gli attributi estetici di un oggetto sopravvengono sui suoi attributi non-estetici. Che cosa ciò
significhi ce lo spiega Levinson in un articolo del 1983 anch’esso divenuto un classico
dell’estetica analitica:
Due oggetti (ad esempio, opere d’arte) che differiscono esteticamente necessariamente differiscono
non-esteticamente (ovvero, non possono darsi due oggetti che siano esteticamente differenti ma non-
esteticamente identici: quando si stabiliscono le proprietà non-estetiche di un oggetto si stabiliscono
anche le sue proprietà estetiche) 269.
Per proprietà o attributi non-estetici di un oggetto Levinson intende attributi strutturali
(ovvero percepibili, come il disegno o i particolari colori di un quadro, le sequenze di note di
una musica, ecc.), sub-strutturali (ossia fisici e non percepibili nella loro specificità, come
l’essere una linea lunga 3.3333 centimetri) e contestuali (comprendenti le relazioni tra 267 Ivi, p. 100. 268 F. Sibley, “Aesthetic Concepts”, p. 319. 269 J. Levinson, “Aesthetic Supervenience” (1983), ora in Id., Music, Art and Metaphysics, cit., p. 135.
146
l’oggetto e il contesto artistico o storico-culturale di provenienza); tuttavia egli si riferisce
principalmente alla relazione tra proprietà estetiche e attributi non-estetici strutturali. Ciò che
la teoria della sopravvenienza afferma è quindi che le proprietà estetiche dipendono dalle
proprietà non-estetiche (soprattutto strutturali) di base, co-variano con esse, ma non sono a
queste ultime riducibili. Di che tipo è allora questa dipendenza?
Levinson difende una particolare forma di sopravvenienza che va sotto il nome di
“emergentismo”, stando alla quale gli attributi estetici di un oggetto sono ontologicamente
distinti da quelli strutturali e dipendono da questi ultimi in un modo causale e contingente (e
quindi non logico) 270. Ciò vuol dire che le proprietà estetiche non sono riducibili a complessi
di proprietà strutturali determinate (come sostiene il riduzionismo fisico) o genericamente
determinabili (come vuole la positive condition-governing theory di Peter Kivy); gli attributi
estetici non sottostanno a nessun tipo di condizione (nemmeno alle condizioni negative
ammesse da Sibley). Per chiarire la natura dell’emergentismo, Levinson equipara il rapporto
tra proprietà estetiche e proprietà strutturali sottovenienti al rapporto che intercorre tra le
proprietà sensibili (ovvero proprietà come l’apparire gialli o retti, le quali sono una classe
delle proprietà strutturali) e le loro basi fisiche. Le proprietà sensibili di un oggetto dipendono
ovviamente dalle proprietà fisiche sottostanti, ed ogni cambiamento in queste comporta un
cambiamento in quelle; tuttavia esse non sono analiticamente ricavabili dalle leggi intrafisiche
di base, in quanto la loro rilevazione implica la messa in gioco di principi ulteriori a tali leggi.
Levinson chiama tali principi “fenomenici”, dal momento che connettono le proprietà e le
leggi fisiche dell’oggetto con le caratteristiche percettive del soggetto. Una linea può ad
esempio possedere la proprietà della rettilineità visiva anche quando, pur non essendo tutti i
punti della linea perfettamente allineati, essi danno comunque un’impressione fenomenica di
rettilineità in un soggetto sano e in riferimento a condizioni standard di osservazione.
Analogamente, sostiene Levinson, tra gli attributi estetici di un oggetto e le sue proprietà
strutturali non-estetiche permane uno scarto, un “residuo irriducibile” dovuto al fatto che nella
rilevazione dei primi entrano in gioco dei principi ulteriori alle leggi intra-fisiche e agli stessi
principi fenomenici in atto nelle percezione delle proprietà sensibili. Tali principi, che
Levinson chiama “strutturo-estetici” o “fenomenico-estetici”, permettono l’interazione e la
fusione (a diversi livelli) delle proprietà strutturali e degli attributi estetici intermedi tra di loro
e con il soggetto percepiente e senziente (ovvero con le sue facoltà percettive, affettive e
intellettive); da tale duplice interazione dipendono gli attributi estetici salienti di un oggetto,
270 Levinson riprende il concetto di “emergentismo” da M. Bearsdley, “The Descriptive Account of Aesthetic Attributions”, Revue Internationale de Philosophie” 28 (1974), pp. 336-52.
147
ovvero la sua impressione estetica generale. L’emergentismo dà quindi in ultimo ragione del
fatto che l’impressione estetica generale di un oggetto (ovvero l’insieme dei suoi attributi
estetici salienti) non deriva dalla semplice giustapposizione degli attributi estetici intermedi e
delle proprietà strutturali, ma è essa stessa un attributo olistico nel senso appena spiegato 271.
La descrizione dell’impressione estetica generale (e quindi di ogni proprietà estetica di un
oggetto) come olistica può far pensare che tutti gli attributi estetici siano per loro natura
gestaltici. Ciò è quanto sostiene Monroe Bearsdley, secondo il quale le proprietà estetiche di
un oggetto sono tutte proprietà regionali, ovvero prodotte dalla sintesi delle parti percepibili
dell’oggetto e delle relazioni che intercorrocono tra di esse 272. Levinson non è dello stesso
parere, e fa l’esempio di proprietà estetiche non-regionali come un suono puro o una tela
monocromatica. Si può tuttavia considerare questi ultimi casi come marginali e ritenere che,
in generale, la maggior parte delle qualità estetiche siano regionali o gestaltiche 273. Levinson
271 J. Levinson, “Aesthetic Supervenience”, cit., pp. 145-154. E’ interessante notare come Levinson, per descrivere i principi strutturo-estetici di interazione e fusione tra proprietà strutturali e proprietà estetiche intermedie da un lato e soggetto dall’altro, utilizzi il termine coalesce, che è lo stesso usato da George Dickie per descrivere il principio di associazione (principle of the possibility of coalescence of ideas) che secondo molti filosofi empiristi del Settecento sta alla base della formazione delle idee del bello e del sublime (vedi George Dickie, The Century of Taste, Oxford University Press, New York 1996, p. 32). Secondo Alexander Gerard, ad esempio, tale principio è in atto quando piaceri o idee differenti si fondono insieme (coalesce) per dar vita all’idea di bellezza, che può essere accostata quindi all’impressione estetica generale di cui parla Levinson (si veda Alexander Gerard, An Essay on Taste (1759-1780), Scholars’ Facsimile & Reprints, Delmar, New York 1978 (Introduction by W. J. Hipple), pp. 18-9). Tale parallelo suggerisce che anche per Levinson vi possa essere una gerarchia tra le proprietà estetiche, le quali formerebbero una piramide con al vertice la bellezza. Di tale possibilità discuterò più avanti: per ora è importante sottolineare come tanto per Levinson quanto per Gerard gli attributi estetici (non solo la bellezza) non derivano da un’unione semplicemente additiva, ma implicano l’instaurasi di diverse possibili interazioni tra le proprietà (non-estetiche) dell’oggetto e le caratteristiche (che Gerard chiama sensi interni) del soggetto. 272 Monroe Beardsley, “What is An Aesthetic Quality?” (1973), ora in Id., The Aesthetic Point of View, cit., pp. 93-110. 273 Come esempi di opere d’arte costituite pressoché esclusivamente da proprietà estetiche non composte, ovvero non regionali, molti autori analitici citano opere a vario titolo classificate come minimaliste (le tele monocrome di Klein, i famosi “tagli” di Lucio Fontana, le sculture di R. Morris e R. Serra, e via dicendo), nel qual caso sarebbe difficile liquidarle come casi marginali e di poco conto. Bisogna però a mio avviso fare attenzione a non incorrere negli stessi errori che alcuni studiosi commettono nell’interpretare riduttivamente il minimalismo come arte dell’annullamento, in quanto derivante da una serie di atti negativi − come la rinuncia, l’astensione, il rifiuto, la restrizione, ecc. − nei confronti dei media, degli stili, delle tecniche e degli scopi artistici riconosciuti. (Questa è ad esempio la lettura che del minimalismo dà Richard Wollheim in “Minimal Art”, Arts Magazine, January 1965 (reprinted in G. Battcock (ed.), Minimal Art: A Critical Anthology, Dutton, New York 1968); Levinson dimostra di accogliere tale lettura, come si evince in “Elster on Artistic Creativity” (2003), in Id., Contemplating Art, cit., pp. 65-66). Credo sia più corretto interpretare il minimalismo come arte della sottrazione − la quale implica l’eliminazione del superfluo volta a indirizzare l’attenzione estetica verso pochi ma significativi elementi − piuttosto che della negazione. La sottrazione è anch’essa una forma di composizione: gli elementi verso cui l’attenzione è diretta riflettono l’operazione di sintesi dell’artista e non sono interpretabili come banalmente semplici. Il celebre motto di Mies van der Rohe, “less is more”, è la cifra poetica di chi cerca di ottenere il massimo effetto estetico con pochi elementi, muovendosi in uno spazio (volutamente) limitato ma non per questo limitante nei confronti della fantasia modellatrice di forme dell’artista − d’altronde, come sostiene J. Elster, la creatività artistica si manifesta soprattutto nell’operare entro dei limiti, piuttosto che nel modificare o nell’ampliare i limiti stessi (Elster sviluppa questo concetto nel terzo capitolo del suo libro Ulysses Unbound: Studies in Rationality, Pre-Commitment and Constraint (2000), trad. it. Ulisse liberato: razionalità e vincoli, Il Mulino, Bologna 2004). Alla sottrazione formale fa da contraltare un’addizione in termini di effetto
148
conviene invece con Bearsdley nell’attribuire alle qualità estetiche un’ulteriore caratteristica,
quella di essere delle “value-grounding qualities”, ovvero delle qualità che possono essere
citate come ragioni per supportare un giudizio normativo sul valore estetico di un oggetto.
Questo rappresenta un altro fattore di differenza dalle proprietà non-estetiche, le quali non
possono mai essere usate a supporto di un giudizio di merito estetico di per se stesse, ovvero
senza che vengano ricollegate a delle qualità estetiche su di esse sopravvenienti 274. Tenendo
conto di quanto detto finora, possiamo allora sinteticamente definire le proprietà estetiche
come modi di apparire di ordine superiore, i quali dipendono in maniera olistica o emergente
sui modi di apparire di ordine inferiore e sono rilevanti ai fini della valutazione estetica di un
oggetto 275. A ciò possiamo aggiungere che le proprietà estetiche sono (quasi) sempre qualità
regionali o gestaltiche. La definizione appena fornita è condivisa dalla maggior parte degli
studiosi che si occupano dell’argomento, e ben si accorda con le intuizioni comunemente
diffuse al riguardo. Pertanto essa può costituire un buon punto di partenza dal quale muovere
per affrontare altri problemi.
B) LO SPETTRO DELLE PROPRIETA’ ESTETICHE
La lista delle proprietà estetiche abbozzata da Sibley e riportata all’inizio del precedente
paragrafo comprende termini alquanto diversi tra loro; tale diversità è peraltro destinata a
crescere, dato che la lista (per ammissione dello stesso Sibley) non è per nulla esaustiva, bensì
solo indicativa. Ciò comporta una serie di problemi ai quali dobbiamo dare una risposta.
Innanzitutto, vi sono delle proprietà estetiche che non sono pensabili senza la concomitante
presenza (nello stesso oggetto) di determinate proprietà non-estetiche: tornando all’esempio
precedente, difficilmente potremmo descrivere un dipinto come ‘grazioso’ se esso non fosse
caratterizzato da linee curve, colori tenui, ecc. L’esistenza di condizioni positive per
l’applicazione di determinati attributi estetici contrasta quindi con la visione emergentista
della sopravvenienza, la quale esclude la possibilità dell’esistenza di qualsiasi tipo di
estetico dei singoli elementi di un’opera, effetto che non può essere percepito se non si intende la sottrazione come una forma di composizione − si può riscontrare un livello, se pur minimo, di composizione, persino in opere estreme come le tele monocromatiche di Klein, laddove la creatività dell’artista si manifesta nella scelta del colore e delle dimensioni della tela. 274 M. Beardsley, “What is An Aesthetic Quality?”, cit., pp. 103-6. A tal proposito alcuni obiettano che, sullo sfondo di contesti appropriati, qualsiasi proprietà (anche non-estetica, come “l’essere scuro”) può essere citata come ragione per giustificare un giudizio normativo. Secondo Bearsdley una siffatta proprietà può rientrare in un giudizio di merito estetico solo se messa in relazione con una proprietà estetica (ad es. l’ “essere dinamico”), di modo che il giudizio assuma una forma del tipo: “(l’oggetto) è così scuro che il contrasto dinamico … viene meno” (in tal caso si tratterebbe verosimilmente di un giudizio di demerito). 275 Così si evince anche da J. Levinson, “What Are Aesthetic Properties?” (2005), ora in Id., Contemplating Art, cit., pp. 342-3.
149
condizioni, siano esse negative o positive. In secondo luogo, attributi estetici come ‘allegro’,
‘commovente’ o ‘tragico’ fanno chiaramente riferimento a una risposta affettiva da parte di un
soggetto: classificarli semplicemente come modi di apparire risulta essere un’operazione
restrittiva, in questi come in altri casi. Infine, se è vero che tutte le proprietà estetiche sono
value-loaded, ovvero sono ragioni che giustificano il merito o il demerito estetico di un
oggetto, alcune costituiscono dei meriti o dei difetti in se stesse (si pensi a termini come
‘bello’, ‘mediocre’, ‘eccellente’, ‘meritevole’, ‘scadente’, ecc.), senza bisogno di essere poste
in relazione con altre proprietà rispetto alle quali sembrano appartenere a un livello superiore.
Queste tre osservazioni corrispondono a intuizioni condivise e difficilmente confutabili; la
definizione delle proprietà estetiche enunciata sopra sembra davvero essere una coperta
troppo corta per poter ricoprire l’intero spettro delle proprietà estetiche realmente esistenti.
Piuttosto allora che tirare ingenuamente la coperta da una parte o dall’altra, sarà più
opportuno fare delle distinzioni all’interno dell’ampia e variegata famiglia delle proprietà
estetiche, per poter pervenire a una versione più completa ed esaustiva del concetto stesso di
proprietà estetiche.
Riguardo alla prima questione, Levinson riconosce che taluni attributi estetici non sono
pensabili senza l’esistenza di determinati attributi non-estetici: i primi sembrano non solo
emergere su, ma addirittura essere costituiti da, i secondi. In effetti, non si può dire che un
dipinto sia sfarzoso senza che abbia colori accesi e luminosi; pure, l’unità di una
composizione musicale non può fare a meno dell’uso costante di ripetizioni e parallelismi
strutturali. Levinson propone allora due possibili correzioni alla nozione di emergentismo,
ipotizzando che: 1) gli attributi estetici formano un continuum che va dagli attributi
interamente condizionati dalle proprietà strutturali sottostanti a quelli totalmente emergenti,
passando per gli attributi in parte emergenti su, e in parte condizionati (e concettualmente
dipendenti) da, gli attributi strutturali non-estetici; oppure 2) tutti gli attributi estetici sono in
parte emergenti su, e in parte determinati da, gli attributi non-estetici sottostanti 276. Entrambe
le correzioni sono da tenere in considerazione, sebbene la prima sia più capace di fornire un
modello esplicativo che trova conferma non appena si passi a considerare il secondo punto in
questione. Anche qui Levinson è disposto a fare delle concessioni alla sua teoria, e ammette
che alcune proprietà estetiche sono fortemente response-dependent, ovvero sono proprietà
che, per essere rilevate, implicano una risposta affettiva da parte del soggetto che viene posto
di fronte a determinate proprietà non-estetiche di un oggetto. Le proprietà estetiche
276 J. Levinson, “Aesthetic Supervenience”, pp. 154-5.
150
maggiormente response-dependent dipendono non tanto da come vengono percepite, ma da
come il percepirle ci fa sentire. La soluzione sta quindi di nuovo nel concepire la famiglia
delle proprietà estetiche come uno spettro ampio e continuo, che va dalle proprietà che sono
correttamente definibili come modi di apparire fenomenici e che non implicano una
consistente risposta affettiva da parte di un soggetto − tali sono soprattutto le proprietà formali
(unito, equilibrato, dinamico, ecc.), ma anche quelle stilistiche (cubista, impressionista,
classico, ecc.) −, passa per le proprietà che implicano una risposta emotiva più o meno elevata
e comunque variabile − ovvero le proprietà espressive (divertente, tragico, commovente,
malinconico, ecc.) − e arriva alle proprietà definibili (quasi) interamente come response-
dependent − Levinson cita come esempi il sublime e la bellezza umana 277. Che relazione c’è
tra i due continua? E’ coerente con l’analisi fin qui svolta affermare che essi sono
perfettamente sovrapponibili: pertanto possiamo rappresentare le proprietà estetiche come
disposte lungo un unico spettro continuo che va dalle proprietà fenomeniche e in piccola parte
(o per nulla) emergenti (sulle proprietà non-estetiche sottostanti) alle proprietà response-
dependent maggiormente (o totalmente) emergenti.
Per affrontare il terzo e ultimo dei problemi poco fa abbozzati, è necessario tornare
nuovamente a Sibley, il quale divide i termini che vengono utilizzati in un giudizio estetico in
tre classi distinte 278. La prima è costituita dai termini intrinsecamente valutativi (come ‘bello,
brutto, eccellente, mediocre’, ecc.), i quali sono usati per indicare che un oggetto ha un certo
valore, senza che si specifichino le proprietà in virtù delle quali tale valore è conseguito. La
seconda è costituita dai termini descrittivi, i quali indicano delle proprietà di per sé neutrali
(dal punto di vista valutativo) dell’oggetto: tali sono ad esempio gli attributi formali
(‘bilanciato, dinamico, equilibrato’, ecc.). Infine vi è la classe dei termini “a valutazione
aggiunta” (evaluation-added terms), i quali insieme indicano sia delle proprietà dell’oggetto
sia il fatto che il soggetto che li utilizza li considera dei valori o dei disvalori per l’oggetto
stesso. Questa terza classe comprende la maggior parte dei termini usati in un giudizio
estetico (soprattutto i termini espressivi, come allegro, angosciante, agitato, ecc.). Ora, Sibley
277 J. Levinson, “What Are Aesthetic Properties?”, pp. 147-50. Riguardo alle proprietà espressive, vi è un ampio dibattito tra i filosofi analitici (soprattutto tra quelli interessati allo studio del linguaggio musicale) sul loro essere o meno response-dependent. La soluzione sta forse anche qui nell’operare delle distinzioni. Goran Hermeren separa ad esempio, all’interno dell’insieme delle proprietà espressive, le emotion-properties (gioioso, malinconico, sentimentale, ecc.) dalle affective-properties (commovente, divertente, scioccante, ecc.), aggiungendo che solo le seconde sono realmente response-dependent, a differenza delle prime le quali invece per essere rilevate non richiedono un particolare coinvolgimento affettivo da parte di uno spettatore. (Goran Hermeren, The Nature of Aesthetic Qualities, Lund University Press, Lund 1988, p. 106). Per comodità parleremo qui delle proprietà espressive come proprietà in vario modo response-dependent, passando sopra la distinzione di Hermeren. 278 F. Sibley, “Particularity, Art and Evaluation”, cit., pp. 88-94.
151
ritiene (e così pure Levinson) che per i termini appartenenti a questa terza classe sia possibile
separare la componente descrittiva o sostanziale − ovvero quella ancorata alle proprietà
strutturali di un oggetto e fenomenicamente emergente su di esse − dalla sua componente
valutativa o preferenziale − ovvero l’attribuzione di valore o disvalore a tali termini. Ciò
significa che un termine come ‘sfarzoso’ può essere approssimato con termini descrittivi
come ‘luminoso’ o ‘non-armonico’ − i quali registrano delle impressioni fenomeniche sulle
quali vi è un accordo generale (tra persone percettivamente sane) − e allo stesso tempo può
essere citato da alcuni come un pregio e da altri come un difetto per il medesimo oggetto − a
seconda del diverso modo in cui la componente descrittiva viene valutata in relazione
all’oggetto nel suo complesso 279.
Stando alla divisione, operata da Sibley e ripresa da Levinson, tra i termini utilizzati in un
giudizio di merito estetico, ne consegue che anche da un punto di vista valutativo le proprietà
estetiche possono essere concepite come disposte lungo un continuum, che va dai termini in
cui la componente descrittiva è più forte a quei termini in cui è la componente preferenziale a
prevalere. Possiamo allora sovrapporre questo continuum agli altri due e ottenere così un
unico spettro delle proprietà estetiche? Sì e no. Sì, in quanto le proprietà con maggiore
componente descrittiva corrispondono alle proprietà più oggettive e ancorate alle proprietà
strutturali di un oggetto, mentre le proprietà con una maggiore componente valutativa sono
anche quelle più emergenti e response-dependent. No, poiché l’eventuale sovrapposizione
lascerebbe fuori le proprietà che occupano l’estremità di destra del continuum descrittivo-
preferenziale, ovvero i termini intrinsecamente valutativi. Tali termini indicano infatti il
valore (o disvalore) globale di un oggetto, e appartengono quindi a un livello superiore alle
altre proprietà estetiche, le quali possono rappresentare solo valori (o disvalori) parziali
dell’oggetto stesso. Allo stesso tempo, i termini intrinsecamente valutativi dipendono dalle
proprietà estetiche di ordine inferiore, in quanto il valore che viene attraverso essi assegnato a
un oggetto nel suo complesso dipende dal modo in cui i valori parziali si combinano insieme e
dall’effetto che tale combinazione produce. Ciò che abbiamo fin qui ricavato da un astratto
confronto di modelli rappresentativi, è peraltro confermato dall’analisi di alcuni importanti
filosofi analitici. Tra questi, Nick Zangwill è quello che più esplicitamente riconosce alla
bellezza e alla bruttezza un ruolo preminente rispetto alle altre proprietà estetiche. Egli infatti
afferma che, come le proprietà non-estetiche hanno un peso in un giudizio di merito estetico
(su un dato oggetto) solo se sono ancorate alle proprietà estetiche su di esse sopravvenienti (le
279 L’esempio è tratto da J. Levinson, “Aesthetic Properties, Evaluative Force and Differences of Sensibility” (2001), ora in Id., Contemplating Art, cit., pp. 517-8.
152
quali, come detto, sono tutte a vario livello value-loaded), così queste ultime hanno senso in
un siffatto giudizio solo in relazione al modo in cui contribuiscono o meno alla bellezza o alla
bruttezza dell’oggetto in questione 280.
Se così stanno le cose, bisogna allora ammettere l’esistenza di un ulteriore livello di
sopravvenienza, questa volta interno alle proprietà estetiche. Levinson parla a tal riguardo
apertamente (sebbene a margine di altre considerazioni) di “aesthetic-value supervenience”
per definire la relazione che intercorre tra le proprietà estetiche intrinsecamente valutative e le
proprietà estetiche sottostanti 281: tra le prime e le seconde vige il medesimo rapporto di
dipendenza, co-varianza e non-riducibilità che abbiamo visto sussistere tra le proprietà
estetiche e quelle non-estetiche. Di conseguenza, le questioni che erano state sollevate a
proposito dell’aesthetic supervenience si ripropongono in maniera analoga e nello steso
ordine per l’aesthetic-value supervenience. Innanzitutto, le proprietà intrinsecamente
valutative (bello, brutto, mediocre, eccellente, ecc.) sono totalmente emergenti sulle altre
proprietà estetiche o sono in parte emergenti e in parte condizionate da queste ultime? Quali
sono i principi che legano le une alle altre? In secondo luogo, sono la bellezza e la bruttezza
proprietà response-dependent? Se sì, in che grado? Di che tipo è la reazione affettiva ad essa
associata (è tale reazione dello stesso tipo di quella che le altre proprietà estetiche provocano,
o si tratta di un tipo di reazione diversa)? Infine, quali sono le caratteristiche del valore
estetico che tali proprietà rappresentano? Può il valore estetico esaurire il valore artistico di un
oggetto? Proveremo nel prossimo paragrafo a rispondere a queste domande, attraverso un
approfondimento dei concetti chiave di esperienza, piacere e valore estetico.
280 Nick Zangwill, “The Beautiful, The Dainty and the Dumpy”, British Journal of Aesthetics 35 (1995), pp. 317-29. Qui Zangwill si oppone ad autori come Wittgenstein, Austin o Goodman, le cui osservazioni tendono a ridimensionare l’importanza della bellezza. (Wittgenstein ad esempio sosteneva: “E’ notevole che nella vita reale, quando si danno giudizi estetici, aggettivi estetici come ‘splendido’, ‘bello’, ecc., abbiano scarsissima importanza”(L. Wittgenstein, Lezioni e conversazioni sull’etica, l’estetica, la psicologia e la credenza religiosa, a cura di M. Ranchetti, Adelphi, Milano 1967, p. 55). Dello stesso tenore è il celebre e spesso citato motto di Austin: “se solo potessimo dimenticare per un momento il bello e scendere invece al delicato e al malinconico”. Sulla stessa scia si pone anche Goodman: “Non tanto i giudizi relativi alle caratteristiche particolari sono semplici strumenti per pervenire all’apprezzamento finale, quanto piuttosto i giudizi relativi al valore estetico sono spesso strumenti per scoprire tali caratteristiche. Se un esperto mi dice che, di due idoli delle Cicladi che mi sembrano del tutto indistinguibili, l’uno è più bello dell’altro, ciò mi induce a cercare, e può aiutarmi a trovare, le differenze significative fra di essi. Le valutazioni di eccellenza sono tra i sussidi secondari della fruizione” (N. Goodman, I Linguaggi dell’Arte, cit., p. 225). Zangwill intende invece ribaltare tali osservazioni, contrapponendovi una visione piramidale delle proprietà estetiche (alla quale abbiamo accennato in una precedente nota), al cui vertice sono collocate le proprietà intrinsecamente valutative (‘bellezza’, ‘bruttezza’, ‘eccellenza’, ‘mediocrità’, e simili). A tal proposito e sempre dello stesso autore, si vedano anche N. Zangwill, The Metaphysics of Beauty, Cornell University Press, Ithaca 2001, e “Beauty” Oxford Companion to Aesthetics, Jerrold Levinson (ed.), Oxford University Press, 2003. 281 J. Levinson, “Aesthetic Supervenience”,cit., pp. 157-8. Il concetto di aesthetic-value supervenience è introdotto da Levinson in una nota aggiuntiva al saggio citato.
153
5.2 Esperienza, piacere, valore
A) I PRINCIPI DELL’ESPERIENZA ESTETICA
I principi che regolano la sopravvenienza delle proprietà strutturali secondarie (come i
colori) sulle proprietà fisiche di base sono, come visto, di tipo fenomenico-percettivo, mentre
i principi che regolano la sopravvenienza delle proprietà estetiche su quelle strutturali (ovvero
non-estetiche) sono fenomenico-estetici (in quanto chiamano in causa una reazione
soggettiva, più o meno rilevante, ad un’impressione fenomenica). Di che tipo sono i principi
che regolano la sopravvenienza delle proprietà estetiche intrinsecamente valutative sulle
proprietà estetiche sottostanti? Dato che si tratta della relazione che intercorre tra le proprietà
estetiche di un oggetto e l’attribuzione di valore estetico allo stesso, i principi che stiamo
cercando non possono che essere i criteri su cui si fonda il giudizio critico-estetico 282.
Secondo Monroe Bearsdley occorre a tal proposito distinguere tra criteri primari e criteri
secondari di giudizio 283. I criteri positivi primari del valore estetico sono costituiti da quelle
proprietà tali che l’aggiunta o l’incremento di una di esse, senza che si abbia la perdita o la
diminuzione di un’altra proprietà primaria, farà sempre sì che l’oggetto che le possiede sia
migliore (da un punto di vista estetico; il che significa che vi sarà un incremento del valore
estetico dell’oggetto in questione). Viceversa, un criterio positivo secondario del valore
estetico è una proprietà la cui aggiunta o il cui incremento all’interno di un dato insieme di
proprietà (sempre secondarie) produrrà sempre un incremento in uno o più dei criteri primari.
Entrambi i criteri sono regole generali dell’attività critico-estetica, ma solo i primi possono
fungere da condizioni necessarie e sufficienti all’attribuzione di valore a un oggetto, laddove i
secondi sono subordinati ai primi.
I criteri secondari sono quindi costituiti dalle proprietà estetiche descrittive e da quelle a
valutazione aggiunta, ovvero dall’intero ambito delle proprietà estetiche, eccezion fatta per
quelle intrinsecamente valutative. In cosa consistono i criteri positivi primari del valore
estetico? Beardsley li identifica con le proprietà dell’unità, della complessità e dell’intensità
282 Per capire cosa si intenda con tale espressione, occorre tener presente che, secondo Bearsdley, assumere un punto di vista estetico nei confronti di un oggetto equivale a prendere interesse nei confronti del suo valore estetico (M. Beardsley, “The Aesthetic Point of View” (1970), ora in Id., The Aesthetic Point of View. Selected Essays, cit., pp. 15-23). Quando poi tale interesse assume la forma del giudizio razionale (che cerca le ragioni su cui fondare l’attribuzione di valore estetico a un oggetto), allora esso va sotto il nome di critica estetica − la quale a sua volta, quando viene indirizzata verso le opere d’arte, diventa a tutti gli effetti la critica d’arte (M. Bearsdley, “What Are Critics For?” (1978), ora in Id., The Aesthetic Point of View. Selected Essays, cit., pp. 147-150). 283 Bearsdley spiega la differenza tra i due criteri in “The Generality of Critical Reasons” (1962), ora in The Aesthetic Point of View. Selected Essays, cit., pp. 208-218.
154
284. Per supportare tale identificazione, egli conferma l’argomento usato da Paul Ziff a favore
del criterio dell’unità − basato sul ragionamento secondo cui, poiché un dipinto (o un
qualsivoglia oggetto che venga giudicato da un punto di vista estetico) non potrà mai essere
considerato bello in quanto disorganizzato, allora l’organizzazione (ovvero l’unità) sarà
sempre un pregio dell’oggetto che la possiede − e lo estende agli altri due criteri da lui
indicati 285. Sulla scia di Ziff, Beardsley afferma che non basta descrivere una sequenza
musicale come vigorosa e drammatica per trarre delle conclusioni circa la sua bellezza (o
bruttezza); a tal fine occorre mostrare che le suddette qualità estetiche contribuiscono (o
meno) ad aumentare il grado di unità e di complessità del brano in questione e ad accrescere
l’intensità delle sue singole qualità regionali (comprese le proprietà citate). Nel corso degli
anni la proposta di Beardsley è stata oggetto di alcune critiche, sia per la limitatezza dei criteri
da lui indicati come primari, sia per il fatto che l’eventuale interazione tra i criteri della triade
beardsleisiana potrebbe non essere necessariamente positiva dal punto di vista del valore
estetico. Il tentativo di trovare dei principi critici intermedi che connettano il valore estetico di
un oggetto con i giudizi particolari sulle proprietà (estetiche e non) dello stesso, non è però
rimasta un’impresa isolata in ambito analitico. Tra gli autori che hanno intrapreso una ricerca
analoga a quella di Bearsdley c’è Jerrold Levinson, il quale, pur concentrandosi sul solo
ambito musicale, perviene a risultati che a mio avviso illuminano quelli del suo illustre
predecessore.
Levinson individua un primo insieme di principi, che legano le osservazioni musicali di
base (concernenti le qualità ritmiche, melodiche, contrappuntistiche, ecc.) al valore di un
brano musicale. Tali principi sono costituiti da: 1) “come la musica procede”, ovvero la
struttura formale della musica, il suo procedere da un motivo a un altro motivo, l’alternarsi di
aspettative e di soddisfazioni (o delusioni) musicali nell’ascoltatore; 2) “ciò che la musica
comunica” riguardo alla nostra vita (in termini di emozioni, pensieri, azioni, etc.); 3) “ciò che
la musica comunica in relazione al modo in cui procede”, ovvero al modo in cui un certo
contenuto è incorporato nella forma e prodotto attraverso questa. Tali principi, che insieme
formano quello che Levinson chiama Modello 1, sono da lui sinteticamente nominati
rispettivamente forma cinetica (o configurazionale), contenuto espressivo e forma 284 La prima formulazione della suddetta triade di criteri risale a M. Beardsley, Aesthetics: Problems in the Philosophy of Criticism, Harcourt Brace, New York 1958. Successivamente egli tornerà più volte sull’argomento (si veda ad esempio M. Beardsley, “The Relevance of Reasons in Art Criticism” (1982), ora in The Aesthetic Point of View. Selected Essays, cit., pp. 332-351). 285 Ziff sostiene che “alcuni buoni dipinti sono in qualche modo disorganizzati; essi sono buoni nonostante il loro essere disorganizzati. Ma nessun dipinto è buono in virtù del suo essere disorganizzato, e molti sono non buoni principalmente perché sono disorganizzati” (Paul Ziff, “Reasons in Art Criticism” (1958), ora in E. Kennick, Art and Philosophy, cit., p. 669).
155
significante. Ovviamente tali principi sono distinguibili solo a posteriori, mentre nell’ascolto
di un brano musicale essi sono fusi insieme nella medesima esperienza 286. Levinson osserva a
questo punto che lo stesso contenuto espressivo può essere dotato di una propria forma,
costituita dalla struttura secondo cui i diversi pensieri o stati d’animo comunicati dalle diverse
sequenze ritmiche o melodiche si susseguono e si intrecciano durante l’ascolto di un brano, e
che comporta un ulteriore livello di complessità del contenuto. Per dar conto di questo
ulteriore e più alto livello di composizione formale e di complessità semantica, dobbiamo
allora formulare una seconda triade di principi, parallela alla prima e articolata nel seguente
modo: 1) “come la musica procede a un livello espressivo” (forma espressiva); 2) “cosa la
musica comunica in relazione a come procede a livello espressivo” (contenuto drammatico);
3) “cosa la musica comunica drammaticamente in relazione a come procede espressivamente”
(forma significante, o contenuto immanente, globale). In realtà nemmeno questi principi, che
insieme costituiscono quello che Levinson chiama il Modello 2, esauriscono l’insieme dei
principi intermedi di cui siamo alla ricerca; a tal fine occorrerebbe considerare anche le
interazioni tra i diversi principi delle due triadi. Tra queste, Levinson sottolinea l’importanza
della relazione tra forma configurazionale e forma espressiva (in quanto il contenuto
drammatico di un brano musicale può essere prodotto tanto dall’una quanto dall’altra) e della
relazione tra contenuto espressivo e contenuto drammatico 287.
Che relazione c’è tra l’analisi di Bearsdley e quella di Levinson? Per rispondere a questa
domanda sarà necessario dare uno sguardo più approfondito a quest’ultima. Ora, non credo
sia una forzatura equiparare i due Modelli di Levinson ai due livelli di sopravvenienza
estetica. Il Modello 1 spiega infatti il modo in cui, dalla percezione della combinazione di
proprietà non-estetiche (formali e non) si possa giungere ad attribuire proprietà estetiche a un
oggetto. Chi esprime un giudizio critico-estetico su un oggetto deve dimostrare che questo
possiede delle proprietà estetiche, prima ancora di stabilirne il valore; per far ciò deve
anzitutto indicare le proprietà non-estetiche, formali e non formali, possedute dall’oggetto. Le
proprietà non-estetiche formali rappresentano la forma configurazionale del Modello 1 di
286 Abbiamo qui di nuovo un fondersi (coalescence) di principi. 287 J. Levinson, “Evaluating Music” (1998), ora in Id., Contemplating Art, cit., pp. 195-204. Per chiarire meglio in cosa consista la forma espressiva in campo musicale, può essere utile pensare alla musica come a un racconto in cui si avvicendano più personaggi, ciascuno col proprio carattere (corrispondente a un particolare motivo melodico o ritmico), i quali interagiscono tra loro in vari modi (corrispondenti ad esempio alla variazione sul tema, al contrappunto, ecc.). Peraltro lo stesso Levinson ha elaborato una teoria, da lui chiamata teoria della “persona musicale” (la quale afferma, in breve, che una musica esprime una data emozione se un ascoltatore qualificato è capace di immaginare, nel corso dell’ascolto del brano musicale in questione, una persona alla quale attribuire tale emozione), che favorisce un siffatto modello di interpretazione del linguaggio musicale (si vedano a tal proposito “Musical Expressiveness” (1996), in Id., The Pleasures of Aesthetics, cit., pp. 90-125, e “Musical Expressiveness and Hearability-as-Expression” (2006), ora in Id., Contemplating Art, cit., pp. 91-108).
156
Levinson e sono costituite dalle relazioni tra le parti percepibili o intelligibili di un oggetto.
Queste parti possono essere le linee e i colori di un dipinto, le note di un brano musicale, i
singoli passi di una danza; esse però possono essere anche rappresentate da unità più
complesse, come una melodia, una sequenza ritmica, una frase musicale, la figura
rappresentata da una dipinto, i personaggi di un racconto, ecc. Queste unità più complesse
sono le proprietà non-estetiche non formali, che insieme costituiscono il contenuto espressivo
di cui parla Levinson nel citato Modello 1. Nella musica abbiamo a che fare soprattutto (oltre
che ovviamente con le proprietà non-estetiche formali) con proprietà non-estetiche espressive,
ovvero con delle sequenze musicali che in virtù della loro struttura dispongono l’ascoltatore a
provare una certa emozione. Nella pittura prevalgono invece le proprietà non-estetiche
rappresentative (ovvero quelle combinazioni di segni e colori che in virtù della loro
costituzione spingono l’osservatore a rilevare una qualche somiglianza tra esse e il mondo
esterno), laddove la letteratura è caratterizzata anche da proprietà non-estetiche simboliche
(ovvero da determinati insiemi di parole che stimolano il lettore ad ampliare il loro significato
letterale) 288. Affinché però si possa dire che l’oggetto possiede delle proprietà estetiche, la
forma configurazionale e il contenuto espressivo devono essere indissolubilmente unite l’una
con l’altro: ciò che il critico (secondo il Modello 1 di Levinson) deve spiegare,
conformemente alla teoria della sopravvenienza estetica, è che da tale unione deriva il
carattere estetico dell’oggetto. Tale carattere è costituito dalla forma significante o contenuto
immanente, i quali sono inscindibili l’uno dall’altro e sono sopravvenienti sulla forma
configurazionale e sul contenuto espressivo.
Col Modello 1 siamo ancora al primo livello della sopravvenienza estetica; è compito del
Modello 2 farci comprendere i principi che regolano l’aesthetic-value supervenience. Prima
però dobbiamo chiederci se i due Modelli siano collegati tra loro. Se è vero, come ritengo, che
essi corrono paralleli ai due livelli di sopravvenienza estetica, la risposta non può che essere
288 Si deve ad Alan Goldman il merito di aver chiarito come tra le proprietà non-estetiche (che egli chiama “base-properties”, ovvero proprietà di base) vi siano anche proprietà non-formali (veda Alan Goldman, Aesthetic Value, Westview Press, Boulder (Colorado) 1995, pp. 45–92). Ciò può sembrare in contraddizione con quanto sostenuto nella formulazione classica della dottrina della sopravvenienza, dove le proprietà non-estetiche vengono identificate principalmente con proprietà strutturali, ovvero formali. In realtà la contraddizione è solo apparente, dal momento che le proprietà non-estetiche non-formali sono del tutto identificabili con la loro struttura formale (il che fa dire a Goldman che tra le proprietà di base, quelle formali sono le più basilari di tutte); semplicemente, esse costituiscono un primo livello di unità formale, la quale può spingere uno spettatore a provare una certa emozione, a riconoscere una certa somiglianza con alcune porzioni di realtà o a intuire un certo significato più o meno profondo, e ad attribuire quindi determinate proprietà estetiche espressive, rappresentative o simboliche a un brano musicale, a un dipinto o a un romanzo. L’attribuzione di tali proprietà estetiche dipende tanto dalla struttura delle proprietà non-estetiche espressive, rappresentative e simboliche e dal modo in cui esse si relazionano alle altri parti di un’opera, quanto dall’effetto che l’insieme di queste proprietà e relazioni (ovvero l’unione organica delle proprietà non-estetiche, formali e non) suscita nel soggetto percepiente e giudicante.
157
affermativa. Può però non essere facile capire da subito che cosa li unisca. A mio avviso
occorre dimostrare che il punto di arrivo del Modello 1 è anche la base di partenza del
Modello 2. Ma cosa altro sono la forma espressiva e il contenuto drammatico, se non la forma
significante e il contenuto immanente scissi dalla loro fusione reciproca e considerati
separatamente, in virtù di un’astrazione senza la quale non vi potrebbe essere giudizio critico
alcuno? Le proprietà estetiche formali e non formali (ovvero rappresentative, espressive,
simboliche, ecc.), che sono fuse insieme nell’esperienza e che insieme costituiscono il
carattere estetico di un oggetto (ovvero la sua forma significante/contenuto immanente)
sancito dal Modello 1, rappresentano quelli che per Bearsdley sono i criteri secondari del
giudizio critico-estetico; laddove i criteri primari (unità, complessità e intensità)
corrispondono alla forma significante (o contenuto immanente) globale. Il Modello 2 di
Levinson mostra come la forma significante globale costituisca un livello di unità superiore a
quella rappresentata dal Modello 1, in quanto si tratta dell’unione di forma e contenuto
considerate già come proprietà estetiche, le quali a loro volta derivano dall’unione (estetica)
delle proprietà non-estetiche. Tale unità comporta anche un livello superiore di complessità
(della sintesi tra proprietà) e di intensità (delle singole qualità estetiche), e (insieme a questi)
determina l’attribuzione di valore estetico a un oggetto. Se la lettura appena fornita è corretta,
allora i modelli di Levinson, piuttosto che contraddire i principi di Bearsdley, ne
rappresentano un’integrazione, in quanto riescono a spiegare il modo in cui i principi della
triade beardsleiana operano durante lo svolgimento dell’esperienza estetica di un oggetto.
L’analisi compiuta nel tempo da Beardsley riguardo al concetto di esperienza estetica
conferma quanto appena detto. In un primo momento, infatti, Bearsdley aveva concepito
l’esperienza estetica come caratterizzata dagli stessi principi che, laddove siano rilevati in un
oggetto, giustificano l’attribuzione ad esso del valore estetico: pertanto, l’esperienza di un
oggetto dotato di unità, complessità e intensità sarà anch’essa unitaria, complessa e intensa.
Tale parallelismo tra soggetto e oggetto appare però un po’ forzato, e non ha mancato di
attirare numerose critiche 289, in seguito alle quali Bearsdley ha sviluppato un concetto di
esperienza estetica maggiormente autonomo rispetto alle proprietà di un oggetto. Secondo
questo nuovo e più soddisfacente concetto, possiamo definire l’esperienza di un oggetto come
estetica quando possiede la prima delle seguenti cinque caratteristiche e almeno tre delle
restanti quattro: 1) la focalizzazione sull’oggetto, ovvero l’essere guidati, attraverso la
successione coerente dei nostri stati mentali, dalle proprietà fenomeniche (qualità e relazioni)
289 Tra i più critici c’è sicuramente George Dickie, le cui osservazioni sono riassunte in Id., Evaluating Art, Temple University Press, Philadelphia 1988, pp. 53-80.
158
di un campo percettivo (la combinazione di linee e colori in un quadro, la composizione di un
brano musicale, ecc.) o intenzionale (il significato simbolico di un dipinto figurativo,
l’intreccio narrativo di un romanzo, ecc.) sul quale la nostra attenzione è concentrata; 2) il
senso di libertà dai problemi della vita quotidiana; 3) il distacco emotivo dall’oggetto verso il
quale la nostra attenzione è diretta; 4) la scoperta attiva delle connessioni tra gli elementi
percettivi e intenzionali di un oggetto; 5) il senso di interezza, ovvero di coerenza degli stati
mentali (percezioni, sentimenti, idee) che si succedono nel corso dell’esperienza, e il senso di
integrità, ovvero di coerenza tra i vari elementi (di nuovo percettivi, affettivi e intellettivi) che
compongono il nostro io 290. Ora, alla luce di questa nuova formulazione fornita da Bearsdley,
è possibile interpretare la prima delle caratteristiche dell’esperienza estetica come l’esperienza
della forma significante di un oggetto (Modello 1 di Levinson), e interpretare l’esperienza
estetica nel suo complesso (includente soprattutto la quinta caratteristica) come l’esperienza
della forma significante globale (Modello 2), ovvero dei principi bearsdleiani dell’unità, della
complessità e dell’intensità 291. Il parallelo così ottenuto tra principi dell’esperienza estetica e
criteri del valore estetico ci consente di ripristinare quella continuità tra oggetto-esperienza-
giudizio che connette tra loro i due livelli di sopravvenienza estetica.
A questo punto possiamo tornare al primo dei nostri tre nuclei di questioni relative
all’aesthetic-value supervenience, e affermare che i principi che regolano la sopravvenienza
delle proprietà intrinsecamente valutative sulle altre proprietà estetiche sono i principi
dell’unità, della complessità e dell’intensità, ovvero (conformemente al Modello 2) il
principio dell’unità di forma espressiva e contenuto drammatico (denominato da Levinson
forma significante globale). Ciò comporta che i principi che regolano la sopravvenienza delle
proprietà estetiche su quelle non-estetiche possono essere racchiusi (conformemente al
Modello 1) sotto il principio dell’unione di forma configurazionale e contenuto espressivo:
l’importante è che si sottolinei come in ambo i casi i principi che regolano le due tipologie di
sopravvenienza siano dei principi di unione o integrazione, e che tale integrazione avvenga tra
le proprietà (non-estetiche o estetiche) dell’oggetto e coinvolga anche le facoltà (percettive,
290 M. Bearsdley, “Aesthetic Experience” (1982), in Id., The Aesthetic Point of View. Selected Essays, cit., pp. 285-297. 291 Una siffatta interpretazione è avallata anche dallo stesso Levinson, come si deduce dalla lettura da lui fornita della Sonata per pianoforte D 959 di Schubert. Nell’analizzare tale sonata, Levinson sottolinea come la struttura formale si fonda col contenuto espressivo in un crescendo di intensità e complessità che ha il suo culmine nella forma significante globale, la quale produce nell’ascoltatore che esperisce la Sonata quel senso di integrazione dell’io che è anche il culmine dell’esperienza estetica, per come descritta da Beardsley. Levinson aggiunge anche che, nel caso in questione, la Sonata raggiunge un livello di eccellenza, da lui chiamato “unità trascendente”, superiore alla stessa forma significante (o contenuto immanente) globale e tale da trasfigurare l’io della persona che ascolta la Sonata. Ciò comporterebbe allora l’esistenza di un valore superiore allo stesso valore estetico, della cui possibilità discuteremo più avanti (J. Levinson, “Evaluating Music”, cit., pp. 204-207).
159
affettive, intellettive e, nel caso della sopravvenienza del valore estetico, anche critiche) del
soggetto. Rimane da stabilire se le proprietà intrinsecamente valutative siano totalmente
emergenti o se invece siano anch’esse in parte costituite da una base strutturale sottostante.
Da quanto detto finora, credo si possa sostenere che tale base esista e che sia costituita dalle
proprietà estetiche formali, e ciò in quanto gli stessi principi primari dell’unità, della
complessità e dell’intensità da cui il valore estetico dipende sono dei principi formali, sebbene
operanti a un livello più alto. Le proprietà estetiche formali rivestono quindi nella aesthetic-
value supervenience lo stesso ruolo delle proprietà formali non-estetiche per la aesthetic
supervenience. Come esiste una componente descrittiva più o meno preminente per le
proprietà estetiche (descrittive o a valutazione aggiunta), così esiste una componente
descrittiva per le proprietà intrinsecamente valutative: si tratta in entrambi i casi di proprietà
formali, più o meno complesse, e di ciò dovrà tener conto la definizione estetica dell’arte di
cui siamo alla ricerca.
B) LA DUPLICE NATURA DEL PIACERE ESTETICO
La componente descrittiva appena indicata non esaurisce certo la bellezza (e gli altri
termini intrinsecamente valutativi). L’esperienza estetica di un oggetto è infatti esperienza del
suo contenuto, oltre che della sua forma; dato che il contenuto è costituito da proprietà
estetiche (soprattutto espressive) che implicano una risposta emotiva (di grado variabile) nel
soggetto (e sono perciò definibili come response-dependent), il giudizio di valore estetico
(che di tale esperienza rappresenta il correlato oggettivo) non può che essere anch’esso
response-dependent. Di che tipo è allora tale risposta emotiva? Dato che l’aesthetic-value
supervenience è, come detto, una sopravvenienza di secondo livello, la risposta emotiva
associata alla percezione della bellezza e di altre proprietà intrinsecamente valutative non può
ridursi alle risposte emotive corrispondenti alle proprietà estetiche sottostanti. Dal punto di
vista di un giudizio normativo (ovvero del giudizio sulla bellezza di un oggetto), tali risposte
rappresentano delle reazioni di primo livello, le quali possono variare per grado e tipo
(possiamo avere reazioni allegre, tristi, divertite, angosciate, ecc., a determinate proprietà).
Ciò che accompagna la percezione della bellezza di un oggetto è piuttosto il sentimento
dell’unità tra tali reazioni di primo livello che il contenuto dell’oggetto provoca e le proprietà
formali dell’oggetto stesso. Tale sentimento è ciò che viene comunemente chiamato piacere
estetico.
Sul fatto che il piacere estetico abbia una struttura duplice concorda la maggior parte dei
filosofi analitici che si sono occupati dell’argomento. Richard Lind descrive ad esempio il
160
piacere estetico come la soddisfazione del meta-interesse edonistico che si ha nel godere del
soddisfacimento di un sotto-interesse percettivo, a sua volta coincidente con l’interesse che si
ha nel discriminare e nel comprendere le relazioni tra gli elementi (sensoriali o semantici) che
sono dati immediatamente nell’esperienza estetica di un oggetto 292. Kendall Walton afferma
che “provare piacere estetico equivale ad elogiare qualcosa con piacere”. Quando ascoltiamo
un quartetto di Beethoven o leggiamo Guerra e Pace di Tolstoj, noi non solo ammiriamo ed
elogiamo tali opere, ma proviamo piacere nell’elogiarle: se non sentiamo il bisogno di
esclamare “che bello! Che meraviglia!” al termine dell’ascolto o della lettura, significa che
non stiamo provando un piacere estetico 293. Sulla stessa scia, J. C. Anderson identifica il
piacere estetico con “il ritenere l’esperienza di determinate proprietà di un oggetto
intrinsecamente apprezzabile” 294. Ciò che tali autori riconoscono − vale a dire la natura
riflessiva del piacere estetico e il suo essere una meta-risposta a delle reazioni di base più o
meno variabili (in quantità e qualità) − trova riscontro anche nella definizione di piacere
estetico data da Levinson, il quale sostiene che “il piacere che proviamo per un oggetto è
estetico quando deriva dalla percezione del, e dalla riflessione sul, carattere e contenuto
individuale dell’oggetto, sia considerati in se stessi, sia considerati in relazione alla base
strutturale sulla quale riposano” 295. Da quest’ultima formulazione soprattutto, appare chiaro
che il piacere estetico non può ridursi alla risposta affettiva alle proprietà a valutazione
aggiunta (espressive, semantiche, ecc.) o al piacere connesso alla percezione delle proprietà
descrittivo-formali, bensì deriva dalla percezione della fusione reciproca di tali proprietà,
ovvero di forma e contenuto. Il contenuto e il carattere di un’opera, continua infatti Levinson,
non sono “liberamente fluttuanti”, ma sono ancorati a una struttura formale che dà loro senso.
Pertanto la soddisfazione estetica non proviene “tanto dall’acquisizione di una certa porzione
di conoscenza scientifica, di un’intuizione morale o di un giudizio politico presi per se stessi,
quanto dalla valutazione della maniera in cui questi aspetti sono incorporati in, e comunicati
da, gli elementi e l’organizzazione specifica dell’opera”. Morte a Venezia di Thomas Mann,
tanto per fare un esempio, ci procura piacere estetico non in quanto contiene importanti
riflessioni sulla vita e sull’arte, ma per il fatto che tali riflessioni sono incorporate nella
particolare forma del romanzo e sono esperite come tali (ovvero come fuse con la forma
292 Richard Lind , “The Aesthetic Essence of Art”, Journal of Aesthetics and Art Criticism 50 (1992), pp. 120-22. 293 Kendall Walton, “How Marvelous! Toward a Theory of Aesthetic Value”, Journal of Aesthetics and Art Criticism 51 (1993), pp. 504-506. 294 J. C. Anderson, “Aesthetic Concepts of Art”, in N. Carroll (a cura di), Theories of Art Today, cit., p. 71. 295 J. Levinson, “What is Aesthetic Pleasure?” (1992), ora in Id., The Pleasures of Aesthetics, cit., p. 6.
161
specifica dell’opera): “i contenuti simbolici e morali sono appresi nel corpo stesso dell’opera
letteraria, attraverso le sue frasi, i suoi paragrafi, gli eventi finzionali” 296.
La concezione riflessiva e duplice della risposta emotiva associata alle proprietà
intrinsecamente valutative mette quindi d’accordo i diversi autori appena citati; inoltre essa è
coerente con la lettura dell’esperienza estetica e del giudizio critico precedentemente fornita.
Se infatti i principi dell’esperienza estetica consistono fondamentalmente nella percezione
dell’unione (che abbiamo visto esplicarsi in due livelli) di forma e contenuto, la quale a sua
volta determina (laddove si passi al secondo livello) il valore estetico di un oggetto (ossia, in
breve, la sua bellezza), allora la reazione soggettiva che si manifesta nel corso dell’esperienza
estetica di un oggetto e che accompagna il giudizio di merito (estetico) sullo stesso, non può
che essere una reazione (almeno in parte) riflessiva (in quanto provocata dalla percezione del
modo in cui un contenuto si realizza in una forma specifica) e duplice (poiché vi sono due
livelli − corrispondenti ai modelli 1 e 2 di Levinson, ovvero ai due livelli di sopravvenienza
estetica − entro cui l’unione di forma e contenuto si realizza). Rimane da spiegare il perché
tale reazione venga descritta dai più come piacevole. Bearsdley sostiene che sono i caratteri
stessi dell’esperienza estetica − la sua capacità di attirare la nostra attenzione su un oggetto
che ci assorbe completamente e ci fa entrare in un mondo immaginario, dove il nostro io si
libera dalle costrizioni materiali e si percepisce come perfettamente realizzato, le nostre
facoltà si potenziano nello scoprire relazioni nascoste, le nostre pulsioni e i nostri desideri
passano da uno stato conflittuale ad uno armonico e appagante − ad essere naturalmente
piacevoli 297. Levinson sostiene (a proposito della musica) che è l’apprezzamento delle nostre
reazioni di primo livello (ovvero delle emozioni che proviamo direttamente dall’ascolto di
una particolare melodia, di un determinato cambio di ritmo, ecc.) quali modi adeguati e
necessari alla comprensione del senso di una composizione musicale, ovvero l’apprezzamento
della loro adeguatezza reciproca, a procurare un meta-piacere definibile come estetico 298.
Sulla scia di quanto detto da entrambi, credo si possa fare un passo più avanti e sostenere con
nettezza che la reazione provocata dall’esperienza estetica di un oggetto nel suo complesso, e
che accompagna il giudizio sul valore dell’oggetto stesso, viene giustamente descritta come
piacere in quanto a provocarla sono delle proprietà formali.
296 Ivi, p. 7. 297 Si vedano il già citato “Aesthetic Experience”, o anche “The Discrimination of Aesthetic Enjoyment” (1963), in M. Beardsley, The Aesthetic Point of View. Selected Essays, cit., pp. 35-45. 298 J. Levinson, “Il piacere nella musica contemporanea”, in Matteucci G. (a cura di), Elementi di Estetica Analitica, Quodlibet, Macerata 2005, pp. 129-141.
162
Per giustificare quest’ultima tesi occorre dimostrare: 1) che le proprietà formali sono
intrinsecamente piacevoli; 2) che l’esperienza estetica (nel suo complesso) è principalmente
esperienza di proprietà formali. Riguardo al primo punto ci sono pochi dubbi. Come afferma
Goldman (e come confermano Beardsley e molti altri), vi è un innato impulso nell’uomo a
porre ordine nella natura e in tutto ciò che lo circonda 299. Parallelamente a tale impulso,
l’essere umano prova naturalmente piacere nell’apprendere, tanto nella natura quanto nei
prodotti del proprio agire, delle forme ordinate e proporzionate, in quanto tale apprensione
armonizza e vivifica (kantianamente parlando) le nostre facoltà percettive, immaginative e
intellettive. Il secondo punto è in apparenza più difficile da dimostrare. Se l’esperienza
estetica è esperienza dell’unione di forma e contenuto, perché il primo dei due termini
dovrebbe prevalere sul secondo? La risposta, in parte anticipata precedentemente, è che
l’unione − intesa come fusione, compenetrazione, adeguatezza reciproca e simili − è essa
stessa un principio formale, il quale può esplicarsi su due livelli. Ad un primo livello,
dall’unione delle proprietà non-estetiche (formali e non) dipendono tutte le proprietà
estetiche: la teoria della sopravvenienza estetica riconosce tale relazione di dipendenza e co-
varianza tra le due famiglie di proprietà, aggiungendo che le seconde non sono riducibili alle
prime. Ma, come abbiamo visto, esiste anche una sopravvenienza di secondo livello, la quale
identifica la relazione (sempre di dipendenza, co-varianza e non riducibilità) tra le proprietà
estetiche intrinsecamente valutative (bellezza, bruttezza e simili) e le altre proprietà estetiche.
Le prime, si è detto, dipendono dal modo in cui le seconde sono unite, ovvero dal modo in cui
il contenuto (ovvero le proprietà espressive, rappresentative, espressive, simboliche, etc.) si
realizza in una certa forma (estetica). Questo secondo livello di unione tra forma e contenuto
rappresenta (secondo le parole dello stesso Levinson) “un tipo di forma più alto” 300: esso è
l’ordine che determina il senso globale di un oggetto, che assegna a ciascuna parte la propria
funzione (sia essa strettamente formale oppure espressiva, rappresentativa, simbolica, ecc.),
che regola il rapporto tra le parti stesse e ci fa percepire tali parti e tali relazioni come
internamente necessarie all’oggetto stesso. Questo superiore ordine formale, nella percezione
(ovvero comprensione) del quale consiste l’esperienza estetica (nella sua completa estensione
e nel suo grado più alto) e in virtù del quale descriviamo un oggetto come ‘bello’, è ciò che
genera quel meta-piacere che va sotto il nome di piacere estetico 301.
299 Goldman esprime questo concetto più volte in Id., Aesthetic Value, cit. 300 J. Levinson, “What is Aesthetic Pleasure?”, cit., p. 10. 301 Ciò spiega secondo Levinson anche il fatto che talvolta (se non spesso) sia gli artisti che gli spettatori ricerchino nelle opere d’arte l’espressione di emozioni negative (ansia, angoscia, tristezza, malinconia, ecc.): tali emozioni sono infatti inserite e amalgamate in una struttura formale che dà loro un senso − un senso che le
163
C) VALORE ESTETICO E VALORE ARTISTICO
La bellezza è un termine intrinsecamente valutativo: esso denota il possesso, da parte di un
oggetto, di un certo grado di valore estetico. Da quanto detto fin qui, segue abbastanza
naturalmente che il valore estetico di un oggetto equivale al valore intrinseco dell’esperienza
estetica che esso produce in virtù dell’interazione tra le sue proprietà estetiche (in relazione a
uno spettatore qualificato) 302. Dato che l’esperienza estetica è sempre accompagnata da un
particolare tipo di piacere che va sotto il nome di piacere estetico, sembra altrettanto naturale
ricondurre a quest’ultimo il valore estetico di un oggetto 303. L’associazione tra valore e
piacere è parsa a molti un’operazione riduttiva, ma le perplessità possono essere
immediatamente fugate non appena ci si ricordi della natura riflessiva e stratificata del piacere
estetico 304. E’ proprio in virtù della natura complessa dell’esperienza estetica e del piacere ad
essa associato che Alan Goldman può legittimamente definire il valore estetico un
“overarching value”: esso è un valore superiore ai valori corrispondenti alle singole qualità
estetiche (formali, espressive, simboliche, ecc.), in quanto risulta dall’interazione (non
semplicemente sommativa) tra tali proprietà in virtù della quale viene prodotta un’esperienza
unica e stimolante 305.
Più precisamente, Goldman sostiene che il valore di ogni proprietà (o insieme di proprietà)
estetica stia soprattutto nel suo contribuire, (quasi) mai isolatamente ma (quasi) sempre in
combinazione con le altre proprietà (o insiemi di proprietà), alla produzione di un’esperienza
avente un grado di coerenza, complessità e intensità (la triade beardsleiana) altrimenti non
raggiungibile nell’esperienza quotidiana: è in questo particolare tipo di esperienza (definibile
come estetica) che risiede il valore estetico di un oggetto. Così, spiega Goldman, il valore
delle proprietà espressive, rappresentative e simboliche sta soprattutto nel fornire basi ulteriori
per l’elaborazione di più elevati livelli di unità formale (che può quindi connettere tra loro
emozioni, caratteri, elementi reali o immaginari, oltre che puramente strutturali), così come il
valore delle proprietà formali sta nel loro permettere alle proprietà espressive, rappresentative
corrispondenti emozioni nella vita reale spesso non hanno (o non sembrano avere per chi le prova sulla propria pelle), e che in quanto tale procura comunque un sentimento di piacere. (Si vedano a tal proposito J. Levinson, “Emotion in Response to Art” (1997), ora in Id., Contemplating Art, cit., pp. 38-55, e “Music and Negative Emotion” (1982), ora in Id., Music, Art, and Metaphysics, cit., pp. 306-335). 302 Ciò è quanto sostenuto, ad esempio, in Malcolm Budd, Values of Art: Pictures, Poetry and Music, Penguin, London 1995, pp. 1-44. 303 Così hanno fatto ad esempio Kendall Walton e Monroe Bearsdley. 304 Le caratteristiche del piacere estetico sono ben chiarite e riassunte in J. Levinson, “Pleasure and the Value of Works of Art” (1992), ora Id., in The Pleasures of Aesthetics, cit., pp. 12-18. 305 Alan Goldman, Aesthetic Value, cit., pp. 6-9. Ciò corrisponde chiaramente a quanto affermato da Bearsdley (con la distinzione tra principi secondari e primari del valore estetico) e da Levinson (con la distinzione tra Modello 1 e Modello 2).
164
e simboliche il loro massimo effetto (che può essere quello di comunicare uno stato d’animo
in tutte le sue sfumature emotive, di mostrare il conflitto tra emozioni contrastanti, di imitare
un paesaggio naturale, di intrecciare i personaggi e i caratteri in un romanzo, ecc.). Bisogna
altresì riconoscere che l’interazione tra le diverse proprietà non può fare a meno, come visto,
delle proprietà formali, senza le quali non vi può essere esperienza estetica alcuna; inoltre vi
sono oggetti, naturali (ad es. un fiore) o artificiali (un dipinto astratto), i quali sono in grado di
produrre un’esperienza estetica di alto livello solamente in virtù del possesso di proprietà
formali (estetiche). Per dar conto di questo fatto, Nick Zangwill reintroduce la distinzione
kantiana tra bellezza libera e bellezza aderente, e sostiene che la seconda dipende dal modo
(che deve essere estetico, ovvero deve rispondere ai criteri dell’unità, della complessità e
dell’intensità) in cui un oggetto realizza la sua funzione (o le sue funzioni, che possono essere
formali, rappresentative, espressive, semantiche, ecc.), laddove la prima è legata al puro
possesso di proprietà formali 306. La bellezza libera indica il valore estetico della maggior
parte delle bellezze naturali e delle opere d’arte astratta, mentre la bellezza aderente si applica
alla maggioranza delle forme d’arte esistenti (dalle arti figurative alla musica, dalla scultura
all’architettura, dalla letteratura al teatro o al cinema) e indica un tipo di valore estetico più
complesso e articolato (overarching, come dice Goldman) 307.
Dal fatto che le opere d’arte sono, tra gli oggetti artificiali, quelli maggiormente in grado di
produrre esperienze estetiche di alto livello in osservatori qualificati e sensibili, molti autori
(tra cui Budd, Bearsdley e Goldman) hanno concluso che il valore artistico di un oggetto
coincida col suo valore estetico. Vi sono però anche autori che si oppongono a tale equazione.
Levinson in particolare, rispondendo a Malcolm Budd, individua tre motivi per cui non è
corretto identificare il valore artistico di un oggetto col valore intrinseco dell’esperienza
estetica che tale oggetto è in grado di procurare 308. Innanzitutto, Levinson osserva come non
sia sempre possibile distinguere ciò che costituisce un’esperienza (o anche parti di essa) dagli
effetti che da questa scaturiscono: in taluni casi non è facile stabilire l’inizio e soprattutto la
306 Nick Zangwill, “Feasible Aesthetic Formalism”, Nous 33 (1999), pp. 610-629. 307 Non tutte le opere d’arte astratte rientrano nella categoria della bellezza pura: vi sono opere astratte che contengono proprietà espressive notevoli (si pensi all’espressionismo astratto degli anni Cinquanta, o all’astrattismo di Kandinsky, il quale ad ogni colore attribuiva una particolare sfumatura emotiva). Per quanto riguarda poi la musica, sebbene i sostenitori della cognitivist-theory siano propensi a considerarla come un’arte puramente formale, personalmente favorisco la posizione dei sostenitori della arousal-theory, i quali attribuiscono alla musica (ai suoi ritmi, alle sue melodie, alle sue dinamiche interne) determinate proprietà espressive, che intrecciandosi con le proprietà formali generano un’esperienza estetica complessa e tale da far rientrare le composizioni musicali nella categoria della bellezza aderente (sul dibattito tra le due teorie, si veda di nuovo A. Goldman, Aesthetic Value, cit., pp. 46-64). 308 J. Levinson, “Evaluating Music”, cit., pp. 184-195. Si veda anche J. Levinson, “Art, Value and Philosophy: A Critical Notice”, Mind 105 (1996), pp. 667-682.
165
fine di esperienze che anche quando sembrano concluse continuano in realtà a produrre nella
nostra coscienza una sorta di eco o riverbero (si pensi alle esperienze traumatiche o anche
all’ascolto di un brano musicale). In secondo luogo, anche se fosse possibile distinguere tra
gli elementi costitutivi di un’esperienza e i suoi effetti, ovvero tra valore intrinseco e valore
strumentale dell’esperienza stessa, non è comunque corretto identificare il valore artistico col
primo dei due tipi di valore appena indicati. Dal nostro contatto con le opere d’arte possono
infatti scaturire dei benefici strumentali di tipo emotivo (ad es. l’acquisizione di una maggiore
sensibilità), cognitivo (il potenziamento delle nostre facoltà percettive e intellettive) e morale
(la scoperta di nuovi punti di vista sul mondo, la trasfigurazione della nostra personalità) 309.
Tali effetti benefici sono tanto consonanti con le intenzioni storicamente attribuite agli artisti
quanto impliciti nella maggior parte dei giudizi sull’arte, e pertanto non possono essere
estromessi dalla considerazione del valore artistico di un’opera. Infine, vi sono valori che, pur
non rientrando tra quelli intrinseci o strumentali dell’esperienza estetica, entrano a buon
diritto a costituire il valore artistico di un’opera. Levinson ne elenca tre: 1) l’ “influence-
value”, ovvero la capacità (realmente attestata) di un’opera di influenzare la creazione di
opere d’arte ad essa successive e a loro volta dotate di valore (questo è uno dei pregi che
capolavori come l’Eroica di Beethoven o il Sacre du Printemps di Stravinsky indubbiamente
possiedono); 2) il “problem-solving value”, ovvero la capacità (realmente attestata) di
un’opera di risolvere problemi di natura formale o espressiva lasciati insoluti dalla tradizione
artistica precedente; 3) l’ “originality-value”, ovvero il carattere di originalità e di novità di
un’opera d’arte rispetto alla tradizione artistica a cui appartiene.
Gli argomenti usati da Levinson, pur essendo ben fondati, si rivelano a una più attenta
analisi insufficienti a farci abbandonare l’equazione tra valore artistico e valore estetico.
Partiamo dal primo punto. Alle osservazioni circa l’indeterminatezza dei limiti di
un’esperienza si può controbattere che, al di là di tale indeterminatezza, un’esperienza (in
particolar modo se estetica) si configura come tale anche in virtù della sua completezza, in
309 Secondo George Dickie anche l’identificazione del valore artistico col valore intrinseco dell’esperienza fa del primo un valore strumentale, in quanto si tratterebbe di un valore determinato non dalle proprietà dell’opera ma dall’effetto (esperienziale) di tali proprietà (G. Dickie, Evaluating Art, cit., pp. 3-14). Se si specifica però (come fa ad esempio Malcolm Budd) che il valore artistico coincide col valore dell’esperienza prodotta dall’opera (su un osservatore attento e qualificato) in virtù delle proprietà estetiche rilevanti possedute da essa, allora si può a mio avviso continuare tranquillamente a parlare di valore intrinseco. D’altronde qualsiasi oggetto ha valore in virtù della sua relazione con gli esseri umani: ciò che è importante verificare è che tale relazione sia sostanziale − ovvero intercorra tra le proprietà essenziali dell’oggetto e le capacità del soggetto che sono chiamate in causa − e non secondaria − essendo quest’ultima la relazione tra le proprietà non essenziali (che, come vedremo fra poco, sono le proprietà dell’opera legate al contesto storico) e il soggetto che le esperisce. Solo il primo tipo di relazione, che ha luogo nell’esperienza estetica dell’opera, può esser fonte del suo valore intrinseco, mentre la seconda può tutt’al più rappresentare un valore strumentale.
166
quanto parte del suo significato può esserci rivelato solo alla fine. Si pensi di nuovo,
suggerisce Beardsley, all’esperienza dell’ascolto di un brano musicale: è solo nei momenti
conclusivi, quando “la gestalt è completa”, che alcune delle aspettative maturate durante
l’ascolto vengono soddisfatte, le tensioni interne al brano trovano una soluzione e il brano
stesso acquista nel suo complesso una maggiore intensità 310. Il secondo argomento elaborato
da Levinson è apparentemente più difficile da controbattere: come negare infatti ad opere
come I Fratelli Karamazov di Dostoyevsky, l’Esecuzione del 3 maggio di Goya o la Missa
Solemnis di Beethoven (per usare alcuni degli esempi da lui stesso riportati) il potere di
sensibilizzarci (talvolta fino a trasfigurare la nostra personalità), di farci riflettere su fatti
sociali o politici, di innalzarci verso verità religiose o metafisiche? Eppure questi aspetti sono
concepibili come elementi interni all’esperienza dell’opera piuttosto che come effetti staccati
da essa. Lo stesso Levinson riconosce che è corretto percepire tali aspetti morali, psicologici,
religiosi o sociali come parti dell’esperienza di un’opera, in quanto inscindibilmente ancorate
alla sua struttura formale − il che fa perdere loro quell’universalità che ne farebbe dei valori a
se stanti. “Ciò che più consideriamo degno di merito del movimento lento della Sinfonia
Eroica di Beethoven”, spiega Levinson, “non è tanto un’introspezione generale sul dolore
quanto piuttosto l’immersione illuminante in una concreta successione di stati angosciosi in
quanto intimamente uniti e sostenuti dallo specifico processo musicale escogitato dal
compositore. Analogamente, l’espansione delle facoltà cognitive che il Quartetto per archi n.
4 di Bartòk produce in noi non è tanto un effetto generale di tal sorta, quanto invece uno
specifico stato di stimolazione inseparabile dai particolari cambi di ritmo della pagina,
estremamente raffinata, di Bartòk” 311.
Levinson aggiunge tuttavia che l’apprezzamento estetico di siffatti importi di carattere
morale, spirituale o cognitivo − ovvero l’apprezzamento del modo in cui essi sono prodotti
attraverso una forma specifica − non esaurisce il valore artistico di un’opera, la quale è capace
di produrre un’elevazione spirituale (o morale) o un’espansione delle facoltà cognitive tout
court, indipendentemente dal modo estetico attraverso cui tali importi sono ottenuti. Che ciò
sia possibile è in realtà tutt’altro che scontato. Goldman osserva ad esempio come spesso
venga erroneamente attribuita alla pittura figurativa la capacità di trasformare il nostro modo
di osservare il mondo, quando in realtà le opere d’arte possono solo modificare il nostro modo
di osservare altre opere d’arte: avere familiarità con le nature morte dipinte da Cezanne
310 M. Beardsley, “Aesthetic Experience Regained” (1969), ora in Id., The Aesthetic Point of View: Selected Essays, cit., pp. 84-86. 311 J. Levinson, “Pleasure and the Value of Works of Art” (1992), cit., pp. 22-3.
167
difficilmente ci porterà a riflettere sulla bellezza di una mela quando siamo sul punto di darle
un morso! 312 Analoghe obiezioni possono essere rivolte, in ambito musicale, ai cognitivisti
come Peter Kivy, i quali sostengono che il valore della musica sta nel fornirci un quadro
approfondito delle nostre emozioni e di migliorare la nostra conoscenza in proposito: a tal
fine, osserva giustamente Goldman, è assai più utile la psicologia che non la musica 313. Non è
quindi affatto certo che l’arte sia in grado di provocare i rimarchevoli effetti di cui parlano
Levinson e altri (l’elevazione morale, l’accrescimento delle nostre conoscenze, l’espansione
delle nostre facoltà, etc.); inoltre, anche se ciò fosse possibile, tali effetti costituirebbero dei
valori secondari (data l’incertezza della loro stessa realtà e la limitatezza del campo di opere a
cui eventualmente si riferiscono) rispetto al valore primario costituito dall’esperienza estetica
intrinsecamente (e non strumentalmente) considerata.
Rimane ancora da vedere che peso hanno, nel giudizio sul merito artistico di un’opera, i
valori esterni all’esperienza (intrinseca o strumentale) dell’opera stessa (da Levinson
etichettati come influence-value, problem-solving value e originality-value). A tal fine può
esserci d’aiuto la distinzione che lo stesso Levinson ha altrove introdotto tra “meaning” e
“significance”, ovvero tra il senso intrinseco di un’opera d’arte (direttamente ricavabile dalle
sue proprietà) e il suo significato estrinseco (rappresentato dalle sue relazioni con fattori
esterni di tipo sociale e culturale) 314. Mentre il meaning è fissato una volta per tutte al
momento della creazione dell’opera, il significance può essere modificato a seconda di come
gli stessi fattori sociali e culturali con la quale l’opera si relaziona si modificano nel corso
della storia. Ciò vuol dire che i valori che rientrano nel significance e non nel meaning, vale a
dire l’originalità di un’opera d’arte e la sua capacità di influenzare altre opere o di risolvere
problemi estetici ereditati dal passato, sono per loro natura dei valori instabili, incerti,
fluttuanti − col passare del tempo un’opera d’arte può non apparire più originale come
all’inizio, opere di scarso valore artistico possono essere prodotte in seguito alla sua influenza
(che in altre circostanze era stata benefica), le soluzioni da essa proposte a problemi formali
ed espressivi preesistenti (e inizialmente valutate come efficaci) possono essere messe in
discussione in un secondo momento − e quindi fondamentalmente inessenziali alla
determinazione del valore artistico dell’opera, il quale rimane ancorato al suo valore estetico 315.
312 Alan Goldman, Aesthetic Value, cit., pp. 73-75. 313 Ivi, pp. 59-60. 314 J. Levinson, “Artworks and the Future” (1987), ora in Id., Music, Art and Metaphysics, cit., pp. 189-193. 315 Appare quindi giustificato il fatto che, nel parlare delle proprietà e delle funzioni caratteristiche delle opere d’arte, abbiamo tralasciato le funzioni relazionali e le proprietà storiche e contestuali (corrispondenti ai criteri
168
Identificare il valore artistico, ovvero il valore di un’opera d’arte in quanto tale, col solo
valore estetico, ovvero col valore intrinseco dell’esperienza estetica che l’opera è in grado di
produrre (in uno spettatore sensibile e qualificato) per mezzo dell’interazione tra le proprietà
estetiche possedute − mettendo quindi da parte ogni considerazione circa i valori estrinseci
all’opera, siano questi correlati all’esperienza dell’opera in quanto suoi effetti o siano invece
indipendenti da tale esperienza −, è tutt’altro che un’operazione riduttiva. Ciò a cui le opere
d’arte tendono, e che costituisce la fonte del loro valore per gli esseri umani, è la produzione
− in virtù di una complessa e coerente integrazione di proprietà estetiche (formali, espressive,
semantiche, ecc.) − di un’esperienza ricca e coinvolgente sotto vari aspetti (sensoriale,
percettivo, affettivo e cognitivo) interrelati tra loro e inscindibili dalla particolare struttura
dell’opera, e la cui intensità (ovvero l’intensità dell’esperienza) è tale da trasportarci in un
altro mondo, dove tempo e spazio sono condensati 316, le preoccupazioni e gli interessi pratici
sono abbandonati e il nostro io si avverte (seppur nel limitato tempo dell’esperienza
dell’opera) integrato e potenziato. Non mi sembra che siano cose da poco.
5.3 Definire l’arte dal punto di vista estetico
A) I DESIDERATA DI UNA DEFINIZIONE ESTETICA DELL’ARTE
Il capitolo quarto si era chiuso con le seguenti domande: 1) a cosa ci riferiamo quando
parliamo di proprietà estetiche? 2) in che modo le proprietà estetiche possono soddisfare la
funzione specifica di un oggetto e permetterne quindi l’identificazione come opera d’arte? 3)
in cosa consiste il valore artistico di un’opera? In seguito alle analisi compiute nei paragrafi
precedenti siamo ora in grado di dare delle risposte a tutti e tre i quesiti; il che ci permetterà
anche di riassumere i risultati finora acquisiti.
Le proprietà estetiche (1) sono modi di apparire di ordine superiore, in quanto
olisticamente emergenti sulle proprietà di ordine inferiore (ovvero sulle proprietà non-
estetiche). Tale relazione è qualificata come sopravvenienza estetica: dire che le proprietà
numero 8 e 9 della lista elaborata nel quarto capitolo). Alla luce della distinzione qui introdotta, possiamo dire che esse (insieme anche al virtuosismo, ovvero al settimo criterio) fanno infatti parte del significance, e non del meaning, di un’opera d’arte. 316 Nel ristretto spazio di un dipinto o nella limitata durata di un racconto, di un film o di una sinfonia, noi sperimentiamo situazioni ed emozioni che nella vita reale occuperebbero un tempo (o uno spazio) assai più lungo (o vasto) e che rispetto a queste ultime (ovvero rispetto alle emozioni o situazioni reali) generalmente presentano un grado di coerenza e di completezza di gran lunga superiore. (A tal proposito vedi: M. Bearsdley, “Aesthetic Experience Regained”, cit., pp. 86-9; M. Bearsdley, “Definitions of Arts” (1961), trad. it. “Le definizioni delle arti”, in P. Kobau, G. Matteucci e S. Velotti (a cura di), Estetica e Filosofia Analitica, Il Mulino, Bologna 2007, pp. 29-53; A. Goldman, Aesthetic Value, pp. 150-170).
169
estetiche sopravvengono (o emergono) sulle proprietà non-estetiche equivale a dire che le
prime dipendono dalle seconde per la loro esistenza e per il loro carattere, ma non sono a
queste ultime riducibili, in quanto il passaggio dalle une alle altre implica la messa in gioco di
principi ulteriori a quelli fisici e percettivi, che vanno sotto il nome di principi fenomenico-
estetici. Ciò significa che l’attribuzione a un oggetto di determinate proprietà estetiche non
può darsi senza che si abbia una reazione soggettiva da parte del soggetto giudicante; tale
reazione è imprevedibile (ovvero non determinabile a priori) e variabile (a seconda del tipo di
proprietà dell’oggetto e delle facoltà − percettive, affettive, intellettive − messe in moto dai
principi fenomenico-estetici). Le proprietà estetiche sono distinguibili in gruppi (proprietà
formali, rappresentative, espressive, ecc.) che si dispongono lungo un continuum che va dalle
proprietà più descrittive (ovvero più ancorate alla base strutturale sulla quale riposano) a
quelle più emergenti (ovvero maggiormente dipendenti dalla risposta soggettiva). La
componente descrittiva che caratterizza le proprietà formali è comunque presente in qualsiasi
proprietà estetica, anche in quelle non-formali (le quali sono dette anche “a valutazione
aggiunta”), il che ci autorizza a dire che le proprietà estetiche alle quali Davies fa riferimento
(come gli esempi da lui stesso riportati confermano) sono proprietà formali. Le proprietà
formali sono, tra le proprietà estetiche, quelle possedute da ogni opera d’arte e riconoscibili (e
apprezzabili) anche da persone ignoranti circa il contesto di creazione dell’opera, in quanto
sono anche le proprietà maggiormente ancorate alle caratteristiche intrinseche (manifeste,
strutturali, non contestuali) dell’opera stessa
Davies ci dice anche, come abbiamo visto, che le proprietà estetiche (ora identificate con
quelle formali) sono le proprietà grazie alle quali un’opera d’arte (secondo Davies solo
primitiva, ma in realtà il ragionamento, si è visto, vale per tutte le opere d’arte) soddisfa la sua
funzione specifica. In che modo ciò avviene? Il soddisfacimento della funzione specifica di
una forma d’arte (2) dipende tanto dalla presenza delle proprietà (non-estetiche) standard di
tale forma (o funzione) quanto dall’interazione di queste con altre proprietà (non-estetiche)
standard di altre funzioni artistiche. Tale interazione è definibile come unione (fusione,
reciproca adeguatezza) di forma e contenuto, ovvero delle proprietà formali (non-estetiche) e
non formali (non-estetiche). L’unione di forma e contenuto è a sua volta una proprietà formale
estetica (insieme all’equilibrio, al bilanciamento, ecc.): essa si può compiere solo attraverso la
messa in gioco dei principi fenomenico-estetici ed è ciò che dona a un oggetto il suo carattere
estetico − in quanto il contenuto stesso (ovvero le proprietà estetiche espressive,
rappresentative, simboliche, ecc.), in seguito a tale unione, sopravviene sulla base non-estetica
(formale e non) sottostante. Le proprietà formali sono quindi essenziali non solo a livello non-
170
estetico − in quanto non c’è contenuto senza una forma − ma anche e soprattutto a livello
estetico − in quanto l’unione di forma e contenuto, la quale dona all’oggetto un particolare
carattere estetico e gli permette di assolvere la funzione specifica della forma d’arte alla quale
appartiene, è una proprietà formale estetica, ovvero non riducibile alla struttura formale di
base. Sono quindi le proprietà formali estetiche (intese come unione formale estetica di forma
e contenuto non-estetici) le proprietà che ogni opera d’arte possiede e in virtù della quale
soddisfa la sua funzione specifica (che può essere puramente formale ma anche espressiva,
rappresentativa, simbolica, ecc.).
Le proprietà estetiche (3) sono tutte value-loaded, ovvero possono essere tutte citate a
supporto di un giudizio critico sul valore estetico di un oggetto. Alcune di esse sono però
intrinsecamente valutative, ovvero costituiscono di per sé un merito o un difetto (dal punto di
vista estetico): tali sono i termini come ‘bello’, ‘brutto’, ‘eccellente’, ‘mediocre’, ecc. Queste
proprietà emergono a loro volta sulle altre proprietà estetiche (ovvero sulle proprietà
descrittive e a valutazione aggiunta): bisogna quindi riconoscere l’esistenza di un secondo
ordine di sopravvenienza, che va sotto il nome di aesthetic-value supervenience. I principi che
regolano questo secondo ordine di sopravvenienza sono gli stessi che stanno alla base dei
giudizi critico-estetici. Possiamo identificare tali principi con le proprietà dell’unità, della
complessità e dell’intensità, specificando che l’unità in questione è, di nuovo, una unità tra
forma e contenuto, considerate però già al livello estetico − ciò che determina la bellezza di
un oggetto non è solo il possedere proprietà estetiche formali, espressive, rappresentative,
ecc., (le quali insieme ne costituiscono il carattere estetico), ma è anche l’esistenza di una
unione (fusione, adeguatezza reciproca) tra proprietà estetiche. Tale unione implica la messa
in gioco delle facoltà sensibili, percettive, affettive, intellettive e anche critiche del soggetto
giudicante. La percezione dell’unione di forma e contenuto (nei suoi due livelli crescenti di
complessità e intensità, corrispondenti ai due livelli di sopravvenienza estetica) è ciò in cui
consiste l’esperienza estetica nel suo complesso − la quale è caratterizzata per l’appunto
dall’attenzione diretta alle concatenazioni formali e semantiche di un oggetto, dalla
rilevazione della coerenza e della completezza delle proprietà interne ad esso, dall’espansione
immaginativa (pur condensata nelle dimensioni spazio-temporali dell’oggetto), dal senso di
libertà e di auto-realizzazione. Possiamo quindi definire il valore estetico come il valore
intrinseco dell’esperienza estetica che un oggetto, in virtù del possesso e dell’interazione
(formale) di proprietà estetiche (formali e non), procura in un soggetto qualificato e sano (dal
punto di vista delle sua facoltà percettive, affettive, intellettive). Un siffatto tipo di esperienza
è accompagnata naturalmente da un piacere duplice e complesso (in quanto derivante dalla
171
percezione di più livelli di ordine formale) che va sotto il nome di piacere estetico. Le opere
d’arte sono, tra gli oggetti prodotti dall’uomo, quelli maggiormente in grado di produrre (in
modo adeguato, ovvero attraverso i principi sopra citati) un’esperienza estetica
intrinsecamente piacevole: è pertanto corretto identificare il valore artistico di un oggetto,
ovvero il valore di un’opera d’arte in quanto tale, col suo valore estetico, ovvero col valore
intrinseco dell’esperienza estetica che esso produce, indipendentemente dagli effetti e dagli
aspetti dell’opera che oltrepassano l’ambito esperienziale (siano essi transitori, come
l’originalità, o universali, come l’innalzamento spirituale, morale o cognitivo dell’uomo).
Se queste sono le risposte ai quesiti che erano stati lasciati in sospeso al termine del
capitolo quarto e che riguardavano la definizione dell’arte di Davies, che è una definizione
estetica, possiamo allora ricavare da esse i desiderata che una definizione estetica dell’arte
deve soddisfare. Per fornire un valido metodo di classificazione delle opere d’arte
coerentemente fondato su criteri estetici, una definizione dell’arte deve quindi: 1) assegnare,
tra le proprietà estetiche che un oggetto deve possedere per poter essere classificato tra le
opere d’arte, un ruolo primario a quelle formali; 2) specificare che le proprietà formali in
questione consistono nell’unione delle proprietà non-estetiche (formali e non) sottostanti,
ovvero nell’unione di forma e contenuto; 3) ammettere che tale unione avviene anche a un
livello superiore − in quanto le stesse proprietà estetiche (formali e non) rappresentano le basi
sub-venienti delle proprietà intrinsecamente valutative (come la bellezza) − e ricondurre il
valore artistico al valore intrinseco dell’esperienza (piacevole) di questo secondo livello di
unione (ovvero al valore estetico) 317. Quali correzioni possiamo allora apportare alla
definizione estetica dell’arte alla quale siamo pervenuti al termine del quarto capitolo e che
abbiamo desunto dalle ricerche di Davies circa le prime opere d’arte? Se precisiamo che le
proprietà estetiche di cui parla Davies sono proprietà (estetiche) formali, la definizione
assume la seguente forma: un oggetto è un’opera d’arte se e solo se le proprietà rilevanti ai
fini del soddisfacimento della sua funzione primaria sono proprietà (estetiche) formali. E’
tautologico affermare che, così riformulata, la definizione soddisfa il primo dei nostri
desiderata. Ma cosa possiamo dire riguardo agli altri due? Essa non ci dice nulla circa il
modo in cui le proprietà formali sono rilevanti per la soddisfazione della funzione primaria
317 Che il compito di una definizione dell’arte sia anche quello di fornire un criterio di valutazione oltreché di classificazione, pur essendo un’intuizione abbastanza diffusa (come sottolinea Wollheim), è un punto sul quale non tutti concordano. Il collegare valutazione e classificazione fa però senza dubbio parte del “sogno filosofico” dei sostenitori delle definizioni estetiche − che, come afferma Carroll, è più ampio di quello dei sostenitori di altre definizioni. Per loro vale il motto di Eddy Zemach: “no identification without evaluation” (un’opera d’arte è anche una buona opera d’arte, altrimenti non è affatto un’opera d’arte ma è qualcos’altro. Vedi E. Zemach, “No Identification without Evaluation”, cit., pp. 239-51).
172
dell’oggetto, né tantomeno ci dice come le stesse proprietà possano eventualmente condurre
all’assegnazione di un certo grado di valore artistico a un oggetto. Stando così le cose, è
necessario escogitare ulteriori modifiche alla nostra definizione; prima però di far questo, può
essere utile vedere se vi siano già delle definizioni estetiche dell’arte che soddisfino, senza
bisogno di ritocco alcuno, tutti e tre i nostri desiderata. Non ci occuperemo, abbastanza
sorprendentemente, della definizione proposta da Monroe Bearsdley, ovvero del massimo
esponente, in filosofia analitica, di una teoria estetica dell’arte, in quanto egli reintroduce, tra
le condizioni definitorie dell’arte, quel concetto di intenzione che abbiamo già visto essere
alquanto problematico. Rivolgeremo invece la nostra attenzione alle definizioni, meno note
ma più congeniali al nostro scopo, che sono state elaborate a cavallo tra gli anni Ottanta e
Novanta da Richard Eldridge e Richard Lind.
B) RICHARD & RICHARD
Secondo Richard Eldridge, un oggetto è un’opera d’arte se e solo se possiede una
“soddisfacente adeguatezza reciproca di forma e contenuto” 318. Nella sua chiarezza e
concisione, tale definizione sembra in grado di dar conto di una serie di fattori senza che vi sia
bisogno di aggiunte o correzioni. Innanzitutto, ad essere soddisfatti sono evidentemente i
primi due desiderata, in quanto sono esplicitati nella definizione stessa. Inoltre essa ci fa
capire, illuminandola, l’evoluzione della storia dell’arte tanto dal punto di vista della
creatività artistica − col passare del tempo nuovi contenuti emergono e reclamano nuove
forme per poter essere adeguatamente espressi − quanto dal punto di vista della ricettività
critica − i giudizi sull’arte sono da sempre volti a sottolineare l’inscindibilità di proprietà
formali, espressive, rappresentative, simboliche, ecc. Ciò che forse non è però ancora chiaro è
che tale inscindibilità avviene anche su un livello più alto, laddove l’adeguatezza che deve
essere valutata è quella tra proprietà (formali e non-formali, ovvero forma e contenuto)
estetici: senza il riconoscimento di questo ulteriore aspetto dell’esperienza estetica e del
giudizio critico, la definizione non può dar pienamente conto del valore estetico di un oggetto.
Quand’anche la nozione di valore estetico fosse sottintesa (il che è plausibile, dato che
Eldridge parla di “soddisfacente” adeguatezza di forma e contenuto), rimangono peraltro dei
dubbi circa la reale intenzione di Eldridge di identificare con esso il valore artistico tout court
di un’opera; egli stesso infatti afferma che il motivo per cui l’arte è importante per l’uomo sta
nel fatto che essa, attraverso la suddetta proprietà dell’adeguatezza di forma e contenuto, è in
318 Richard Eldridge, “Form and Content: an Aesthetic Theory of Art” (1985), ora in A. Neill. A. Ridley (a cura di), cit., p. 246.
173
grado di dare un senso alla realtà in cui viviamo e di cambiare il nostro modo di pensare e
agire nel mondo 319. Questi valori sono stati da noi precedentemente esclusi dal dominio del
valore artistico propriamente detto, per dar conto del quale è forse necessario stabilire una
gerarchia tra le funzioni che un’opera d’arte deve soddisfare. Ciò è quanto ha in parte
compiuto Lind nella sua articolata definizione, che andiamo subito ad analizzare.
Secondo Richard Lind, un’opera d’arte è l’ “assestamento creativo di uno o più media la
cui principale funzione è quella di comunicare un oggetto estetico significante”. Si tratta,
come anticipato, di una definizione complessa, la cui comprensione richiede, come l’autore
stesso ammette, il chiarimento dei termini in essa contenuti. Per “assestamento creativo” Lind
intende la ri-composizione (creativa) di un medium, la quale può essere il frutto tanto del
lavoro artigianale quanto di operazioni concettuali. Per funzione egli intende “il modo di agire
attraverso cui qualcosa soddisfa il proprio scopo”: ciò significa che un oggetto, per poter
essere classificato come opera d’arte, deve soddisfare la funzione specifica delle opere d’arte,
che chiameremo funzione artistica. “Comunicare” significa “rendere disponibile
all’esperienza intersoggettiva”, indipendentemente dalle intenzioni dell’autore dell’opera
(talune opere sono state esperite pubblicamente nonostante l’autore le avesse escluse dal
proprio catalogo: pensiamo al caso già trattato de Il Castello di Kafka). L’oggetto estetico è,
come anticipato in precedenza, un oggetto che è in grado, in virtù della propria costituzione,
di soddisfare un doppio interesse, formato dal sotto-interesse percettivo che si ha nel
comprendere le relazioni tra le parti (percettive e semantiche) dell’oggetto e dal meta-
interesse edonistico che si ha nel godere (ovvero nel provare piacere) del soddisfacimento di
tale sotto-interesse percettivo. Infine, un oggetto può, in generale, significare qualcosa in due
sensi: esso può essere informativo − nel qual caso il significato è esterno all’oggetto − o
significante − nel qual caso il significato è fenomenicamente fuso con l’oggetto e col suo
particolare assestamento formale. Quest’ultimo è il caso delle opere d’arte 320.
La definizione di Lind soddisfa anch’essa i primi due desiderata, in quanto assegna un
ruolo privilegiato alle proprietà (estetiche) formali e, attraverso la nozione di oggetto estetico
significante, specifica che esse consistono nella fusione reciproca di forma e contenuto (non-
estetici). Inoltre essa è in grado, allo stesso modo della definizione di Eldridge, di dar conto
dell’evoluzione produttiva e ricettiva della storia dell’arte (di nuovo interpretabile sulla
falsariga dell’evoluzione del rapporto tra forma e contenuto). Rispetto però alla definizione di
Eldridge, quella di Lind sembra in grado di soddisfare anche il terzo dei nostri desiderata,
319 Ivi, pp. 247-8. 320 Richard Lind, “The Aesthetic Essence of Art”, cit., pp. 117-129.
174
quello relativo al valore artistico. Aggiungendo infatti la nozione di funzione, e specificando
che tale funzione deve essere soddisfatta, essa introduce un livello superiore al quale l’opera
va riportata: solo soddisfacendo la funzione primaria dell’arte, che è quella di comunicare un
oggetto estetico significante, l’opera possiede un valore artistico. La riuscita della
comunicazione non può che dipendere dalla stessa caratteristica che fa dell’opera un oggetto
estetico significante: la fusione (o reciproca adeguatezza) di forma e contenuto, questa volta
però valutata a livello estetico (ovvero come unità tra le proprietà estetiche, formali e non) e
tale da procurare quel meta-piacere che va sotto il nome di piacere estetico. Riassumendo: un
oggetto è un’opera d’arte in quanto possiede la caratteristica formale della reciproca
adeguatezza di forma e contenuto (primi due desiderata) e in quanto, in virtù di tale
caratteristica (percepita e compresa anche a livello di unione di proprietà estetiche, formali e
non) assolve la funzione estetica (che è quella di soddisfare un meta-interesse edonistico), la
quale coincide con la funzione primaria dell’opera d’arte (terzo desideratum). Certo, si può
obiettare che quest’ultimo punto non è così esplicito nella definizione enunciata da Lind, la
quale in fin dei conti non sembra essere meno macchinosa delle definizioni di Levinson e di
Stecker. C’è però una differenza fondamentale da sottolineare: mentre la macchinosità di
queste ultime era dovuta al fatto che sia Levinson che Stecker erano stati costretti ad apportare
modifiche al nucleo originario delle loro teorie (per correggerne gli evidenti difetti)
aggiungendo parti tra loro eterogenee che con tale nucleo avevano poco a che fare − il che ne
faceva dei macchinari complessi e mal funzionanti −, la definizione di Lind si articola sì in
più parti, le quali sono però specificazioni, e non correzioni, di un originario nucleo estetico, e
riescono a dare delle risposte positive ai problemi posti sia dalla definizione dell’arte sia dalla
natura dei concetti estetici. Il meccanismo da lui ingegnato funziona.
Se si preferisce però cercare una definizione altrettanto efficace ma più agevole di quella di
Lind, possiamo vedere se e in che modo le altre due definizioni estetiche prese in esame
possano essere proficuamente modificate. Per quanto riguarda la definizione di Eldridge, è
sufficiente specificare che il criterio così chiaramente enunciato della reciproca adeguatezza
di forma e contenuto, nell’essere “soddisfacente”, dona all’oggetto che possiede tale proprietà
un valore estetico che insieme coincide col suo valore artistico. Per quanto riguarda la
definizione di Davies il discorso è più complesso, poiché le lacune da colmare riguardano non
solo il terzo, ma anche il secondo dei nostri desiderata. Quest’ultimo può in realtà essere
soddisfatto semplicemente richiamando la prima delle due condizioni che Davies stesso aveva
considerato come necessarie alla definizione delle prime opere d’arte (definizione che
175
abbiamo poi esteso anche alle opere successive) 321. Aggiungendo (anzi, specificando) che le
proprietà formali che un oggetto possiede devono essere integrali al tutto, oltreché (devono
essere) essenziali al raggiungimento della funzione primaria (o delle funzioni primarie)
dell’oggetto (affinché tale oggetto possa essere classificato come opera d’arte), risulta chiaro
che le proprietà a cui ci si riferisce sono quelle dell’unione (fusione, reciproca adeguatezza) di
forma e contenuto; con ciò è quindi assolto in pieno il secondo desideratum. Per rendere la
definizione completa (e assolvere quindi il terzo desideratum) occorre invece, come
indirettamente suggerito da Lind, introdurre una condizione realmente funzionale − ovvero
una condizione che specifichi la funzione primaria che deve essere soddisfatta, e non solo le
proprietà essenziali al soddisfacimento della stessa o il modo in cui le stesse proprietà devono
interagire. Tale funzione non può che essere una funzione estetica, ovvero la funzione di
produrre un’esperienza estetica piacevole e intrinsecamente dotata di valore. La definizione di
Davies viene allora ad assumere la seguente forma:
un oggetto è un’opera d’arte se e solo se le proprietà rilevanti, integralmente alle altre proprietà, ai
fini del soddisfacimento della funzione specifica dell’oggetto (che può essere espressiva,
rappresentativa, puramente formale, ecc.) e della funzione primaria estetica, sono proprietà estetiche
formali.
Subordinando la funzione specifica dell’opera d’arte alla funzione estetica (così come le
proprietà stesse dell’opera sono subordinate a quelle formali) si viene finalmente a instaurare
una gerarchia tra i criteri comuni alle opere d’arte individuati dai vari Dutton, Gaut e
Moravcsik: come le proprietà essenziali di un’opera d’arte sono proprietà (estetiche) formali,
così la funzione essenziale dell’arte (che, non a caso, corrisponde al primo dei nove criteri
della lista di cui abbiamo parlato nel capitolo quarto) è estetica 322.
La lunga ricerca che abbiamo intrapreso ci ha condotto alla scoperta di ben tre definizioni
dell’arte. Tutte e tre sono definizioni estetiche neo-formaliste. Formaliste, in quanto le
proprietà che le opere d’arte devono possedere sono formali. Neo-formaliste, in quanto a
differenza delle teorie formaliste classiche (come quelle di Clive Bell e Roger Fry), le
proprietà formali sono concepite non tanto in isolamento dalle altre proprietà che insieme
321 Davies, come riportato a pag. 129 del nostro lavoro, esplicita queste due condizioni tanto in “First Art and Art’s Definition”, cit., pp. 26-33, quanto in “Non-Western Arts and Art’s Definition”, cit., p. 207. 322 La corrispondenza di cui qui si parla non è casuale, poiché la funzione corrispondente al primo criterio della suddetta lista era proprio la capacità di procurare piacere; funzione che già allora era fatta dipendere dal possesso della proprietà della bellezza, ovvero dalla fusione armonica delle varie proprietà possedute dall’opera (in virtù della quale siamo assorbiti in un’esperienza unica).
176
costituiscono il contenuto di un’opera, quanto piuttosto in unione con queste. Estetiche, in
quanto le proprietà formali in questione sono estetiche (ovvero sopravvengono sulle basi
strutturali non-estetiche), e in quanto la loro unione con le altre proprietà estetiche che l’opera
possiede (ovvero con le proprietà espressive, rappresentative, ecc.) deve produrre
un’esperienza estetica sufficientemente piacevole, in cui il valore estetico (e artistico)
dell’opera si identifica. Non è importante stabilire nell’immediato quale delle tre sia da
preferire; ciò che conta è aver sufficientemente delimitato il terreno sul quale una definizione
estetica dell’arte può crescere e fiorire. Affinché ciò accada è necessario però proteggere
questo terreno dalle insidie velenose che si insinuano tra le radici delle definizioni estetiche.
Nel prossimo paragrafo analizzeremo da vicino tali insidie e vedremo anche se disponiamo di
un buon antidoto per scacciarle.
5.4 I dilemmi di una definizione estetica dell’arte
A) TROPPO INCLUSIVA O TROPPO ESCLUSIVA?
Le principali questioni alle quali una definizione estetica neo-formalista dell’arte è
chiamata a rispondere si presentano nella forma del dilemma. Il primo dilemma riguarda la
questione se una siffatta definizione sia abbastanza inclusiva da comprendere le forme e le
opere d’arte unanimemente riconosciute come tali e abbastanza esclusiva da non permettere
l’ingresso nel dominio artistico ad oggetti comunemente e ragionevolmente ritenuti non
artistici. Alcuni autori (tra cui Carroll) sostengono che esistono diversi tipi di oggetti non
artistici (prodotti artigianali o industriali, libri di filosofia o di scienza, azioni sportive, ecc.)
che presentano un certo grado di adeguatezza reciproca di forma e contenuto: stando quindi
alla definizione estetica neo-formalista essi dovrebbero essere classificati come opere d’arte,
il che andrebbe contro il senso comune 323. E’ in effetti innegabile che le opere d’arte possano
avere delle funzioni comuni a quelle di oggetti non-artistici, come la funzione di comunicare
un significato più o meno profondo o quella di esprimere emozioni; ed è altrettanto innegabile
che la soddisfazione di tali funzioni richieda anche per gli oggetti non-artistici un certo grado
di adeguatezza tra forma e contenuto (non possiamo ad esempio giustificare una verità
matematica o filosofica senza l’aiuto di una dimostrazione coerente; affinché una partita di
323 Noel Carroll, Philosophy of Art, cit., pp. 131-136. Analoghe argomentazioni sono presenti in R. Stecker, Artworks: Definition, Meaning, Value, cit., pp. 40-43, e Alfonso Ottobre, “Sulle proprietà estetiche”, Rivista di Estetica 23 (2/2003), pp. 87-90.
177
tennis sia emozionante occorre che i protagonisti sappiano eseguire bene i colpi di base).
Tuttavia negli oggetti non artistici la stessa funzione può essere soddisfatta attraverso forme
diverse, pur mantenendo costante il contenuto. Sappiamo ad esempio che Kant invitò altri
filosofi ad esporre il contenuto della sua Critica della Ragion Pura in un’altra forma, se
questa si fosse rivelata più congeniale alla comprensione del contenuto stesso. Viceversa, non
è possibile esprimere il contenuto di una poesia o di un romanzo modificando anche solo una
delle parole usate dall’autore. Ciò significa che il grado di adeguatezza tra forma e contenuto
riscontrabile in alcuni oggetti non-artistici non è equiparabile a quello delle opere d’arte.
Quand’anche poi in certi oggetti non-artistici si verificasse un livello alto di adeguatezza
reciproca di forma e contenuto, ciò costituirebbe un valore parziale per essi, e non il valore
primario. Abbiamo visto infatti che l’identificazione delle opere d’arte dipende, oltreché da
una condizione sostanziale (il possesso della proprietà dell’adeguatezza di forma e contenuto)
anche da una condizione funzionale (il soddisfacimento della funzione estetica, ovvero la
produzione di un’esperienza estetica intrinsecamente piacevole e apprezzabile). Ora, è
innegabile che la funzione primaria di oggetti come un saggio filosofico non è estetica: non
riteniamo lo Zarathustra di Nietzsche migliore della Critica kantiana, sebbene il valore
estetico del primo sia superiore a quello del secondo; e ciò poiché il valore primario di tali
oggetti è filosofico e non estetico. La finale del French Open di tennis del 1984 tra McEnroe e
Lendl è stata altamente emozionante, sebbene abbia prevalso il giocatore dai colpi meno
raffinati ed eleganti (sto parlando ovviamente di Lendl). Viceversa nelle opere d’arte la
funzione estetica prevale sulle funzioni rappresentative, espressive, semantiche, ecc.: se non
vi fosse questa gerarchia tra funzioni, sarebbe in alcuni casi difficile (come abbiamo visto nel
capitolo quarto) distinguere tra arte e non-arte. Pertanto, il fatto che anche oggetti non-artistici
possiedano un certo grado di valore estetico (in virtù di una considerevole adeguatezza
reciproca di forma e contenuto) non costituisce un problema per una definizione estetica
dell’arte, ma suggerisce piuttosto due considerazioni. La prima è che, come detto, tale
proprietà è comunque presente in un grado superiore nelle opere d’arte; il che non solo è
presupposto dalla definizione ma è anche confermato dall’esperienza. La seconda è che
l’esperienza estetica non è confinata al solo ambito delle opere d’arte, sebbene questo ne sia il
terreno d’elezione. Possiamo provare un’esperienza estetica anche nel contemplare un
tramonto, nel leggere un saggio filosofico, nell’assistere a una partita di tennis o nel costruire
(perfino nell’aggiustare, come suggerisce Robert Pirsig 324) una motocicletta. E’ proprio in
324 Robert Pirsig, Zen and the Art of Motorcycle Maintenance (1974), trad. it. (a cura di Delfina Vezzoli) Lo Zen e l’arte della manutenzione della motocicletta, Adelphi, Milano 1999 (XII edizione).
178
virtù dell’universalità e della naturalezza dell’esperienza estetica che John Dewey si era a suo
tempo posto il compito di “ripristinare la continuità tra quelle forme raffinate e intense
d’esperienza che sono le opere d’arte e gli eventi, i fatti e i patimenti di ogni giorno” 325.
L’aggiunta della condizione funzionale a quella rappresentata dal possesso della proprietà
della reciproca adeguatezza di forma e contenuto permette quindi alla definizione estetica di
essere abbastanza esclusiva da impedire che oggetti come un libro di filosofia o una partita di
tennis vengano inavvertitamente classificati come opere d’arte. Così facendo però, la
definizione rischia secondo alcuni di diventare troppo esclusiva. Innanzitutto essa non sembra
in grado di dar conto della cosiddetta bad-art, dal momento che solo un oggetto che riesca a
soddisfare la funzione estetica può essere classificato come opera d’arte. Lind replica a tale
accusa (formulata di nuovo da Carroll) sostenendo che possiamo parlare di bad-art quando il
grado di soddisfazione della funzione estetica è estremamente basso. Piuttosto però che
escogitare stratagemmi che ci permettano di giustificare l’esistenza della bad-art, ci si
dovrebbe chiedere se essa costituisca davvero un problema sostanziale per una qualsivoglia
definizione dell’arte, o non sia invece solamente un problema nominale. La definizione
dell’arte che stiamo difendendo fornisce un criterio di classificazione che è insieme anche un
criterio di valutazione: un oggetto è un’opera d’arte se possiede la proprietà della reciproca
adeguatezza di forma e contenuto e se è in grado di soddisfare (attraverso questa proprietà) la
primaria funzione estetica (ovvero se è dotata di valore estetico). Per quel che concerne poi
quegli oggetti che possiedono tale proprietà a un grado minimo e che quindi riescono solo in
parte a soddisfare la funzione estetica, etichettarli come bad-art o not-at-all-art è una
questione di convenzioni linguistiche. Personalmente sono propenso a considerare la maggior
parte degli oggetti di questo tipo come not-at-all-art o al limite come still-not-art, ovvero
come tentativi falliti di creare opere d’arte, piuttosto che onorarli dell’appellativo di arte
(sebbene “cattiva”, ovvero di basso livello); il che è più coerente con le premesse teoretiche
dalle quali le definizioni estetiche muovono (la maggiore ampiezza del sogno filosofico
perseguito dai sostenitori di tali definizioni, rispetto ad esempio a quello dei proceduralisti
alla Dickie, si riflette necessariamente in una maggiore selettività nella classificazione delle
opere d’arte, essendo quest’ultima inscindibile dalla valutazione) 326. Ciò non vuol dire
325 John Dewey, Art as Experience (1934), trad. it. (a cura di Giovanni Matteucci) Arte come esperienza, Aesthetica, Palermo 2007, p. 31. 326 Le espressioni not-at-all-art e still-not-art sono mie. Nel limitare l’ampiezza della bad-art non intendo negarne l’esistenza. Una cospicua parte di musica pop rientra probabilmente in tale categoria: in certe canzonette (non certo nella musica pop di qualità, di cui fortunatamente abbiamo numerosi esempi) esiste un livello basilare di abilità, ad esempio nel creare dei “tormentoni” (per quanto mi fa sempre un certo effetto parlare di Laura Pausini come di un artista). A mio avviso la maggior parte delle opere dei madonnari, dei graffitari, dei pittori e
179
ovviamente che tutti gli oggetti che meritano l’appellativo di opere d’arte stiano sullo stesso
livello: l’edificio dell’Arte è fatto di più piani, e solo i grandi artisti alloggiano nella suite
royal, mentre quelli meno bravi (il che non vuole affatto dire meno famosi) devono
accontentarsi di un monolocale assai meno confortevole. Entrambi però devono entrare dalla
porta principale − il valore estetico − e non da quella di servizio − il mondo dell’arte.
L’accusa di eccessiva esclusività si fa però più pressante non appena si passi a considerare
quelle forme d’arte − come le arti narrative o l’arte concettuale − che, non essendo
apparentemente legate alla presenza di alcun tipo di proprietà formale, sembrano contraddire
l’assunto di base di una definizione estetica neo-formalista dell’arte. Tali forme ci pongono un
serio dilemma: se esse vengono accettate così come le abbiamo descritte (ovvero come arti
non formali e non estetiche), dobbiamo di conseguenza abbandonare la nostra definizione;
altrimenti, se vogliamo ancora fare affidamento su una definizione estetica neo-formalista,
dobbiamo clamorosamente escludere tali forme dal regno dell’arte. Procediamo con ordine e
partiamo dalle arti narrative. Secondo Nick Zangwill ci sono due modi in cui esse possono
accordarsi con una definizione estetica neo-formalista 327. Il primo consiste nel sottolineare
come in realtà anche la letteratura (ovvero l’arte narrativa per eccellenza) dipenda da proprietà
formali, costituite in questo caso dalle proprietà sonore della parola in sé (si pensi alla rima,
all’allitterazione, ecc.) e dalle parole stesse considerate come espressioni sonore di un certo
significato (si pensi all’onomatopea). Questo tipo di proprietà è però alquanto ristretto (e lo è
ancora di più se ad essere presa in esame è la prosa letteraria piuttosto che la poesia), e non
può certo costituire una soluzione al problema (come lo stesso Zangwill riconosce). Occorre
allora chiamare in causa un concetto più ampio di forma, costituito dall’insieme di relazioni,
percettive e non, tra le parti di un’opera. Dire che le proprietà estetiche, incluse quelle formali,
sono percettive, non equivale infatti al dire che esse dipendono necessariamente dai cinque
sensi. Quando Sibley afferma che dobbiamo “vedere la grazia o l’unità di un’opera, sentire la
tristezza o la frenesia nella musica, percepire lo splendore di una combinazione di colori,
avvertire il potere di un racconto o la sua atmosfera”, egli intende solamente affermare che le
proprietà estetiche devono essere rilevate per mezzo dell’esperienza diretta piuttosto che
essere razionalmente inferite da regole prestabilite. Una siffatta nozione “larga” di percezione,
sostenuta da Sibley e recentemente ripresa e approfondita da James Shelley, è quella sottesa
dei poeti della domenica, e via dicendo, rientrano invece nella categoria della still-not-art o della not-at-all-art. Non si tratta, si badi bene, di una questione di status sociale: ci sono infatti artisti assai poco famosi che producono opere di valore talvolta superiore a quello di artisti famosi e alquanto sopravvalutati. 327 Nick Zangwill, “Feasible Aesthetic Formalism”, cit., pp. 620-622.
180
alla nozione ampia di forma che abbiamo appena introdotto 328. In tal senso si può allora ben
dire che la letteratura possieda delle proprietà formali, essendo queste costituite dalle relazioni
che intercorrono tra i personaggi, le situazioni e gli eventi che si succedono nel corso di un
racconto, ovvero dall’intreccio (o plot) narrativo.
Che dire però di quelle opere appartenenti a forme d’arte narrative (le quali comprendono
ovviamente, oltre alla letteratura, anche il teatro, il cinema, l’opera, ecc.) che non assolvono
alcuna funzione estetica e il cui unico scopo è puramente narrativo? In tali opere, pur essendo
talvolta presente un apprezzabile grado di adeguatezza di forma e contenuto, il secondo
termine prevale nettamente sul primo e il loro valore è principalmente informativo piuttosto
che estetico. Di fronte a casi simili Zangwill sostiene che, anziché tentare di apportare delle
modifiche alla definizione estetica, sia più indicato rimettere in discussione la classificazione
delle belle arti introdotta nel Settecento da Batteux e giunta pressoché immutata fino a nostri
giorni 329. Il modello settecentesco concepisce staticamente le diverse forme d’ ‘arte bella’
(pittura, musica, poesia, scultura, danza) come racchiuse in uno stesso insieme, al di là delle
differenze specifiche tra di esse. Se invece si tiene maggiormente conto di tali differenze e dei
cambiamenti che ciascuna forma ha attraversato nel tempo (cambiamenti che sono talvolta
sfociati nella nascita di nuove forme, come la fotografia e il cinema), è preferibile secondo
Zangwill concepirle come disposte lungo un continuum (ancora!) cha va dalle forme artistiche
più puramente estetico-formali (come la pittura astratta e la musica strumentale), passa per
forme intermedie (come la pittura figurativa e l’opera) e giunge, all’estremità opposta, alle arti
prevalentemente narrative e semantiche (romanzi, film, rappresentazioni teatrali). Talvolta
però la componente narrativa o semantica (in breve, il contenuto) prevale in maniera totale
(sulla forma): le opere così costituite fuoriescono allora dal continuum e devono essere
escluse, secondo Zangwill e in opposizione al modello di Batteux, dal dominio artistico − nel
quale dominio possono invece fare la loro comparsa forme nuove e per alcuni discutibili come
la folk art, il design e la decorazione artigianale (oltre alle già citate fotografia e cinema). Un
siffatto modello più mobile e articolato delle forme d’arte, il quale è in grado di dar conto
tanto delle differenze tra le forme d’arte esistenti quanto dei mutamenti avvenuti nel corso
della storia dell’arte, trova un perfetto riscontro in una definizione estetica dell’arte, la quale
può quindi, secondo Zangwill, essere mantenuta così com’è.
328 James Shelley, “The Problem of Non-Perceptual Art”, British Journal of Aesthetics 43 (2003), pp. 363-378. 329 Nick Zangwill, “Are There Counter-Examples to Aesthetic Theories of Art?”, Journal of Aesthetics and Art Criticism 60 (2002), pp. 113-118.
181
La soluzione di Zangwill, per quanto radicale possa a prima vista apparire, è a mio avviso
fondamentalmente ragionevole. Che la letteratura (come le altre arti narrative) possieda una
componente rappresentativa, ovvero semantica o intellettuale, particolarmente spiccata, non
costituisce certo un buon motivo per escluderla dal novero delle forme d’arte riconosciute.
Tale componente è peraltro condivisa da altre forme d’arte: basti pensare ai dipinti di Bosch,
De Chirico o Magritte, non a caso apparentati da una forte carica simbolica e intellettuale e a
vario titolo etichettati come esempi di pittura ‘letteraria’. Vi sono però in effetti dei romanzi o
dei film in cui la componente rappresentativo-semantica, ossia il contenuto, è talmente
preponderante da oscurare la componente estetico-formale. In casi come questi, quando cioè
la letteratura si avvicina alla psicologia o alla sociologia e il cinema sconfina nel reportage
documentaristico, è allora forse più corretto non ricorrere al termine ‘arte’ (come Zangwill
suggerisce). Con ciò non si vuole negare l’esistenza di un rapporto dell’arte con la realtà. Pur
assegnando un ruolo primario alle proprietà formali (il che fa sì che possano darsi anche opere
puramente formali), la definizione estetica neo-formalista dell’arte riconosce un valore
superiore a quelle opere in cui la forma sia congiunta a un contenuto specifico, che può essere
rappresentativo, espressivo o simbolico. La maggior parte delle opere d’arte − i dipinti
figurativi, i romanzi, i film, le rappresentazioni teatrali, l’opera, la fotografia, e via dicendo −
deriva infatti dall’unione di forma e contenuto. A questa lista aggiungerei la musica
strumentale (almeno in parte) tonale, in cui è possibile identificare un contenuto espressivo
(corrispondente a determinate melodie, ritmi, accordi, variazioni, ecc.) per lo più assente nella
musica atonale pura, il cui valore sta unicamente nella struttura compositiva. In tutte queste
forme artistiche la realtà offre la materia sulla quale la creatività dell’artista opera producendo
vari livelli di elaborazione formale − che vanno dalla costituzione delle unità rappresentative
o espressive primarie (la figura di un dipinto, la melodia di un brano musicale, i personaggi di
un romanzo o di un film) alla tessitura delle relazioni tra tali unità (il rapporto tra figura e
sfondo, la variazione melodica, il plot narrativo) e tra i loro portati emotivi e valutativi (in
breve, la forma espressiva) −, salendo i quali l’opera raggiunge il suo valore intrinseco.
La definizione estetica dell’arte non nega quindi che vi sia un input della realtà nell’opera.
Essa nega però che vi sia un output dell’opera nella realtà o che, qualora vi fosse, esso sia
rilevante ai fini dell’identificazione, della comprensione e della valutazione di un’opera
d’arte. La presenza, in un’opera d’arte, di elementi tratti dalla realtà (figure, personaggi,
eventi, stati emotivi, ecc.), rende senza dubbio l’opera stessa più coinvolgente dal punto di
vista emotivo − in quanto esseri umani, siamo naturalmente più attratti da opere che facciano
riferimento alle condizioni in cui viviamo quotidianamente − e stimolante dal punto di vista
182
percettivo e intellettivo − tali elementi costituiscono infatti la base di livelli crescenti (in
quanto a complessità) di elaborazione formale 330. Questi stati emotivi o cognitivi sono però
limitati alla sola durata dell’esperienza estetica. Attraverso l’osservazione di un dipinto,
l’ascolto di una sinfonia, la lettura di un romanzo o la visione di un film, noi siamo trasportati,
insieme al nostro abituale bagaglio di emozioni, percezioni e conoscenze, in un mondo
immaginario dove tali emozioni, percezioni e conoscenze sono trasfigurate e rese più coerenti,
intense, appaganti. Finita però l’esperienza estetica, ridiscendiamo immediatamente nella
nostra, quotidiana e imperfetta, realtà. Forse saremo spinti a modificarla, in quanto trascinati
da nuove idee; oppure saremo talmente commossi da guardarla con occhi diversi, cercando il
bello dove prima vedevamo solo imperfezioni. Ma questi sono effetti secondari: il vero valore
dell’arte − se la nostra interpretazione della definizione estetica dell’arte e dei concetti ad essa
sottesi di proprietà, piacere e valore estetico è corretta − sta nella sua capacità di farci vivere
un’esperienza fuori dall’ordinario, sebbene tale esperienza sia tanto più complessa, intensa e
stimolante quanto più essa attinge dalla realtà in cui viviamo.
Rimane ancora da analizzare il caso delle opere d’arte concettuali. Tali opere non
presentano proprietà formali di nessun livello e tipo (non si può parlare per esse nemmeno di
una forma intellettuale o immaginativa); per questo motivo rappresentano il contro-esempio
che più frequentemente viene usato per respingere le definizioni estetiche dell’arte, soprattutto
da chi (come Danto, Dickie e altri ancora) da questi esempi ha preso spunto per elaborare
nuove definizioni. Si tratta dunque di un problema delicato, che in quanto tale merita
un’analisi a parte; ad esso sarà dedicato quindi il prossimo paragrafo.
B) DUCHAMP: DENTRO O FUORI?
Che tipo di difesa può adottare un sostenitore di una definizione estetica dell’arte di fronte
all’accusa di non essere in grado di dar conto di un’importante fetta dell’arte contemporanea,
vale a dire di quel vasto insieme di opere che prende le mosse dai ready-made di Duchamp e
che è solita essere etichettata come arte concettuale? Nick Zangwill suggerisce al proposito di
adottare una delle tre seguenti strategie difensive. La prima, da lui chiamata “retreat-strategy”,
consiste nell’accettare senza troppi patemi il fatto che le definizioni estetiche non siano capaci
di giustificare l’esistenza di opere (come quelle concettuali) che costituiscono comunque una
330 La presenza, in un’opera d’arte, di siffatti agganci con la realtà, favorisce anche la percezione dell’unicità dell’esperienza dell’opera stessa: questo è un’ulteriore pregio o valore della presenza di una figura riconoscibile in un dipinto, dell’utilizzo di una melodia orecchiabile in musica e in generale dell’impiego, in un’opera d’arte, di elementi con i quali possediamo naturalmente un certo grado di familiarità (vedi a tal proposito J. Levinson, “Aesthetic Uniqueness” (1980), ora in Music, Art, and Metaphysics, cit., pp. 130-133).
183
minoranza rispetto al restante corpus delle opere d’arte realizzate dalle origini fino ad oggi.
C’è poi la “negative-strategy”, che considera le opere concettuali come opere anti-estetiche:
esse possiedono quindi ancora una funzione estetica, sebbene tale funzione sia negativa, dato
che lo scopo di queste opere è di negare la funzione estetica stessa. Infine, le opere d’arte
concettuali possono essere interpretate come parassitarie rispetto al passato, in quanto il loro
significato può essere compreso solo alla luce della comprensione delle opere d’arte già
esistenti, le quali sono tradizionalmente legate alla soddisfazione di una funzione di tipo
estetico. Le opere concettuali risulterebbero essere delle opere estetiche di secondo ordine, e
la teoria che così le definisce non può che chiamarsi “second-order strategy” 331.
Quale di queste strategie può essere ritenuta la più efficace? Zangwill favorisce
esplicitamente la terza, che ricorda da vicino una delle due soluzioni prospettate da Levinson
per far sì che la definizione storico-intenzionale fosse in grado di dar conto dell’arte
cosiddetta rivoluzionaria. Levinson propose infatti a suo tempo di considerare l’arte
rivoluzionaria (in pratica, l’arte concettuale) come arte sorta dalla constatazione, da parte di
qualche artista illuminato o visionario, della carenza (rispetto alle esigenze moderne) dei modi
di considerazione propri dell’arte del passato, in particolare di quelli estetici, ai quali l’arte
concettuale stessa è quindi indirettamente (parassitariamente, direbbe Zangwill) collegata.
Alternativamente, Levinson ha valutato la possibilità di mantenere un riferimento intenzionale
dell’arte concettuale nei confronti dell’arte precedente in virtù della relazione di contrarietà,
che nei termini di Noel Carroll è diventata ripudio e che costituisce la base della seconda
strategia proposta da Zangwill, ovvero la negative-strategy. Nessuna delle due alternative
proposte da Levinson, e parallelamente della seconda e terza delle strategie difensive indicate
da Zangwill, è però a mio avviso sufficiente a giustificare l’esistenza dell’arte concettuale, e
ciò per motivi intuitivamente comprensibili. Anche un libro di storia dell’arte è infatti
parassitario rispetto all’esistenza di opere d’arte apprezzate e riconosciute per il loro valore
estetico, ma non per questo esso è un’opera d’arte! D’altro canto, attribuire lo status di
artisticità a certi oggetti solo in quanto sono stati creati in netto contrasto con opere d’arte
unanimemente riconosciute, alle quali vengono poi affiancati teoricamente (nei libri di critica)
e praticamente (nelle rassegne di arte moderna e contemporanea), significa spezzare quel
paradigma della continuità della storia dell’arte che il senso comune e lo studio trans-culturale
attestano, e che costituisce il fondamento della stessa definizione storica dell’arte di Levinson.
331 Nick Zangwill, “Are There Counter-Examples to Aesthetic Theories of Art?”, cit., pp. 111-113.
184
Dirò di più: nessuna soluzione al problema dell’arte concettuale è veramente necessaria,
perché questo è un finto problema. L’arte concettuale non può essere usata come un contro-
esempio nei confronti delle definizioni estetiche dell’arte, in quanto essa non costituisce un
caso esemplare o paradigmatico di arte. Sin dalla loro comparsa sulla scena artistica, i ready-
made hanno suscitato perplessità non inferiori alle approvazioni negli appassionati e nei
critici, e lo stesso risultato è stato conseguito dai movimenti artistici che da Duchamp hanno
preso le mosse, in particolare quello dell’Arte Concettuale. Le opere concettuali, come anche i
ready-made, oltre a non essere paradigmatiche, sono anche controverse, dal momento che non
hanno alcun aspetto in comune con le opere d’arte precedenti (nemmeno con le opere
appartenenti alle Avanguardie del primo Novecento, che invece un legame con la tradizione
artistica, occidentale e non, lo mantengono sempre: non a caso usiamo per esse categorie
come ‘espressionismo’, ‘astrattismo formale’, ‘neo-classicismo’, ecc.). Le opere concettuali
rappresentano dei casi problematici per la loro stessa classificazione (per questo motivo Nigel
Warburton le chiama “oggetti ansiosi” 332), e non possono costituire un problema per una
definizione estetica dell’arte, la quale è costruita su basi più solide rispetto alle definizioni che
da tali opere eccentriche e discutibili prendono le mosse (stiamo parlando delle definizioni
istituzionali).
Come ricorda giustamente Zangwill, una definizione dell’arte deve infatti essere valida
tanto da un punto di vista estensionale − il che significa che essa deve essere in grado di dar
conto del maggior numero possibile di opere d’arte esistenti e intorno alle quali vi è un alto
grado di consenso − quanto dal punto di vista esplicativo − essa deve spiegare il valore
dell’arte nella vita dell’uomo, ovvero deve aiutarci a capire perché produciamo, consumiamo
e conserviamo le opere d’arte, e deve anche fornirci dei criteri per poter stabilire quali oggetti
potranno essere classificati come opere d’arte in futuro. La definizione istituzionale (ma in
parte anche, come visto, la definizione storico-intenzionale) ha privilegiato l’aspetto
estensionale a totale discapito di quello esplicativo: essa è sì in grado di dar conto delle opere
rivoluzionarie, concettuali e quant’altro, ma abbandona i criteri di classificazione e di
valutazione dell’arte all’arbitrarietà di un ermetico mondo dell’arte. La definizione estetica
(neo-formalista) dell’arte soddisfa invece entrambi i criteri, in quanto riesce a dar conto della
stragrande maggioranza delle opere d’arte esistenti e riconosciute, e insieme ci fornisce un
criterio (identificabile nella capacità che un oggetto ha di soddisfare una funzione estetica in
virtù delle proprietà formali possedute) di classificazione e valutazione tanto dell’arte del
332 N. Warburton, The Art Question (2003), trad. it. La questione dell’arte, Einaudi, Torino 2004, cit., p. 104.
185
presente quanto di quella del futuro. Occorre precisare che il potere esplicativo di una siffatta
definizione non è il frutto, come vorrebbero alcuni, della “stupefacente capacità che certi
filosofi si attribuiscono”, né di un aprioristico “sapere metafisico” 333; il criterio di
classificazione e valutazione che dona alla definizione estetica neo-formalista tale potere
affonda le sue radici nella concreta storia dell’arte, come la ricerca intrapresa a partire dal
quarto capitolo ci ha mostrato. E’ proprio in virtù di tale radicamento nella storia che la
definizione estetica è in grado di dare “una spiegazione razionale della stragrande
maggioranza dell’arte e delle attività relative all’arte che il mondo ha prodotto negli ultimi
millenni. Ciò è sicuramente più importante della questione se una teoria sia capace di fornire
una spiegazione per una manciata di opere sperimentali prodotte a New York negli anni
Sessanta” 334.
La strategia che i difensori di una definizione estetica dell’arte devono adottare di fronte a
movimenti artistici come l’Arte Concettuale è quindi la prima delle tre soluzioni proposte da
Zangwill, vale a dire la strategia della ritirata (retreat-strategy). Non si tratta però di una
ritirata sommessa e rassegnata, né di un arroccarsi su posizioni inattaccabili in quanto dedotte
da un sapere aprioristico, bensì dell’affermazione di un’identità (estetica) conosciuta
attraverso lo studio concreto della storia dell’arte. Di fronte a opere come Fountain di
Duchamp non c’è quindi tanto da spaventarsi per la minaccia che esse possono rappresentare
per una definizione estetica dell’arte, quanto invece da sorprendersi per il clamore che ha
suscitato e che continua tuttora a suscitare un oggetto il cui scopo principale era, secondo le
parole sarcastiche di Bearsdley, quello di vedere fino a che punto poteva arrivare la tolleranza
di una giuria artistica. In fondo Duchamp non fece altro che indicare un oggetto e chiamarlo
arte: ma, si chiede Bearsdley, qual è il senso di una simile operazione? “Classificare degli
oggetti come opere d’arte solo in quanto sono stati chiamati arte da coloro i quali sono
chiamati artisti in quanto producono oggetti che loro stessi chiamano arte non significa affatto
classificarli, ma pensare in una maniera circolare. Probabilmente questi oggetti hanno bisogno
di essere chiamati con un nome speciale, ma non con quello di arte” 335.
E’ pur vero che una buona parte di arte contemporanea è stata ed è tuttora creata con
l’intenzione di ribellarsi all’arte del passato e di scioccare, stupire o disgustare lo spettatore, 333 Questa è l’accusa formulata da Roger Pouivet, in Id., “Definire l’arte: missione impossibile?”, Studi di Estetica 28 (2003/2007), pp. 319-322. 334 Nick Zangwill, “L’irrilevanza dell’avanguardia”, Rivista di Estetica 35 (2007), p. 94. Tornando per un momento al capitolo secondo, possiamo ora dire che Currie aveva ragione nel sostenere che esiste un concetto di “artisticità”, parallelo a quello di “acquosità” e tale da unire tra loro le diverse tradizioni artistiche esistenti; egli aveva però torto nel definirlo un concetto aprioristico, laddove esso è identificabile a posteriori con la reale essenza estetica di ogni tradizione artistica. 335 Monroe Beardsley, “An Aesthetic Definition of Art” (1983), cit., p. 25.
186
piuttosto che coinvolgerlo in un’esperienza estetica intrinsecamente piacevole. Tuttavia,
precisa ancora Bearsdley, come è un diritto dell’artista l’ampliare il campo delle esperienze
che un’opera d’arte può suscitare, così è un diritto del filosofo dell’arte confrontare tali
esperienze con quelle comunemente descritte come estetiche e decretare che, laddove le
differenze prevalgano sulle somiglianze, non abbiamo a che fare con opere d’arte ma con un
differente tipo di oggetti, indipendentemente dal loro valore (che sarà ovviamente stabilito a
partire da un punto di vista diverso da quello estetico). E’ anzi compito precipuo del filosofo
dell’arte, soprattutto in un’epoca tumultuosa come la nostra, ricordarci che “esiste un tipo di
gratificazione” (a cui le vere opere d’arte mirano) che è “qualcosa in più” che futili “gag” o
banali “shock”, e ribadire una volta di più l’importanza dell’esperienza estetica nella vita
dell’uomo 336.
C) OGGETTIVITA’ O SOGGETTIVITA’ DELLE PROPRIETA’ ESTETICHE?
Una definizione estetica neo-formalista ha l’indubbio pregio di fornirci un criterio ben
preciso per classificare e valutare le opere d’arte. Tale criterio è costituito dalla capacità di un
oggetto di soddisfare la funzione primaria estetica, ovvero la sua capacità di procurare
un’esperienza estetica soddisfacente in virtù del possesso di proprietà estetiche formali. Non
basta quindi che un oggetto procuri un’esperienza estetica di un certo livello perché esso sia
classificabile come opera d’arte; occorre anche che tale esperienza sia correttamente prodotta
e vissuta attraverso le proprietà estetiche formali possedute dall’oggetto e percepite dal
soggetto. La componente soggettiva che è presente nel criterio che la suddetta definizione ci
fornisce, vale a dire l’esperienza (estetica), è quindi controbilanciata da una componente
oggettiva, ossia le proprietà (estetiche). Fino a che punto possiamo però parlare di oggettività
per le proprietà estetiche? Esse sono infatti tutte, seppur in grado variabile, proprietà
response-dependent. Certo, tra queste proprietà quelle formali sono le meno emergenti,
ovvero le più ancorate alla base strutturale sottostante. Tuttavia in presenza di altre proprietà
(rappresentative, espressive, simboliche, ecc.), la forma stessa opera in congiunzione col
contenuto espressivo, rappresentativo e simbolico dell’opera, producendo tanto il carattere
estetico dell’opera (ovvero l’insieme delle proprietà estetiche espressive, rappresentative e
simboliche) quanto la sua bellezza (frutto diretto dell’unione delle proprietà estetiche, formali
e non, dell’opera). Ora, sia le proprietà estetiche che formano il contenuto di un’opera d’arte
sia il suo valore intrinseco (ovvero la sua bellezza) sono proprietà fortemente response-
336 Monroe Bearsdley, “Aesthetic Experience Regained”, cit., pp. 89-92.
187
dependent, come abbiamo visto; il che costituisce una complicazione per la definizione che
stiamo esaminando, dato che essa non può prescindere da tali elementi.
I difensori del realismo estetico, ovvero dell’oggettività delle proprietà estetiche, possono
appellarsi all’uniformità delle reazioni che tali proprietà provocano. Questo tipo di difesa,
denominata “prova percettiva”, è stata sostenuta per primo da Frank Sibley, il quale la deduce
dal modello delle proprietà secondarie. Le proprietà secondarie come i colori, osserva
giustamente Sibley, pur dipendendo da una risposta soggettiva (costituita dall’impressione
fenomenica corrispondente alla percezione di un dato colore, ad esempio al colore rosso),
possono aspirare a un certo grado di oggettività in virtù del fatto che osservatori qualificati
(ovvero dotati di un sufficiente grado di sensibilità percettiva), posti di fronte a un
determinato oggetto in condizioni di osservazione standard, reagiranno tutti alla stessa
maniera, ovvero riceveranno tutti più o meno la medesima impressione fenomenica
corrispondente al colore rosso 337. Posto quindi che possiamo garantire delle condizioni
standard di osservazione, per sostenere l’oggettività delle proprietà estetiche di un oggetto,
ovvero l’uniformità delle reazioni ad esse corrispondenti, dobbiamo verificare se anche la
sensibilità estetica presenta un grado di uniformità pari a quello posseduto dalla sensibilità
percettivo-fenomenica, ovvero dalla sensibilità che ci permette di percepire e rilevare con una
certa regolarità proprietà secondarie come i colori. Dato però che lo spettro delle proprietà
estetiche è, come abbiamo visto, assai più ampio e articolato (in relazione soprattutto alle
risposte soggettive ad esse associate) di quello delle proprietà (strettamente) percettive, sarà
necessario distinguere i tipi di sensibilità estetica corrispondenti ai diversi gruppi di proprietà
estetiche − ovvero ai diversi piani in cui la piramide estetica si articola − e verificare quindi se
per ciascuno di essi la prova percettiva possa essere sostenuta 338.
Partiamo dal vertice della piramide, ovvero dalle proprietà intrinsecamente valutative
(bellezza, bruttezza e simili). Esse, come visto, sono legate alle altre proprietà estetiche da una
relazione di sopravvenienza di secondo livello; i principi che legano i due insiemi di proprietà
sono i principi dell’unità, della complessità e dell’intensità, ovvero della reciproca
adeguatezza di forma e contenuto (considerati già a livello estetico). Tali principi sono
proprietà formali di secondo (e più alto) livello, le quali per essere percepite o rilevate 337 Frank Sibley, “Colours” (1967-8), ora in Id., Approach to Aesthetics: Collected Papers on Philosophical Aesthetics, cit., pp. 54-70. 338 La difesa del realismo estetico si riduce quindi, come sottolineato da Matteucci, alla ricerca delle “condizioni che consentono di ritenere valido il discorso su una qualità estetica”; dalla “questione dello statuto delle proprietà estetiche” si passa cioè al “dibattito sulle condizioni di normalità dell’esperienza estetica e di corretta apprensione delle qualità estetiche, ovvero sulle condizioni contestuali e convenzionali della predicazione estetica e della recensione critica” (Giovanni Matteucci, “Ci sono e percepiamo le qualità estetiche?”, in Studi di estetica 27 (2003), pp. 215-6).
188
richiedono l’esercizio di una sensibilità percettiva parallela ma superiore alla sensibilità
percettivo-gestaltica richiesta per la rilevazione delle proprietà formali di primo livello. Tale
sensibilità, che coinvolge insieme percezione, emotività, immaginazione e giudizio,
corrisponde a ciò che gli empiristi inglesi del XVIII secolo chiamavano gusto, o meglio, buon
gusto 339. E’ attraverso il gusto (d’ora in avanti daremo per sottinteso che si tratta di buon
gusto) che il critico, o anche l’appassionato d’arte sufficientemente colto e sensibile,
nell’esperire un’opera d’arte ne soppesa le diverse qualità e difetti, ovvero valuta il modo
(ovvero il grado di coesione formale) in cui le diverse proprietà estetiche dell’opera, nonché le
reazioni che esse provocano, si amalgamano tra loro; quando tale modo presenta un certo
grado di coerenza, che si riflette nell’esperienza stessa dell’opera, quest’esperienza è
naturalmente accompagnata da un piacere che, in quanto riflessivo e superiore alla reazione
suscitata dalle singole qualità dell’opera, legittima il soggetto giudicante ad attribuire la
proprietà della bellezza all’opera in questione.
Dobbiamo ora chiederci se esiste un sufficiente grado di uniformità, anche solo tra critici
ed esperti, nell’esercizio del gusto. Gli empiristi britannici del diciottesimo secolo, a lungo
impegnati nella ricerca dello standard of taste, ci insegnano però che permangono sempre,
almeno a livello teorico, delle differenze di gusto ineliminabili anche tra persone altamente
qualificate a giudicare del valore di un’opera d’arte. La lezione ereditata da questi filosofi è
stata pienamente assorbita dai filosofi analitici contemporanei, i quali sono pressoché tutti
concordi nel ribadire il punto appena esposto. Tra questi, Alan Goldman è uno dei più risoluti
nell’affermare che perfino tra i critici ideali (di nuovo viene usato qui un termine di chiara
ascendenza humiana) sono riscontrabili delle differenze di gusto, dovute alle diverse attitudini
che essi hanno nei confronti di determinati stili, forme o generi 340. Lo stesso Levinson, che
pure si professa un realista (estetico) moderato, riconosce che tra persone qualificate come ad
esempio i critici esistono delle differenze di gusto, da lui denominate differenze di “sensibilità
attitudinale”, che li portano a reagire con atteggiamenti diversi − di favore o sfavore, di
approvazione o disapprovazione, di piacere o disgusto − alle medesime proprietà estetiche, sia
prese in se stesse sia considerate in relazione alle altre proprietà estetiche, e che li portano
quindi ad esprimere giudizi talvolta discordanti sul valore estetico, ovvero sulla bellezza o 339 La precisazione è dovuta, dal momento che gli empiristi britannici del diciottesimo secolo distinguevano tra gusto e buon gusto, identificando il primo termine con una capacità principalmente percettivo-discriminatoria (che Hume chiamava “delicatezza del gusto”) inferiore a quella sottesa al secondo termine, che indicava invece la capacità, propria dell’intelletto (in collaborazione con la sensibilità e con l’immaginazione), di cogliere “la coerenza e l’unità dell’insieme”, ovvero, in ultimo, di attribuire o meno la qualità della bellezza a un’opera d’arte (David Hume, On the Standard of Taste (1757), trad. it. Sul Canone del gusto, in M. M. Rossi (a cura di), L’Estetica dell’Empirismo Inglese, Sansoni, Firenze 1944, p. 586). 340 Alan Goldman, Aesthetic Value, cit., pp. 176-7.
189
sulla bruttezza, di una determinata opera d’arte 341. Se quanto detto dagli empiristi inglesi del
diciottesimo secolo prima e dai filosofi analitici contemporanei poi − ovvero che esistono
dispute irresolubili tra critici ed esperti in materia di valore estetico − è vero, dobbiamo allora
concludere che la prova percettiva sostenuta da Sibley, almeno al livello delle proprietà
intrinsecamente valutative, non è sostenibile.
Come detto, il valore estetico, ovvero artistico, di un’opera, sopravviene sulle altre
proprietà estetiche; esso è solo il vertice di una costruzione piramidale, i cui piani sottostanti
devono ancora essere testati. Possiamo quindi dire che esiste almeno un’oggettività nella
percezione delle singole proprietà estetiche, se non nel modo in cui esse si combinano e
conducono al valore artistico di un’opera? I.C. Vaida risponde negativamente a questa
domanda, e a sostegno della sua tesi fornisce delle prove a mio avviso incontrovertibili 342.
Innanzitutto, Vaida osserva che proprietà secondarie come i colori sono proprietà percettive
semplici, la rilevazione delle quali implica il solo esercizio di abilità fisiche che la maggior
parte delle persone fisicamente sane possiede più o meno allo stesso grado. Viceversa le
proprietà estetiche sono proprietà percettive più complesse (non a caso parliamo per esse di
percezione in senso largo o ampio, come abbiamo visto prima), in quanto sopravvengono
sulle proprietà strutturali sottostanti (tra cui vi sono anche quelle cromatiche) e chiamano in
causa, oltre alle abilità fisiche di un soggetto, anche la sua sensibilità affettiva e le sue
capacità immaginative e intellettive, le quali interagiscono tra loro in più modi e possono
variare in maniera consistente da persona a persona. La maggiore complessità delle
attribuzioni estetiche rispetto ad esempio a quelle cromatiche comporta anche la minore
scientificità del linguaggio estetico rispetto a quello cromatico; il che è un ulteriore indice del
fatto che la sensibilità estetica (col quale termine si intende quel gioco di capacità percettive,
emotive e intellettive che la rilevazione delle proprietà estetiche richiede) è assai meno
uniforme delle abilità fisico-percettive richieste per la rilevazione delle proprietà secondarie.
Possiamo infatti distinguere, afferma Vaida, la ‘grazia’ di un dipinto dalla ‘monumentalità’ di
un altro dipinto, così come distinguiamo un oggetto rosso da un oggetto blu; ma non possiamo
distinguere la grazia di un dipinto dalla grazia di un altro dipinto con la stessa precisione con
cui distinguiamo un rosso 16 da un rosso 18 (ovvero due diverse gradazioni di rosso).
Il motivo dell’imprecisione del linguaggio estetico sta in una caratteristica delle
attribuzioni estetiche già sottolineata da Sibley, e identificata da Vaida con la presenza di una
341 J. Levinson, “Aesthetic Properties, Evaluative Force and Differences of Sensibility”, cit., pp. 329-332. 342 Iuliana Corina Vaida, “The Quest for Objectivity: Secondary Qualities and Aesthetic Qualities”, The Journal of Aesthetics and Art Criticism 56 (1998), pp. 283-297.
190
componente “indicista” (indexicalist) in tali attribuzioni. La grazia che assegniamo a un dato
dipinto è un tipo specifico di grazia, e non una generica qualità che va sotto il nome di grazia:
per quanto noi possiamo avere familiarità con altri dipinti graziosi, quand’anche fossero
realizzati dallo stesso autore e per quanta conoscenza noi possiamo avere della poetica
dell’autore e delle proprietà non-estetiche dei suoi dipinti, è solo attraverso l’esperienza
diretta del dipinto in questione che potremo percepirne la grazia. Ciò che Vaida vuole qui
farci capire, e che riprende le considerazioni di Sibley circa la particolarità dei giudizi estetici,
è ulteriormente chiarito da Arnold Isenberg, il quale afferma (ancor prima dei due autori
citati) che la percezione diretta (pur intesa in senso ampio) di un oggetto ne completa la
descrizione estetica 343. Con questa frase Isenberg intende dire che i termini estetici sono
termini generali dotati di una componente dimostrativa nascosta − essi registrano una
relazione di similarità approssimativa tra oggetti graziosi, ma non ci forniscono delle
condizioni positive di applicazione del termine ‘grazioso’ (anche questo è un punto ben
chiarito da Sibley, come visto in precedenza). Ciò è peraltro confermato, aggiunge Vaida, dal
modo in cui impariamo ad usare i termini estetici. Difatti, proprio in conseguenza del fatto
che i termini estetici sopravvengono su (ovvero dipendono da, ma non sono riducibili a) i
termini non-estetici sottostanti, noi impariamo ad utilizzarli e ad attribuirli a determinati
oggetti non tanto in seguito all’apprendimento di norme, ovvero di generalizzazioni induttive
relative al rapporto tra proprietà estetiche e non-estetiche, quanto piuttosto “per ostensione”,
ovvero attraverso il “riferimento ad esempi e a paradigmi artistici”: un’opera d’arte è quindi
‘graziosa’ se esibisce “una somiglianza rilevante con dei paradigmi riconosciuti di grazia” 344.
Dato però che non possiamo inferire la qualità della ‘grazia’ dagli attributi non-estetici
dell’opera, tale somiglianza riguarderà più le esperienze che uno stesso soggetto ha di diversi
oggetti ‘graziosi’, che non le caratteristiche strutturali (degli oggetti) che pure di tali
esperienze sono il fondamento. Inoltre, dal momento che ogni oggetto è grazioso nel suo
particolare e irripetibile modo, il significato che assegniamo al termine ‘grazioso’ cambierà in
relazione ai paradigmi artistici di grazia ai quali facciamo riferimento nel nostro giudizio su
un particolare oggetto o opera d’arte.
Le argomentazioni usate da Vaida (e dagli altri autori citati) conducono verso un
relativismo soggettivista delle attribuzioni estetiche. C’è però ancora una possibilità di salvare
il realismo estetico, che fa appello all’esistenza di una componente descrittiva delle
343Arnold Isenberg, “Critical Communication” (1949), ora in A. Neill e A. Ridley (a cura di), cit., pp. 363-373. 344 Iuliana Corina Vaida, “The Quest for Objectivity: Secondary Qualities and Aesthetic Qualities”, cit., p. 293. Concetti del tutto analoghi si possono trovare anche in J. Levinson, “Aesthetic Properties, Evaluative Force and Differences of Sensibility”, cit., pp. 323-4.
191
attribuzioni estetiche stesse: se la prova percettiva vale per questa componente, che è la base
di tutte le proprietà estetiche, allora l’intera costruzione piramidale in cui queste si articolano
e che ha il suo vertice nella bellezza riceverà solidità e stabilità. Il primo problema che i
difensori del realismo devono qui affrontare è costituito dal fatto che tale componente
descrittiva, pur essendo preponderante nelle proprietà formali, ovvero in quelle proprietà
estetiche maggiormente ancorate alla base strutturale sottostante, tende a scemare man mano
che si passa a considerare le proprietà estetiche non-formali, le quali sono maggiormente
response-dependent, ovvero emergenti su tale base. Secondo Levinson tale problema non è
insolubile, dato che possiamo sempre approssimare le proprietà estetiche non-formali con
determinati insiemi di termini descrittivi, corrispondenti alle impressioni fenomeniche
prodotte dalla base strutturale sottostante 345. Il termine estetico ‘sgargiante’ può ad esempio
essere approssimato con termini descrittivi come ‘brillante’, ‘non-armonico’ e ‘con
combinazioni di colore vistose’. Su questi ultimi termini, che costituiscono il contenuto
descrittivo di un oggetto, tutti i critici (ovvero gli osservatori qualificati) concordano; le
differenze di giudizio sorgono quando essi devono esprimere la loro approvazione o
disapprovazione nei confronti di tale contenuto. Da alcuni, quindi, il medesimo contenuto
(ovvero termini come ‘brillante’, ‘non-armonico’, ecc.) sarà chiamato ‘sgargiante’, da altri
invece ‘intensamente cromatico’: entrambi i termini aggiungono delle valutazioni (non a caso
parliamo di proprietà a valutazione aggiunta) ad un nucleo neutrale condiviso (il contenuto
descrittivo), le quali valutazioni differiscono tra loro tanto in virtù delle diverse reazioni (di
favore o sfavore) dei critici a tale nucleo, quanto in considerazione del rapporto tra i diversi
termini a valutazione aggiunta che costituiscono un oggetto estetico (abbiamo infatti visto
come la bellezza di un oggetto dipenda dal modo in cui le diverse proprietà estetiche si
fondono insieme). In quest’ultimo caso è all’opera una sensibilità di tipo attitudinale (ovvero
la disposizione a reagire con reazione di favore o sfavore a determinate impressioni
fenomeniche), che come visto può variare da critico a critico; la rilevazione del contenuto
descrittivo di un termine estetico (a valutazione aggiunta) dipende invece da una sensibilità di
tipo percettivo (ovvero dalla disposizione a ricevere una determinata impressione fenomenica
in seguito alla percezione di un certo insieme di proprietà non-estetiche), per la quale è lecito,
secondo Levinson, attendersi una generale convergenza tra i critici. E’ quindi grazie
all’esistenza di un contenuto descrittivo comune alle diverse attribuzioni estetiche (siano esse
345 J. Levinson, “Aesthetic Properties, Evaluative Force and Differences of Sensibility”, cit., pp. 315-335.
192
descrittive, a valutazione aggiunta o intrinsecamente valutative) che queste possono dirsi
oggettive, e che il realismo estetico può ancora essere sostenuto.
La difesa del realismo estetico tentata da Levinson è però contestabile per due motivi,
puntualmente rilevati da John Bender 346. A creare difficoltà è innanzitutto l’idea che le
attribuzioni estetiche a valutazione aggiunta possano essere approssimate con determinate
attribuzioni descrittive. Levinson ritiene che le seconde costituiscano delle “descrizioni
alternative” delle prime, con ciò affermando la quasi interscambiabilità tra i due insiemi di
proprietà (scambio che è impedito solo dal sopraggiungere di un atto valutativo). Se ciò fosse
vero, sostiene Bender, il prezzo da pagare sarebbe alto, in quanto verrebbe meno la specificità
dei termini estetici (in particolare di quelli non-formali); specificità che consiste non solo,
come dice Bender, nella “sottigliezza” delle descrizioni estetiche (che verrebbero invece
appiattite su un comune nucleo descrittivo), ma anche, aggiungiamo noi, nel loro essere
response-dependent in un modo specifico. Nell’approssimare le proprietà estetiche a un
contenuto descrittivo neutrale, Levinson sembra dimenticarsi del fatto (fondamentale) che
esse sono oggetto di una percezione ampia, in quanto implicante una risposta soggettiva che
coinvolge tanto la percezione in senso stretto quanto le capacità affettive e intellettive. La
reazione che un critico prova di fronte a una determinata proprietà estetica di un’opera d’arte
non si riduce all’approvazione o alla disapprovazione (che sono espressioni della sua
sensibilità attitudinale), ma è costituita prima ancora dalla sua risposta emotiva (che è
espressione di quella che prima abbiamo chiamato sensibilità estetica): senza quest’ultima
nemmeno la prima sarebbe possibile, poiché le proprietà estetiche, prima ancora che essere
termini a valutazione aggiunta, sono proprietà response-dependent.
La completa approssimazione delle proprietà estetiche con un nucleo descrittivo neutrale è
quindi impossibile da realizzare. Quand’anche poi fosse possibile, ciò non risolverebbe il
problema del realismo estetico. Bender contesta infatti a Levinson anche l’assunto secondo
cui vi sia, nella sensibilità percettiva (ovvero della sensibilità responsabile della rilevazione
del contenuto descrittivo di un attributo estetico), una uniformità che non è invece
riscontrabile nella sensibilità attitudinale (ovvero nella sensibilità responsabile della
valutazione estetica di un’opera) o, aggiungiamo noi, nella sensibilità estetica (ovvero nella
sensibilità responsabile della reazione emotiva alle proprietà estetiche). Non è affatto sicuro,
afferma Bender, che un dipinto descritto da me come ‘sgargiante’ e da un’altra persona come
‘intensamente cromatico’ produca in entrambi la stessa impressione fenomenica; sostenere
346 John Bender, “Realism, Supervenience and Irresolvable Aesthetics Disputes”, (1996), trad. it. “Realismo, sopravvenienza e alcune dispute estetiche insolubili”, in Studi di Estetica 34 (2006), pp. 32-57.
193
che ad ogni attributo estetico sia associabile una determinata impressione fenomenica
significa difendere una “forma discutibile (e superficiale) di psicologia cognitiva” 347. Ciò su
cui possiamo trovarci tutti d’accordo quando attribuiamo ad un quadro delle proprietà come
‘sgargiante’ o ‘intensamente cromatico’, o quando descriviamo un brano musicale come
‘sferzante’ o ‘vigoroso’, è l’insieme delle proprietà non-estetiche (linee, colori, ritmi, melodie,
ecc.) del quadro e del brano in questione. L’impressione fenomenica che ricaviamo da queste
ultime, e che costituisce la componente descrittiva delle proprietà estetiche appena citate,
dipende a sua volta dalla percezione di quanto siano preminenti certi ritmi o certi colori, di
come siano connesse le cellule melodiche o le linee, e via dicendo, ovvero dalla percezione
del grado in cui tali attributi non-estetici sono presenti (nel dipinto o nel brano) e si
rapportano tra loro; laddove il ‘quanto’ e il ‘come’, ovvero il ‘grado’, non sono determinabili
oggettivamente ma dipendono dalla riposta complessa e personale del soggetto giudicante 348.
Anche in questo caso abbiamo quindi a che fare con una percezione in senso largo o ampio, in
quanto costituita dalla sintesi soggettiva degli elementi percettivi non-estetici, e non da una
loro oggettiva registrazione − il che peraltro è confermato dallo stesso Levinson quando
afferma che l’impressione fenomenica globale è costituita, oltre che da elementi percettivo-
gestaltici, anche da elementi affettivi (che accompagnano la percezione) e intellettivi (che
talvolta guidano la percezione stessa) 349. Ciò significa che la sensibilità percettiva non è poi
così diversa dalla sensibilità estetica e da quella attitudinale, e non può reclamare per sé un
grado di uniformità superiore rispetto a queste; ne consegue altresì che la prova percettiva
fallisce anche per ciò che concerne sia le proprietà formali sia, in generale, le componenti
descrittive di tutte le proprietà estetiche di un’opera d’arte. Non solo il vertice e i piani
intermedi della piramide entro cui i diversi insiemi di proprietà estetiche si dispongono sono
traballanti, ma nemmeno le fondamenta sono solide.
La conclusione inevitabile alla quale l’analisi dei vari tentativi compiuti per difendere il
realismo estetico ci ha condotti è che non sembra possibile sostenere l’oggettività delle
347 Ivi, p. 45. 348 Ivi, pp. 39-47. Il giudizio di grado è, come sottolinea giustamente Bender, una questione di sensibilità soggettiva, di gusto, se non addirittura di valutazione: le differenze tra una rappresentazione troppo o poco ‘bilanciata’ o tra un movimento sufficientemente ‘energico’ o eccessivamente ‘debole’ sono differenze sottili e non misurabili. 349 J. Levinson, “Aesthetic Properties, Evaluative Force and Differences of Sensibility”, cit., p. 323. Anche qui il parallelo con le nozioni settecentesche di gusto e buon gusto può esserci d’aiuto. Sappiamo infatti che ciò che i filosofi britannici intendevano col termine gusto, che pure era associato ad una capacità discriminatoria vicina alla percezione sensibile ed era considerato quindi inferiore al buon gusto, consisteva di fatto in un’attività di sintesi soggettiva che ci impedisce di ridurla alla percezione sensibile stessa. Ciò che è vero per il gusto degli empiristi inglesi del Settecento, è vero anche per la sensibilità percettiva di cui parlano i filosofi analitici contemporanei.
194
proprietà estetiche mantenendo insieme la teoria della sopravvenienza estetica. Ciò che difatti
tale teoria afferma è sia la non riducibilità delle proprietà intrinsecamente valutative alle altre
proprietà estetiche (sopravvenienza di secondo livello, o aesthetic-value supervenience), sia
soprattutto la non riducibilità di queste ultime alle proprietà non-estetiche sottostanti
(sopravvenienza di primo livello, o aesthetic supervenience). Le proprietà estetiche (da quelle
formali-descrittive a quelle non-formali e a valutazione aggiunta, fino ad arrivare a quelle
intrinsecamente valutative) sono tutte, seppur in grado e modalità variabile, response-
dependent; ovvero, non sono percepibili senza che vi sia una determinata reazione di tipo
esperienziale nel soggetto che le percepisce. Tale reazione non raggiunge lo stesso livello di
uniformità che si può a buon diritto predicare per le impressioni fenomeniche associate alla
percezione di proprietà secondarie come ad esempio i colori. Mentre infatti in quest’ultimo
caso è in gioco una percezione ‘stretta’, ovvero limitata ad operazioni percettive comuni a
tutte le persone fisicamente sane poste in condizioni standard di osservazione, la percezione
che ci permette di rilevare le proprietà estetiche è una percezione ‘ampia’ (o larga), ovvero
implicante tanto la percezione ‘stretta’ quanto la partecipazione di altre facoltà (sensibilità,
emotività, immaginazione, intelletto), la cui interazione (Kant direbbe gioco) è assai meno
prevedibile e può causare esperienze diverse in soggetti differenti ma egualmente abili e posti
in condizioni standard di osservazione di una medesima opera.
Alcuni tra i sostenitori del realismo estetico hanno proposto allora l’abbandono della teoria
della sopravvenienza estetica 350. Rifiutare la teoria della sopravvenienza significherebbe però
regredire a un riduzionismo fisico che, facendo collassare le proprietà estetiche su quelle non-
estetiche, ci precluderebbe di fatto la possibilità di spiegare la specificità delle prime rispetto
alle seconde e insieme anche il particolare fascino che le opere d’arte esercitano su di noi in
virtù del loro spiccato carattere e valore estetico 351. Si può forse accusare la teoria della
sopravvenienza di non essere sufficientemente esplicativa, in quanto non ci dice che tipo di
dipendenza sia quella che lega le proprietà sopravvenienti a quelle sottovenienti; ma non si
può negare che tale relazione di dipendenza, co-varianza e non riducibilità tra proprietà
estetiche e non-estetiche vi sia, ragion per cui la teoria della sopravvenienza è casomai “fin
troppo evidentemente vera” 352. Altri ancora hanno invece proposto di relativizzare la
sopravvenienza a dei gruppi di sensibilità (attitudinale), all’interno dei quali è lecito attendersi
350 Vedi ad es. Marcia Mulder Eaton, “The Intrinsic, Non-Supervenient Nature of Aesthetic Properties”, Journal of Aesthetics and Art Criticism 52 (1994), pp. 383-97. 351 Su questo punto si veda J. Levinson, “Aesthetic Supervenience”, cit., pp. 153-55. 352 Alfonso Ottobre, “La sopravvenienza estetica”, Rivista di Estetica 36 (2007), p. 225.
195
una certa uniformità di giudizio 353. Ciò salverebbe l’oggettività delle proprietà estetiche,
seppur limitatamente a certi standard del gusto, ovvero a determinati ordini di valore
(estetico) condivisi da particolari gruppi di critici o esperti; laddove tra gruppi diversi (ovvero
tra diversi standard del gusto) permarrebbero delle differenze insolubili in materia di giudizio
e di attribuzione delle proprietà estetiche a un medesimo oggetto. Anche questa proposta però,
seppur più moderata della prima, non è in definitiva percorribile. Innanzitutto, come
sottolinea Bender, la relativizzazione suggerita da Goldman, se accettata, snaturerebbe il
concetto stesso di sopravvenienza, in quanto a uno stesso oggetto potrebbero essere attribuite,
in virtù di un semplice “slittamento del gusto”, delle proprietà estetiche diverse e contrastanti,
pur rimanendo intatti i suoi attributi non-estetici; il che negherebbe i principi di dipendenza e
co-varianza impliciti nella nozione di sopravvenienza 354. Ma soprattutto, bisogna di nuovo
sottolineare il fatto che le differenze di (buon) gusto, ovvero di sensibilità attitudinale, non
sono le uniche responsabili della non uniformità delle attribuzioni estetiche a uno stesso
oggetto, dato che la percezione delle proprietà estetiche (e non solo la loro valutazione)
comporta sempre una sintesi soggettiva complessa e difficilmente prevedibile.
La strada da seguire è un’altra. Se si vuole mantenere la teoria della sopravvenienza, come
credo sia necessario, occorre riconoscere una certa dose di soggettività nell’attribuzione delle
proprietà estetiche a un oggetto. Ciò non significa però cedere del tutto all’antirealismo o al
relativismo estetico assoluto. Abbiamo infatti esempi di opere d’arte il cui carattere e il cui
valore estetico non sono in discussione, e che si avvicinano quindi a un alto grado di
oggettività. Chi mai potrebbe negare, si domanda retoricamente Levinson, che “l’apertura
della Nona Sinfonia di Beethoven è oscura e densa di presagi? Che Broadway Boogie-Woogie
di Mondrian è vibrante ed esuberante? Che Uccello nello Spazio di Brancusi è levigato ed
elegante? Che Vertigo di Hitchcock è tragico e angosciante?” 355. Se è vero allora, come
sostiene Vaida, che l’attribuzione delle proprietà estetiche si apprende e si sviluppa per
ostensione, ovvero per confronto con dei casi esemplari e paradigmatici, e se è vero altresì,
come sostengono le definizioni storiche e come conferma lo studio comparato delle culture,
che la storia dell’arte è costellata di opere paradigmatiche dal carattere e dal valore estetico
stabili e (quasi) oggettivi, allora è proprio dal confronto con la storia dell’arte che dobbiamo
ripartire per limitare, per quanto possibile, la soggettività delle attribuzioni estetiche e per
rendere più sicuro e meno vago il criterio di identificazione delle opere d’arte che la
353 Vedi Alan Goldman, “Realism About Aesthetic Properties”, The Journal of Aesthetics and Art Criticism 51 (1993), pp. 31-37. 354 John Bender, “Realismo, sopravvenienza e alcune dispute estetiche insolubili”, cit., pp. 35-9. 355 J. Levinson, “Aesthetic Properties, Evaluative Force and Differences of Sensibility”, cit., p. 335.
196
definizione estetica neo-formalista ci ha fornito. Un siffatto metodo comparativo chiama
nuovamente in causa la definizione storica dell’arte di Levinson, secondo modalità in parte
prefigurate dallo stesso autore e che verranno esplorate nel prossimo capitolo.
197
CAPITOLO SESTO
Giudicare l’arte storicamente
L’analisi delle definizioni storiche dell’arte effettuata nei primi tre capitoli, pur lasciandoci
insoddisfatti relativamente agli scopi che tali definizioni si sono poste, ci ha altresì fornito lo
spunto per iniziare una investigazione archeologica verso le origini dell’arte. Questa
investigazione è stata l’oggetto del quarto capitolo e ci ha condotto verso la scoperta
dell’origine estetica dell’arte, che insieme rappresenta l’essenza di ogni opera d’arte presente,
passata e futura. Su tale base estetica abbiamo poi ricavato nel quinto capitolo il seguente
criterio di classificazione e valutazione delle opere d’arte: un oggetto è un’opera d’arte se, in
virtù delle proprietà formali possedute, esso soddisfa la sua primaria funzione estetica. Se si
specifica, come abbiamo fatto, che le proprietà formali consistono nell’unione di forma e
contenuto e che la funzione estetica è identificabile con la produzione di un’esperienza
estetica soddisfacente (a sua volta fonte del valore estetico, ovvero artistico), la definizione
così ottenuta (e che possiamo chiamare definizione estetica neo-formalista) soddisfa i
principali requisiti che una definizione dell’arte in generale, e una definizione estetica in
particolare, deve assolvere. Il criterio che abbiamo a disposizione è però difficile da applicare,
in virtù della natura sopravveniente delle proprietà dalla cui discriminazione dipendono la
classificazione e la valutazione di un’opera d’arte. Considerato il fatto che la sopravvenienza
estetica è duplice e partendo quindi dall’alto, ovvero dal secondo livello di sopravvenienza,
abbiamo constatato come le proprietà intrinsecamente valutative dipendono, per la loro
rilevazione, dalla sensibilità attitudinale, ovvero dal (buon) gusto, che è una capacità non solo
posseduta da pochi individui (i critici o gli esperti), ma che può generare discrepanze
insolubili perfino all’interno di questa ristretta cerchia.
Scendendo al primo livello di sopravvenienza, abbiamo visto che le proprietà estetiche a
valutazione aggiunte o descrittive, ovvero contenuto e forma di un’opera d’arte, non sono
percepibili senza che le facoltà percettive, affettive e intellettive del soggetto entrino in gioco
e producano una sintesi soggettiva delle proprietà non-estetiche dell’opera in questione.
Questo gioco di facoltà, che prende il nome alternativamente di sensibilità estetica o
percettiva (a seconda che ci si riferisca alle proprietà estetiche non-formali o a quelle formali,
ovvero alla componente descrittiva di ogni proprietà estetica), può presentare sensibili
oscillazioni, se non proprio discrepanze, tra un soggetto e un altro, nella stessa maniera in cui
198
lo standard del gusto può far discutere tra loro due critici egualmente qualificati a giudicare
del valore di un’opera. Di contro a tale disuniformità, che a livello teorico potrebbe impedire
l’applicabilità di un criterio definitorio di tipo estetico, la storia dell’arte è testimone tuttavia
di come esista di fatto una vasta uniformità e convergenza nei giudizi estetici relativi a un
cospicuo numero di opere d’arte, che sono perciò dette paradigmatiche. Dato che è proprio
grazie al confronto con i casi esemplari e paradigmatici che apprendiamo il significato e
l’utilizzo dei termini estetici (da quelli formali a quelli non-formali e ai termini
intrinsecamente valutativi), sarà allora alla storia dell’arte che dovremo attingere per
stabilizzare il nostro criterio, così come da essa siamo partiti per ricercarlo. Nel far ciò,
ovvero nello sviluppare un metodo di giudizio estetico comparativo, dovremo tener conto del
fatto che la percezione delle proprietà estetiche è accompagnata sempre da una reazione
soggettiva dalla quale non è separabile; pertanto il confronto tra opere d’arte sarà anche, se
non principalmente, un confronto tra esperienze estetiche. Prima però di entrare nel merito
della questione, può senz’altro esserci utile fare una ricognizione un po’ più approfondita del
cammino che abbiamo fin qui percorso e riallacciare le fila con la definizione storica dell’arte,
dalla quale siamo partiti e alla quale ci accingiamo a tornare, sebbene con intenti diversi da
quelli che avevamo all’inizio.
6.1 Dalla storia all’opera
Il punto di partenza del nostro studio è stata la definizione storico-intenzionale dell’arte di
Jerrold Levinson, di cui sono stati enucleati i concetti guida e sono stati presi in
considerazione pregi e difetti (primo capitolo). Il punto di approdo è invece rappresentato
dall’enunciazione e dalla difesa di una definizione estetica neo-formalista dell’arte (quinto
capitolo). Ciò può sembrare a prima vista paradossale, ma cessa di esserlo non appena si
ripercorra il tragitto che ci ha condotti dall’una all’altra definizione. L’esame del fitto scambio
di obiezioni e repliche che è sorto intorno alla definizione di Levinson e che ha occupato il
secondo capitolo, si è concluso con una condanna in primo appello per quest’ultima. La
condanna era accompagnata però anche da un accenno alla strategia difensiva da adottare al
secondo appello. La strategia consisteva nel cercare di porre riparo ai difetti della definizione
storico-intenzionale attraverso una sua integrazione con elementi di tipo istituzionale o
funzionale. La prima alternativa ha prodotto le teoria stilistica di Carney e quella delle
narrazioni storiche di Carroll, la seconda ha preso forma nella definizione storico-
199
funzionalista di Stecker. La strategia si è però mostrata fallimentare in ambo i sensi, come il
terzo capitolo ha mostrato. Mentre tuttavia la prima delle due alternative era palesemente
inefficace, la seconda lasciava ancora aperto qualche spiraglio di salvezza. Si poteva dunque
tentare nella terza e ultima istanza di appello, ma per sperare in un successo bisognava
cambiare strategia difensiva. Ciò è quanto è stato fatto nel quarto capitolo. Qui la definizione
storica ha rivelato la sua fertilità teoretica non per le condizioni definitorie da essa proposte,
ma per la possibilità che essa ha dischiuso verso una ricerca, insieme filosofica e storica, delle
origini e dell’essenza universale dell’arte. Ciò che per Levinson era una possibilità teorica, è
stato messo in pratica da altri studiosi i quali, attraverso un metodo storico-comparativo, sono
risaliti verso l’origine delle tradizioni artistiche. Il riesame poi dei concetti guida delle teorie
di Levinson, Carney, Carroll e Stecker, ovvero delle nozioni di continuità e storicità, ci ha
permesso di legittimare l’identificazione di tale condizione originaria con l’essenza dell’arte
prodotta in ogni luogo e in ogni tempo, e di trasformare quella che era considerata una
condizione aggiuntiva e secondaria come l’unica condizione necessaria e sufficiente alla
classificazione e alla valutazione delle opere d’arte. Su tale condizione, che è di tipo estetico,
è stata costruita poi la definizione estetica neo-formalista esposta e difesa nel quinto capitolo.
Le definizioni storiche ci hanno quindi fornito la base per uno studio filosofico e storico
che ci ha condotti verso una definizione estetica dell’arte. Ma non è tutto. La stessa struttura
con cui abbiamo compiuto l’analisi del dibattito di obiezioni e repliche sorto intorno alla
definizione di Levinson ci ha suggerito l’ordine con cui procedere in questa indagine a ritroso
verso l’origine e l’essenza dell’arte. Nel secondo capitolo infatti, per testare la capacità della
definizione storico-intenzionale di fornire condizioni sufficienti all’artisticità, abbiamo
allargato il nostro campo di indagine fino ad estenderlo a tradizioni a noi lontane
geograficamente (le tradizioni non-occidentali) e temporalmente (le origini delle varie
tradizioni), per poi restringere il nostro obiettivo sulle singole opere d’arte e sul loro senso
intrinseco. La definizione storico-intenzionale non si è mostrata sufficiente a fornire un valido
criterio di identificazione artistica in ciascuno di questi campi, e alla condizione storico-
intenzionale è stato necessario affiancare una condizione di tipo funzionale. Ad una più
attenta analisi, la condizione indicata da Levinson si è mostrata non necessaria (sotto le
critiche fatali di Kolak); il che ha suggerito la possibilità che la condizione funzionale fosse la
sola condizione che dovesse rientrare in una definizione dell’arte. Ora, il medesimo percorso
dal generale al particolare è stato compiuto nel quarto capitolo, dove attraverso uno studio
storico comparativo e genealogico si è arrivati alla scoperta della condizione originaria
dell’arte, che è una condizione di tipo estetico. Nel quinto capitolo abbiamo cercato di vedere
200
come su di essa potesse essere costruita una definizione capace di dar conto dei concetti
chiave che erano presupposti da tale condizione, ovvero quelli di proprietà, piacere,
esperienza e valore estetico. La definizione così ottenuta, che è una definizione estetica neo-
formalista, si è rivelata in grado di fornire una condizione necessaria e sufficiente
all’artisticità. Questa condizione (identificata nella capacità di un oggetto di soddisfare una
funzione estetica attraverso il possesso di proprietà estetiche formali) deriva la sua necessità
dalla storia dell’arte delle diverse tradizioni culturali e dalla continuità con cui questa si è
sviluppata dalle origini sino ad oggi; inoltre essa è in grado di spiegare (ovvero di fornire
delle ragioni sufficienti) perché tradizioni culturali diverse o lontane dalla nostra sono
artistiche e perché in generale l’uomo crea le opere d’arte.
Il problema che dobbiamo ora affrontare è costituito dal fatto che la condizione di cui
siamo venuti alla scoperta, ovvero il criterio con cui possiamo classificare e valutare le opere
d’arte, è di difficile applicazione. Si tratta tuttavia di una difficoltà che, pur essendo
ineliminabile in quanto legata alla natura sopravveniente delle proprietà estetiche, può essere
notevolmente ridotta se si studia più da vicino il modo in cui tale criterio viene utilizzato da
coloro i quali per mestiere esprimono giudizi circa la classificazione e il valore dell’arte,
ovvero i critici e gli esperti. Come Sibley ha mirabilmente chiarito nella seconda parte del più
volte citato saggio Aesthetic Concepts, l’attività critica si compone principalmente di due fasi:
la prima consiste nel sottolineare il collegamento che il critico rileva tra le proprietà non-
estetiche possedute da un’opera d’arte e le proprietà estetiche da lui attribuite all’opera stessa,
mentre la seconda consiste nel rafforzare la validità di tale collegamento attraverso una serie
di stratagemmi, tra i quali spicca l’esercizio (effettuato in prima persona dal critico e da questi
consigliato al comune spettatore che si accinge a sua volta a dare un giudizio estetico) del
confronto tra l’opera in questione ed altre opere d’arte 356. Entrambe le fasi non mirano a
elaborare norme razionali per il giudizio critico-estetico, ma contribuiscono invece a
sviluppare e rafforzare la naturale tendenza dell’uomo ad assegnare attributi estetici a un
oggetto (in particolare a un’opera d’arte) in corrispondenza di determinate caratteristiche
strutturali e in seguito alla somiglianza con altre opere che suscitano in noi un’analoga
reazione. Né le proprietà estetiche né le opere d’arte, afferma giustamente Sibley, sono enti
356 Frank Sibley, “Aesthetic Concepts”, cit., pp. 323-331. In realtà Sibley distingue sette fasi dell’attività critica, che sono state da me raggruppate in due fasi, in maniera tale da rispettare comunque l’ordine seguito da Sibley nell’elencarle. Solitamente si tende a prendere in considerazione esclusivamente la prima parte di Aesthetic Concepts (dove il rapporto tra proprietà estetiche e non-estetiche è analizzato da un punto di vista teoretico) a discapito della seconda parte del saggio (dove tale rapporto è analizzato in relazione all’attività critica), che, come sottolinea Mackinnon, è egualmente importante e ricca di spunti (vedi John Mackinnon, “Scruton, Sibley, and Supervenience”, The Journal of Aesthetics and Art Criticism 58 (2000), pp. 383-392).
201
esoterici o inafferrabili: man mano che acquistiamo familiarità con essi nella maniera appena
citata, saremo in grado di assegnare le une e di classificare e giudicare le altre con correttezza
sempre maggiore. Ovviamente più ci riferiamo a proprietà descrittive, ovvero alle proprietà
maggiormente ancorate alla base non-estetica sottostante, più sarà la prima fase del giudizio
critico a prevalere; più ci spostiamo invece verso l’altro versante dello spettro delle proprietà
estetiche, ovvero verso quelle maggiormente emergenti e response-dependent, più sarà
l’esercizio del confronto con altre opere d’arte, in particolare con quelle paradigmatiche, ad
esserci d’aiuto.
Si tratta allora di ripercorrere a ritroso il cammino che abbiamo intrapreso nel capitolo
quarto (a sua volta suggerito dall’esame della condizione storico-intenzionale compiuto nel
capitolo secondo) e che ci ha portato all’elaborazione di un criterio di classificazione e
valutazione dell’arte di tipo estetico. Allora siamo partiti dal generale, ovvero dalla ricerca
delle proprietà e delle funzioni comuni alle opere che si sono succedute nel corso della storia
dell’arte (occidentale e non), per arrivare al particolare, ovvero allo studio della relazione tra
tali proprietà e tali funzioni all’interno di una singola opera d’arte; ora dobbiamo invece
partire dalla struttura interna alla singola opera d’arte, ovvero al rapporto (interno all’opera)
tra le proprietà non-estetiche e quelle estetiche, per poi estendere il nostro campo di indagine
e sottoporre l’opera a un confronto graduale con le opere d’arte prodotte dallo stesso autore,
dalla stessa scuola o dalla stessa tradizione, e infine con i capolavori riconosciuti che
travalicano i confini nazionali, stilistici e temporali. Questo percorso ci permetterà di rendere
più sicure e stabili tanto l’attribuzione a un’opera d’arte delle proprietà estetiche (nell’ordine)
formali, non-formali e intrinsecamente valutative, quanto di conseguenza la classificazione e
la valutazione dell’opera stessa. Nel far ciò non dovremo dimenticarci del fatto che le
proprietà estetiche sono tutte, in grado diverso, response-dependent, e che il loro
riconoscimento va di pari passo con la produzione di una determinata esperienza nel soggetto
giudicante. Pertanto le tre fasi in cui il processo di perfezionamento del criterio estetico di
classificazione e valutazione dell’arte si articola e che verranno discusse nel prossimo
paragrafo, saranno associate ciascuna ad uno specifico stadio nello sviluppo dell’esperienza
estetica che la percezione delle proprietà estetiche di volta in volta produce e che prenderà il
nome (nell’ordine) di rimodellamento, estensione e innalzamento dell’esperienza.
202
6.2 Dall’opera alla storia
A) RIMODELLARE L’ESPERIENZA
“… una linea scura segna i contorni, e con elastico zigzagare che imprime a tutta la composizione
un forte impulso dinamico, costruisce una griglia che dinamizza l’immagine raccordando in modo mai
arbitrario le suggestioni delle forme e i limiti dei piani d’interferenza” (tratto da un commento sul
quadro Ritmo di danza di Gino Severini).
“L’ultimo movimento è scritto in forma di rondò; il tema principale riappare più volte per dare
unità ai diversi e contrastanti episodi che si succedono secondo un contrappunto continuo di grande
ingenuità ed estrema chiarezza ed equilibrio” (tratto da un commento sul movimento finale del
Concerto per piano e orchestra n. 3 di Bela Bartòk).
I commenti riportati rappresentano il modo in cui l’attività critica si esplica nella sua prima
fase e raggiunge il suo massimo grado di scientificità. Attraverso essi il critico fornisce delle
ragioni a sostegno del suo giudizio circa il particolare carattere estetico di un’opera d’arte;
ragioni che consistono nelle specifiche proprietà non-estetiche possedute dall’opera e ritenute
responsabili del suddetto carattere. Egli in questa fase non fa altro che assegnare all’opera
determinati attributi estetici e indicare le proprietà non-estetiche che a suo avviso ne stanno a
fondamento. Il valore di verità del giudizio critico-estetico in questa fase sarà perciò tanto
maggiore quanto più sarà riferito alle proprietà estetiche meno emergenti e più ancorate alle
proprietà non-estetiche sottostanti: tali sono le proprietà formali e, in misura minore, le
proprietà stilistiche e storico-relazionali 357. Tale fase è peraltro parallela a quella che per
Hume era la fase iniziale del perfezionamento del gusto, quella cioè caratterizzata dall’esame
ripetuto delle relazioni percettive tra le parti di un’opera e dall’allenamento delle nostre
capacità discriminatorie 358.
Nel parlare di scientificità del discorso critico non si deve tuttavia intendere l’espressione
in senso letterale. Le ragioni che il critico cita a sostegno dei suoi giudizi sono infatti sempre
le giustificazioni di un giudizio particolare, che aspira kantianamente all’universalità in virtù
di una uniformità presupposta ma non verificabile nella sensibilità percettiva della comunità
delle persone giudicanti. Da questi giudizi non possiamo quindi ricavare delle norme da
applicare analiticamente a qualsiasi opera d’arte; anche laddove si verificasse un’ampia
357 Queste ultime sopravvengono sulle nozioni di carattere contestuale e storico, che pure fanno parte della base non-estetica sottostante (oltre a quelle strutturali che sono comunque preponderanti). 358 David Hume, Sul canone del gusto, cit., p. 582.
203
convergenza intorno a una particolare connessione tra proprietà non-estetiche e proprietà
estetiche, questa rimarrebbe pur sempre una generalizzazione la cui validità va verificata
soggettivamente e caso per caso. Questo significa che i commenti critici simili a quelli qui
riportati possono essere compresi solo mettendoli personalmente alla prova, ovvero facendo
noi stessi esperienza della particolare connessione, evidenziata dal critico, tra le proprietà di
un’opera: senza questo atto percettivo (in senso ampio), il giudizio non è completo. Ciò è
particolarmente evidente laddove abbiamo a che fare con giudizi relativi alle proprietà
estetiche espressive, le quali, pur essendo dipendenti dalle proprietà non-estetiche sottostanti
(fino ad essere talvolta addirittura impensabili senza di esse: si pensi all’effetto di gioia che
una tonalità maggiore o una combinazione di colori accesi produce pressoché sempre nello
spettatore), sono altresì fortemente response-dependent; ma riguarda anche le proprietà
formali. Anche queste infatti, pur essendo maggiormente descrittive e connesse alla base
strutturale non-estetica, abbisognano, per essere rilevate, di una sintesi soggettiva tra la
suddetta base e la facoltà percettive, affettive e intellettive del soggetto giudicante; sintesi che
si accompagna a un’esperienza unica e irripetibile nel soggetto stesso. Anche l’attribuzione di
proprietà estetiche formali a un oggetto (e in particolare a un’opera d’arte) richiede un
completamento esperienziale soggettivo, sebbene sia lecito supporre un maggiore grado di
uniformità tra le esperienze associate alla percezione di proprietà estetiche formali rispetto a
quello riscontrabile tra le esperienze associate alla percezione di proprietà estetiche non-
formali, e ciò in virtù del maggior ancoramento delle prime alla base strutturale.
Il vero scopo dei giudizi critici espressi in questa prima fase è quindi quello di rimodellare
la nostra esperienza estetica di un’opera d’arte, in modo da renderla il più possibile conforme
a quella ritenuta corretta (in quanto causata dalle proprietà, estetiche e non-estetiche, rilevanti
dell’opera) dal critico. Sottolineando la connessione tra certi attributi estetici e certe proprietà
non-estetiche di un’opera d’arte, il critico ci esorta ad osservare più attentamente queste
ultime e ad esperirle più approfonditamente: egli ci invita a ri-orientare la nostra attenzione
verso le caratteristiche strutturali dell’opera che altrimenti potrebbero sfuggirci, e a sviluppare
di conseguenza una nuova esperienza dell’opera stessa 359. Questo “secondo momento
dell’esperienza estetica”, ovvero l’ “esperienza post-critica”, può essere visto come il
completamento dell’ “esperienza pre-critica”, rispetto alla quale pure presenta delle
somiglianze 360. E’ questo il senso dell’invito humiano all’esperienza ripetuta e all’esercizio
359 Si veda su tale punto Marcus Hester, “Hume on Principles and Perceptual Ability”, Journal of Aesthetics and Art Criticism 37 (1979), pp. 295-302. 360 Arnold Isenberg, “Critical Communication”, cit., p. 371.
204
abitudinario delle nostre capacità discriminatorie. Alle volte però non basta seguire le
indicazioni dei critici ed esercitarsi ripetutamente, perché si raggiunga lo scopo prefissato.
Può succedere infatti che, pur prestando attenzione alle caratteristiche dell’opera rilevate dai
critici e pur ripetendo l’operazione più volte e in momenti diversi, ciononostante la nostra
esperienza dell’opera non ci permetta di riconoscerle le proprietà estetiche ad essa attribuite
dal critico o da altre persone qualificate. Ciò dipende dal fatto che, come chiarisce Pettit, le
proprietà estetiche, oltre ad essere “essenzialmente percettive”, sono anche “percettivamente
elusive”: non solo esse possono essere rilevate solo attraverso la percezione (in senso ampio)
diretta, ma nemmeno tale percezione può essere sufficiente a farci attribuire a una medesima
opera le stesse proprietà estetiche attribuite ad essa da altre persone parimenti qualificate 361.
Questa situazione può verificarsi soprattutto con le proprietà estetiche più emergenti e
response-dependent, ma nulla ci garantisce che non possa verificarsi anche per quelle
maggiormente descrittive. Quando ciò accade, ovvero quando la nostra esperienza, pur
correttamente e ripetutamente rimodellata, non si uniforma a quella del critico, significa che
siamo giunti al punto in cui, per dirla con Wittgenstein, “le spiegazioni hanno termine” 362.
Non si tratta tuttavia di un punto di non ritorno. Il critico ha ancora un’arma a sua
disposizione, con la quale può cercare di perfezionare ulteriormente l’esperienza già
rimodellata in questa prima fase: il metodo del confronto.
B) ESTENDERE L’ESPERIENZA
“Nei ritratti femminili, in particolare, si nota la costante ricerca di un’essenzialità espressiva di
immediata derivazione post-impressionista, in cui prevale l’eco di Cézanne, elaborato dall’artista
marchigiano attraverso l’uso di tonalità sempre molto delicate che privano la figura di quella
monumentalità tipica del Cezanne dei ritratti” (commento a Ritratto di Donna di Osvaldo Licini).
“Finalmente un omaggio a Fellini che esula dai rituali d’obbligo e assume un significato concreto
… ultimo nella schiera delle imitazioni, Lisbon Story è il film che più assomiglia a 8 1/2. Anche se
può non sembrare. Nella visione rimanda piuttosto ad Antonioni, al suo modo inconfondibile di
stilizzare nel rettangolo dell’immagine la città e il paesaggio; e si collega, per fortuna, anche
all’andamento rapsodico di vari road movies dello stesso Wenders” (commento a Lisbon Story di Wim
Wenders).
361 Philip Pettit, “The Possibility of Aesthetic Realism” (1983), trad. it. “La possibilità del realismo estetico”, in Kobau P., Matteucci G. e Velotti S. (a cura di), Estetica e Filosofia Analitica, cit., pp. 212-220. 362 L. Wittgenstein, Ricerche Filosofiche, cit., § 1, p. 10.
205
Commenti di questo tipo sono pressoché onnipresenti nei testi critici che accompagnano la
presentazione al pubblico di un dipinto, di una sinfonia, di un romanzo, di un film e via
dicendo. Per rafforzare l’analisi di una data opera condotta in termini delle relazioni tra le sue
proprietà non-estetiche e i suoi attributi estetici, i critici ricorrono infatti quasi sempre all’uso
di confronti di vario genere tra l’opera in questione e altre opere ritenute esemplari. Ciò
avviene soprattutto a livello delle proprietà estetiche non-formali, le quali sono quelle più
emergenti e response-dependent e costituiscono a vario titolo il contenuto di un’opera d’arte.
L’esercizio del confronto corrisponde peraltro ad uno dei requisiti centrali che il critico
humiano doveva possedere 363; inoltre anche Wittgenstein sosteneva che “per risolvere i
quesiti estetici abbiamo bisogno di certi confronti − di raggruppare certi casi” 364. Che il
critico faccia frequente uso di confronti non deve stupire, se è vero, come sostiene Vaida, che
si impara ad attribuire e a comprendere le proprietà estetiche di un’opera principalmente per
ostensione, ovvero attraverso il riferimento a dei casi esemplari e paradigmatici. Il problema è
semmai quello di stabilire quale sia il modo corretto di applicare il metodo comparativo.
Un aiuto in questo senso ce lo fornisce Hippolyte Taine, il quale già nel 1881 affermava
che per stabilire che cosa sia un’opera d’arte “non c’è bisogno di uscire dall’esperienza: tutta
l’operazione consiste nello scoprire, attraverso numerosi paragoni e progressive eliminazioni,
i tratti comuni che appartengono a tutte le opere d’arte, e nello stesso tempo anche i tratti
distintivi grazie ai quali le opere d’arte si differenziano dagli altri prodotti dello spirito
umano” 365. Taine parte quindi dalla constatazione che “l’opera d’arte non è qualcosa di
isolato” e che per scoprirne la natura dobbiamo “cercare l’insieme da cui essa dipende e che la
spiega”; egli specifica poi quali siano questi insiemi, seguendo un ordine che scandisce le
tappe di un metodo comparativo del giudizio estetico circa un’opera d’arte. Il primo insieme è
costituito dalla “produzione globale dell’artista che ne è l’autore”: infatti “tutti sanno che le
diverse opere sono imparentate tra loro come le figlie di uno stesso padre, e ciò vuol dire che
tra loro ci sono marcate somiglianze”; inoltre, “ogni artista ha un suo stile … che si ritrova in
tutte le sue opere”. Tuttavia “questo stesso artista, considerato con la totalità dell’opera da lui
prodotta, a sua volta non è isolato”, ma fa parte di un secondo insieme “più grande di lui, che
363 Nel Settecento è stata prodotta una vasta letteratura sull’importanza dell’esercizio del confronto per il perfezionamento del gusto e per l’acquisizione del buon gusto. D’altronde l’esercizio del confronto di cui parla Hume e che sarà ripreso tra gli altri da Alexander Gerard, è desunto del gout de comparaison che già Du Bos indicava come qualità principale della borghesia colta che si interessa di arte (vedi J.B. Du Bos, Reflexions Critiques sur la Poesie et sur la Peinture (1719), ed. it. a cura di M. Mazzocut-Mis e P. Vincenzi, Riflessioni Critiche sulla Poesia e sulla Pittura, Aesthetica Edizioni, Palermo 2005). 364 L. Wittgenstein, Lezioni e conversazioni sull’etica, l’estetica, la psicologia e la credenza religiosa, cit., p. 98. 365 Hippolyte Taine, Philosophie de l’Art (1881), trad. di O. Settineri, La Filosofia dell’Arte, Bompiani, Milano 2001, p. 45.
206
è la scuola o la famiglia di artisti dello stesso paese o dello stesso tempo a cui egli
appartiene”. Infine, “questa stessa famiglia di artisti è compresa essa stessa in un insieme più
vasto, vale a dire il mondo che la circonda e il cui gusto è conforme al suo. Infatti, lo stato dei
costumi e dello spirito è lo stesso sia per il pubblico sia per gli artisti, i quali non sono uomini
isolati” 366. Possiamo allora provare a seguire le indicazioni metodologiche di Taine, e vedere
in che modo e fino a che punto l’esercizio del confronto possa affinare la nostra capacità di
giudizio estetico sull’arte.
Partiamo allora dal primo insieme. Levinson sostiene che l’oeuvre di un artista, ovvero
l’insieme completo delle opere d’arte da lui realizzate, possa essere legittimamente
interpretato esso stesso come un’opera d’arte, ovvero come il risultato di un singolo atto
artistico in cui le diverse opere hanno la stessa funzione che le parti di un’opera singola
rivestono rispetto al tutto 367. In tal senso, in quanto cioè lette come tappe intermedie di un
unico percorso creativo, le varie opere sono i veicoli per l’espressione di un contenuto che
può essere pienamente compreso solo alla luce della considerazione del tutto di cui esse sono
le parti, ovvero alla luce della considerazione dell’ oeuvre dell’artista. Per meglio chiarire
questo concetto, Levinson utilizza l’analogia con il linguaggio parlato. Spesso il senso che
attribuiamo a una porzione di discorso cambia laddove si aggiunga un’ulteriore porzione al
discorso stesso durante l’atto comunicativo. Lo stesso accade con le opere d’arte: la creazione
di nuove opere da parte di un artista sovente modifica la nostra ipotesi interpretativa circa le
precedenti opere dello stesso artista, in quanto il contesto entro cui queste vanno lette risulta
ora modificato e allargato.
Ciò non vuol dire che il cambiamento che, alla luce della proiezione di un’opera su uno
sfondo allargato e comprendente le altre opere prodotte dallo stesso autore, avviene a livello
del contenuto dell’opera in questione, sia elevato o inevitabile. Infatti (proseguendo l’analogia
col linguaggio parlato), le singole opere d’arte hanno, rispetto al corpus produttivo dello
stesso autore, un grado di autonomia superiore a quello che le singole frasi possiedono nei
confronti dell’intero discorso pronunciato; inoltre, non sempre nel percorso creativo di un
artista è possibile rilevare una continuità tale da autorizzare una siffatta lettura contestuale
delle sue singole produzioni. In generale possiamo però affermare che il significato tanto delle
opere più remote quanto di quelle più recenti di uno stesso artista può essere afferrato con più
sicurezza se tali opere vengono considerate e giudicate alla luce di un contesto più esteso e
comprendente sia le une che le altre. Levinson fa a tal proposito l’esempio a mio avviso
366 Ivi, pp. 25-33. 367 J. Levinson, “Work and Oeuvre” (1996), in Id., The Pleasures of Aesthetics, cit., pp. 242-273.
207
illuminante di Piet Mondrian. Se si confronta la serie dei paesaggi dipinti dall’artista olandese
prima del 1918 con le opere astratte realizzate dopo questa data, si può rilevare una continuità
tra le due diverse fasi tale che non solo le opere astratte possono essere lette, in relazione a
quelle precedenti, come il risultato di un progressivo processo di astrazione della natura, ma le
stesse opere paesaggistiche possono essere lette, alla luce della successiva fase astratta, come
la rappresentazione teleologica dell’essenza della natura. Ciò che è vero per Mondrian (come
confermato dal fatto che il confronto tra le due fasi artistiche dell’artista olandese è l’oggetto
ricorrente di numerose mostre e lo si può trovare in molti libri di storia dell’arte), è in
generale plausibile per la maggior parte delle opere d’arte esistenti. Possiamo quindi
concordare con Levinson e affermare che il confronto con l’oeuvre di un artista facilita la
nostra comprensione del contenuto di ogni singola opera da lui prodotta, ovvero ci aiuta a
percepirne le proprietà estetiche rappresentative, espressive, semantiche, e via dicendo.
Quello che è stato detto a proposito dell’oeuvre di un artista non può essere esteso, sostiene
ancora Levinson, né alla storia dell’arte né ai singoli movimenti o periodi artistici: né gli uni
né gli altri possono infatti essere considerati, al pari del corpus produttivo di un solo artista,
come il prodotto di un unitario e indivisibile atto creativo (nel primo caso ciò sarebbe
possibile solo equiparando la storia dell’arte all’opera realizzata da un Dio creatore e artista, il
che ci farebbe però sconfinare dall’estetica alla teologia) 368. Ciò non toglie che si possa
comunque trarre giovamento dall’inquadramento di un’opera d’arte all’interno di un contesto
ancora più esteso e comprendente il periodo, lo stile o la scuola ai quali l’opera può essere
ricollegata. Per capire come il confronto di un’opera d’arte con le opere appartenenti allo
stesso periodo, stile o scuola possa giovare alla comprensione del carattere estetico dell’opera
stessa, sarà utile riprendere alcuni aspetti della teoria stilistica di Carney precedentemente
analizzata. Carney sostiene che l’assegnazione di un particolare stile a un’opera d’arte sia il
fattore decisivo riguardo alla determinazione del carattere estetico di quest’ultima, ovvero
riguardo alle proprietà estetiche da essa possedute. Alla luce di quanto detto nel quinto
capitolo, possiamo affermare con sicurezza che la teoria di Carney è inapplicabile alle
proprietà formali, essendo queste le proprietà più ancorate alla base strutturale e meno
dipendenti da fattori esterni e contestuali, ed è comunque discutibile anche per ciò che
concerne le altre proprietà estetiche, dato che queste fanno parte del meaning di un’opera e
non del suo significance (esse rientrano cioè nel significato intrinseco dell’opera e non nelle
sue relazioni con fattori storici o contestuali).
368 Ivi, pp. 245-249.
208
Fatta questa precisazione, possiamo ora vedere come l’assegnazione di un particolare stile
a un’opera d’arte possa influenzare la percezione delle sue proprietà estetiche (soprattutto di
quelle non-formali, ovvero del suo contenuto), nella misura in cui queste vengono apprese per
ostensione, ovvero attraverso il confronto con dei casi esemplari. Tali casi altro non sono che
le opere paradigmatiche di una certa scuola, periodo o stile ai quali l’opera in questione
appartiene. Una volta quindi che l’opera è stata messa a confronto con l’oeuvre dell’artista,
diviene altrettanto importante sapere come si fa a classificare correttamente tale oeuvre
all’interno di un particolare stile artistico. A tal fine è sufficiente ricordare che, come chiarito
da Carney, un critico è legittimato a classificare un corpus artistico W entro lo stile S se: 1)
esiste un consenso tra i critici e gli storici circa l’appartenenza di W a S; 2) la maggior parte
delle caratteristiche possedute da W sono standard rispetto a S; 3) S è in sintonia con le
intenzioni riconosciute del creatore di W; 4) attraverso l’assegnazione di S a W, W si
relaziona anche ad altri stili artistici; 5) attraverso l’assegnazione di S a W, W si relaziona alla
cultura del suo tempo 369. La lista di condizioni elaborata da Carney corrisponde
evidentemente all’invito di H. Taine a mettere a confronto il corpus produttivo (primo
insieme) di un artista tanto con le scuole e i movimenti a cui appartiene (secondo insieme)
quanto con il mondo che lo circonda (terzo insieme). All’interno di tale lista, il ruolo
principale è rivestito dalla seconda condizione, che Carney riprende da Kendall Walton. Per
entrambi è di fondamentale importanza verificare se una data opera possieda le caratteristiche
(non-estetiche) standard di una data categoria (stilistica o di altro tipo), ovvero se vi siano
delle somiglianze estrinseche tra alcune proprietà (non-estetiche) dell’opera in questione e
alcune proprietà (non-estetiche) delle opere paradigmatiche di una data categoria, per sapere
se l’opera sia correttamente classificabile entro tale categoria e se possieda le proprietà
estetiche caratteristicamente associate alla categoria stessa.
La lettura appena fornita della seconda condizione sembra riportarci alle analisi tipiche
della prima fase del giudizio critico, laddove si cercava principalmente di rintracciare dei
legami tra le proprietà non-estetiche e gli attributi estetici di un’opera d’arte. Bisogna allora
aggiungere che lo stesso Walton, il quale ha introdotto il concetto di proprietà standard
rispetto a una categoria, precisa che il possesso delle proprietà (non-estetiche) standard è
rilevante soprattutto ai fini dell’appartenenza di un’opera a una categoria stilistica
caratterizzata prevalentemente da proprietà (estetiche) formali 370. Per quanto riguarda invece
le proprietà estetiche non formali di un’opera, ovvero il suo contenuto, Walton sostiene che
369 J. Carney, “Style and Formal Features”, cit., p. 434. 370 Kendall Walton, “Categories of Art”, cit., pp. 338-345.
209
esse dipendono da proprietà (non-estetiche) variabili (il che è coerente con la loro natura di
proprietà spiccatamente emergenti e response-dependent). Ciò significa che, in generale,
l’assegnazione di uno stile a un’opera d’arte (o a un corpus di opere), e quindi il confronto di
tale opera con altre opere appartenenti allo stesso stile o a stili a questo collegati, può
influenzare la comprensione del carattere estetico dell’opera soprattutto in virtù dell’analogia
tra le esperienze che le varie opere classificate entro la stessa categoria stilistica provocano su
un medesimo soggetto, piuttosto che per effetto di una somiglianza esteriore tra proprietà non-
estetiche (quest’ultima può soprattutto facilitare, sebbene mai esaurire, la comprensione delle
proprietà estetiche formali dell’opera in questione). In breve, estendendo la nostra conoscenza
alle opere paradigmatiche di un dato stile (scuola, periodo) a cui l’opera che stiamo
giudicando appartiene, acquisiamo familiarità con le proprietà estetiche caratteristiche di tale
stile e riusciamo di conseguenza a penetrare più a fondo nel contenuto dell’opera data −
sebbene quest’ultimo rimanga un atto singolare, soggettivo ed esperienziale 371.
Il confronto di un’opera d’arte col corpus produttivo del suo autore e con le opere
appartenenti allo stile di provenienza dell’opera (o agli altri stili con questo imparentati) può
quindi aiutarci a comprendere il contenuto dell’opera stessa e a fissarlo in una descrizione il
più possibile autentica e stabile. C’è però anche il rischio che il confronto introduca un
elemento di instabilità nella stessa percezione del contenuto estetico di un’opera d’arte.
Questo è il rischio che si corre quando un’opera d’arte viene messa in relazione non solo con
le opere precedenti o contemporanee, ma anche con le opere appartenenti a stili, scuole e
periodi artistici successivi. Secondo Arthur Danto, ogni opera X stilisticamente innovativa
introduce almeno una nuova proprietà estetica (che chiameremo F) in virtù della quale la
proprietà opposta (non-F), da proprietà posseduta ma non rilevante, diviene proprietà
posseduta e artisticamente rilevante ai fini della determinazione del carattere estetico di tutte
le opere d’arte create in un periodo precedente quello in cui X è stata creata 372. La posizione
espressa da Danto nel 1964 è stata ripresa e sostenuta da numerosi altri autori, tutti concordi
371 Il possesso delle proprietà standard è importante soprattutto quando abbiamo a che fare con categorie caratterizzate da una funzione estetico-formale, mentre è meno rilevante quando abbiamo a che fare con categorie la cui funzione principale è, ad esempio, espressiva (dal momento che le proprietà estetiche espressive sono assai più emergenti sulla base non-estetica rispetto a quelle formali). Ciò significa che, ad esempio, il ripetersi di certe combinazioni di colori o linee può permetterci di classificare un dipinto come astratto-formale e attribuirgli la proprietà dell’ ‘equilibrio’, mentre il ripetersi di determinati soggetti, figure e combinazioni cromatiche difficilmente potrà permetterci di classificare il dipinto come espressivo e di attribuirgli le proprietà dell’ ‘essere angoscioso’, del ‘comunicare tensione’ e via dicendo (sebbene anche in quest’ultimo caso certe proprietà non-estetiche − come l’uso di colori accesi, di linee nervose, di soggetti inquietanti, ecc. − siano più efficaci di altre; d’altronde anche l’attribuzione di proprietà formali non è mai un atto meccanico ma implica sempre una reazione soggettiva). 372 A. Danto, “The Artworld”, cit., pp. 211-2.
210
nell’affermare che il futuro possa modificare retroattivamente il passato (della storia
dell’arte): la creazione di opere d’arte innovative ci mette a disposizione nuove ragioni su cui
fondare il nostro giudizio estetico e che possono pertanto modificare i giudizi già espressi
sull’arte precedente 373. Se da un lato quindi il confronto di un’opera d’arte col suo presente e
col suo passato (ovvero con l’oeuvre dell’artista e con gli stili riconosciuti ai quali questo è
ricollegabile) tende verso la fissazione del suo contenuto estetico, dall’altro lato il confronto
col futuro (ovvero con le opere successive, reali o anche solo ipotetiche) tende verso la
direzione opposta e rischia di farci perdere ciò che a fatica avevamo conquistato.
Levinson descrive la posizione che attribuisce al futuro il potere di modificare il significato
delle opere passate col nome di “forward-retroactivism” (d’ora in poi FR), che egli critica e al
quale contrappone la posizione da lui difesa e denominata “backward-retroactivism” (d’ora in
poi BR) 374. Per chiarire la differenza tra le due posizioni, egli ipotizza l’esistenza di due
opere d’arte W1 e W2 create rispettivamente nel 1887 e nel 1987. Mentre il BR sostiene che
possiamo leggere W1 più chiaramente alla luce di W2 e successivamente re-interpretare W2
alla luce del W1 così riletto, il FR afferma invece che la conoscenza di W2 ci porta a re-
interpretare, modificandolo, il significato di W1, che diventa così (dal punto di vista estetico)
un altro oggetto W1’. Le due teorie condividono quindi solamente il passo iniziale, che
coincide con la posizione dello storicismo tradizionale (HT) e che afferma che il significato di
W2 dipende da W1 ed è da questo determinato, ma differiscono in quelli successivi. Difatti,
quello che per il BR rappresenta un passo intermedio (ovvero, la rilettura di W1 alla luce di
W2), per il FR costituisce il passo finale (ovvero, la re-interpretazione di W1 alla luce di W2
e il suo diventare un W1 modificato, che abbiamo chiamato W1’). Ciò che il BR riconosce è
che la conoscenza di W2 possa aiutarci a rilevare una parte latente del contenuto di W1, che
per via di una qualche mancanza da parte dei soggetti giudicanti non era stata notata o presa
adeguatamente in considerazione; ciò che il BR nega, e che costituisce invece il nocciolo del
FR, è che la conoscenza di W2 possa modificare il contenuto di W1. Il BR sostiene ad
esempio che non sia corretto dire che in seguito alla comparsa (nei primi del Novecento) di
generi quali il ragtime, lo stride-piano, il boogie-woogie e via dicendo, la Sonata op. 111 per
pianoforte di Beethoven acquista un’atmosfera jazzistica (che Levinson chiama “jazzy
373 Vedi ad esempio Alan Goldman, “Art Historical Value”, British Journal of Aesthetics 33 (1933), pp. 17-28; Graham Mc Fee, “The Historicity of Art”, The Journal of Aesthetics and Art Criticism 38 (1980), pp. 307-24; Anthony Savile, “The Rationale of Restoration”, The Journal of Aesthetics and Art Criticism 51 (1993), pp. 463-474; Anita Silvers, “The Story of Art Is the Test of Time”, The Journal of Aesthetics and Art Criticism 49 (1991), pp. 211-224. 374 J. Levinson, “Artworks and the Future”, cit., pp. 179-214.
211
quality” 375); possiamo invece affermare che la conoscenza di questi nuovi (rispetto all’epoca
di Beethoven) generi permette all’ascoltatore di riconoscere con più facilità quella jazzy
quality che era già posseduta dalla Sonata di Beethoven, ma che rimaneva latente e nascosta
ai più.
Levinson sostiene quindi che si debba rivedere la teoria di Danto sopra esposta e affermare
che la proprietà non-F era già posseduta da W1 prima ancora che fosse creata W2 (ovvero
un’opera tra le cui proprietà c’è F), ma non era ancora stata percepita; perciò la percezione di
non-F in W1 ne lascia intatto il contenuto (di cui possiamo tutt’al più venire a conoscenza in
modo più completo), mentre può modificare il contenuto di W2. Per capire ad esempio il
significato di un dipinto cubista (il quale introduce delle nuove proprietà estetiche F), è
importante percepire l’assenza di tali proprietà in opere precedenti (ovvero percepire la
presenza di non-F in dipinti realisti, impressionisti e via dicendo), il cui contenuto non viene
però in alcun modo cambiato: il cubismo può essere interpretato come una reazione
all’impressionismo o al realismo, ma non si può certo affermare il contrario 376. La difesa del
BR condotta da Levinson riflette l’adesione da parte sua a uno storicismo che già altrove
(come abbiamo visto nel primo capitolo) egli si era preoccupato di distinguere da altre forme,
più estreme e radicali, di storicismo. Tali forme sono sostenute da Danto e dai sostenitori del
FR, che non a caso si rivela congeniale a teorie definitorie di tipo istituzionale. Il FR muove
infatti dal presupposto generale che l’ “understanding” possa modificare il “meaning” di un
oggetto 377: in ambito artistico ciò significa che i giudizi dei critici possono determinare, fino
a modificare a ritroso, il contenuto delle opere d’arte, e che l’ultima parola circa la loro
classificazione e la loro valutazione spetti al mondo dell’arte. Lo storicismo abbracciato da
Levinson fa perno invece su quella nozione di continuità che ci ha permesso di identificare un
centro naturale dell’arte, un’essenza (estetica) comune alle opere prodotte in ogni luogo e in
ogni tempo e dalla quale abbiamo ricavato le basi per una definizione estetica dell’arte. Il BR
si inserisce perfettamente in questa cornice concettuale e ristabilisce il giusto ordine degli
eventi: è il passato che condiziona il futuro, e non viceversa; è la storia dell’arte che ci
suggerisce il criterio per classificare e valutare l’arte presente e futura, e non il mondo
dell’arte. Ciò che in ultimo ci fa quindi preferire il BR al FR, e che ci permette insieme di
preservare la bontà del metodo critico-estetico basato sul confronto, è quindi il suo poggiare
375 Ivi, p. 188. 376 Ivi, pp. 194-6. L’unico caso in cui il FR può essere legittimamente applicato, è secondo Levinson, quello dell’oeuvre di un artista, in virtù del fatto che lo stesso oeuvre può essere interpretato come il prodotto di un singolo atto creativo. 377 Vedi Graham McFee, “The Historical Character of Art: a Re-Appraisal”, British Journal of Aesthetics 32 (1992), pp. 312-19.
212
su un concetto di storicismo più credibile e più in sintonia con i presupposti di una definizione
estetica dell’arte.
C’è ancora un ultimo nodo da sciogliere. Il BR di Levinson, pur negando che il contenuto
di un’opera d’arte possa essere determinato o modificato dagli sviluppi storici e culturali
successivi alla creazione dell’opera, sembra concedere che lo stesso contenuto possa essere
determinato dal passato della storia dell’arte piuttosto che dalle sue caratteristiche intrinseche;
il che contrasterebbe con quanto affermato dalla definizione estetica dell’arte e si
avvicinerebbe invece alle posizioni (sostenute da Carney) prima contestate circa l’influenza
diretta che le classificazioni stilistiche hanno sul carattere estetico di un’opera. In realtà è
sufficiente richiamare alla memoria la distinzione introdotta da Levinson tra meaning e
significance per scongiurare il pericolo. Ciò che il passato della storia dell’arte può
determinare è solo il significance di un’opera, ovvero il suo significato estrinseco (il quale
dipende dalla relazione dell’opera con fattori di carattere storico-contestuale e può modificarsi
al variare di questi), e non il suo meaning, ovvero il suo senso intrinseco (il quale è fissato una
volta per tutte al momento della sua creazione, indipendentemente da fattori esterni all’opera,
ed è costituito dalle proprietà estetiche espressive, rappresentative, formali, ecc., dell’opera
stessa). Il confronto di un’opera d’arte col passato artistico può quindi modificare il suo
significance, mentre il confronto tanto col passato quanto col futuro può solo illuminare (che
è ben diverso dal determinare o modificare) il suo meaning − acquisendo familiarità con opere
in qualche modo imparentate con l’opera d’arte in questione aumentiamo la nostra possibilità
di percepire correttamente il carattere estetico dell’opera, al quale non vi è però altra via
d’accesso che l’esperienza soggettiva.
C) INNALZARE L’ESPERIENZA
“Accolta con qualche sospetto nell’olimpo del sinfonismo classico … la nuova partitura ci rende
partecipi del suo meccanismo di violenta accelerazione linguistica soprattutto allo scoccare del fatale
quarto movimento. Quando lo sguardo al futuro pare fermarsi e invece sta soltanto riconquistando lo
slancio risolutivo. La Sinfonia s’impenna in un gesto di riesame e di memoria del cammino fin lì
percorso − forse di tutta la storia del genere sinfonico − prima di penetrare con un gesto unico il nostro
tempo, perforando la corazza strumentale dell’orchestra, complice la voce umana e i versi da
trent’anni in attesa dell’Inno alla gioia assegnati ai solisti e al coro: variamente ripetuti e
musicalmente interpretati” (commento alla Nona Sinfonia di Ludwig van Beethoven).
“I bar, le episodiche considerazioni sul destino, il cinismo, l’ormai sbiadito demone del sesso, il
fallimento professionale ed esistenziale, insieme alle invenzioni narrative, diventano il pulp
213
(“pasticcio”) del titolo. Lontano dalle atmosfere tenebrose delle ordinarie follie, un piccolo capolavoro
d’ironia, il testamento spirituale di un grande scrittore che non ha mai esitato a immergersi nel degrado
della società contemporanea” (commento a Pulp. Una storia del XX secolo di Charles Bukowski).
Riassumendo e semplificando quanto fin qui esposto, possiamo dire che mentre l’esercizio
e l’osservazione ripetuta ci aiutano a percepire soprattutto (ma non solo) le proprietà estetiche
formali di un’opera d’arte, il confronto dell’opera con l’oeuvre dell’artista e con gli stili,
scuole e periodi a cui essa è ricollegabile ci permette di fissarne soprattutto (nei limiti del
possibile) il significato, ovvero il contenuto estetico. L’analisi sull’attività critico-estetica
effettuata da Sibley termina qui. Abbiamo visto però che le opere d’arte sono caratterizzate
anche da proprietà formali di livello superiore, ovvero dalla proprietà della reciproca
adeguatezza di forma e contenuto (considerati già a livello estetico). Per rilevare tale proprietà
e completare il nostro giudizio estetico sull’opera abbiamo bisogno di una particolare
sensibilità, da Levinson chiamata attitudinale − la quale attribuisce un valore positivo o
negativo a ciascuna proprietà estetica posseduta dall’opera a seconda del suo contribuire o
meno (da sola o in relazione con le altre proprietà) all’unità, complessità e intensità dell’opera
−, al fine di stabilire in ultimo se il contenuto è espresso in modo conveniente e appropriato
alla forma. Dobbiamo allora aggiungere una terza fase dell’attività critico-estetica, ulteriore
alle due individuate da Sibley e responsabile dell’assegnazione delle proprietà
intrinsecamente valutative all’opera d’arte, ovvero del suo valore estetico/artistico 378. Tale
fase corrisponde, come detto, all’esercizio della sensibilità attitudinale, ovvero di quel buon
gusto che, come già nel Settecento Hume e Gerard sostenevano, distingue e soppesa i pregi e i
difetti di un’opera d’arte, valuta il loro contribuire o meno alla coerenza interna dell’opera ed
esprime il giudizio di merito complessivo e conclusivo sulla stessa.
Essendo questa la fase più complessa e delicata del giudizio critico-estetico, diventa ancor
più urgente stabilire dei criteri il più possibile oggettivi ai quali ricondurla. Il primo è quello
di affidarsi al giudizio degli esperti, ovvero al giudizio di coloro i quali, essendosi esercitati
nelle due precedenti fasi dell’attività critica e in virtù del possesso di un alto grado di
raffinatezza della sensibilità attitudinale, godono di una certa autorità in ambito estetico.
Abbiamo visto però che anche a questo livello possono esistere delle differenze tra i giudizi
espressi dagli esperti; differenze che danno origine a dispute che sono insolubili, in quanto
378 E’ peraltro normale che Sibley si sia fermato alle due fasi suddette, dato che la sua analisi delle proprietà estetiche e dell’attività critica che di queste si occupa si ferma al livello che è stato poi ribattezzato sopravvenienza estetica, e non tiene volutamente conto del valore estetico (ovvero della sopravvenienza del valore estetico).
214
non possiamo per ipotesi fare appello a una qualche lacuna percettiva o culturale dei soggetti
giudicanti (i quali per essere esperti devono aver già esercitato le loro capacità discriminatorie
e devono aver effettuato un numero cospicuo di confronti). Le dispute tra esperti sono
insolubili poiché qui abbiamo a che fare con una sensibilità percettiva di ordine più alto, alla
quale compete la rilevazione di proprietà formali a loro volta superiori rispetto alle altre
proprietà estetiche formali, e consistenti nell’unione di queste con le proprietà estetiche
espressive, rappresentative e simboliche. L’osservazione ripetuta di un’opera d’arte e il
confronto con le opere direttamente o stilisticamente imparentate con essa può aiutarci a
percepire le proprietà estetiche, formali e non, dell’opera, ma difficilmente potrà servirci a
percepire l’unione tra tali proprietà.
Al di là dell’insolubilità di alcune dispute, esistono però delle opere d’arte intorno al cui
valore estetico nessun soggetto chiamato ad esprimere un giudizio, sia egli un esperto, un
critico o un semplice appassionato, potrà mai dissentire. Tali sono i capolavori riconosciuti
della storia dell’arte, che in virtù della loro eccellenza travalicano i confini spazio-temporali,
le classificazioni stilistiche e le preferenze personali, e riscuotono un consenso esteso e
imperituro. Questo consenso riguarda anzitutto le proprietà estetiche formali, la cui
percezione è agevolata dall’attenzione concentrata sulla struttura percettiva (non-estetica) di
base, e le proprietà estetiche espressive, rappresentative e simboliche, ovvero il contenuto, che
nel caso dei capolavori è talmente profondo da reclamare continuamente nuove
interpretazioni, le quali ci permettono di cogliere parti non ancora rilevate (più per via della
ricchezza dell’opera che per una deficienza nel pubblico, come nel caso già citato della
Sonata per piano Op. 111 di Beethoven) del significato. Ma ad essere universalmente
condiviso è soprattutto il giudizio sul valore di tali opere, ovvero sulla loro capacità di
realizzare una fusione di forma e contenuto ad un grado sommo, che costituisce un superiore
livello di unità formale nella cui percezione l’esperienza estetica si intensifica e si completa.
Ecco allora qual è il criterio che guida la terza e ultima fase del giudizio critico-estetico su
un’opera d’arte: il confronto con i capolavori riconosciuti della storia dell’arte.
A ben vedere, si può dire che sia stato Levinson a suggerirci indirettamente questo criterio.
Nel difendere la legittimità del realismo estetico egli sostiene infatti, come visto poc’anzi, che
esistono dei capolavori indiscussi (le sinfonie di Beethoven, le sculture di Brancusi, i dipinti
di Mondrian, e via dicendo) sulle cui qualità non est disputandum (ribaltando così il celebre
motto de gustibus non disputandum est, che come dimostrano anche i filosofi empiristi del
Settecento non deve essere preso alla lettera). Ma soprattutto egli, messo di fronte (da
Wollheim) alla necessità di motivare l’intenzione storico-ricorsiva a suo avviso responsabile
215
dell’artisticità di un oggetto, fa un’importante concessione alla sua definizione dell’arte e
sostiene (come abbiamo visto nel secondo capitolo del presente lavoro) che un oggetto, per
essere classificato come opera d’arte, non solo deve essere stato inteso per essere considerato
nello stesso modo in cui precedenti opere d’arte sono state correttamente considerate, ma deve
anche produrre un’esperienza il cui valore sia simile a quello correttamente attribuito all’arte
precedente. Con tale concessione Levinson ha di fatto aperto le porte ad una definizione
funzionale dell’arte (come è stato a più riprese sottolineato), di cui abbiamo investigato la
genesi, la struttura e le condizioni di applicabilità. E’ proprio in relazione a queste ultime che
possiamo ora recuperare con profitto la concessione levinsoniana, non più però come
condizione definitoria (aggiuntiva) bensì come criterio di giudizio critico-estetico, il quale ci
dice che è solo confrontando l’esperienza che un oggetto ci procura con l’esperienza
procurataci dalle opere d’arte il cui valore è indiscusso, ovvero con i capolavori riconosciuti
della storia dell’arte, che possiamo rendere più sicuro e stabile il nostro giudizio di merito
sull’opera in questione. Le definizione storica allora, come prefigurato al termine del secondo
capitolo, rientra in gioco in seconda battuta, come ausilio metodologico all’applicazione della
vera definizione dell’arte, che è di tipo estetico-funzionale.
Il criterio che caratterizza questa terza e ultima fase del giudizio critico-estetico ha un
aspetto paradossale. Difatti tra le opere d’arte sono proprio i capolavori le più restie al
confronto con altre opere, in quanto procurano in noi un’esperienza talmente intensa,
complessa e internamente coerente da produrre, una volta finita, una sorta di riverbero, di
corteccia invisibile in virtù della quale l’unicità della nostra esperienza è messa al riparo da
qualsiasi contaminazione esterna. Eppure questa stessa esperienza, oltre a rappresentare un
valore intrinseco, ha anche un valore strumentale, identificabile tanto nell’affinamento della
nostra sensibilità attitudinale che ne deriviamo, quanto nel fatto che, acquisendo familiarità
con le superiori leggi di unità formale attraverso le quali i capolavori comunicano il loro
contenuto, siamo in grado di riconoscere comparativamente tali leggi anche in altre opere
d’arte e di giudicarne quindi il valore. Ovviamente tali leggi, come pure le proprietà che
attraverso esse sono unite, possono essere apprese non con la deduzione razionale ma solo
attraverso l’esperienza estetica soggettiva; esperienza che, rimodellata dall’esercizio, estesa
dal confronto con le opere affini e innalzata dal contatto con i capolavori, garantisce un certo
grado di affidabilità al giudizio critico-estetico, ovvero al criterio di classificazione e
valutazione delle opere d’arte, che di tale esperienza è la manifestazione concreta.
216
D) R. S. V. P.
“Costumers who bought Adams’s piano concerto also bought Ligeti’s piano concerto..”; “.. if you
are listening to Terry Riley’s A Rainbow in a Curved Air, you may also like Portishead…” (tratto da
Amazon.com).
“Depeche Mode: Best of. Raccomandato Se Vi Piace (R. S. V. P.): Duran Duran” (tratto dalla
rivista Venerdì del quotidiano La Repubblica).
Il metodo di giudizio critico-estetico che abbiamo elaborato si basa su un uso ponderato e
graduale del confronto, che dall’oeuvre a cui un’opera appartiene si estende alle opere
stilisticamente affini e giunge a toccare i capolavori consacrati dalla storia. Nella società in
cui viviamo però, spesso non abbiamo né il tempo né lo spazio necessari per procedere nel
modo indicato. Non ne abbiamo il tempo, poiché l’informazione corre veloce, i nostri ritmi di
vita sono accelerati e il tempo per l’approfondimento è sempre più ridotto. Non ne abbiamo lo
spazio, poiché l’artista postmoderno mette in discussione le gerarchie ereditate dal passato,
non si riconosce in nessuna zona privilegiata e infrange i confini tra un campo artistico e
l’altro. In una situazione così mutevole e frammentata, il confronto critico-estetico è spesso
condensato nella forma di slogan pubblicitario. Prendiamo ad esempio la musica, che è un
caso esemplare in quanto a contrazione temporale − non c’è momento della giornata in cui
non siamo sottoposti, anche contro la nostra volontà, a un bombardamento acustico sotto
forma di suonerie, radio, sigle, spot, mentre sempre di meno ci dedichiamo all’ascolto della
musica con l’attenzione che questa merita − e a de-territorializzazione spaziale − una delle
cifre dominanti della ricerca musicale contemporanea è la contaminazione tra alto e basso, tra
colto e popolare, tra musica scritta e improvvisata, e così via. Parallelamente a questo
contrarsi della fruizione e frammentarsi della creazione, anche l’informazione musicale si fa
più veloce e più incurante delle distinzioni tra generi, stili e valori. Accanto quindi a
recensioni più tradizionali e approfondite, condotte cioè col metodo critico-estetico che
abbiamo identificato nelle tre fasi dell’analisi e dell’esercizio discriminatorio, del confronto
tra opere stilisticamente imparentate e dell’elevazione attraverso i capolavori della storia
dell’arte, ci imbattiamo sempre più spesso, nei giornali o su internet, in commenti fugaci
caratterizzati da un utilizzo estremamente sintetico, talvolta spiazzante e spesso immotivato
del metodo comparativo. Hai comprato il cd con il concerto per pianoforte e orchestra di John
Adams? Guarda che altri utenti che hanno fatto la tua scelta hanno poi acquistato il cd col
concerto per pianoforte di Gyorgy Ligeti. Hai ‘cliccato’ più volte su Terry Riley? Allora ti
217
potrebbero piacere anche i Portishead. Stai leggendo la recensione dell’ultimo cd dei Depeche
Mode? Te lo raccomando se ti piacciono i Duran Duran 379.
Come dobbiamo leggere queste indicazioni? Si tratta di semplici strategie di marketing o di
giudizi ponderati e fondati su una reale affinità tra le opere accostate? Tutte e due le cose.
Non c’è dubbio che la loro sinteticità sia il frutto di una precisa strategia, mirata perlopiù alla
vendita di prodotti artistici (cd, dvd o altro ancora). La brevità di questi giudizi ci colpisce
prima ancora che abbiamo finito di leggere una recensione, stuzzica la nostra curiosità
segnalandoci connessioni con altre opere, ci inserisce in una rete di consumatori guidati da
interessi simili. Esse sono il riflesso di una società caratterizzata da tempi ridotti, da una
molteplicità crescente di proposte e dal continuo rimescolamento delle categorie culturali. Ciò
non è però necessariamente sinonimo di superficialità. Spesso tali giudizi ci sorprendono per
la loro immediatezza, ci spiazzano per l’apparente arditezza, ci fanno sospettare una certa
infondatezza, ma il più delle volte celano affinità genuine tra le opere accostate. Certo, per
essere sicuri di questo dobbiamo poi affidarci a giudizi estetici più approfonditi e seguire il
metodo prima delineato. Solo osservando ripetutamente la singola opera, inserendola in un
contesto storico culturale appropriato e confrontandola con le opere esemplari di un certo stile
e con quelle in generale più elevate, saremo in grado di verificare se l’iniziale effetto di
sorpresa, arditezza e mancanza di fondamento che i suddetti giudizi hanno suscitato in noi
fosse solo apparente 380. Per rafforzare il criterio di classificazione e valutazione delle opere
d’arte che una definizione estetico-funzionale ci mette a disposizione abbiamo bisogno di
entrambe le forme del metodo comparativo, quella breve, che ci stimola ad allargare il nostro
orizzonte estetico, e quella canonica, che mette a confronto l’esperienza di una singola opera
con l’esperienza di altre opere ad essa collegate e ci permettere di verificare fino a che punto
379 Il primo è un esempio di confronto sintetico (Adams e Ligeti sono entrambi autori colti e in parte influenzati, seppur in modo diverso, dal minimalismo; di ciò però non si fa menzione nel commento citato); il secondo di confronto spiazzante (Terry Riley è sì un pioniere dell’elettronica, ma appartiene a un genere diverso dal pop, pur raffinato, di gruppi come i Portishead); il terzo di confronto immotivato (qualsiasi fan dei Depeche Mode si guarderà bene dal confondersi con i fans dei Duran Duran). 380 Tornando ai nostri esempi, ho personalmente messo in pratica il suggerimento che ho scovato su amazon.com e ho abbinato l’acquisto dei cd di Adams e Ligeti. L’approfondimento dei due autori e l’ascolto dei loro concerti per pianoforte mi hanno confermato la bontà dell’accostamento: entrambi riflettono, seppur in modo differente, l’influenza della musica minimalista e delle sperimentazioni poliritmiche di Conlon Nancarrow, e i loro concerti presentano un incedere frenetico, quasi meccanico e a tratti umoristico. Queste qualità sono fuse insieme nell’ascolto con un grado di coerenza tale da permetterci di assegnare ad entrambe un certo grado di valore estetico e di classificarle a pieno titolo come opere d’arte di ottimo livello. Passando poi al secondo suggerimento, l’accostamento di Terry Riley con i Portishead è spiazzante soprattutto per chi non è a conoscenza dell’influenza che il compositore californiano ha avuto su vari gruppi rock (non a caso gli Who gli dedicarono un brano, intitolato significativamente Baba o’Riley). Infine, pur essendo io stesso un fan dei Depeche Mode, devo riconoscere che il raffronto con i Duran Duran non è poi così blasfemo: a pensarci bene, i Duran Duran non erano affatto da buttare.
218
il nostro orizzonte estetico si sia effettivamente ampliato. D’altronde entrambe possono non
bastare.
219
Bibliografia
Adajian, T., “On the Cluster Account of Art”, British Journal of Aesthetics 43
(2003), pp. 379-85.
Amoroso, L., “Somiglianze di famiglia e storie di famiglia nella ricerca di
Tatarkiewicz”, Rivista di Estetica 46 (1994/95), pp. 79-106.
Anderson, J., “Aesthetic Concepts of Art”, in N. Carroll (a cura di), Theories of Art
Today, pp. 65-92.
Batteux, C., Les Beaux-Arts Reduits a un meme principe (1746), trad. it. (a cura di E.
Migliorini, I. Torrigiani, F. Vianovi), Le belle Arti ricondotte ad unico principio,
Aesthetica, Palermo 2002 (la prima ed. it. è del 1983).
Beardsley, M., Aesthetics: Problems in the Philosophy of Criticism, Harcourt Brace,
New York 1958.
−, “An Aesthetic Definition of Art” (1983), in Curtler, pp. 15-29.
−, “Definitions of Arts” (1961), trad. it. “Le definizioni delle arti”, in P. Kobau, G.
Matteucci e S. Velotti (a cura di), Estetica e Filosofia Analitica, pp. 29-53.
−, The Aesthetic Point of View: Selected Essays, Cornell University Press, Ithaca
1982. Contiene:
“Aesthetic Experience” (1982), pp. 285-97.
“Aesthetic Experience Regained” (1969), pp. 77-92.
“Redefining Art” (1982), pp. 298-315.
“The Aesthetic Point of View” (1970), pp. 15-34.
“The Discrimination of Aesthetic Enjoyment” (1963), pp. 35-45.
“The Generality of Critical Reasons” (1962), pp. 208-218.
“The Relevance of Reasons in Art Criticism” (1982), pp. 332-351.
“What Are Critics For?” (1978), pp. 147-164.
“What Is an Aesthetic Quality?” (1973), pp. 93-110.
220
−, “The Descriptive Account of Aesthetic Attributions”, Revue Internationale de
Philosophie” 28 (1974), pp. 336-52.
Bell, C., Art, Chatto & Windows, London 1914.
Bender, J., “Realism, Supervenience and Irresolvable Aesthetics Disputes”, (1996),
trad. it. “Realismo, sopravvenienza e alcune dispute estetiche insolubili”, in
Studi di Estetica 34 (2006), pp. 32-57.
−, “Sensitivity, Sensibility and Aesthetic Realism”, Journal of Aesthetics and Art
Criticism 59 (2001), pp. 73-83.
−, “Supervenience and the Justification of Aesthetic Judgements”, Journal of
Aesthetics and Art Criticism 46 (1987), pp. 31-40.
Blocker, H. G., “Is Primitive Art Art?”, Journal of Aesthetic Education 25 (1991),
pp. 87-97.
−, “L’Estetica non-occidentale come invenzione coloniale”, in G. Matteucci (a cura
di), Elementi di Estetica Analitica, cit., pp. 211-222.
−, The Aesthetics of Primitive Art, University Press of America, Lanham 1993.
Bloom, P., “Intention, History and Artifact Concepts”, Cognition 60 (1996): pp. 1-
29.
Bollino, F. (a cura di), Estetica analitica, 2 voll., numero monografico di Studi di
estetica 27-28, Clueb, Bologna 2003/2007.
−, “Fra Croce e Wittgenstein: aria di famiglia?”, Studi di Estetica 27, pp. 239-289.
Bond, E. J., “The Essential Nature of Art”, American Philosophical Quarterly 12
(1975), pp. 177-183.
Brady, E., Levinson J. (a cura di), Aesthetic Concepts: Essays after Sibley,
Clarendon Press, Oxford 2001.
Budd, M., Values of Art: Pictures, Poetry and Music, Penguin, London 1995.
221
Carney, J., “Defining Art Externally”, British Journal of Aesthetics 34 (1994), pp.
114-23.
−, “Individual Style”, Journal of Aesthetics and Art Criticism 49 (1991), pp. 15-22.
−, “Style and Formal Features”, Southern Journal of Philosophy 29 (1991), pp. 431-
44.
−, “ The Style Theory of Art”, Pacific Philosophical Quarterly 72 (1991), pp. 272-
89.
Carroll, N., “Art and Interaction”, Journal of Aesthetics and Art Criticism 45 (1986),
pp. 57-68.
−, “Art, Practice and Narrative”, Monist 71 (1988), pp. 140-56.
−, “Historical Narratives and the Philosophy of Art”, Journal of Aesthetics and Art
Criticism 51 (1993), 313-26.
−, “Identifyng Art” (1994), in Yanal R., pp. 3-39.
−, “Interpretation and Intention: The Debate Between Hypotetical and Actual
Intentionalism”, Metaphilosophy 31 (2000), pp. 75-95.
−, Philosophy of Art: A Contemporary Introduction, Routledge, London and New
York 1999.
− (a cura di), Theories of Art Today, University of Wisconsin Press, Madison
(Wisconsin) 2000.
Cavell, S., “Aesthetic Judgement and a Philosophical Claim” (1969), ora in A. Neill
e A. Ridley (a cura di), pp. 354-362.
Chiodo, S. (a cura di), Che Cosa è Arte?, UTET, Torino 2007.
Cohen, T., “Aesthetic/Non-aesthetic and the Concept of Taste: a Critique of Sibley’s
Position” (1973), ora in Kennick (a cura di), Art and Philosophy, pp. 565-593.
Collingwood, R. G., The Principles of Art (1938), Oxford University Press, Oxford
1958.
Cometti, J-P., “Miseria dello storicismo”, Studi di estetica 28, pp. 407-27.
222
Cometti, J-P., Morisot, J., Pouivet, R., Le Sfide dell’Estetica. Momenti e Problemi
della Contemporaneità, Utet, Torino 2002.
Currie, G., “Aliens, Too”, Analysis 53 (1993), pp. 116-118.
−, “A Note on Art and Historical Concepts”, British Journal of Aesthetics 40 (2000),
pp. 186-90.
−, “Supervenience, Essentialism and Aesthetic Properties”, Philosophical Studies 58
(1990), pp. 243-57.
Curtler, H. (a cura di), What is Art?, Haven, New York 1983.
D’Agostini, F., Vassallo, N. (a cura di), Storia della Filosofia Analitica, Einaudi,
Torino 2002.
D’Angelo, P., “Analitici e continentali in estetica”, in Matteucci G. (a cura di),
Elementi di Estetica Analitica, pp. 7-23.
− (a cura di), Introduzione all’estetica analitica, Laterza, Milano-Bari 2008.
−, “La definizione dell’arte”, in Id. (a cura di), Introduzione all’estetica analitica,
pp. 3-36.
− (a cura di), Le Arti nell’estetica analitica, Quodlibet, Macerata 2008.
Danto, A., “Artifact and Art”, contribution o the exhibition catalogue for
ART/artifact (New York: Center for African Art, 1988), pp. 18-32.
−, “Art, Evolution and the Consciousness of History”, Journal of Aesthetics and Art
Criticism 44 (1986), pp. 223-33.
−, “The Artworld” (1964), ora in A. Neill e A. Ridley (a cura di), cit., pp. 202-12.
−, The Philosophical Disenfranchisement of Art, Columbia University Press, New
York 1986, trad. it. (a cura di T. Andina e C. Barbero), La Destituzione filosofica
dell’arte, Aesthetica, Palermo 2008.
−, “The Transfiguration of the Commonplace”, Journal of Aesthetics and Art
Criticism 33 (1974), pp. 139-48.
−, The Transfiguration of the Commonplace. A Philosophy of Art, Harvard
University Press, Cambridge (Mass.) and London 1981, trad. it. (a cura di S.
223
Velotti), La trasfigurazione del banale. Una filosofia dell’arte, Laterza, Roma-
Bari 2008.
Davies, S., Definitions of Art, Cornell University Press, Ithaca (N.Y.) 1991.
−, “First Art and Art’s Definition”, Southern Journal of Philosophy 35 (1997), pp.
19-34.
−, “Non-Western Arts and Art’s Definition”, in N. Carroll (a cura di), Theories of
Art Today, pp. 199-216.
−, “The Cluster Account of Art”, British Journal of Aesthetics 44 (2004), pp. 297-
300.
Dewey, J., Art as Experience (1934), trad. it. (a cura di Giovanni Matteucci), Arte
come esperienza, Aesthetica, Palermo 2007.
Desideri, F., Forme dell’Estetica, Laterza, Roma-Bari 2004.
Dickie, G., Art and the Aesthetic: An Institutional Analysis, Cornell University Press,
Ithaca (N.Y.) 1974.
−, Evaluating Art, Temple University Press, Philadelphia 1988.
−, The Art Circle, Haven, New York 1984.
−, The Century of Taste, Oxford University Press, New York 1996.
−, “The New Institutional Theory of Art” (1983), ora in A. Neill e A. Ridley (a cura
di), pp. 213-23.
Diffey, T., “Essentialism and the Definition of ‘Art’”, British Journal of Aesthetics
13 (1973), pp. 103-120.
Di Giacomo F., C. Zambianchi (a cura di), Alle origini dell’opera d’arte
contemporanea, Laterza, Roma-Bari 2008.
Du Bos, J. B., Reflexions Critiques sur la Poesie et sur la Peinture (1719), ed. it. a
cura di M. Mazzocut-Mis e P. Vincenzi, Riflessioni Critiche sulla Poesia e sulla
Pittura, Aesthetica, Palermo 2005.
224
Dutton, D., “A Naturalist Definition of Art”, Journal of Aesthetics and Art Criticism
64 (2006), pp. 367-377.
−, “But They Don’t Have Our Concept of Art”, in N. Carroll (a cura di), Theories of
Art Today, pp. 217-238.
−, “Tribal art and Artifact”, Journal of Aesthetics and Art Criticism 51 (1993), pp.
13-21.
Eaton, M. M., “The Intrinsic, Non-Supervenient Nature of Aesthetic Properties”,
Journal of Aesthetics and Art Criticism 52 (1994), pp. 383-97.
Eldridge, R., “Form and Content: an Aesthetic Theory of Art” (1985), ora in A.
Neill., A. Ridley (a cura di), pp. 239-53.
Elster, J., Ulysses Unbound: Studies in Rationality, Pre-Commitment and Constraint
(2000), trad. it. Ulisse liberato: razionalità e vincoli, Il Mulino, Bologna 2004.
Fry, R., “An Essay in Aesthetics” (1909), trad. it. “Un saggio di estetica”, in Di
Giacomo, C. Zambianchi (a cura di), Alle origini dell’opera d’arte
contemporanea, pp. 5-18.
Gallie, W. B., “Art as an Essentially Contested Concept”, Philosophical Quarterly 6
(1956), pp. 97-114.
Gaut, B., “ ‘Art’ as a Cluster Concept”, in N. Carroll (a cura di), Theories of Art
Today, pp. 25-44.
Gell, A., “The Technology of Enchantement and the Enchantement of Technology”,
in J. Coote a A. Shelton (ed. by), Anthropology, Art, and Aesthetics, Clarendon
Press, Oxford 1992, pp. 40-63.
Gerard, A., An Essay on Taste (1759-1780), Scholars’ Facsimile & Reprints,
Delmar, New York 1978 (Introduction by W.J. Hipple).
Goldman, A., Aesthetic Value, Westview Press, Boulder (Colorado) 1995.
225
−, “Art Historical Value”, British Journal of Aesthetics 33 (1993), pp. 17-28.
−, “Realism About Aesthetic Properties”, The Journal of Aesthetics and Art
Criticism 51 (1993), pp. 31-37.
Goodman, N., The Languages of Art: An Approach to a Theory of Symbols (1968),
trad. it. (a cura di F. Brioschi), I Linguaggi dell’Arte, NET, Milano 2003.
Haines, V., “Recursive Chaos in Defining Art Recursively”, British Journal of
Aesthetics 44 (2004), pp. 73-83.
−, “Refining Not Defining Art Historically”, Journal of Aesthetics and Art Criticism
48 (1990), pp. 237-38.
Hart, L., “Three Walls: Regional Aesthetics and the International Art World”, in G.
E. Marcus e F. E. Myers (ed. by), The Traffic in Culture: Refiguring Art and
Anthropology, University of California Press, Berkeley 1995, pp. 127-50.
Hermeren, G., The Nature of Aesthetic Qualities, Lund University Press, Lund 1988.
Hester, M., “Hume on Principles and Perceptual Ability”, Journal of Aesthetics and
Art Criticism 37 (1979), pp. 295-302.
Hume, D., On the Standard of Taste (1757), in The Philosophical Works of David
Hume, 4 vols., ed. by H. Green and T. H. Grose, 1882-6 (rpt., Scientia Verlag,
Aalen 1992); trad. it. Sul Canone del gusto, in M. M. Rossi (a cura di),
L’Estetica dell’Empirismo Inglese (1944), pp. 568-595.
Iseminger, G., “Actual Intentionalism vs. Hypotetical Intentionalism”, Journal of
Aesthetics and Art Criticism 54 (1996), pp. 319-26.
−, “Aesthetic Appreciation”, Journal of Aesthetics and Art Criticism 39 (1981), pp.
389-99.
− (a cura di), Intention and Interpretation, Temple University Press, Philadelphia
1992.
226
Isenberg, A., “Critical Communication” (1949), ora in A. Neill e A. Ridley (a cura
di), pp. 363-373.
Kant, I., Kritik der urteilskraft (1790), trad. it. (a cura di Leonardo amoroso), Critica
della capacità di giudizio, BUR, Milano 1995.
Kennick, E. (a cura di), Art and Philosophy: Readings in Aesthetics, St. Martin
Press, New York 1979.
−, “Does Traditional Aesthetic Rest on a Mistake?”, Mind 67 (1958), pp. 317-34.
Kivy, P., “Aesthetic Perception” (1973), ora in E. Kennick (a cura di), Art and
Philosophy, pp. 411-431.
−, The Corded Shell, Princeton University Press, Princeton 1980.
Kobau, P., Matteucci, G., Velotti, S. (a cura di), Estetica e Filosofia Analitica, Il
Mulino, Bologna 2007.
Kolak, D., “Art and Intentionality”, Journal of Aesthetics and Art Criticism 48
(1990), pp. 158-62.
Levinson, J., “A Refiner’s Fire: Reply To Sartwell and Kolak”, Journal of Aesthetics
and Art Criticism 48 (1990), pp 231-35.
−,“Art Historically Defined: Reply to Oppy”, British Journal of Aesthetics 33
(1993), pp. 380-85.
−, “Art, Value and Philosophy: A Critical Notice”, Mind 105 (1996), pp. 667-682
−, Contemplating Art, Clarendon Press, Oxford (N. Y.) 2006. Contiene:
“Aesthetic Properties, Evaluative Force and Differences of Sensibility” (2001), pp.
315-335.
“Artworks as Artifacts” (2006), pp. 27-37.
“Elster on Artistic Creativity” (2003), pp. 56-74.
“Emotion in Response to Art” (1997), pp. 38-55.
“Evaluating Music” (1998), pp. 184-208.
“Hume’Standard of Taste: the Real Problem” (2002), pp. 366-385.
227
“Hypotetical Intentionalism: Statement, Objections and Replies” (2002), pp. 302-
311.
“Intrinsic Value and the Notion of a Life” (2004), pp. 400-418.
“Nonexistent Artforms and the Case of Visual Music” (1997), pp. 109-128.
“Musical Expressiveness and Hearability-as-Expression” (2006), pp. 91-108.
“The Irreducible Historicality of the Concept of Art” (2002), pp. 13-26.
“What Are Aesthetic Properties?” (2005), pp. 336-351.
−, “Further Fire: Reply To Haines”, Journal of Aesthetics and Art Criticism 49
(1991), pp. 76-77.
−, “Il piacere nella musica contemporanea”, in Matteucci G. (a cura di), Elementi di
Estetica Analitica, cit., pp. 129-141.
−, Music, Art, and Metaphysics, Cornell University Press, Ithaca (N.Y.) 1990.
Contiene:
“Aesthetic Supervenience” (1983), pp. 134-158.
“Aesthetic Uniqueness” (1980), pp. 107-133.
“Artworks and the Future” (1987), pp. 179-214.
“Defining Art Historically” (1979), pp. 3-25.
“Hybrid Art Forms” (1984), pp. 26-36.
“Music and Negative Emotion” (1982), pp. 306-335.
“Refining Art Historically” (1989), pp. 37-59.
“What a Musical Work Is” (1980), pp. 63-88.
−, The Pleasures of Aesthetics, Cornell University Press, Ithaca 1996. Contiene:
“Extending Art Historically” (1993), pp. 150-171.
“Intention and Interpretation in Literature” (1992), pp. 175-213.
“Messages in Art” (1995), pp. 224-241.
“Musical Expressiveness” (1996), pp. 90-125.
“Pleasure and the Value of Works of Art” (1992), pp. 11-24.
“What is Aesthetic Pleasure?” (1992), pp. 3-10.
“Work and Oeuvre” (1996), pp. 242-273.
Lind, R., “The Aesthetic Essence of Art”, Journal of Aesthetics and Art Criticism 50
(1992), pp. 117-29.
228
Lochhead, J., Auner, J. (a cura di), Postmodern Music/Postmodern Thought,
Routledege, New York 2002.
Mackinnon, J., “Scruton, Sibley, and Supervenience”, The Journal of Aesthetics and
Art Criticism 58 (2000), pp. 383-392.
Mandelbaum, M., “Family Resemblances and Generalisations Concerning the Arts”
(1965), ora in A. Neill e A. Ridley (a cura di), pp. 193-201.
Marchetti, L., Arte ed Estetica in Nelson Goodman, Aesthetica Preprint,
Supplementa, Palermo 2006.
Matravers, D., “Aesthetic Concepts and Aesthetic Experiences”, British Journal of
Aesthetics 36 (1996), pp. 265-77.
Matteucci, G., “Ci sono e percepiamo le qualità estetiche?”, in Studi di estetica 27
(2003), pp. 207-22.
− (a cura di), Elementi di Estetica Analitica, Quodlibet, Macerata 2005.
Mc Fee, G., “The Historical Character of Art: a Re-Appraisal”, British Journal of
Aesthetics 32 (1992), pp. 307-19.
−, “The Historicity of Art”, Journal of Aesthetics and Art Criticism 38 (1980), pp.
307-24.
Moravcsik, J., “Why Philosophy of Art in a Cross-cultural Perspective?”, Journal of
Aesthetics and Art Criticism 51 (1993), pp. 425-435.
Neill, A., Ridley, A. (a cura di), The Philosophy of Art: Readings Ancient and
Modern, McGraw-Hill, New York 1995.
Oppy, G., “On Defining Art Historically”, British Journal of Aesthetics 32 (1992),
pp. 153-61.
229
Ottobre, A., “L’abuso delle proprietà estetiche”, Rivista di Estetica 35 (2007), p.
293-310.
−, “La sopravvenienza estetica”, Rivista di Estetica 36 (2007), pp. 209-231.
−, “Sulle Proprietà Estetiche”, Rivista di Estetica 23 (2/2003), pp. 84-106.
Pettit, P., “The Possibility of Aesthetic Realism” (1983), trad. it. “La possibilità del
realismo estetico”, in Kobau, Matteucci, Velotti (a cura di), Estetica e Filosofia
Analitica, pp. 207-233.
Pirsig, R., Zen and the art of Motorcycle Maintenance (1974), trad. it. (a cura di
Delfina Vezzoli), Lo Zen e l’arte della manutenzione della motocicletta,
Adelphi, Milano 1999 (XII edizione).
Pouivet, R., “Definire l’arte: missione impossibile?”, Studi di Estetica 28, pp. 319-
332.
Rossi, M. M. (a cura di), L’Estetica dell’Empirismo Inglese, Sansoni, Firenze 1944.
Russo, L., (a cura di), Il Gusto. Storia di un’Idea Estetica, Aesthetica, Palermo 2000.
− (a cura di), Jean-Baptiste Du Bos e l’estetica dello spettatore, Aesthetica Preprint,
Palermo 2005.
Sartwell, C., “A Counter-Example to Levinson’s Historical Theory of Art”, Journal
of Aesthetics and Art Criticism 48 (1990), pp. 157-58.
Savile, A., “The Rationale of Restoration”, The Journal of Aesthetics and Art
Criticism 51 (1993), pp. 463-474.
Shelley, J., “The Problem of Non-Perceptual Art”, British Journal of Aesthetics 43
(2003), pp. 363-378
Sibley, F., , “Aesthetic Concepts” (1963), ora in Neill. A. e Ridley A. (ed. by), The
Philosophy of Art: Readings Ancient and Modern, pp. 312-331.
230
−, Approach to Aesthetics: Collected Papers on Philosophical Aesthetics, Clarendon
Press, Oxford 2001. Contiene:
“Aesthetic and Non-aesthetic” (1965), pp. 33-51.
“Colours” (1967-8), pp. 54-70.
“General Criteria and Reasons in Aesthetics” (1983), pp. 104-118.
“Particularity, Art and Evaluation” (1974), pp. 88-103.
Silvers, A., “The Story of Art Is the Test of Time”, The Journal of Aesthetics and Art
Criticism 49 (1991), pp. 211-224.
Stecker, R., “Alien Objections to Historical Definitions of Art”, British Journal of
Aesthetics 36 (1996), pp. 305-8.
−, Artworks: Definition, Meaning, Value, Pennsylvania State University Press,
University Park, PA 1997.
−, “Historical Functionalism or the Four Factor Theory”, British Journal of
Aesthetics 34 (1994), pp. 255-65.
−, “Is It Reasonable to Attempt to Define Art?”, in N. Carroll (a cura di), Theories of
Art Today, pp. 45-64.
−, “The Boundaries of Art”, British Journal of Aesthetics 30 (1990), pp. 266-72.
Taine, H., Philosophie de l’Art (1881), trad. di O. Settineri, La Filosofia dell’Arte,
Bompiani, Milano 2001.
Tatarkiewicz, W., Storia di Sei Idee, Aesthetica, Palermo 1993.
−, “What is Art? The Problem of Definition Today”, British Journal of Aesthetics
11 (1971), 134-53.
Tolhrust, W., “On What a Text Is and How It Means”, British Journal of Aesthetics
19 (1979), pp. 3-14.
Tormey, A., “Critical Judgement” (1973), ora in E. Kennick, Art and Philosophy,
cit., pp. 620-630.
231
Vaida, I-C., “The Quest for Objectivity: Secondary Qualities and Aesthetic
Qualities”, The Journal of Aesthetics and Art Criticism 56 (1998), pp. 283-297.
Velotti, S., Estetica analitica: un breviario critico, Aesthetica Preprint, Palermo
2008.
Vermazen, B., “Comparing Evaluations of Works of Art” (1975), ora in W. E.
Kennick, Art and Philosophy, pp. 707-718.
Vickers, A., Bali: A Paradise Created, Penguin, Victoria 1989.
Voltolini, A., Guida alla lettura delle ricerche filosofiche di Wittgenstein, Laterza,
Roma-Bari 1998, p. 45.
Walton, K., “Categories of Art” (1970), ora in A. Neill e A. Ridley (a cura di), pp.
332-354.
−, “How Marvelous! Toward a Theory of Aesthetic Value”, Journal of Aesthetics
and Art Criticism 51 (1993), pp. 499-510.
Warburton, N., The Art Question (2003), trad. it. (a cura di G. Bonino), La Questione
dell’Arte, Einaudi, Torino 2004.
Weitz, M., “The Role of Theory in Aesthetics” (1956), ora in A. Neill e A. Ridley (a
cura di), pp. 183-92.
Wieand, J., “Quality in Art”, British Journal of Aesthetics 21 (1981), pp. 330-335.
Wittgenstein, L., Lezioni e conversazioni sull’etica, l’estetica, la psicologia e la
credenza religiosa, a cura di M. Ranchetti, Adelphi, Milano 1967.
−, Philosophische Untersuchungen, Blackwell, Oxford 1953; trad. it. (a cura di M.
Piovesan e M. Trinchero), Ricerche Filosofiche, Einaudi, Torino 1995 (la prima
ed. it. è del 1967).
Wollheim, R., Art and Its Objects, Cambridge University Press, Cambridge 1980.
232
− “Minimal Art”, Arts Magazine, January 1965 (reprinted in G. Battcock (ed.),
Minimal Art: A Critical Anthology, Dutton, New York 1968).
Yanal, R. (a cura di), Institutions of Art: Reconsiderations of George Dickie’s
Philosophy, Pennsylvania State University Press, University Park 1994.
Zangwill, N., “Aesthetic/Sensory Dependence”, British Journal of Aesthetics 38
(1998).
−, “Are There Counter-Examples to Aesthetic Theories of Art?”, Journal of
Aesthetics and Art Criticism 60 (2002), pp. 111-118.
−, “Beauty” Oxford Companion to Aesthetics, Jerrold Levinson (ed.), Oxford
University Press, 2003.
−, “Feasible Aesthetic Formalism”, Nous 33 (1999), pp. 610-629.
−, “L’irrilevanza dell’avanguardia”, Rivista di Estetica 35 (2007), pp. 387-395.
−, “The Beautiful, The Dainty and the Dumpy”, British Journal of Aesthetics 35
(1995), pp. 317-29.
−, The Metaphysics of Beauty, Cornell University Press, Ithaca 2001.
Zemach, E., “No Identification without Evaluation”, Journal of Aesthetics and Art
Criticism 26 (1986), pp. 239-51.
Ziff, P., “Reasons in Art Criticism” (1958), ora in E. Kennick, Art and Philosophy,
pp. 669-686.
−, “The Task of Defining a Work of Art”, Philosophical Review 62 (1953), pp. 58-
78.