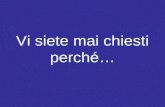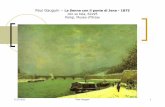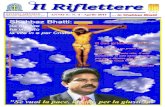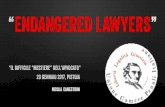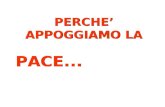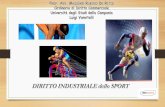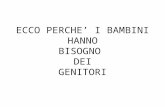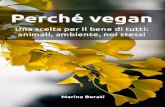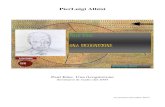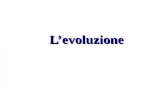Il Potere Del Carattere_ Perche - Tough, Paul
-
Upload
martinaspadafora -
Category
Documents
-
view
137 -
download
0
Transcript of Il Potere Del Carattere_ Perche - Tough, Paul
-
www.princexml.comPrince - Personal EditionThis document was created with Prince, a great way of getting web content onto paper.
-
Crescere bambini realizzati, che diventeranno adulti di suc-cesso, non un gioco dazzardo. quasi una scienza esatta, basta sapere come fare. Ci han-no abituato a credere che lunica cosa che conta per raggi-ungere risultati importanti lintelligenza e in particolare ilQI, lintelligenza cognitiva, misurabile con i test e gli es-ami di cui costellata la carriera scolastica. Sbagliato! Se-condo Paul Tough le qualit che contano di pi hanno a chefare con il carattere. Tenacia, curiosit, disciplina, ottim-ismo, grinta: ecco le chiavi per riuscire, a scuola ma soprat-tutto nella vita. Con il sostegno delle pi recenti scopertedella psicologia, delle neuroscienze e delleconomia,Tough ci mostra il collegamento fra stress infantile e suc-cesso da adulti, spiegandoci come le difficolt vissute dur-ante linfanzia non hanno soltanto un effetto psicologicoma possono persino modificare la biochimica del cervello.Tuttavia, a differenza del QI che dopo una certa et nonpu pi essere cambiato le forze del carattere sonocompetenze che si possono allenare, e che possono essereinsegnate. Provocatorio, coinvolgente e con un messaggiocarico di speranza, Il potere del carattere destinato a
-
trasformare il nostro modo di pensare lorganizzazionedella scuola e leducazione dei nostri figli. Per aiutarli acostruirsi un futuro brillante e ricco di successi esoddisfazioni.
3/608
-
PAUL TOUGH scrive di educazione e infanzia per ilNew York Times, il New Yorker, GQ e Esquire.Ha lavorato come reporter e produttore per il programmaradiofonico This American Life e ha fondato la rivista on-line Open Letters. Vive a New York con sua mogliee suofiglio. Il potere del carattere in corso di traduzione in 10Paesi.
-
Paul Tough
Il potere del carattereTraduzione di Daniele Didero
-
Propriet letteraria riservataCopyright 2012 by Paul Tough
Published by arrangement with Marco Vigevani AgenziaLetteraria
2013 RCS Libri S.p.A., Milano
ISBN 978-88-65-97066-9
Titolo originale dellopera: How children succeed
Prima edizione Fabbri Editori: ottobre 2013
In copertina:Eliot fotografato da Tom Zed Tom Zed
Art Director: Francesca Leoneschi / theWorldofDOT
www.fabbrieditori.eu
-
Il potere del carattere
-
A Ellington,che preferisce i libri che parlano
di autocarri con il cassone ribaltabile
-
Introduzione
Nellestate del 2009, un paio di settimane dopo lanascita di mio figlio Ellington, ho trascorso unagiornata in un asilo di una cittadina del New Jer-sey. Non mi trovavo per nellaula 140 della RedBank Primary School nelle vesti di genitore, main quelle di giornalista che segue uninchiesta. Diprimo acchito, laula sembrava normale in tutto eper tutto, con le pareti dipinte di un giallo vivacee la bandiera americana accanto alla lavagna bi-anca. I bambini di quattro anni si dedicavano al-legri ai tipici passatempi dellasilo: costruire torridi mattoncini Lego, giocare con le macchinine ecomporre puzzle. Con il passare delle ore, tut-tavia, mi sono reso conto che in quella classe
-
cera qualcosa di molto insolito, tanto evidentequanto difficile da cogliere nellimmediato. In-nanzitutto, i bambini erano molto pi calmi e dis-ciplinati di quanto ci si potrebbe aspettare: nonpiangevano, non litigavano, non facevano a botte,insomma, nessuna crisi. A rendere ancora pistrana la cosa, poi, la loro maestra la signorinaLeonardo, una giovane donna dai capelli scuri non pareva affannarsi troppo a mantenere lor-dine; anzi, non sembrava neppure che stesseguidando le attivit, perlomeno non apertamente.Non li richiamava, non dava medaglie, non inter-rompeva i giochi, non diceva mai: Vorrei tantoche stessi attento come Kellianne!; di fatto, noncera nessun premio per i buoni e nessuna puniz-ione per i cattivi.
I bambini dellaula 140 stavano partecipando aun programma per gli asili chiamato Tools ofthe Mind, strumenti della mente, messo a puntodi recente da due educatori di Denver e basato suuna teoria non ortodossa dello sviluppo infantile.1Oggi negli Stati Uniti la maggior parte delle
11/608
-
scuole per linfanzia mira a insegnare una seriespecifica di competenze prescolastiche, legatesoprattutto alla lettura dei testi e alle operazionicon i numeri. Tools of the Mind, invece, puntaa far s che i piccoli sviluppino un altro tipo diabilit: controllare i loro impulsi, restare concen-trati su quello che stanno facendo, evitando didistrarsi o di disperdere la propria attenzione, ge-stire le emozioni e organizzare i pensieri. I fond-atori di questo programma sono convinti che, almomento di passare in prima elementare e anchepi avanti, possedere queste abilit che possonoessere riassunte nel termine autoregolazione sar per i bambini un aiuto molto pi valido diquello offerto dalle competenze prescolastichetradizionali.
Tools of the Mind suggerisce una serie distrategie, trucchi e abitudini per apprendere aconcentrarsi. I bambini imparano a tenere amente i vari passaggi di unoperazione difficile,come tracciare la lettera W (gi, su, gi, su). Siservono di mediatori, oggetti fisici che gli
12/608
-
ricordano come eseguire una particolare attivit(per esempio, due carte una con il disegno di unpaio di labbra e laltra con un orecchio che, neimomenti di lettura comune, indicano a chi toccaleggere e chi deve invece ascoltare). Ogni mat-tina, preparano dei piani di gioco in cuidescrivono, a parole o con un disegno, le attivitdella giornata: Oggi guider il treno, oppureOggi porter le bambole in spiaggia. Inoltre,trascorrono molte ore immersi nella recita dagrandi, ripercorrendo lunghe e complessesceneggiature di fantasia grazie alle quali sos-tengono gli ideatori del programma possonoimparare con naturalezza a seguire le regole e acontrollare i loro impulsi.
Mentre guardavo i bambini nellaula, mi sonoinevitabilmente ritrovato a pensare a Ellington, laminuscola forma di vita che in quel momentoemetteva vagiti una cinquantina di chilometri pia nord, nel nostro appartamento di Manhattan.Volevo che la sua vita fosse felice e piena di suc-cessi, su questo non avevo dubbi, ma non avrei
13/608
-
saputo dire con precisione n che cosa intendessicon successi, n tantomeno che cosa avremmodovuto fare io e mia moglie per aiutarlo aconseguirli.
Non ero comunque il solo a essere confuso. El-lington era nato in un periodo in cui i genitoriamericani erano preda di una particolare ansia,una tensione che si faceva sentire soprattutto inmetropoli come New York, dove la lotta per ac-caparrarsi un posto nei migliori asili ricordava gliscontri fra gladiatori. Una Rug Rat Race, unacorsa sfrenata al successo dei bambini, come dueeconomisti dellUniversit della California hannodi recente soprannominato questa sfida scolasticainfantile che ha ormai contagiato lintera nazionee che ogni anno sembra farsi pi agguerrita.2 Dueanni prima della nascita di Ellington, statoaperto anche a New York un centro per lappren-dimento Kumon. Qui i bambini di due anni pas-sano la mattinata riempiendo fogli di esercizi eallenandosi nel riconoscimento delle lettere e deinumeri, secondo il metodo sviluppato
14/608
-
dalleducatore giapponese Toru Kumon, che pre-vede anche di sottoporre i bambini a periodicitest di verifica. Tre anni let migliore ha di-chiarato il direttore finanziario della Kumon auna giornalista del New York Times, ma se nonportano pi il pannolino e riescono a stare fermi eseduti davanti a un nostro assistente per quindiciminuti, noi li prendiamo anche prima.3
Frequentando uno di questi centri, Ellingtonsarebbe cresciuto in una cultura permeata daquella che potremmo definire ipotesi cognit-iva: la convinzione, perlopi implicita manondimeno comunemente accettata, secondo cuiil successo oggi dipende soprattutto dalle abilitcognitive (quel tipo di intelligenza che viene mis-urato dai test del QI e che comprende, tra laltro,la capacit di riconoscere lettere e parole, di cal-colare e di individuare schemi) e che ritiene cheil modo migliore per sviluppare tali abilit con-sista nellesercitarle il pi possibile, cominciandogi da piccolissimi. Lipotesi talmente condi-visa che facile dimenticarsi di come, in realt,
15/608
-
si tratti di una teoria piuttosto recente: la sua af-fermazione nella cultura contemporanea pu es-sere fatta risalire al 1994, quando una delle piprestigiose fondazioni americane, la CarnegieCorporation di New York, pubblic un rapportodai toni allarmistici sullo sviluppo cognitivo deibambini americani intitolato Starting Points:Meeting the Needs of Our Youngest Children.4Punto primo: provvedere alle necessit dei pipiccoli. Il problema, stando a questo studio, erache i bambini non ricevevano abbastanza stimolicognitivi nei primi tre anni di vita, anche per viadel crescente numero di famiglie monoparentali edi madri lavoratrici; i piccoli, cos, arrivavanoallasilo impreparati allapprendimento. Il rap-porto lanci unintera industria di prodotti per losviluppo del cervello dei bambini da zero a treanni, pensati pi che altro per placare le ansiedei genitori: il risultato fu la vendita di enormiquantit di libri, eserciziari, Dvd e videocassettesu come trasformare i propri figli in piccoli Ein-stein, con un fatturato di miliardi di dollari.
16/608
-
Le scoperte della Carnegie e gli studi cheseguirono ebbero un forte impatto anche sullepolitiche pubbliche, spingendo legislatori e fil-antropi ad abbracciare la conclusione secondocui, se i bambini svantaggiati restavano benpresto indietro, era a causa di un insufficiente al-lenamento cognitivo. Psicologi e sociologi evid-enziarono il collegamento fra lo scarso rendi-mento scolastico dei bambini poveri e la man-canza di stimoli verbali e matematici a casa e ascuola: uno degli studi pi famosi era stato con-dotto da due psicologi dellinfanzia, Betty Hart eTodd R. Risley, che a partire dagli anni Ottantaavevano seguito un gruppo di quarantaduebambini di Kansas City, figli di professionisti, dioperai e di genitori che vivevano col sussidio didisoccupazione.5 Stando alla loro ricerca, la dif-ferenza cruciale nelleducazione dei bambini nonch la ragione del successivo divario a livellodi risultati scolastici si riduceva a un unico ele-mento: il numero di parole che avevano sentitopronunciare dai genitori nei primi anni di vita.
17/608
-
Secondo i calcoli di Hart e Risley, nei primi treanni ai figli dei professionisti erano state rivoltetrenta milioni di parole, mentre quelli dei disoc-cupati ne avevano sentite solo dieci milioni;questa disparit, stando alle loro conclusioni, eraalla radice degli insuccessi a cui i bambini pipoveri sarebbero andati incontro nella scuola enella vita.
Il fascino dellipotesi cognitiva innegabile: ilmondo che descrive chiaro e netto, rassicurantenella sua linearit, governato da un infallibilerapporto di causa ed effetto. Avere pochi libri incasa porta a una ridotta capacit di leggere; menoparole sentite dai genitori implicano unvocabolario pi limitato per i figli; pi esercizi dicalcolo alla Junior Kumon si traducono inmigliori risultati in matematica a scuola. In alcunicasi, le correlazioni erano talmente precise dasuonare quasi comiche: stando alle valutazioni diHart e Risley, un bambino cresciuto con i sussidiavrebbe bisogno esattamente di quarantun oresettimanali di recupero linguistico intensivo per
18/608
-
colmare il divario tra il suo vocabolario e quellodi un figlio di operai.
Nello scorso decennio e in particolare negliultimi anni un gruppo di economisti, educatori,psicologi e neuroscienziati ha per iniziato apresentare prove che mettono in discussionemolti degli assunti alla base dellipotesi cognit-iva. Ad aiutare lo sviluppo dei bambini, af-fermano, non il numero di informazioni cheriusciamo a stipare nel loro cervello nei primis-simi anni di vita, ma la nostra capacit di aiutarlia potenziare tutta unaltra serie di qualit laperseveranza, lautocontrollo, la curiosit, la cos-cienziosit, la fermezza e la fiducia in se stessi che gli economisti chiamano competenze noncognitive, gli psicologi tratti della personalite luomo della strada carattere.
Per lo sviluppo di alcune attitudini, il mero cal-colo che sta dietro allipotesi cognitiva iniziareprima e fare pi pratica resta valido: sevogliamo perfezionarci nel basket, fare duecentotiri a canestro ogni pomeriggio certo meglio che
19/608
-
farne soltanto venti; allo stesso modo, un alunnodi quarta elementare che durante lestate leggequaranta libri far pi progressi nella lettura diuno che ne legge solo quattro. Alcune abilitsono molto meccaniche, ma quando parliamodello sviluppo di tratti pi sottili della personal-it, le cose non sono cos semplici: per migliorareil nostro modo di affrontare le delusioni nonbasta lavorarci sopra pi a lungo e con maggioreimpegno, e il motivo per cui un bambino pococurioso non va cercato nel fatto che non ha inizi-ato a esercitarsi abbastanza presto. Le strade checi portano ad acquisire e a perdere questi talentinon sono certo casuali (negli ultimi decenni, glipsicologi e i neuroscienziati hanno imparato tan-tissimo sulla loro origine e sul modo in cui si svi-luppano), ma restano nondimeno complesse,poco conosciute e spesso assolutamentemisteriose.Questo libro incentrato su unidea che sta con-quistando sempre pi consensi nelle aule, nellecliniche, nei laboratori e nelle sale conferenze
20/608
-
degli Stati Uniti e del mondo. Secondo questonuovo modo di pensare, le teorie convenzionalisullo sviluppo infantile affermatesi negli ultimidecenni hanno preso una direzione fuorviante: cisiamo concentrati sulle capacit e sui talentisbagliati e, per coltivarli e insegnarli, abbiamousato strategie non corrette. Forse ancora pre-maturo parlare di questidea come di una nuovascuola di pensiero: in molti casi, infatti, i ricer-catori che portano il loro contributo a questa cres-cente mole di dati lavorano ancora da soli. Maqualcosa sta cambiando: scienziati e educatorihanno pi occasioni di incontro e sono pi portatia stabilire collegamenti fra le diverse disciplineaccademiche. La teoria a cui stanno lavorandopotrebbe cambiare il modo in cui alleviamo i nos-tri figli, gestiamo le nostre scuole e mettiamo apunto il nostro welfare.
Al centro di questa nuova rete interdisciplin-are, c indubbiamente James Heckman, un eco-nomista dellUniversit di Chicago. A un primosguardo, questo tipico intellettuale accademico
21/608
-
con le lenti spesse, un QI stratosferico e iltaschino della camicia pieno di matite a pulsantepotrebbe sembrare il personaggio meno adatto aguidare una sfida alla supremazia delle abilitcognitive. Cresciuto a Chicago fra gli anni Quar-anta e Cinquanta, figlio di un dirigente di mediolivello nellindustria della carne. I suoi genitorinon avevano studiato al college, ma si resero benpresto conto dellintelligenza precoce del figlio: aotto anni, Heckman rub al padre e lesse tuttadun fiato la copia di un famoso libro di auto-aiuto, 30 Days to a More Powerful Vocabulary,Migliorare il proprio vocabolario in 30 giorni; anove, mise da parte la sua paghetta per ordinareMathematics for the Practical Man, Matematicaper luomo pratico, pubblicizzato sulla quarta dicopertina di un fumetto. Heckman mostr diavere un talento innato per la matematica: sitrovava pi a suo agio con le equazioni che con lepersone. Da adolescente, si divertiva a pensare agrandi numeri e a scomporli mentalmente in fat-tori primi: fu quello che fece quando, a sedici
22/608
-
anni, gli arriv per posta il suo numero di previd-enza sociale.
Nominato professore di economia prima allaColumbia University e quindi allUniversit diChicago, nel 2000 Heckman vinse il premio No-bel per leconomia grazie a un complesso metodostatistico che aveva inventato negli anni Settanta.Fra gli economisti, famoso per il suo talento ineconometria, un tipo di analisi statistica che, ingenere, risulta comprensibile solo agli addetti ailavori: ho provato a frequentare diversi corsi spe-cialistici di Heckman ma, pur mettendoci tutto ilmio impegno, la maggior parte delle lezioni misembravano impossibili da seguire, pienecomerano di sconcertanti equazioni e di frasicome funzioni generalizzate di Leontief oelasticit di sostituzione di Hicks-Slutsky, chemi facevano venir voglia di nascondere la testasotto il banco e tapparmi le orecchie.
Anche se le tecniche di cui si avvale Heckmanpossono risultare oscure, i temi su cui ha scelto diconcentrarsi non lo sono affatto. Dopo aver vinto
23/608
-
il Nobel, ha sfruttato il prestigio non per cement-are la propria reputazione nel suo campo diricerca ma per espandere i propri interessi e lapropria influenza in aree di studio per luinuove, tra cui la psicologia della personalit, lamedicina e la genetica. (Sugli affollati scaffalidella libreria del suo ufficio, infilata tra due pes-anti volumi di storia delleconomia, c ancheuna copia di Genetics for Dummies, Genetica pernegati.) Dal 2008, Heckman ha organizzato conregolarit una serie di conferenze in cui psicologied economisti sono stati invitati a concentrarsi sualcuni interrogativi in particolare: quali sono itratti caratteriali e le abilit che conducono alsuccesso? Come si sviluppano nellinfanzia? Eche tipo di interventi possono aiutare i bambini amigliorarli?
In un paio di edifici del campus dellUniversitdi Chicago, Heckman guida un gruppo di duedozzine di ricercatori e specializzandi provenientida tutto il mondo, che, tra il serio e il faceto, siriferiscono alla loro trib chiamandola
24/608
-
Heckmanland. Portano sempre avanti pi pro-getti contemporaneamente: del resto anche lostesso Heckman, quando parla del suo lavoro,salta da un argomento allaltro, entusiasmandositanto per gli studi sulle scimmie condotti nelMaryland quanto per quelli sui gemelli in Cina oper la collaborazione con un filosofo che indagasulla vera natura della virt. (Una volta sono an-dato a trovarlo e ho provato a chiedergli di spie-garmi come si incontrassero i vari filoni delle suericerche. Pi tardi, mentre mi accompagnavaalluscita, la sua assistente si girata verso di medicendo: Se riesce a scoprirlo, ce lo facciasapere.)
La svolta della carriera di Heckman ha le sueradici in uno studio da lui condotto verso la finedegli anni Novanta sul programma per lo Svi-luppo educativo generale, meglio noto come pro-gramma GED (General Educational Develop-ment), che allepoca stava diventando sempre pipopolare fra chi aveva abbandonato le scuole su-periori e voleva ottenere lequivalente di un
25/608
-
diploma. In molti lo vedevano come uno stru-mento per offrire agli studenti appartenenti ainuclei familiari a basso reddito e alle minoranzeetniche quelli, insomma, che avevano le mag-giori probabilit di interrompere il loro percorsoscolastico , una via daccesso alternativa alcollege.
Il GED si basava su una versione dellipotesicognitiva: se la scuola ha lo scopo di svilupparele abilit cognitive, allora il diploma delle superi-ori non altro che la certificazione del possessodi queste abilit. Ma un adolescente che abbia gile conoscenze e le capacit necessarie perottenere questo diploma, non ha bisogno di spre-care il suo tempo portando a termine il liceo: pulimitarsi ad affrontare un test che misuri quelleconoscenze e quelle capacit, e ottenere un at-testato legale che gli consentir di entrare alluni-versit. Si tratta di una possibilit affascinante soprattutto per quei giovani che non sopportanolidea di frequentare le scuole superiori e dalmomento della sua introduzione, negli anni
26/608
-
Cinquanta, il programma ha registrato una rapidacrescita: nel 2001, al culmine del suo successo, iltest era stato affrontato da pi di un milione digiovani, e quasi un diplomato su cinque avevadi fatto ottenuto la sua qualifica grazie al GED.(Oggi il rapporto sceso a circa uno su sette.)
Volendo approfondire lidea che i giovani cheavevano sostenuto il GED erano preparati allesfide accademiche allo stesso modo dei normalidiplomati, Heckman analizz alcuni databasenazionali e not che, sotto molti aspetti import-anti, la premessa era del tutto valida: stando ai ri-sultati delle prove, strettamente correlati al QI, chipassava il GED era intelligente come chi si diplo-mava alle superiori. Tuttavia, le differenzeemergevano nitidamente guardando la carrierascolastica successiva: allet di ventidue anni, in-fatti, solo il 3 per cento dei giovani del GED eranoiscritti a un corso quadriennale alluniversit oavevano conseguito un diploma universitariobreve, contro il 46 per cento dei normali diplo-mati. Di fatto, Heckman scopr che, se si
27/608
-
prendono in considerazione le principali con-quiste che un giovane pu raggiungere nel suofuturo (dal reddito annuale al tasso di disoccu-pazione, dalle percentuali di divorzio alluso distupefacenti), chi ha passato il GED si distingue dachi ha semplicemente abbandonato la scuola soloper il fatto di aver ottenuto questa credenziale(dal dubbio valore) in pi e di essere, in media,parecchio pi intelligente.6
Dal punto di vista delle iniziative di governo,si trattava di una scoperta utile, per quanto dep-rimente: sul lungo periodo, il GED non sembravain grado di migliorare la vita di una persona. An-zi, avrebbe potuto persino avere un impatto gen-erale negativo, inducendo i giovani ad abbandon-are le scuole superiori. Per Heckman questi datierano un autentico enigma: dopo aver semprecreduto, come la maggior parte degli economisti,che le abilit cognitive fossero il fattore pi de-terminante del successo di ciascun individuo, orasi ritrovava con un gruppo di persone quelleche avevano passato il GED la cui vita sembrava
28/608
-
non essere stata affatto influenzata in modo posit-ivo dai buoni risultati ottenuti nei test.
Heckman concluse che lelemento mancantefosse costituito da quei tratti psicologici comelattitudine a portare avanti un compito noioso espesso non appagante, la capacit di rimandare legratificazioni e la tendenza a seguire un pianoprestabilito che avevano permesso ai normalidiplomati di superare gli anni di scuola e che sidimostravano importanti anche alluniversit, sulposto di lavoro e nella vita in generale. Comespieg in un suo articolo, il GED involontaria-mente diventato un test che, fra gli studenti chehanno abbandonato la scuola, separa quelli intel-ligenti ma incostanti e indisciplinati dagli altri. Igiovani che si sono qualificati con il GED sonotipi svegli a cui manca la capacit di progettareil futuro, portare avanti unattivit o adattarsi alloro ambiente.7
Lo studio sul GED, per, non aveva dato aHeckman alcuna indicazione su come fosse pos-sibile aiutare i bambini a sviluppare queste
29/608
-
competenze trasversali, le cosiddette soft skills.Per cercare risposte, quasi un decennio fa sispinse fino a Ypsilanti, una vecchia citt indus-triale a ovest di Detroit, nel Michigan, dove versola met degli anni Sessanta, allinizio dellaGuerra alla povert portata avanti dal presid-ente Lyndon Johnson, un gruppo di psicologidellinfanzia e di scienziati delleducazioneaveva intrapreso un esperimento invitando i gen-itori con un reddito modesto e un QI basso chevivevano nei quartieri neri a iscrivere i loro figlidi tre e quattro anni alla scuola materna Perry,che attuava un programma prescolastico biennaledi alta qualit. I bambini furono suddivisi casual-mente in due gruppi, uno di trattamento e uno dicontrollo: solo i primi vennero ammessi al Pro-getto Perry. I soggetti sarebbero stati poi monit-orati per decenni, in uno studio continuativo cheintendeva seguirli per il resto della loro vita; oggihanno pi di quarantanni, il che significa che iricercatori hanno avuto modo di osservare gli ef-fetti del Progetto Perry fino allet adulta.
30/608
-
Il Progetto scuola materna Perry famosonellambiente delle scienze sociali ed Heckmanlo aveva gi incontrato diverse volte nel corsodella sua carriera. Come esempio di interventosulla prima infanzia, lesperimento era semprestato considerato un insuccesso: i bambini delgruppo di trattamento avevano conseguito ri-sultati notevolmente migliori nei test cognitivimentre frequentavano la scuola materna e pi omeno per i due anni successivi, ma questovantaggio non era stato duraturo e, arrivati interza elementare, i loro punteggi ai test del QI nonsuperavano quelli del gruppo di controllo. Studi-ando per i risultati a lungo termine, Heckman ealtri ricercatori rilevarono dei dati pi pro-mettenti: se da una parte era vero che i soggettiammessi al Perry non avevano ottenuto beneficiduraturi in termini di QI, dallaltra avevanocomunque ricevuto da questa esperienza qualcosadi importante, i cui effetti positivi duravano perdecenni. Rispetto agli studenti del gruppo di con-trollo, quelli del Progetto Perry avevano maggiori
31/608
-
probabilit di diplomarsi alle superiori, diottenere un lavoro a ventisette anni e a quarantadi guadagnare pi di venticinquemila dollari lan-no, e minori probabilit di finire in galera o didover ricorrere per un certo periodo al sussidio didisoccupazione.8
Esaminando pi attentamente il Progetto Perry,Heckman scopr che negli anni Sessanta e Set-tanta i ricercatori non avevano incluso nella loroanalisi alcuni dei dati raccolti sugli studenti: lerelazioni, stilate dagli insegnanti delle elementari,che valutavano i bambini di entrambi i gruppisotto il profilo del comportamento personale(la frequenza con cui dicevano parolacce,mentivano, rubavano, arrivavano in ritardo ascuola o non si presentavano affatto) e dello svi-luppo delle attitudini sociali (il loro livello dicuriosit e i loro rapporti con compagni e maes-tri).9 Heckman etichett questi tratti caratterialicome competenze non cognitive, in quantoerano del tutto distinte dal QI. Dopo tre anni di at-tenti studi, lui e i suoi ricercatori erano in grado
32/608
-
di affermare con certezza che da quei fattori noncognitivi come la curiosit, lautocontrollo e lafacilit nei rapporti sociali dipendevano i dueterzi dei benefici che il Progetto Perry avevaportato agli studenti ammessi.
In altri termini, il Progetto scuola maternaPerry aveva funzionato, ma in un modo com-pletamente diverso dalle aspettative. Gli edu-catori che lo avevano messo in piedi negli anniSessanta erano animati dalle migliori intenzioni:volevano creare un programma in grado distimolare lintelligenza dei figli delle famiglie abasso reddito perch credevano, come tutti, chefosse quello il modo giusto per aiutarli a trovarela loro strada. La prima sorpresa era che, a lungotermine, il loro modello non faceva molto per ilQI, ma migliorava il comportamento e le compet-enze sociali; la seconda, comunque molto utile,era che, per i bambini di Ypsilanti, le competenzee i tratti caratteriali che esse implicavano sisarebbero dimostrati una risorsa preziosa.
33/608
-
Mentre lavoravo su questo libro, ho passatomolto tempo a discutere di successo e di compet-enze con economisti, psicologi e neuroscienziati,molti dei quali erano in qualche modo legati aJames Heckman. Ai miei occhi, comunque, ciche dava concretezza e significato alle loro ricer-che, ci che le rendeva vive, era un diverso tipodi indagini che stavo conducendo in quello stessoperiodo nelle scuole pubbliche, nelle cliniche pe-diatriche e nei fast food, dove parlavo congiovani le cui vite incarnavano e illustravano ilcomplesso problema di quali bambini raggiun-geranno il successo e come.
Prendiamo il caso di Kewauna Lerma. Quandolho incontrata, nellinverno del 2010, viveva nelSouth Side di Chicago, non troppo lontano dalcampus universitario dove Heckman portava av-anti le sue ricerche. Kewauna, seconda figlia diuna madre che aveva avuto la sua prima bambinada adolescente, era nata diciassette anni prima inuna famiglia povera del South Side e aveva avutouninfanzia difficile, senza la possibilit di
34/608
-
mettere radici in nessun posto: la madre si eratrasferita, portandosi dietro le figlie, prima nelMississippi, quindi nel Minnesota e infine dinuovo a Chicago, passando da una relazioneallaltra, sempre in mezzo ai guai. Quando lecose andavano male, si fermavano per un po inqualche casa rifugio o saltavano dal divano di unamico a quello di un altro. A volte la bisnonna diKewauna prendeva con s per un po le bambinelasciando che la madre cercasse di mettere ordinenella propria vita.
Non avevo una vera e propria famiglia mi hadetto Kewauna al nostro primo incontro in uncaff nel quartiere di Kenwood. Linverno a Ch-icago era rigido e le finestre erano tutte appan-nate. Kewauna una ragazza dalla carnagionescura, con un paio di occhioni gentili e un voltoincorniciato da capelli neri lisci; stava seduta pro-tendendosi in avanti, cercando di riscaldarsi lemani con una tazza di cioccolata con panna.Continuavo a passare di qui e di l, non avevo
35/608
-
un padre, talvolta stavo da mia nonna. Era tuttoconfuso, un gran casino.
Crescendo, Kewauna inizi a odiare la scuola.Non impar mai a leggere bene e alle elementaririmaneva sempre pi indietro: si metteva neiguai, saltava le lezioni e rispondeva male agli in-segnanti. Verso la met della prima media,mentre viveva nelle vicinanze di Minneapolis, ilsuo comportamento inappropriato laveva portataa collezionare settantadue note, in seguito allequali venne assegnata a una classe di recupero,cosa che la lasci ancor pi amareggiata. Pochesettimane prima della fine delle lezioni venne es-pulsa dalla scuola per aver fatto a botte.
Quando ho incontrato Kewauna stavo gi con-ducendo da diversi anni le mie ricerche suibambini cresciuti in povert e avevo sentito unsacco di storie come la sua: anche se non dettoche tutte le famiglie sfortunate lo siano per glistessi motivi e nello stesso modo, in quelle cherestano imprigionate per generazioni nella spiraledella povert lo schema pu essere tristemente
36/608
-
simile, con un ciclo in apparenza interminabile digenitori assenti o negligenti, scuole che funzion-ano male e decisioni sbagliate. Sapevo come van-no a finire di solito vicende simili: le ragazze coni suoi precedenti, nonostante le buone intenzioni,abbandonano la scuola alle superiori, rimangonoincinte ancora adolescenti, lottano per tirare su dasole la loro famiglia e, dopo qualche anno, i lorobambini si ritrovano a scivolare su quello stessopiano inclinato che porta allinsuccesso.
A un certo punto, per, la vita di Kewaunaprese unaltra direzione. Poco prima del suosecondo anno alle superiori e qualche settimanadopo il suo primo arresto (si era azzuffata con unpoliziotto), la madre le disse che voleva parlarle.Kewauna intu che si trattava di una cosa seriaperch era presente anche la bisnonna, lunicomembro della famiglia per il quale la ragazzaaveva sempre nutrito rispetto. Le due donne la fe-cero sedere e sua madre le grid una delle cosepi dure che un genitore possa dire: Non voglioche finisca anche tu come me. Le tre donne
37/608
-
parlarono per ore, discutendo del passato e delfuturo e riportando in luce alcuni segreti sepoltida tempo. La madre le confid che riconosceva lastrada che stava percorrendo: anche lei era stataespulsa da scuola da adolescente ed era stata ar-restata per essere venuta alle mani con i polizi-otti. Il capitolo successivo della storia di Ke-wauna, per, avrebbe potuto essere diverso: a dif-ferenza di sua madre, poteva ancora evitare unagravidanza indesiderata. E, a differenza di lei,avrebbe potuto andare al college e costruirsi unacarriera.
La madre di Kewauna pianse per tutto il tempoin cui parlarono, mentre lei non vers neppureuna lacrima. Si limit ad ascoltare, senza saperebene cosa pensare. Non era sicura di poter cambi-are, e non era neppure certa di volerlo. Tornata ascuola, per, inizi a stare pi attenta in classe.Durante il primo anno di superiori, aveva fre-quentato un brutto giro di ragazze organizzate inbande e di ragazzi che si drogavano, che spessosaltavano le lezioni; allontanatasi da quelle
38/608
-
compagnie, ora trascorreva pi tempo da sola, fa-cendo i compiti e pensando al futuro, e i suoi ri-sultati scolastici si erano notevolmente alzati.
A febbraio, la sua insegnante di inglese laincoraggi a fare domanda per entrare in un pro-gramma triennale intensivo di preparazione alcollege che era stato introdotto da poco nella loroscuola; Kewauna venne accettata e si mise a la-vorare con ancora pi impegno. Quando ci siamovisti, era a met del terzo anno: la media dei suoivoti era lievitata e si stava chiedendo a quali col-lege avrebbe potuto iscriversi.
Morale della storia? Se aveste incontrato Ke-wauna allinizio del secondo anno di superiori,avreste avuto buoni motivi per credere che nonavesse nessuna concreta possibilit di farcela. Ilsuo destino pareva segnato. Poi, per, in lei qual-cosa cambiato. stata davvero sufficientequella singola, aspra discussione con la madre?Oppure stata linfluenza positiva della bis-nonna? O lintervento dellinsegnante dinglese?O, magari, pi in profondit, nel suo stesso
39/608
-
carattere si nascondeva gi qualcosa che la ori-entava verso lidea di lavorare sodo per il suc-cesso, nonostante tutti gli ostacoli che aveva af-frontato e gli sbagli che aveva commesso?In che modo le esperienze che abbiamo fatto dabambini ci plasmano come adulti? una dellepi grandi domande dellumanit, al centro di in-numerevoli romanzi, biografie e autobiografie, dimoltissimi trattati filosofici e psicologici scrittinel corso dei secoli. Questo processo lesperi-enza della crescita si mostra a volte prevedibile,quasi meccanico, e a volte arbitrario e capric-cioso: tutti noi abbiamo incontrato uomini edonne che sembrano prigionieri di un destino giscritto fin dalla loro infanzia, cos come abbiamoanche avuto modo di vedere persone che, dopouna partenza difficile, si sono risollevate in modoquasi miracoloso.
Fino a non molto tempo fa, per, non era maistato fatto alcun serio tentativo di usare gli stru-menti della scienza per indagare i misteri
40/608
-
dellinfanzia e scoprire, attraverso gli esperimentie lanalisi, il rapporto fra le esperienze dei primianni di vita e il carattere che si manifesta in etadulta. Oggi, grazie agli sforzi di questa nuovagenerazione di ricercatori, la situazione sta cam-biando. La premessa alla base del loro lavoro tanto semplice quanto radicale: se non siamoriusciti a risolvere questi problemi perch ab-biamo cercato le risposte nei posti sbagliati. Sevogliamo migliorare le opportunit per i bambini e per quelli poveri in particolare dobbiamoadottare un nuovo approccio verso linfanzia, apartire da alcune questioni fondamentali su comei genitori influenzano i loro figli, su comenelluomo si sviluppano le abilit e il carattere.
In sostanza, questo libro si inserisce nel quadrodi unambiziosa e lungimirante campagna per ri-solvere alcuni degli enigmi pi profondi dellavita: chi raggiunge il successo e chi non ce la fa?Perch alcuni bambini crescono rigogliosi mentrealtri finiscono per perdersi? E che cosa possiamofare per allontanare un singolo bambino o
41/608
-
unintera generazione di bambini dallinsuc-cesso e aiutarlo a riuscire nella vita?
42/608
-
1La strada per linsuccesso (e come evitarla)
Una scuola superiore sotto sorveglianza
Nadine Burke Harris, figlia di due colti profes-sionisti giamaicani di Kingston che si eranotrasferiti nella Silicon Valley quando lei avevaquattro anni, ha trascorso linfanzia a Palo Alto,in un ambiente privilegiato. Da ragazza si sentivaspesso unestranea, una dei pochi studenti neridella sua scuola superiore, frequentata perlopida bianchi ricchi e dove le alunne piangevanonella caffetteria se per il sedicesimo compleannonon ricevevano in regalo lauto dei loro sogni.
Elizabeth Dozier invece cresciuta poco fuoriChicago in condizioni pi modeste. Nata
-
dallimprobabile e illecita storia damore tra undetenuto del carcere di Joliet, nellIllinois, e unasuora che visitava la struttura per recare confortoreligioso ai prigionieri, stata allevata solo dallamadre, che insegnava nella scuola cattolica delposto e destate lavorava come cameriera in unmotel per arrotondare il magro stipendio.
Nadine ed Elizabeth hanno alle spalle due stor-ie molto diverse, che le hanno portate per aperseguire il medesimo obiettivo: aiutare igiovani, soprattutto quelli pi svantaggiati, a rag-giungere il successo. La prima si iscritta alla fa-colt di medicina, diventata una pediatra e haaperto una clinica nella zona pi povera di SanFrancisco; la seconda ha iniziato come inseg-nante e in seguito diventata preside lavorandoin alcuni dei quartieri pi poveri di Chicago. Leho incontrate, separatamente, un paio danni fa, eci che mi ha spinto a volerle conoscere non stata soltanto lintensa vocazione umanitaria chele accomunava, ma anche quella sorta di frus-trazione pi profonda che sembravano
44/608
-
condividere. Entrambe erano da poco giunte allaconclusione che neppure i migliori strumenti of-ferti dalle rispettive professioni potevano essereallaltezza delle sfide che dovevano affrontareogni giorno: si trovavano a un punto di svoltanelle loro carriere e nelle loro vite, erano allaricerca di nuove strategie o, meglio, di un sistemacompletamente nuovo.
Nellagosto del 2009, la Dozier vennenominata preside della scuola superiore ChristianFenger, proprio mentre listituto stava attra-versando un momento di crisi (che si protraevada almeno ventanni). La scuola era stata fondatapi di ottantanni prima nel cuore di Roseland,nel South Side di Chicago, una zona un tempoprospera e oggi tra i quartieri peggiori della cittsotto quasi ogni aspetto: povert, tasso di disoc-cupazione, livello di criminalit, e un generalesenso di vuoto e desolazione che aleggia per lestrade. Dove una volta sorgevano case e fiorentiattivit commerciali, oggi ci sono terreni incolti,invasi dalle erbacce. Roseland si trova molto
45/608
-
dopo lultima fermata della ferrovia sopraelevata,ed quindi isolata dal punto di vista geografico esegregata da quello razziale: in una metropolidove la popolazione divisa grossomodo in partiuguali fra bianchi, afro-americani e latino-amer-icani, Roseland per il 98 per cento nera. E comela maggior parte delle grandi scuole superioripubbliche dei quartieri poveri, la Fenger vantavauna triste serie di record: punteggi sempre bassinei test scolastici, scarsa frequenza alle lezioni,problemi cronici di disciplina e un alto tasso diabbandono.
Le scuole come la Fenger hanno spesso allespalle storie di negligenza, sono istituti lasciati aimargini con studenti dimenticati e ignorati daiburocrati locali e di Washington. La Fenger,per, occupa una posizione atipica in questoquadro, perch al contrario, nel corso degli ultimidue decenni stata al centro di diverse riforme,ambiziose e ben finanziate, portate avanti da al-cuni dei pi illustri filantropi ed esperti gov-ernativi di educazione del Paese. In questo
46/608
-
istituto stata messa alla prova, in una forma onellaltra, quasi ogni strategia che sia mai stataelaborata per fronteggiare il problema dellaltotasso di abbandono nelle scuole superioripubbliche.
La storia recente della Fenger inizi nel 1995,quando il sindaco di Chicago, Richard M. Daley,ricevette dallassemblea legislativa dellIllinoislincarico di occuparsi delle scuole della citt. Inlinea con il suo approccio prettamente imprendit-oriale, Daley decise che il funzionario a capo delsistema scolastico non sarebbe pi stato chiamatosovrintendente bens CEO (Chief ExecutiveOfficer, amministratore delegato). Come primoCEO scelse il suo responsabile del bilancio, PaulVallas, un uomo ambizioso che si concentrsubito sul miglioramento della Fenger e di altrescuole superiori che presentavano risultatiscadenti. Vallas cre un sistema di valutazioneche classificava gli istituti in base alla quantit diaiuti di cui avevano bisogno, e pose la Fengernella categoria pi disperata: doveva essere
47/608
-
tenuta sotto stretta sorveglianza.1 Lui stesso, daadolescente, vi aveva studiato per due anni, eforse fu proprio questo il motivo che lo spinse aconvogliare l i suoi sforzi. Introdusse un piano diristrutturazione che includeva lassunzione di unesperto che avrebbe formato i professori nelletecniche di insegnamento della lettura e dellascrittura;2 istitu nella scuola unassociazioneriservata agli studenti appena arrivati, checopriva un intero piano delledificio, dove iragazzi avrebbero ricevuto una particolare atten-zione per tutto il primo anno.3 Nel 1999 creunaccademia di matematica e scienze, dotata diun laboratorio scientifico da 525.000 dollarisponsorizzato dalla NASA.4 Due anni dopo tras-form la Fenger in un polo magnetico dellis-truzione di Chicago, una scuola specializzatanella tecnologia.5
Tuttavia, nonostante le continue riforme diVallas, per gli studenti della Fenger le cose nonsembravano mai migliorare davvero. Lo stessodeludente risultato si ottenne anche con il suo
48/608
-
successore, Arne Duncan. Grazie a lui, nel 2006,la Fenger fu scelta come una delle scuole pilotaper un esperimento di collaborazione su vastascala tra il sistema scolastico di Chicago e laFondazione Bill e Melinda Gates,6 un programmachiamato Trasformazione della scuola superi-ore a cui la fondazione aveva destinato un finan-ziamento iniziale di 21 milioni di dollari (dopotre anni, il bilancio complessivo per il progetto alivello cittadino sarebbe salito a 80 milioni).7Quando liniziativa venne annunciata, Duncandisse che era un giorno storico, non solo per lacitt di Chicago e le sue scuole pubbliche, ma perlintero Paese.8 Poco pi di due anni dopo, per,di fronte ai dati che indicavano che la trasform-azione della scuola superiore non stava pro-ducendo i risultati sperati, la Fenger venne des-tinata allultimo programma di riforma di Dun-can,9 la Ristrutturazione della scuola superiore,che prevedeva il licenziamento del preside e dialmeno met del corpo docente di una scuola elassunzione di una squadra completamente
49/608
-
nuova. Nel 2009, la carica di preside fu affidataquindi a Elizabeth Dozier.
importante ricordare che Vallas e Duncannon sono burocrati che si cimentano per la primavolta con il sistema scolastico, ma due dei pifamosi esperti di educazione del Paese. Dopoaver lasciato Chicago, Vallas ha guidato le scuoledi Philadelphia e si distinto a livello nazionalecome il responsabile della ricostruzione e dellatrasformazione del sistema scolastico di New Or-leans dopo il disastro delluragano Katrina. Perquanto riguarda Duncan, la sua carriera dopo Ch-icago stata ancora pi gloriosa: nel 2009, ilpresidente Obama lo ha scelto come ministrodellIstruzione. Ciononostante, a dispetto di tuttele riforme tentate dai due uomini a Chicago,mosse da ottime intenzioni e spesso moltocostose, i dati statistici della Fenger erano rimastipi o meno identici a quelli del 1995: fra la mete i due terzi dei nuovi iscritti di ogni classe ab-bandonava la scuola prima della fine dellultimoanno. Inoltre, anche gli studenti che giungevano
50/608
-
al diploma non avevano poi quasi mai successoalluniversit: nel 2008 (lultimo anno di Duncana Chicago), meno del 4 per cento degli allievidella Fenger raggiungeva o superava gli standardnei test statali per valutare la preparazione al col-lege, affrontati il terzo e lultimo anno. Durante ilmandato di Duncan, la scuola non fece mai gliadeguati progressi annuali richiesti dalla leggefederale No Child Left Behind (Nessunragazzo venga lasciato indietro). Nel 1995, Val-las aveva definito la Fenger come una scuola datenere sotto sorveglianza pensando che si trat-tasse di uno stato temporaneo di emergenza, maquesta designazione diventata una realt cost-ante per listituto: nel 2011, la scuola statamessa sotto sorveglianza per il sedicesimo annodi fila.
Al suo arrivo alla Fenger, Elizabeth Dozier eraunambiziosa e determinata trentunenne, convin-ta che fra gli strumenti fondamentali del riform-atore educativo moderno ci fosse gi tutto il ne-cessario per risollevare le sorti della scuola e dei
51/608
-
suoi studenti: aveva seguito per un anno un pro-gramma di formazione per presidi molto compet-itivo, che ruotava attorno allidea che un diri-gente dinamico sarebbe stato in grado di far salireil rendimento dei ragazzi a livelli elevati a pre-scindere dalle loro situazioni socioeconomiche,alla sola condizione di poter contare sullim-pegno di un personale motivato. La Dozier fecesubito grandi pulizie alla Fenger, sostituendo di-versi amministratori e la maggior parte del corpodocente: al nostro primo incontro nel suo ufficio,poco pi di un anno dopo il suo insediamento, trai settanta membri dello staff solo tre insegnantilavoravano l da prima della Ristrutturazione. Lamaggior parte dei nuovi professori erano giovani,ambiziosi e non di ruolo, cosa che rendeva pi fa-cile rimpiazzarli nel caso non si fossero mostratiallaltezza dei suoi standard.
Nel nostro colloquio, per, la Dozier mi harivelato che lesperienza alla Fenger lha spinta acambiare idea sulla gestione scolastica: Primapensavo che se una scuola non andava bene,
52/608
-
doveva essere per colpa di un cattivo preside o diinsegnanti incapaci mi ha spiegato. In realt,per, la Fenger una scuola di quartiere e noisiamo soltanto un riflesso della comunit: nonpossiamo aspettarci di risolvere i problemi dellascuola senza tener conto di ci che avviene nellacomunit.
Man mano che conosceva meglio i suoi stu-denti, la Dozier non ha potuto fare a meno di rim-anere impressionata dalla gravit dei problemiche dovevano affrontare a casa: La maggiorparte di loro mi ha riferito vive in povert, e fafatica ad arrivare alla fine del mese. Molti abit-ano in zone dove impazzano le bande giovanili.Non saprei fare neanche un nome di uno studentedi quella scuola che non debba fronteggiare qual-che seria difficolt. Mi ha raccontato che unquarto delle studentesse erano incinte o gimadri, e quando le ho chiesto di fare una stima suquanti dei suoi allievi vivessero con entrambi igenitori biologici, sul suo volto apparso unosguardo perplesso: Sul momento, non saprei
53/608
-
indicargliene nemmeno uno ha risposto, maqualcuno ci sar di sicuro!.
Sugli studenti della Fenger sembrava poi in-combere sempre la minaccia della violenza. Iltasso di omicidi a Chicago pari al doppio diquello di Los Angeles e pi del doppio di quellodi New York. La presenza di gang giovanili pidiffusa e letale a Chicago che in ogni altra grandecitt americana, e poco prima dellarrivo dellaDozier alla Fenger, nel 2008, cera stato un picconella violenza a mano armata fra i giovani: in cit-t erano stati uccisi ottantatr adolescenti in etscolastica e pi di seicento erano sopravvissuti auno scontro a fuoco.10
La nuova preside era consapevole che la ris-trutturazione della Fenger non sarebbe stata unapasseggiata, ma non era certo preparata a ci cheaccadde durante il suo sedicesimo giorno di la-voro, nel settembre del 2009, quando a pochiisolati dalla scuola scoppi una grossa rissa trauna cinquantina di adolescenti, perlopi suoi stu-denti. Non cerano pistole o coltelli, ma alcuni
54/608
-
ragazzi avevano raccolto delle traversine dei bin-ari e avevano iniziato a brandirle come mazze.Un alunno di sedici anni che si era gettato nellamischia, Derrion Albert, venne colpito alla testa equindi preso a pugni in faccia; il ragazzo perseconoscenza e cadde a terra, ma altri giovani con-tinuarono a tirargli calci in testa fino adammazzarlo.
Quella morte non era affatto diversa dalledozzine di altre uccisioni avvenute quellanno fragli studenti delle superiori di Chicago; la rissa elomicidio del ragazzo, per, erano stati filmatida un passante, e quellautunno il video diventun fenomeno su YouTube e venne poi trasmessoripetutamente nei notiziari, richiamando sullaFenger lattenzione dei media locali e nazionali.Per settimane, la scuola rimase assediata dai cam-ion della tv satellitare e di fronte allistituto sitennero diverse veglie di preghiera e manifest-azioni di protesta; anche il ministro della Giustiz-ia statunitense, Eric Holder, and a incontrare glistudenti. Poco tempo dopo, a ottobre, la Fenger
55/608
-
torn di nuovo sulle prime pagine dei giornaliquando su tre piani diversi della scuola scoppi-arono contemporaneamente tre violenti scontrifra bande: arrivarono decine di auto della polizia,cinque studenti furono arrestati e lintero edificiovenne isolato per ore.
In seguito a queste risse, la Dozier adott unapolitica di tolleranza zero nei confronti non solodella violenza, ma anche di quei comportamentiche avrebbero potuto in qualche modo incorag-giarla: bastava, per esempio, che gli studenti siscambiassero i saluti o le tipiche strette di manodelle gang nei corridoi dellistituto perch si bec-cassero dieci giorni di sospensione. Se venivanoalle mani, la preside chiamava la polizia e lifaceva arrestare, dopodich faceva tutto il pos-sibile per espellerli definitivamente dalla scuola.Quando ho iniziato a recarmi alla Fenger, pi diun anno dopo la morte di Albert, nei corridoisembrava regnare una certa tranquillit, anche sela situazione non era certo rientrata nella normal-it: i locali scolastici erano sempre pattugliati da
56/608
-
guardie armate fino ai denti, gli studenti non po-tevano girare senza il loro tesserino didenti-ficazione appeso al collo e quando un ragazzoaveva bisogno di andare in bagno durante unalezione doveva esibire un pass largo pi di mezzometro, di un giallo brillante. Negli intervalli, glialtoparlanti nei corridoi trasmettevano la colonnasonora di Un piedipiatti a Beverly Hills: gli stu-denti sapevano che dovevano raggiungere laclasse successiva prima che suonasse lultimanota. Nonostante le regole ferree, per, ceranoancora dei momenti di scompiglio: quando sonoarrivato per la prima intervista con ElizabethDozier, siamo stati interrotti due volte dalle urlaprovenienti dal corridoio e lei ha dovuto correrefuori per sedare la rissa.
Verso la met del suo secondo anno comepreside, la Dozier mi ha confidato che iniziava asospettare che i metodi educativi pi importantiche poteva mettere in campo non avessero moltoa che fare con linsegnamento nelle aule. Dopolomicidio di Derrion Albert, Holder e Arne
57/608
-
Duncan offrirono uno stanziamento federale di500.000 dollari per listituzione di alcuni corsi didoposcuola sulla gestione della rabbia e il supera-mento dei traumi, e la scuola inizi a indirizzareil servizio di assistenza psicologica non solo aglistudenti ma anche alle loro famiglie. La Dozieriscrisse venticinque dei suoi ragazzi pi problem-atici a un programma intensivo di supporto. Eraalla ricerca di qualunque tipo di intervento ingrado di risolvere quella che ora vedeva come lacrisi pi urgente alla Fenger: non i deficit scol-astici dei suoi studenti (che pure rimanevanogravi e angoscianti), ma una serie di problemi piprofondi che nascevano dalla loro vita familiare,tormentata e spesso traumatica, e che facevano sche per questi giovani fosse difficile andare av-anti. Allinizio non davo peso a domande comeDa che tipo di famiglie provengono i ragazzi? eChe effetto ha la povert sui bambini? mi haspiegato la preside una mattina. Ma da quandoho iniziato a lavorare alla Fenger, ho cambiatoidea.
58/608
-
Una pediatra in lotta contro la povert
Che effetto ha la povert sui bambini? era ladomanda che, dallaltra parte degli Stati Uniti, sistava ponendo anche Nadine Burke Harris; es-sendo per una dottoressa e non uneducatrice, selo chiedeva dal punto di vista della salute fisicadei suoi pazienti. Dal 2007 era la primaria di pe-diatria del Bayview Child Health Center nelquartiere di Bayview-Hunters Point di San Fran-cisco, una squallida area industriale nascostanellangolo sud-orientale della citt, che ospitaalcuni dei pi grandi e violenti quartieri popolari.Quando Nadine aveva fondato la clinica, dopoessersi da poco laureata alla Harvard School ofPublic Health, era una giovane idealista assuntadal California Pacific Medical Center, una riccacatena di ospedali privati, per portare avanti unamissione non ben definita ma dallapparenza no-bile: identificare le disuguaglianze in tema disanit a San Francisco e porvi rimedio. Queste
-
difformit non erano certo difficili da indi-viduare, soprattutto a Bayview-Hunters Point: iltasso di ricoveri per scompenso cardiaco, per es-empio, era cinque volte pi alto di quello regis-trato nel Marina District, a pochi chilometri didistanza. E prima dellapertura della clinica diNadine Burke Harris cera un solo studio pediat-rico privato a servire una comunit con pi didiecimila bambini.
La Burke Harris aveva studiato la questionedelle disuguaglianze in tema di sanit a Harvard econosceva la ricetta tradizionale seguita dallasanit pubblica per far fronte al problema: migli-orare laccesso allassistenza sanitaria per lefamiglie a basso reddito, in particolare attraversoi medici di base. Quando lambulatorio apr i bat-tenti, la dottoressa si concentr sui punti dove ledisparit tra i bambini ricchi e quelli poveri eranopi evidenti e meglio conosciute la gestione dacasa delle patologie asmatiche, la nutrizione e levaccinazioni per la difterite, la pertosse e il tetano e, nel giro di pochi mesi, ottenne notevoli
60/608
-
progressi: Far salire i tassi di vaccinazione e farscendere quelli dei ricoveri per lasma si di-mostr molto pi facile del previsto mi ha dettoal nostro primo incontro nella sua clinica.Avevo per limpressione che non stessimodavvero combattendo le radici degli squilibri hacontinuato. Cio, per quanto ne so, nessunbambino della nostra comunit moriva di tetanoda moltissimo tempo, ormai.
La dottoressa si trovava cos in una situazionemolto simile a quella di Elizabeth Dozier: stavafacendo il lavoro dei suoi sogni, aveva a dispos-izione ingenti risorse, era ben addestrata e sistava impegnando al massimo, eppure sembravache tutti i suoi sforzi non avessero poi questogrande impatto sulle vite dei giovani che cercavadi aiutare. Questi ultimi, infatti, restavano cir-condati da violenza e caos, sia per le strade sianelle loro case, una situazione che non potevanon avere pesanti ripercussioni sotto il profilofisico ed emotivo. Molti dei bambini che ar-rivavano nella clinica sembravano depressi o
61/608
-
ansiosi; alcuni di loro, poi, erano chiaramentetraumatizzati, e lo stress a cui erano sottopostinella quotidianit si traduceva nei sintomi pi di-versi, dagli attacchi di panico ai disordini ali-mentari fino alle tendenze suicide. A volte Nad-ine non si sentiva una pediatra, ma piuttosto unchirurgo militare che, sul campo di battaglia,prova a ricucire in qualche modo i suoi pazientiper poi rispedirli subito al fronte.
In cerca di risposte, la dottoressa venne a con-oscenza di un nuovo approccio alla povert e alleavversit, un dibattito che non veniva portato av-anti sulle riviste dedicate alle politiche pubblicheo nelle conferenze di scienze politiche, ma nellepubblicazioni mediche e nei convegni dei neuros-cienziati. Poco per volta, la Burke Harris si con-vinse della validit di quella che, di primo ac-chito, le era parsa unidea estremista: che, cio,nei quartieri come Bayview-Hunters Point e Ro-seland, molti di quei problemi che sono in genereclassificati come questioni sociali, e come talipertinenti agli studi di economia e sociologia,
62/608
-
possono essere analizzati e affrontati meglio alivello molecolare, nel cuore del regno della bio-logia umana.
63/608
-
Trasformare loro in piombo: gli studi sui traumiinfantili
Il cammino di Nadine Burke Harris inizi da unarticolo di una rivista medica che uno psicologodella sua clinica, Whitney Clarke, le aveva fattotrovare sulla scrivania nel 2008: La relazione trale esperienze infantili negative e la salute nelletadulta: trasformare loro in piombo.11 Lautoreera Vincent Felitti, direttore del Dipartimento dimedicina preventiva della Kaiser Permanente,unimportante organizzazione per la tutela dellasalute fondata in California. Larticolo descrivevalo studio sulle esperienze traumatiche infantili,comunemente chiamato studio ACE (AdverseChildhood Experiences), che Felitti aveva con-dotto negli anni Novanta assieme a Robert Anda,un epidemiologo del Centro per il controllo dellemalattie di Atlanta. Quando la dottoressa lo lesse,nella sua mente si accese una lampadina: Lanebbia si dissolta mi ha raccontato con un
-
sorriso. Gli angeli cantavano. Era come la scenafinale di Matrix, dove Neo vede scorrere il codicesorgente dellintero universo.
A partire dal 1995, i pazienti iscritti al CentroKaiser che si presentavano per un check-upmedico generale ricevevano per posta un ques-tionario che chiedeva di riportare le loro storiepersonali allinterno di dieci differenti categoriedi esperienze infantili negative, tra cui gli abusifisici e sessuali, labbandono fisico ed emotivo evari gradi di disfunzioni familiari, come averegenitori separati o divorziati, o qualche parentestretto incarcerato, mentalmente instabile odrogato. Nel giro di qualche anno, i questionarifurono compilati e restituiti da pi di 17.000pazienti, con un tasso di risposta di quasi il 70per cento.12 Gli intervistati erano comuni rapp-resentanti del ceto medio e medio-alto: il 75 percento di loro erano bianchi e avevano frequentatoil college e let media era di cinquantasette anni.
Quando Anda e Felitti elaborarono le risposte,rimasero sorpresi per la diffusione dei traumi
65/608
-
infantili in una categoria di popolazione benest-ante come quella: pi di un quarto dei pazienti di-chiarava di essere cresciuto in una famiglia in cuiera presente un alcolista o un consumatore didroghe, e pi o meno la stessa percentuale erastata picchiata nel corso dellinfanzia. Quando idottori usarono i dati per assegnare a ciascunpaziente un punteggio ACE, dando loro un puntoper ogni tipologia di trauma in cui erano rimasticoinvolti, videro che i due terzi di loro avevanovissuto almeno unesperienza negativa e che unosu otto totalizzava quattro o pi punti.13
La seconda e pi significativa sorpresa, per,giunse al momento di confrontare i punteggi ACEcon le voluminose anamnesi mediche che laKaiser aveva raccolto su tutti i suoi pazienti. Lecorrelazioni tra i traumi infantili e i problemiriscontrati nellet adulta erano talmente forti edevidenti da lasciarli scioccati, scrisse in seguitoAnda.14 Inoltre, quelle correlazioni sembravanosorprendentemente lineari: quanto pi era alto ilpunteggio ACE, tanto peggiori erano le
66/608
-
conseguenze nellet adulta in quasi ogni campo,dai diversi tipi di dipendenza fino alle malattiecroniche. Felitti e Anda usarono quindi i dati perpreparare una serie di diagrammi, ognuno deiquali presentava pi o meno lo stesso andamento:in ogni grafico i dottori riportavano sullasseorizzontale delle ascisse il numero di esperienzeinfantili negative vissute dai pazienti, e sullasseverticale delle ordinate la frequenza di una spe-cifica conseguenza indesiderata (obesit, depres-sione, attivit sessuale precoce, fumo ecc.). I dia-grammi evidenziavano una crescita lineare dasinistra (0 punti ACE) a destra (pi di 7 puntiACE). In confronto alle persone che non avevanovissuto alcun momento negativo,15 quelle con 4 opi punti ACE avevano il doppio di probabilit difumare,16 sette volte pi probabilit di essere al-colisti e altrettante di aver fatto sesso prima deiquindici anni; avevano il doppio di probabilit divedersi diagnosticare un cancro, di affrontare unamalattia cardiaca17 o del fegato,18 e quattro voltepi probabilit di soffrire di enfisema o di
67/608
-
bronchite cronica. In alcuni grafici, la pendenzaera particolarmente ripida: gli adulti con pi di 6punti ACE avevano trenta volte pi probabilit ditentare il suicidio rispetto a quelli con un punteg-gio ACE pari a zero.19 Inoltre, le categoriemaschili con pi di 5 punti ACE avevano quar-antasei volte pi probabilit di fare uso di drogherispetto a quelli che non avevano avuto esperien-ze infantili negative.20
Le ripercussioni sul piano comportamentale,per quanto sorprendenti nella loro intensit, sem-bravano perlomeno sensate a livello intuitivo: glipsicologi, infatti, erano giunti gi da tempo allaconclusione che i traumi infantili potevanoprodurre scarsa autostima o senso di inadeg-uatezza, ed era ragionevole supporre che tali sen-timenti potessero a loro volta condurre alle di-pendenze, alla depressione e magari anche al sui-cidio. Inoltre, alcune delle conseguenze sul pianosanitario emerse nello studio ACE come le mal-attie del fegato, il diabete e il cancro ai polmoni erano probabilmente, almeno in parte, il risultato
68/608
-
di atteggiamenti autodistruttivi come labuso dialcolici, gli eccessi alimentari e il fumo. Tuttavia,Felitti e Anda scoprirono che gli shock infantiliavevano un profondo effetto negativo sulla salutenellet adulta anche in assenza di quei com-portamenti: esaminando i pazienti con punteggiACE elevati (7 o pi punti) che non fumavano,non eccedevano nel bere e non erano sovrappeso,videro che il loro rischio di ischemia cardiaca su-perava comunque del 360 per cento quello di chiaveva un punteggio ACE pari a 0. Le avversitsperimentate nellinfanzia li facevano ammalareda adulti, a prescindere dal loro stile di vita.21
69/608
-
Leffetto caserma dei pompieri
Dopo lo studio ACE, Nadine Burke Harris si doc-ument su altre ricerche simili e, nel giro di pochimesi, si ritrov a restare sveglia fino a tardi ogninotte leggendo articoli di riviste mediche e con-trollando rimandi e note a pi di pagina su undatabase medico online. Gli appunti presi durantequesto periodo di intenso lavoro riempiono oggiquattro grossi raccoglitori. Gli scritti abbraccianodiverse discipline scientifiche, ma la maggiorparte di essi si concentra su due campi piuttostooscuri della medicina: la neuroendocrinologia (lostudio di come gli ormoni interagiscono con ilcervello) e la fisiologia dello stress (lo studio dicome lo stress influisce sul corpo). Anche seAnda e Felitti non avevano compreso fin dasubito i meccanismi biologici che si nascon-devano sotto i loro dati ACE, nello scorso decen-nio gli scienziati sono giunti alla conclusione cheil canale chiave attraverso il quale le esperienze
-
negative infantili provocano danni al fisico e alcervello in fase di sviluppo lo stress.
I nostri corpi regolano lo stress per mezzo diun sistema detto asse ipotalamo-ipofisi-surrene(o HPA, hypothalamic-pituitary-adrenal), at-traverso il quale i segnali chimici che partono dalcervello scendono a cascata lungo il corpo in ris-posta a emozioni particolarmente forti. Davanti aun potenziale pericolo, la prima linea di difesa costituita dallipotalamo, la regione del cervelloche controlla i processi biologici involontaricome la temperatura corporea, la fame e la sete.Lipotalamo secerne una sostanza chimica che at-tiva i recettori nellipofisi, che a sua volta pro-duce ormoni di segnalazione che stimolano leghiandole surrenali. Sono queste ultime a rilas-ciare gli ormoni dello stress, detti glucocortic-oidi, che scatenano una serie di specifiche ris-poste difensive nellorganismo. Alcune di questerisposte possono essere avvertite e riconosciutedal soggetto mentre avvengono (la paura elansia, per esempio, e le reazioni fisiche come
71/608
-
laccelerazione del battito cardiaco, i sudorifreddi e la secchezza delle fauci), ma molti effettidellasse HPA non sono immediatamente evidenti,nemmeno per il soggetto interessato: i neuro-trasmettitori si attivano, c un aumento dei liv-elli di glucosio, il sistema cardiovascolare mandasangue ai muscoli e nel flusso sanguigno si regis-tra un picco di proteine infiammatorie.22
Nel suo arguto e divertente libro, Perch lezebre non si ammalano dulcera, il neuroscienzi-ato Robert Sapolsky spiega che il nostro sistemadi risposta allo stress, come quello di tutti i mam-miferi, si evoluto per reagire a stati di tensionebrevi e acuti. Un meccanismo che poteva fun-zionare finch gli esseri umani vivevano nellasavana e dovevano fuggire dai predatori; capitaper di rado che gli uomini moderni si ritrovino afronteggiare lattacco di un leone: oggi la mag-gior parte dello stress dipende da processi men-tali, dal nostro preoccuparci per cose e situazioni,e lasse HPA non progettato per gestire questotipo di ansia. Noi attiviamo un sistema
72/608
-
fisiologico che si evoluto per rispondere aemergenze fisiche acute scrive Sapolsky, mafiniamo per tenerlo acceso per mesi, preoccupan-doci per il mutuo, i rapporti personali e il la-voro. Negli ultimi cinquantanni, gli scienziatihanno inoltre scoperto che questo meccanismonon soltanto inutile, ma anche fortemente dis-truttivo: sovraccaricare lasse HPA, soprattuttodurante linfanzia, produce effetti nocivi di lungadurata, sotto il profilo fisico, psicologico eneurologico.
Laspetto pi problematico di tutto questo pro-cesso, per, che, di fatto, a rovinarci non lostress in se stesso, ma la reazione del nostrocorpo allo stress. Nei primi anni Novanta, unneuroendocrinologo della Rockefeller University,Bruce McEwen, ha formulato una teoria oggiampiamente condivisa sul funzionamento diquesto fenomeno.23 Stando a McEwen, il pro-cesso di controllo dello stress, da lui chiamatoallostasi, ci che provoca il logoramento delcorpo: se i sistemi di gestione dello stress
73/608
-
dellorganismo vengono gravati eccessivamente,finiscono per crollare sotto il peso della tensione.McEwen ha indicato questo progressivo affatica-mento con lespressione carico allostatico, sos-tenendo che i suoi effetti distruttivi possono es-sere osservati in tutto il corpo. Uno stress acuto,per esempio, provoca un aumento della pressionesanguigna, il che garantisce un adeguato afflussodi sangue ai muscoli e agli organi che devonorispondere a una situazione pericolosa, e questo senzaltro un bene; tuttavia, ripetuti aumenti dellapressione sanguigna conducono alla formazionedi placche arteriosclerotiche. E questo non piun bene.
Il sistema umano di reazione allo stress unarealt biologica molto complessa, ma il suo fun-zionamento pratico semplice come una mazzada cricket. A seconda del tipo di stress a cuisiamo sottoposti, dovrebbero esistere meccanismidi difesa diversificati. Se stiamo per ricevere unaferita superficiale, per esempio, sarebbe unabuona idea far s che il nostro sistema
74/608
-
immunitario inizi a produrre una forte quantit dianticorpi; se dobbiamo scappare da un assalitore,ci farebbe invece comodo un aumento del battitocardiaco e della pressione sanguigna. Lasse HPA,per, non in grado di distinguere fra i diversitipi di minaccia e, di conseguenza, attiva sempretutte le difese insieme. Questo, purtroppo, signi-fica che spesso ci troviamo ad avere risposte allostress che non sono affatto necessarie o, magari,addirittura controproducenti, come quando dob-biamo parlare in pubblico e allimprovviso ci rit-roviamo con la bocca secca perch il nostro asseHPA, percependo il pericolo, vuole conservare ifluidi preparandosi a respingere un attacco.
Si pu immaginare lasse HPA come una case-rma dei pompieri allavanguardia, dotata di fant-astici camion ultratecnologici, ognuno con unasua particolare serie di strumenti altamente spe-cializzati e una squadra di vigili del fuoco esperti.Quando inizia a suonare lallarme, per, questiultimi non si prendono la briga di valutare lanatura del problema per stabilire quale potrebbe
75/608
-
essere il veicolo pi appropriato per affrontarlo.Risultato: tutti i camion partono insieme versolincendio, procedendo alla massima velocit econ le sirene spiegate. Cos come lasse HPA, silimitano a rispondere il pi in fretta possibile conogni strumento a loro disposizione. Questastrategia potrebbe salvare delle vite, ma potrebbeanche portare a una situazione in cui una decinadi camion viene mandata a spegnere un fuocher-ello o, peggio ancora, esce per un falso allarme.
76/608
-
Una diciottenne spaventata a morte
Per Nadine Burke Harris, i risultati di questo ef-fetto caserma dei pompieri non costituivanouna novit: poteva osservarli ogni giorno nei suoipazienti. In uno dei nostri incontri alla clinica diBayview me ne ha presentata una, Monisha Sulli-van, una ragazza arrivata nella struttura quando,allet di sedici anni, aveva appena partorito. Lasua infanzia era stata segnata dallo stress: abban-donata dalla madre che faceva largo uso dicrack e altre droghe pochi giorni dopo la nas-cita, era cresciuta con il padre e il fratello mag-giore ad Hunters Point, in una zona devastatadalla violenza delle bande giovanili. Quandoaveva dieci anni, per, anche il padre era di-ventato tossicodipendente e i servizi sociali eranointervenuti per togliergli la custodia dei figli, sep-arando Monisha dal fratello e dando entrambi inaffidamento. Da quel momento, la ragazza avevacontinuato a rimbalzare da una famiglia o
-
istituto daccoglienza allaltra, fermandosi peruna settimana, un mese o un anno finch, inevit-abilmente, le tensioni per il cibo, i compiti o la tvcrescevano e lei fuggiva, oppure i suoi affidatarigettavano la spugna. Negli ultimi sei anni erapassata per nove case diverse.
Quando lho incontrata, nellautunno del 2010,Monisha aveva appena compiuto diciottanni e siera emancipata da quel sistema di tutela deiminori che laveva accompagnata per quasi metdella sua vita. La sua esperienza pi dolorosa, miha raccontato, era stata proprio il primo giorno diaffidamento: senza nessun preavviso, unassist-ente sociale che non aveva mai incontrato si erapresentata a scuola, laveva prelevata e portata inuna casa che non aveva mai visto. Non le fecerocontattare il padre per mesi: Ricordo quel primogiorno come se fosse ieri mi ha detto. Ognidettaglio. Me lo sogno ancora adesso. Ho lasensazione che questa cosa mi abbia provocatoun danno permanente.
78/608
-
Le ho quindi chiesto di descrivermi questodanno. Monisha molto brava ad articolare i suoistati danimo scrive poesie quando si sentetriste o depressa e ha enumerato i suoi sintomicon precisione. Mi ha riferito che soffriva din-sonnia, aveva gli incubi e a volte avvertiva doloriin apparenza inspiegabili in diverse parti delcorpo. Di tanto in tanto le veniva un incontrol-labile tremore alle mani. Da poco aveva iniziato aperdere i capelli e in testa portava un foulardverde chiaro per coprire una piccola chiazza ros-ata. Soprattutto, per, si sentiva ansiosa: per lascuola, per la sua bambina piccola, per i terre-moti. Mi ritrovo a pensare alle cose pi stranemi ha confidato. Penso alla fine del mondo.Quando un aereo passa sopra la mia testa, pensoche stiano per sganciare una bomba. Temo che ilmio pap muoia: se lo perdessi, non so propriocome farei. Era in ansia persino per il fattostesso di essere ansiosa: Quando sonospaventata, inizio a tremare mi ha rivelato. Ilcuore comincia a battermi forte, sudo. Hai
79/608
-
presente quando si dice Ero spaventata amorte? Ecco, forse un giorno o laltro mispaventer davvero al punto di morire.
La metafora della caserma dei pompieri puaiutarci a comprendere la situazione di MonishaSullivan. Da bambina, il suo allarme antincendiocontinuava a suonare a tutto volume: La miamamma e la matrigna si stanno prendendo apugni; Non vedr mai pi il mio pap; Acasa non c nessuno a prepararmi la cena; Lamia famiglia adottiva non si prender mai cura dime. E ogni volta che scattava, il sistema di ris-posta allo stress di Monisha mandava fuori tutti icamion a sirene spiegate e i pompieri sfondavanoqualche finestra, inzuppavano qualche tappeto;cos, a diciottanni, il suo problema pi grandenon erano pi le minacce provenienti dal mondoesterno, ma i danni che avevano fatto i pompieridentro di lei.
Quando negli anni Novanta McEwen proposeper la prima volta il concetto di carico allostatico,non lo considerava un indice numerico vero e
80/608
-
proprio. Di recente, per, lui e altri ricercatori,guidati da Teresa Seeman (una gerontologadellUniversit della California di LosAngeles),24 hanno tentato di operazionalizzareil carico allostatico, cos da ricavare per ciascunindividuo un singolo valore che esprima il dannoprovocato dalla gestione dello stress a cui statosottoposto durante tutta la sua vita. Oggi i medicifanno comunemente uso di analoghi indicatori dirischio biologico, soprattutto per quel che ri-guarda la pressione sanguigna; tali numeri sonoutili per prevedere determinate patologie: perquesto che il medico ci misura la pressione ognivolta che andiamo nel suo studio, a prescinderedal problema specifico per cui ci siamo present-ati. Il guaio, per, che i dati sulla pressione delsangue non bastano, da soli, a fornire unavalutazione precisa dei futuri rischi per la salute.Un indice di carico allostatico pi accuratodovrebbe includere non solo la pressione san-guigna e il battito cardiaco, ma anche altri fattoriinfluenzati dallo stress: i livelli del colesterolo e
81/608
-
della proteina C-reattiva ad alta sensibilit (unodei principali indicatori delle malattie cardi-ovascolari); le letture del cortisolo e di altri or-moni legati allo stress nelle urine e del glucosio,dellinsulina e dei lipidi nel sangue. McEwen e laSeeman hanno mostrato che un indice complessoche includa tutti questi valori sarebbe un indic-atore molto pi affidabile dei futuri rischi per lasalute di quanto non lo sia ogni altra misurazionedi un singolo fattore in uso oggi.
Si tratta di unidea avvincente e affascinante,anche se forse incute un po di timore: un singolonumero che un dottore potrebbe darvi, mettiamo,a ventanni rifletterebbe sia lo stress a cui sietestati esposti nella vostra vita fino a quel mo-mento, sia i rischi medici che, di conseguenza, vitroverete a dover affrontare. Sotto certi aspetti,sarebbe una versione pi raffinata del punteggioACE ma, a differenza di questultimo, che si basasu unautovalutazione dellinfanzia, lindice dicarico allostatico non rifletterebbe nientaltro chei dati medici nella loro fredda oggettivit: gli
82/608
-
effetti fisici reali delle esperienze infantili negat-ive scritti nel vostro corpo, sotto la vostra pelle.
83/608
-
Quando lo stress influenza il cervello
Come medico, allinizio Nadine Burke Harris erainteressata agli effetti fisiologici che i traumi in-fantili e lo stress incontrollato avevano sui suoipazienti: il tremore alle mani, la perdita deicapelli e i dolori in apparenza inspiegabili avver-titi da Monisha, per esempio. Ben presto, per, sirese conto che queste esperienze traumaticheavevano un impatto altrettanto serio su altri as-petti della vita dei pazienti della sua clinica.Quando sottopose pi di settecento di loro a unaversione modificata del questionario ACE diFelitti e Anda, scopr una forte e inquietante cor-relazione tra i punteggi ACE e i problemi scol-astici: solo al 3 per cento dei pazienti con unpunteggio ACE pari a 0 erano stati diagnosticatiproblemi comportamentali o di apprendimento,mentre il dato saliva al 51 per cento nei pazienticon 4 o pi punti ACE.25
-
I fisiologi che studiano lo stress hanno trovatouna spiegazione biologica anche per questofenomeno. La parte del cervello pi esposta aglieffetti dello stress infantile la corteccia pre-frontale, che riveste unimportanza critica in ognitipo di attivit di autoregolazione, sia sul pianoemotivo sia su quello cognitivo: di conseguenza,i bambini che crescono in un ambiente stressantetrovano in genere pi difficile concentrarsi, rim-anere seduti tranquilli, riprendersi dalle delusionie seguire determinate istruzioni, tutte cose che in-fluenzano direttamente il loro rendimento ascuola. Se si travolti da impulsi incontrollabili edistratti da stati danimo negativi, difficile im-parare lalfabeto. E infatti quando le maestredasilo vengono interrogate sui loro allievi, di-chiarano che il problema pi grosso non sono ibambini che non distinguono le lettere dai nu-meri, ma quelli che non si sanno controllare o chenon riescono a calmarsi dopo una provocazione.In unindagine nazionale, il 46 per cento dellemaestre dasilo ha affermato che almeno la met
85/608
-
degli allievi della loro classe ha dei problemi aseguire le istruzioni;26 in un altro studio, le inseg-nanti del programma pedagogico Head Start han-no riferito che un quarto dei loro studenti assumeatteggiamenti estremamente negativi legati allamancanza di autocontrollo prendono a calci iloro compagni, li minacciano almeno una voltaalla settimana.27
Alcuni degli effetti dello stress sulla cortecciaprefrontale, come ogni tipo di ansia e depres-sione, rientrano pi propriamente nella categoriadei disturbi emotivi o psicologici. Nei mesi suc-cessivi al nostro primo incontro sono rimasto incontatto con Monisha e ho visto in lei molti diquesti sintomi emotivi: era perseguitata dallamancanza di fiducia in se stessa, dal suo peso,dalle sue capacit di madre, dal suo futuro in gen-erale. Una sera stata aggredita dallex ragazzo,uno squilibrato cui aveva imprudentemente tele-fonato perch si sentiva sola. Monisha era cost-antemente in lotta con una marea di emozioni chesembravano sempre sul punto di sopraffarla. A
86/608
-
volte lo stress mi sembra impossibile da sop-portare mi ha spiegato un giorno. Non riesco acapire come facciano le altre persone.
Nel suo caso, leffetto principale del sovracca-rico di stress sulla corteccia prefrontale era quellodi rendere difficile il controllo delle emozioni;per molti altri giovani, invece, a essere com-promessa la capacit di dare un ordine ai pen-sieri. Tutto questo ha a che fare con un particol-are insieme di abilit cognitive localizzate nellacorteccia prefrontale, le cosiddette funzioni es-ecutive. Nei distretti scolastici ricchi, funzioneesecutiva diventato il nuovo motto delledu-cazione, il nuovo dato da valutare e diagnosti-care. Fra gli scienziati che studiano i bambinicresciuti in povert, invece, la ragione che rendeinteressante lo studio di queste funzioni unaltra: il loro miglioramento, infatti, sembra es-sere un promettente mezzo per ridurne il divariodi rendimento rispetto ai figli del ceto medio.
Stando alle nostre conoscenze attuali, le fun-zioni esecutive sono una serie di abilit mentali
87/608
-
di ordine superiore; Jack Shonkoff, direttore delCentro sullo sviluppo infantile dellUniversit diHarvard, le ha paragonate ai controllori di voloche sorvegliano le funzioni del cervello.28 In ter-mini pi generali, hanno a che fare con la capa-cit di affrontare informazioni e situazioni disori-entanti e imprevedibili. Un famoso test per valut-are le funzioni esecutive quello di Stroop, in cuiil soggetto vede la parola rosso scritta in verdee gli viene chiesto di dire di che colore sono lelettere: occorre un certo sforzo per trattenersi dalrispondere rosso; le abilit su cui facciamoleva quando riusciamo a resistere a quellimpulsosono proprio le funzioni esecutive. Queste capa-cit sono di particolare importanza a scuola, dovei bambini sono chiamati a confrontarsi di con-tinuo con informazioni contraddittorie: paroleche si scrivono allo stesso modo ma che hannodue significati completamente diversi; uno 0,per esempio, significa una cosa quando da soloe unaltra cosa, del tutto diversa, quando prece-duto da un 1. Per districarsi fra trucchi ed
88/608
-
eccezioni occorre una certa dose di controllodellimpulso cognitivo, unabilit neurologica-mente collegata al controllo dellemotivit (gra-zie al quale un bambino pu trattenersi dal pren-dere a pugni il compagno che gli ha appena sot-tratto la sua macchinina preferita): sia nel test diStroop sia nel caso della macchinina, la cortecciaprefrontale viene usata per vincere la reazioneistintiva immediata. E tanto nel campo emotivoquanto in quello cognitivo, la capacit di auto-controllo di importanza cruciale per affrontarele giornate a scuola, dallasilo alle superiori.
89/608
-
Giocando con Simon
Da tempo sappiamo che lo sviluppo delle fun-zioni esecutive strettamente correlato al redditofamiliare, ma la ragione di questo legame statascoperta soltanto di recente. Nel 2009, GaryEvans e Michelle Schamberg, due ricercatoridella Cornell University, hanno realizzato un es-perimento che ha permesso per la prima volta divedere con chiarezza in che modo la povert in-fantile influisce sulle funzioni esecutive.29 Laparticolare abilit presa in esame dai due scienzi-ati era la cosiddetta memoria di lavoro, ossia lacapacit di tenere a mente un gruppo di dati di-versi nello stesso momento. Si tratta di una fa-colt del tutto distinta dalla memoria a lungo ter-mine: la memoria di lavoro quella che vi fa ri-cordare tutte le cose che dovete comprare al su-permercato, ma non centra nulla con il fatto chevi rammentiate o meno il nome della maestra cheavete avuto in prima elementare. Lo strumento
-
scelto da Evans e Schamberg per misurare la me-moria di lavoro era alquanto kitsch: il giocoelettronico Simon. Chi, come me, cresciutonegli anni Settanta, si ricorder questo gioco: undisco simile a un UFO, dalle dimensioni grosso-modo uguali a quelle di un LP ma pi spesso, conquattro pannelli colorati che si accendono in di-verse sequenze e producono suoni differenti. Loscopo del gioco consiste nel ricordare lordineesatto dei suoni e delle luci.
Evans e Schamberg usarono Simon per testarela memoria di lavoro di 195 diciassettenni dellezone rurali settentrionali dello Stato di NewYork, che facevano parte di un gruppo di ragazziche Evans studiava sin da quando erano nati.Circa la met di loro era cresciuta sotto la sogliadella povert, mentre laltra apparteneva afamiglie della classe operaia o del ceto medio. Laprima scoperta fu che, in media, la quantit ditempo che i bambini avevano trascorso in condiz-ioni di povert durante linfanzia era strettamentecorrelata ai risultati ottenuti nel test: in altre
91/608
-
parole, i ragazzi vissuti nellindigenza per diecianni andavano peggio di quelli che erano statipoveri soltanto per cinque. Questa scoperta, diper s, non era molto sorprendente: i ricercatori,infatti, avevano gi individuato diverse correl-azioni fra la povert e la memoria di lavoro.
Evans e Schamberg fecero per qualcosa dinuovo, introducendo nel loro test alcune misurebiologiche dello stress. I ricercatori di Evansavevano raccolto una serie di dati medici suognuno dei bambini coinvolti nello studio, alletdi nove anni e poi di nuovo quando ne avevanotredici: la pressione sanguigna, lindice di massacorporea e i livelli di determinati ormoni dellostress, come il cortisolo. Evans e Schambergcombinarono questi fattori biologici per creare unloro indice di carico allostatico, che misurava glieffetti fisici di un sovraffaticamento del sistemadi risposta allo stress. Una volta raccolti tutti idati, confrontando il punteggio totalizzato daogni bambino al test di Simon con gli anni cheaveva trascorso in povert e il valore del suo
92/608
-
carico allostatico videro che le tre misure eranocorrelate fra loro: essere stati per un tempo mag-giore in condizioni di indigenza significava avereun maggior carico allostatico e un punteggio pibasso nel gioco. Ma la vera sorpresa arriv solosuccessivamente: quando i due studiosi si ser-virono di alcune tecniche statistiche per scorpor-are dai dati a loro disposizione lesito del caricoallostatico, leffetto della povert venne a scom-parire del tutto. A compromettere le funzioni es-ecutive dei bambini poveri non era quindi lindi-genza in s ma lo stress che la accompagnava.
Questa scoperta segnava, almeno potenzial-mente, un grosso passo avanti nella compren-sione delle situazioni di povert. Immaginatevidue bambini seduti assieme a giocare per laprima volta a Simon: uno appartiene al cetomedio-alto mentre laltro proviene da unafamiglia a basso reddito. Il primo molto piabile nel memorizzare le sequenze. Potremmoipotizzare che la ragione di questa disparit sia dicarattere genetico: forse c un qualche gene di
93/608
-
Simon che i bambini ricchi hanno maggioriprobabilit di possedere. O, magari, la differenzaha a che fare con i vantaggi materiali offerti dalvivere in una famiglia del ceto medio-alto: pilibri, pi giocattoli, pi giochi elettronici. O forsela scuola frequentata dal bambino ricco unposto migliore per imparare a usare la memoria abreve termine. O magari, ancora, c in gioco unacombinazione fra questi tre fattori. La scoperta diEvans e Schamberg, per, ci dice che lo svantag-gio pi significativo per i bambini poveri difatto quello di avere un carico allostatico pi el-evato: se quindi dovesse arrivare un altrobambino povero con un livello pi basso di ca-rico allostatico perch per una qualunque ra-gione ha avuto uninfanzia meno stressante,nonostante la povert della sua famiglia ,giocando a Simon raggiungerebbe con ogni prob-abilit gli stessi buoni risultati del bambino ricco.E perch dobbiamo ritenere importante il punteg-gio raggiunto giocando a Simon? Perch sin dallescuole superiori, fino alluniversit e al posto di
94/608
-
lavoro, la vita piena di compiti dove la memoriadi lavoro riveste un ruolo cruciale per il successo.
La ragione per cui i ricercatori che si preoccu-pano del divario tra ricchi e poveri sono cos in-teressati alle funzioni esecutive che queste nonsono soltanto strettamente legate al futuro suc-cesso, ma sono anche malleabili, molto pi diquanto non lo siano le altre abilit cognitive. Lacorteccia prefrontale risponde agli interventimeglio di altre parti del cervello e rimane fless-ibile anche nelladolescenza e allinizio delletadulta; pertanto, se riuscissimo a migliorare lam-biente di un bambino in modo da favorirne il raf-forzamento delle funzioni esecutive, potremmofar crescere le sue prospettive di successo conparticolare efficacia.
95/608
-
Quando un bambino innocente si trasforma in unadolescente violento? La storia di Mush
nella prima infanzia che il cervello e il corposono pi sensibili agli effetti dello stress e deitraumi, ma nelladolescenza che i danni che civengono inflitti dallo stress possono portare aproblemi pi gravi e duraturi. In parte, ci dovuto semplicemente al fatto di crescere. Se ab-biamo dei problemi a controllare i nostri impulsialle elementari, le conseguenze saranno relativa-mente limitate: al massimo possiamo finire dalpreside, o magari litigare con un amichetto. Maquel genere di scelte impulsive che siamo tentatidi prendere nelladolescenza mettersi alla guidaubriachi, avere rapporti sessuali non protetti, ab-bandonare la scuola alle superiori, rubare unportafoglio possono spesso avere conseguenzeche ci portiamo dietro per tutta la vita.
Inoltre, i ricercatori hanno scoperto che nelcervello degli adolescenti c uno squilibrio
-
specifico che lo rende particolarmente suscet-tibile alle decisioni sbagliate e impulsive.30Laurence Steinberg, uno psicologo della TempleUniversity, ha analizzato i due sistemi neurolo-gici separati che si sviluppano tra linfanzia elinizio dellet adulta e che, insieme, hanno unprofondo effetto sulla vita degli adolescenti.31 Ilproblema che non sono ben allineati. Il primo,chiamato sistema di elaborazione degli stimoli,ci spinge a essere pi reattivi sul piano emotivo ea prestare maggiore attenzione allo scambio diinformazioni: a ognuno di noi, ripensando allad-olescenza, queste sensazioni suoneranno famili-ari. Il secondo, il cosiddetto sistema di controllocognitivo, ci permette invece di regolare tuttiquesti impulsi. La ragione per cui gli annidelladolescenza sono sempre stati un periododifficile, afferma Steinberg, che il sistema dielaborazione degli stimoli raggiunge il suo pienosviluppo nella prima adolescenza, mentre il sis-tema di controllo cognitivo finisce di maturaresoltanto dopo i ventanni: di conseguenza, per
97/608
-
qualche frenetico anno siamo tutti presi a rincor-rere e a elaborare gli stimoli senza avere ancoraun sistema di controllo che tenga imbrigliato ilnostro comportamento. Se poi a questa normalesituazione di squilibrio neurochimico adoles-cenziale si uniscono anche gli effetti di un sov-raccarico dellasse HPA, i risultati possono essereparticolarmente pericolosi.
Era proprio questa combinazione di forze,presente in molti dei suoi studenti alla Fenger,che Elizabeth Dozier non si sentiva in grado digestire. Dopo che nella scuola si era sfiorata larivolta, nellottobre del 2009, decise che alcunistudenti andavano semplicemente espulsi. Incima alla lista cera un sedicenne, Thomas Ga-ston, noto a tutti come Mush. La Dozier lo ve-deva come un capobanda a cui bastava lanciareunocchiata ai suoi sottoposti per scatenare rissenellistituto. Era linferno in terra mi ha detto.Appena entrava nelledificio, finiva tutto sot-tosopra. Metteva a ferro e fuoco la scuola per unsacco di stupidaggini.
98/608