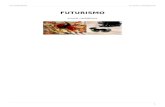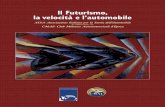IL PORTICO. - OPUS at UTS: Home VINCENTI fin… · La fase del futurismo denominata secondo...
Transcript of IL PORTICO. - OPUS at UTS: Home VINCENTI fin… · La fase del futurismo denominata secondo...


IL PORTICO.BIBLIOTECA DI LETTERE E ARTI
163.
Sezione: MATERIALI LETTERARI

a Federica Ginanni CorradiniElvira Settimelli
Motrici di ricerca

Gloria De Vincenti
Il genio del SecondoFuturismo Fiorentinotra macchina e spirito
Prefazione di Gloria Manghetti
LONGO EDITORE RAVENNA

ISBN 978-88-8063-756-1
© Copyright 2013 A. Longo Editore sncVia P. Costa, 33 – 48121 Ravenna
Tel. 0544.217026 – Fax 0544.217554e-mail: [email protected]
www.longo-editore.itAll rights reserved
Printed in Italy

Ringraziamenti
A questa ricerca hanno concorso molte persone.Desidero ringraziare Federica Venanzio Ginanni Corradini e Lucia Collarile per
la consultazione del fondo Ginanni Corradini e per avermi fatto entrare nella sferapersonale di Arnaldo e Bruno attraverso aneddoti, riflessioni, fotografie. Lucia Col-larile è stata un punto di riferimento lungo tutto il mio percorso. La mia ricono-scenza va anche ad Elvira Settimelli che, condividendo le foto di papà Emilio e deicompagni di “pattuglia”, oltreché ricordi e riflessioni, ha creato un quadro vivido diquegli anni. Segno tangibile della loro generosità e del loro impegno per la ricerca,così come della disponibilità di Eda Pratella, è l’autorizzazione a pubblicare stralcidella corrispondenza inedita B. Corra-E. Settimelli e B. Corra-F. Balilla Pratella,custodita presso la Fondazione Primo Conti. Il consenso è stato poi ratificato dalComitato Scientifico della Fondazione, presieduto da Gloria Manghetti.
Ad arricchire la mia ricerca con il racconto del vissuto ha contribuito altresìMario Verdone, con cui ho avuto un dialogo ricco e proficuo. Un altro scambio im-portante è stato quello con Simona Cigliana che, con grande generosità, mi ha of-ferto spunti e indicato letture pertinenti. E come dimenticare il travolgenteentusiasmo con cui Carmelo Calò Carducci ha passato in rassegna la sua collezioneprivata per mettermi a disposizione rare fonti primarie.
Non avrei potuto svolgere questa ricerca senza l’assistenza della FondazionePrimo Conti di Fiesole, nella persona di Maria Chiara Berni in particolare, la Bi-blioteca Nazionale Centrale di Roma e la Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze.Al personale di quest’ultima va il mio affetto per avermi preparato, senza che lochiedessi, un cuscinetto di polistirolo e nastro adesivo con cui raggiungere il tavolodella sala lettura.
Questo lavoro è nato come tesi di dottorato presso The University of Sydney.Un sentito ringraziamento va a Paolo Bartoloni per avere seguito la mia ricerca coninteresse, acume e sensibilità. Sono molto grata anche a Nerida Newbigin, Nina Ru-bino, Tim Fitzpatrick e Corinne Mesana per il loro continuo input e supporto.
Sezioni di questo lavoro sono state pubblicate su “Rivista di Studi Italiani”, annoXXVII, n. 1, 2009 e “The Italianist”, vol. 33, n. 1, 2013.
Non mi è mai mancato il sostegno dei miei colleghi di UTS, Faculty of Arts andSocial Sciences, in particolare di Alastair Pennycook e Maja Mikula. A Universityof Technology Sydney devo anche la maggior parte del supporto finanziario per

questo studio e il privilegio di lavorare in un ambiente dinamico. Ad Anthony Verna,ponte tra i due mondi e mia bussola dal 2010, l’approccio pragmatico, tanto pre-zioso nella realizzazione di un progetto.
Passando al contingente personale, ringrazio Richard per essermi stato vicino eavermi sostenuto con il suo incrollabile, snervante equilibrio, ma anche tanto sensodell’umorismo; papà Aldo per avermi trasmesso l’impeto, mamma Anna l’applica-zione e “le sorelline” Angela e Loredana il dubbio, espresso scherzosamente in ca-labrese: “sapim”?
A Vito Cavalluzzi, che ha creato l’illustrazione per la copertina, devo un’emo-zione fulminante.
6 Ringraziamenti

Prefazione
A seguito delle recenti celebrazioni del Centenario del Manifesto Futurista(1909-2009), la già smisurata bibliografia relativa alla più nota delle avanguardie ita-liane ha registrato sicuramente una significativa impennata. Segno della vitalità diun movimento che ha visto diverse e fruttuose stagioni, oltre che una sorprendentemolteplicità di luoghi e di connessioni nell’ambito dell’ampio spettro interdiscipli-nare che gli pertiene. Tutte pubblicazioni che hanno contribuito ad accendere i ri-flettori sia su aspetti in varia misura conosciuti che su altri fino ad allora trascurati,attraverso uno specifico lavoro di analisi e approfondimento. Tra gli studi più ori-ginali, quelli che hanno privilegiato un indirizzo di indagine accurata di fonti docu-mentarie ancora inedite o comunque sino ad oggi sondate solo parzialmente, senzaindugiare su ipotesi critiche ormai consunte o su pregiudizi che a lungo hanno gra-vato sul futurismo. Per fortuna lo spesso velo di indifferenza un tempo calato sullaprima avanguardia storica italiana del Novecento può dirsi, infatti, infranto, avendosuperato il concetto di identificazione tout court futurismo/fascismo e rivelato unastoria assai più articolata e complessa. Tale rilettura è stata resa possibile grazie inparticolare all’attuale disponibilità di archivi pubblici e privati divenuti accessibilinegli ultimi anni per mezzo di un importante lavoro di recupero, catalogazione evalorizzazione di un patrimonio testimone insostituibile della galassia futurista coltanel suo personalissimo combinato di ‘storia’ e ‘geografia’.
Nella scia di tale proficua impostazione rientra a pieno titolo anche il saggio diGloria De Vincenti, che al secondo tempo del futurismo fiorentino ha dedicato ri-cerche e riflessioni utili ad illuminare un’esperienza centrale – non solo locale, maitaliana – nella vicenda del movimento di ‘Effeti’. Tralasciando di tornare in ter-mini esclusivi alla dibattuta questione delle diverse posizioni tra «Lacerba» (1913-1915) e «L’Italia futurista» (1916-1918), o piuttosto alla contrapposizione tra ilfuturismo nato a Firenze e quello milanese, l’autrice concentra l’attenzione su ma-nifestazioni meno note e tuttavia, come è stato di recente suggerito, «organizzati-vamente importanti e con una continuità nel tempo» quali la rivista attorno a cui simuoveva la ‘Pattuglia azzurra’. Un’esplorazione minuziosa, che ha passato al vaglioin parallelo sia l’ingente corpus di scritti teorici e programmatici, di testi narrativie poetici, sia alcune rare quanto significative corrispondenze, nella fattispecie tra idue direttori del nuovo foglio, Bruno Corra e Emilio Settimelli, protagonisti indi-

scussi del futurismo post-lacerbiano. Si tratta naturalmente di una prospettiva di as-soluto privilegio, che ha permesso alla De Vincenti di evidenziare i retroscena di unsegmento nevralgico, seppure circoscritto, nella storia del movimento, tra strategie,progetti, polemiche, entusiasmi e delusioni. Ad emergere è un quadro composito,aperto ad una dimensione internazionale – per il tramite in primis dei fratelli GinanniCorradini –, dominato da una sensibilità post-simbolista e pre-surrealista ed insiemedall’interesse per il paranormale e per l’occulto. Parimenti vengono ampiamente ri-levate e documentate all’interno dell’«Italia futurista» l’anima tecnologico moder-nista dei marinettiani e quella cerebrale del nucleo dirigente, cogliendo la specificitàdel contributo offerto da alcuni dei numerosi collaboratori. Una analisi che, cosìcome altri avevano fatto in passato, non può non tenere conto delle divergenze colgruppo lacerbiano che aveva agito in un tempo spostato cronologicamente di pochianni ma qualitativamente remoto rispetto a quello del nuovo periodico. In effetti lestesse personalità che si distinsero nel così detto secondo futurismo fiorentino,spesso indicate dalla critica come emarginate, furono a più riprese impegnate a mar-care una discontinuità anche polemica, sentendosi a ragione estranee alla rivista diGiovanni Papini e Ardengo Soffici. Si trattava di posizioni dichiarate ad alta voce findal primo editoriale di Settimelli, quando nel giugno 1916, rivendicando di essere«i primi veri futuristi fiorentini», scriveva: «Essendo questo giornale edito a Firenzee diretto da poeti futuristi fiorentini sento il bisogno di dichiarare che noi non con-tinuiamo Lacerba». E piace qui ricordare quanto, molti anni dopo, Primo Conti te-neva a ribadire circa la necessità di liquidare definitivamente «un equivoco criticoe storico, non so fino a qual punto disinteressato, che poneva la fine del futurismocon la fine del giornale “Lacerba”». L’ormai anziano artista non solo individuava nel1916 la data in cui il movimento si era aperto a esperienze di portata internazionale,ma anche il termine post quem l’eredità maggiore dei pionieri della straordinariaavventura primonovecentesca della cultura italiana era stata assimilata nella suaparte più dinamica.
Viene quindi a trovare conferma il disegno di una testata molto operosa, spessofervida in alcune sue zone sperimentali, col monitoraggio sulla realtà circostanteper rinnovare il patrimonio del gesto e dell’espressione e con lo sforzo di lanciarsiin nuovi campi della sensibilità umana comprensiva di una dimensione onirica finoa quel momento trascurata. Così come tornano a distinguersi, nell’ambito di unamonocorde adesione al marinettismo in terra fiorentina e di una composizione al-quanto eterogenea ed eclettica, alcuni apporti qualitativi individuali notevolissimi so-prattutto per le ricerche lirico-fantastiche in campo letterario, che trovaronoespressione, oltre che sulle colonne della rivista, nella collana «Libri di valore» di-retta da Maria Ginanni.
Naturalmente il percorso intrapreso è ancora lungo e complesso, come la stessaDe Vincenti tiene a sottolineare, consapevole della poliedricità delle voci presentinella fitta trama delle collaborazioni a «L’Italia futurista» da tempo censite, ma nontutte studiate a dovere. E l’auspicio è che nell’anno in cui ci accingiamo a ricordareil centenario della nascita di «Lacerba» ci si appresti anche a polarizzare l’atten-zione sull’originalità del contributo del periodico che operò nel triennio successivo,proponendosi di divenire «il primo giornale dinamico italiano». Sulle sue pagine si
8 Prefazione

possono riconoscere, accanto a quelli già ricordati, molti altri spunti d’interesse cri-tico quali, per esempio, le sintesi teatrali, il cinematografo o il fertile esercizio delparoliberismo. E il discorso potrebbe ampliarsi qualora si volessero affrontare lequestioni d’ordine politico, ricongiungendosi «L’Italia futurista» al marinettismomilitante e ardito fino alla pubblicazione, sull’ultimo numero, del Manifesto delPartito politico futurista. Una aspirazione conoscitiva che, in virtù anche del pre-sente lavoro, dovrà a maggior ragione tenere conto delle carte d’archivio, insosti-tuibile specchio – come ebbe a scrivere ancora Conti – della «meravigliosaprimavera che avevamo vissuto tutti insieme in una ebbrezza creativa indicibile» edi una cultura che «aveva saputo ritrovare, nel fervore degli ultimi movimenti no-vatori, e in opposizione a ogni sterile prudenzialismo scolastico, il culto dell’av-ventura spirituale nella ricerca di una sempre più aggiornata comunicabilità».
Gloria Manghetti
Presidente Fondazione Primo Conti
9Prefazione


Introduzione
Il che cosa è preso dalla realtà, ma non è essenziale; il come è proprio della forza creativa del genio, equesto conta.
(Rudolf Steiner, da un quaderno di appunti del 1888)
La fase del futurismo denominata secondo futurismo fiorentino è stata fino atempi relativamente recenti una stagione poco studiata. Per molti anni non si è pre-stata la dovuta attenzione al secondo futurismo fiorentino, in quanto l’interesse eraprincipalmente rivolto verso il recupero storico-critico del futurismo nella sua glo-balità. A partire dalla fine degli anni sessanta si è infatti assistito ad un revival delmovimento attraverso un’intensa attività: riedizioni di opere, antologie, studi cri-tici, retrospettive sul futurismo pittorico e convegni tesi a rivalutare il movimento neisuoi vari aspetti. La rivisitazione del futurismo ne ha messo in luce la natura etero-genea e frastagliata. In questo quadro il secondo futurismo fiorentino ha trovato col-locazione soprattutto nell’ambito di opere che hanno ripercorso le varie fasi delmovimento. Pur ricevendo dalla critica minore attenzione rispetto ai filoni principalidel futurismo, è iniziato ad emergere il ruolo svolto da questo nucleo che, per l’ori-ginalità degli esiti artistico-letterari, rappresenta un tassello significativo nella sto-ria dell’avanguardia italiana ed europea del Novecento.
A più riprese gli studiosi hanno rivendicato per il secondo futurismo fiorentinoil ruolo di precursore del surrealismo. Nel 1973 Mario Verdone, a cui spetta il me-rito di essere stato tra i primi a rivalutare questa fase del futurismo, parlava di “unaspetto presurrealista dentro la letteratura italiana, e futurista, che finora non erastato appieno valutato”1. E avanzava l’ipotesi che “nella storia delle espressioni let-terarie contemporanee, tra i poemi in prosa di Baudelaire, di Saint-Pol-Roux, diJarry e i ‘campi magnetici’ di Breton e Soupault stanno, come tappa intermedia,proprio le prose poetiche, e i frammenti del ‘secondo’ gruppo futurista fiorentino”2.De Maria avrebbe concordato nel riconoscere nella produzione del nucelo “probantie rilevantissimi” esempi italiani di poema in prosa presurrealista3.
Al recupero del secondo futurismo fiorentino e del suo organo “L’Italia Futuri-sta” (1916-1918) contribuiscono iniziative importanti tese a rimetterne in circola-zione la produzione più significativa. “L’Italia Futurista” torna all’attenzione delpubblico nel 1977 grazie al lavoro di schedatura condotto da Maria Carla Papini
1 Mario Verdone, Prosa e critica futurista, Milano, Feltrinelli, 1973, p. 20.2 Ibid.3 Luciano De Maria, La nascita dell’avanguardia, Venezia, Marsilio, 1986, p. 62.

nell’omonimo volume4. La riproduzione anastatica della rivista uscirà però nel 1992a cura di Luciano Caruso5. La ristampa completa rappresenta una chiave di volta nelrecupero di questo filone, consentendo l’accesso a fonti primarie altrimenti difficil-mente reperibili. La pubblicazione include una raccolta di saggi che vanno ad ap-profondire vari aspetti di questa produzione sottolineandone l’originalità econtribuendo quindi alla rivisitazione di questo momento del futurismo6. Nel 1995,sempre ad opera di Caruso, esce Dossier futurista che include le ristampe integralidi alcuni scritti del nucleo fiorentino, quali Notti filtrate di Mario Carli, Mascheratefuturiste di Emilio Settimelli, e Pittura dell’avvenire di Arnaldo Ginna, così comeerano stati pubblicati nelle Edizioni de “L’Italia Futurista” tra il 1917 e il 19187.
Restando in tema di diffusione dell’apparato teorico, un altro apporto rilevante èdato da Mario Verdone, con la pubblicazione di Manifesti futuristi e scritti teorici diArnaldo Ginna e Bruno Corra8. In quest’opera, che vede la luce nel 1984, lo stu-dioso raccoglie circa 15 scritti, molti dei quali firmati in collaborazione con altriesponenti del movimento. La raccolta è introdotta da due saggi, su Ginna e Corra ri-spettivamente, nei quali Verdone traccia un profilo di questi personaggi che sono trai principali esponenti del secondo futurismo fiorentino. La ricchezza di particolariche emerge dalla lettura dei saggi è dovuta, come si scopre, al rapporto di amiciziache legava Verdone ai fratelli ravennati9. Il privilegiato angolo d’osservazione portaalla pubblicazione di alcune pagine di taccuini di Ginna, nella stessa raccolta di scrittiteorici, oltreché in altre sedi10. Verdone, a cui Ginna si rivolgerà scrivendo come de-dica: “al carissimo e geniale amico Mario Verdone mio primo interprete”11, ha nelcorso degli anni contribuito enormemente alla diffusione, rivalutazione e analisi dellaproduzione di Ginna e Corra.
È a cura di Verdone la ristampa del romanzo di Corra Sam Dunn è morto, uno deilavori più conosciuti e citati di questo nucleo, avvenuta nel 1970 presso Einaudi. Altritesti creativi dei fratelli, così come degli altri protagonisti del movimento, vengonoinclusi soprattutto in antologie dedicate al futurismo. Per quanto riguarda la produ-zione femminile, è da segnalare il lavoro svolto da Claudia Salaris per diffondere ilcontributo apportato dalle donne futuriste. Con Le futuriste: donne e letteraturad’avanguardia in Italia (1909-1944)12 vengono riproposte le liriche di personaggi di
12 Gloria De Vincenti
4 Maria Carla Papini (a cura di), L’Italia Futurista (1916-1918), Roma, Edizioni dell’Ateneo e Biz-zarri, 1977, p. 26.
5 Luciano Caruso (a cura di), “L’Italia Futurista 1916-1918”, Firenze, S.P.E.S, 1992.6 Luciano Caruso (a cura di), Il “fronte interno” de “L’Italia Futurista”(Firenze 1916-1918), Firenze,
S.P.E.S, 1992.7 Luciano Caruso (a cura di), Dossier futurista 1910-1919, Firenze, S.P.E.S.,1995.8 Mario Verdone (a cura di), Manifesti futuristi e scritti teorici di Arnaldo Ginna e Bruno Corra, Ra-
venna, Longo, 1984. Si tratta dei fratelli Ginanni Corradini, ribattezzati Bruno Corra ed Arnaldo Ginna dalpittore Balla.
9 Verdone, che ricorda come la frequentazione fosse favorita dal fatto di essere vicini di campagna interra sabina, ne parla nell’introduzione ai Manifesti futuristi e scritti teorici, cit., p. 8.
10 Si veda Mario Verdone, Arnaldo Ginna tra astrazione e futurismo, Ravenna, Edizioni Essegi, 1985.11 Lo racconta Verdone nell’Introduzione a Manifesti futuristi e scritti teorici, cit., p. 8.12 Claudia Salaris, Le futuriste: donne e letteratura d’avanguardia d’Italia (1909-1944), Milano, Edi-
zioni delle donne, 1982.

spicco del secondo futurismo fiorentino quali Maria Ginanni e Irma Valeria. Passando all’apparato critico, oltre ai cospicui saggi che accompagnano le rac-
colte antologiche, il secondo futurismo fiorentino viene trattato a partire dagli studicritici sul filone fiorentino del futurismo e sui rapporti tra questo e il filone milanese.Un notevole apporto è dato dal convegno del 1984 “Futurismo a Firenze 1910-1920”, i cui atti sono stati raccolti a cura di Gloria Manghetti13. Nello stesso annola Manghetti ha curato, insieme a Fabrizio Bagatti e Silvia Porto, il catalogo dellamostra “Futurismo a Firenze 1910-1920”14 e ancora, nel 1994, il catalogo della mo-stra “Marinetti e il Futurismo a Firenze”15. Laddove gli studi assumono un’angola-zione più specifica, numerosi interventi vengono dedicati all’aspetto esoterico delfuturismo e mettono in luce il modo in cui questi interessi vengono declinati dalgruppo de “L’Italia Futurista”16. Tra questi, in tempi più recenti, si distingue un ca-pitolo di Simona Cigliana nell’ambito dell’importante volume Futurismo esote-rico17, che pone all’attenzione le peculiarità del gruppo. Un altro contributo è datodalle iniziative – come quella a cura dell’assessorato per la cultura della provinciadi Modena – che pongono particolare enfasi sugli sviluppi regionali e delineano i ca-ratteri specifici del movimento in una particolare area18. Dal momento che i fratelliGinanni Corradini erano ravennati, questa ricognizione concorre alla comprensionedi alcuni caratteri specifici della Romagna del tempo, come l’interesse per la teosofiae l’antroposofia.
Sull’onda delle indicazioni di Verdone, numerosi saggi hanno come oggetto l’in-dividuazione di elementi “protosurrealisti”19 nella produzione del gruppo. Il termineè di Mirella Bandini che, avendo pubblicato un’opera sul surrealismo20, valuta gliesiti del secondo futurismo fiorentino alla luce dei legami con la cultura francese,già presente nella formazione del nucleo. Gli studiosi che rilevano queste affinità at-tingono ad una comune radice rappresentata dall’esplorazione nel profondo e dalletecniche attraverso cui veicolare l’espressione di questo livello subcosciente21. Pur nei
Introduzione 13
13 Gloria Manghetti (a cura di), Futurismo a Firenze 1910-1920, Atti del convegno “Futurismo a Fi-renze 1910-1920”, tenutosi a Firenze, Palazzo Medici Riccardi (1-3 marzo 1984), Verona, Bi & Gi edi-tori, 1984.
14 Fabrizio Bagatti, Gloria Manghetti, Silvia Porto (a cura di), Futurismo a Firenze 1910-1920, Ca-talogo della mostra “Futurismo a Firenze 1910-1920”, tenutasi a Firenze, Palazzo Medici Riccardi (18febbraio-8 aprile 1984), Firenze, Sansoni, 1984.
15 Gloria Manghetti (a cura di), Marinetti e il Futurismo a Firenze, Catalogo della mostra (Firenze,19 dicembre 1994-21 gennaio 1995), Roma, De Luca, 1994.
16 Si segnalano i seguenti lavori: Germano Celant, Futurismo esoterico, in “Il Verri”, n. 33-34,1970, pp. 108-117; Anna Maria Cioni, Teoria e pratica della scrittura esoterica nel futurismo, in “Cri-tica letteraria”, a. III, n. 9, 1975, pp. 684-687; Sandro Zanotto, Motivi irrazionali ed esoterici nel futu-rismo toscano, in Futurismo a Firenze 1910-1920, Bi & Gi, cit., pp. 111-118.
17 Simona Cigliana, Futurismo esoterico (prima edizione, 1996), Napoli, Liguori, 2002.18 Anna Maria Nalini (a cura di), Futurismo in Emilia Romagna, Modena, Artioli, 1990.19 Mirella Bandini, Elementi protosurrealisti nei testi di Mario Carli, Bruno Corra e Maria Gi-
nanni in “L’Italia Futurista”, in Luciano Caruso (a cura di), Il “fronte interno” de “l’Italia Futurista”,cit., p. 15.
20 Mirella Bandini, La vertigine del moderno: percorsi surrealisti, Roma, Officina, 1986.21 Si segnalano i seguenti interventi: Maria Carla Papini, Tra futurismo, surrealismo e oltre: il gruppo
dell’ “Italia Futurista”, in Luciano Caruso, Il “fronte interno” de “l’Italia Futurista”, cit., pp. 62-65;

rispettivi tempi storici e con diversi sviluppi teorici a disposizione, appare evidenteche l’ “ultrarealtà”22 a cui si riferisce Corra anticipa di un decennio il concetto di sur-realtà che sarebbe poi stato teorizzato nel Manifesto del Surrealismo del 1924.
Nel 2009, il centenario della nascita del futurismo ha segnato un momento im-portante di celebrazione e riflessione a partire da Milano, culla e centro propulsoredel movimento. Un vortice di iniziative ispirate al concetto di poliespressività: mo-stre e convegni23, spettacoli e serate futuriste, saggi e numeri monografici24 chehanno reso omaggio al movimento, sollecitato un riesame di alcuni aspetti e nuoveanalisi nei suoi anfratti. L’eredità del futurismo è stata individuata nel suo caratteredi attualità, nel suo “divenire” rintracciabile in successive forme artistiche, lettera-rie e della conoscenza, come anche nella percezione della realtà come contraddi-zione e paradosso25. Riflettendo su questo retaggio, Nino Arrigo afferma: “Tutta lafilosofia e l’epistemologia contemporanea costituiranno una messa in discussionedel Logos della tradizione metafisica occidentale, della certezza della sua logicafondata sull’aut aut classico tra vero e falso”26.
Tra le iniziative più nello specifico tese a valorizzare l’apporto dei protagonistidel secondo futurismo fiorentino, va segnalata la mostra su Arnaldo Ginna “Armo-nie e disarmonie degli stati d’animo-Ginna futurista”, promossa dai Musei Vaticanie dalla Galleria Nazionale di Arte Moderna di Roma, e curata da Micol Forti, LuciaCollarile, Mariastella Margozzi27. A rendere la mostra di grande interesse concorreil ricco materiale collezionistico, archivistico e documentario custodito dagli eredi,che include illustrazioni, schizzi, pagine manoscritte, taccuini. I saggi, raccolti nelcatalogo, contribuiscono a creare un quadro ricco e suggestivo di Ginna e dei suoiinteressi occultistico-spirituali28.
Nel 1909 nasceva dunque il futurismo: un movimento poliedrico che, a qualcheanno dalla sua esplosione, avrebbe fecondato l’attività di un secondo nucleo fio-
14 Gloria De Vincenti
Gianni Grana, Dal futurismo al surrealismo in Novecento, le avanguardie letterarie, vol. II, Milano, Mar-zorati, 1986, pp. 499-511; Gianni Grana, Il surreal-futurismo fiorentino, ibid., pp. 555-565; Maurizio Cal-vesi, L’écriture médiumnique comme source de l’automatisme futuriste et surréaliste, in “Europe”, n. 551,mars 1975, pp. 44-48.
22 Bruno Corra, Sam Dunn è morto, pubblicato a puntate su “L’Italia Futurista” nel 1916 e poi per leEdizioni Futuriste di “Poesia”, Milano, 1917. La citazione da quest’ultima edizione, p. 82.
23 Nel contesto del futurismo fiorentino si ricorda il convegno di studi “Firenze Futurista 1909-1920”,svoltosi a Palazzo Medici Riccardi (Firenze) il 15 e il 16 maggio 2009, promosso da vari enti ed istituzionitra cui la Provincia di Firenze, il Gabinetto G.P. Vieusseux e la Fondazione Primo Conti. Gli atti sono poistati raccolti a cura di Gloria Manghetti per le Edizioni Polistampa, 2010.
24 Si veda Federico Luisetti and Luca Somigli (edited by), A Century of Futurism:1909-2009, “An-nali d’Italianistica”, vol. 27, 2009; Ignazio Apolloni e Nino Arrigo (a cura di), Futurismo come attualitàe divenire, “Rivista di Studi Italiani”, a. XXVII, n. 1, 2009; Giuseppe Gazzola (edited by) Futurismo: im-pact and legacy, Stony Brook, NY, Forum Italicum Publishing, Filibrary Series n. 31, 2011.
25 Nino Arrigo, Futurismo come attualità e divenire, in “Rivista di Studi Italiani”, cit., p. 2.26 Ibid.27 “Armonie e disarmonie degli stati d’animo-Ginna Futurista”, a cura di Micol Forti, Lucia Collarile,
Mariastella Margozzi, Roma, Museo Boncompagni Ludovisi per le Arti decorative, il Costume e la Modadei secoli XIX e XX, 12 marzo-10 maggio 2009; Firenze, Palazzo Pitti, 23 giugno-20 settembre 2009.
28 Micol Forti, Lucia Collarile, Mariastella Margozzi (a cura di), Armonie e disarmonie degli statid’animo- Ginna Futurista, Roma, Gangemi, 2009.

rentino, già molto operativo a partire dal 1912. È questo l’anno in cui i fratelli Gi-nanni Corradini incontrano il gruppo milanese nella Casa Rossa di Marinetti per di-scutere uno scritto sull’arte scritto dai fratelli. Alcuni anni dopo, nel 1916, le energiecongiunte sarebbero confluite ne “L’Italia Futurista”, organo del secondo futurismofiorentino, con il patrocinio di Marinetti “suscitatore meraviglioso”29.
Questo lavoro apporta un contributo alla rivisitazione del secondo futurismo fio-rentino investigando il rapporto tra arte e civiltà tecnologica. Partendo dal presup-posto che il futurismo nasce come risposta all’accelerazione della vita modernaindotta dalla rivoluzione tecnologica, lo studio intende esplorare come questo im-patto incide sulle dinamiche che sottendono il processo creativo nella concezione ce-rebralista del gruppo che dà vita al secondo futurismo fiorentino.
Questo obiettivo evoca due tendenze distinte: il culto della modernità metropo-litana e macchinistica dell’anima milanese da un lato, la direttrice esoterica ed oni-rica della corrente fiorentina dall’altro. Un proposito che accosti queste due estetichesi pone come momento di confronto, corrisponde all’analisi di un cortocircuito pro-dotto dalla collisione di queste due correnti e degli effetti che ne derivano. Diversistudi sui rapporti tra i due rami del futurismo hanno evidenziato le tendenze nonconformi del futurismo fiorentino rispetto ai canoni del futurismo ortodosso, loscarto del primo rispetto all’estetica tecnologico-modernista del secondo. In riferi-mento al gruppo de “L’Italia Futurista”, Mario Verdone osserva che “costituiva l’alamagico-occultistica con poca o punta idolatria per la macchina e, viceversa, unagran passione per le ‘attività inconscie dello spirito’”30. L’ipotesi da cui parte que-sto lavoro è che “la macchina” e “le attività inconscie dello spirito” non stiano in rap-porto di opposizione ma di dialogo, in quanto le due sfere confluiscono nella poeticadel secondo futurismo fiorentino. Il carattere positivista veicolato dalla civiltà in-dustriale si riflette nella concezione cerebralista dell’arte elaborata dal nucleo, chevede il “genio” impegnato a captare ed esprimere l’essenza profonda della realtà edil suo fermento, potenziato dai ritmi della civiltà moderna.
Attingendo ad un considerevole corpus di scritti teorici e creativi, si procede aduno studio sistematico per ricostruire il percorso ideologico del movimento a par-tire dagli anni del noviziato letterario. Lo studio esplora, capitolo per capitolo, ilruolo dell’artista, passa al vaglio gli strumenti di cui dispone, esamina quindi le con-dizioni che favoriscono l’impiego di tali strumenti e in ultimo le modalità che ac-compagnano il momento espressivo.
All’interesse di questo lavoro concorre in maniera significativa la ricchezza dellerare fonti primarie impiegate. Tra gli scritti teorici sono stati esaminati innanzituttoi periodici “La Difesa dell’Arte” (novembre 1909-dicembre 1910), “Il Centauro”(novembre 1912-febbraio 1913), “Rivista” (aprile-agosto 1913), e “L’Italia Futuri-sta” (giugno 1916-febbraio 1918). La rassegna si è estesa altresì ai due volumi della“Collezione di saggi critici” (1912), in cui Corra e Settimelli riprendono teorie le-gate alla concezione cerebralista dell’arte avanzate nell’ambito dei periodici. L’ana-
Introduzione 15
29 Emilio Settimelli, L’Italia Futurista, in “L’Italia Futurista”, a. I, n. 1, Firenze, 1 giugno 1916, p. 1.30 Mario Verdone, Il futurismo fiorentino. Documenti per l’avanguardia, in Luciano Caruso (a cura
di), Il “fronte interno” de “L’Italia Futurista”, cit., p. 86.

lisi della corrispondenza inedita di Corra a Settimelli offre inoltre elementi di grandeinteresse. Si tratta dei due direttori principali delle testate del movimento, dei duemaggiori teorici del secondo futurismo fiorentino.
Nello specifico di questa ricerca, le informazioni emerse hanno assunto partico-lare valenza perché la consultazione del fondo Settimelli è avvenuta in contempo-ranea alla lettura delle riviste. Dal momento che il contenuto delle lettere verte difrequente su decisioni e intenzioni relative alle riviste, è stato possibile seguire i re-troscena di quanto veniva pubblicato, capire i moventi, le strategie, e avere quindi adisposizione materiali di prima mano. Questo metodo ha fornito una prospettiva chesarebbe mancata se avessi letto le due fonti separatamente e a distanza di tempo, emi ha aiutato a collocare le lettere in un ordine cronologico. Generalmente Corra nondatava le lettere specificando l’anno, a volte includeva il luogo, il giorno e il mese.Tuttavia, dai riferimenti è stato possibile in una certa misura capire a quale periodorisalissero le lettere e quindi utilizzare la documentazione per meglio interpretare al-cune vicende del gruppo. Ciò è particolarmente utile quando si analizza un movi-mento come il futurismo, le cui strategie propagandistiche fatte di toni provocatorie polemiche contaminano spesso la realtà fattuale. Il fatto che esistano dei docu-menti affidabili e diretti a sostegno delle ipotesi comprova la validità del discorso.
Le lettere veicolano altresì il clima culturale europeo, documentano l’interessedi Corra verso movimenti attecchiti oltralpe e la sua intenzione di diffondere que-ste teorie nel territorio italiano. Si apprende dell’interesse verso l’occultismo e dellasua adesione alla Scuola di Psichismo sperimentale della Società Magnetica di Fran-cia. Corra si propone di avviare, tramite il periodico (“Rivista” come si deduce dalcontesto) un movimento che parte da quanto fatto all’estero per promuovere lo svi-luppo delle energie e delle facoltà latenti di ogni individuo. La corrispondenza at-testa l’esposizione dei fratelli Ginanni Corradini all’ambiente internazionaleattraverso i lunghi soggiorni all’estero. Ma le lettere parlano anche di un rapportodi solida amicizia e grande confidenza. A Settimelli Corra confida fragilità e fru-strazioni, idee e progetti. Gli scritti, che mettono a nudo alcuni tratti della persona-lità di Corra, intervengono nel momento in cui determinate vicende e scelte possonoessere spiegate e vanno spiegate anche in base a ragioni personali.
Gli scritti creativi, la cui selezione viene esposta più avanti quando si procede allasintesi dei capitoli, si affiancano a quelli teorici nell’illustrare l’aspetto program-matico del movimento e concorrono ad indicare il percorso dell’artista dalla fasepercettiva a quella rappresentativa. Essi dimostrano come le preoccupazioni teori-che espresse dal gruppo trovino riscontro sul piano creativo. Tra questi, è da segna-lare il recupero di un racconto di Mario Carli intitolato Il Barbaro. Esso compare apuntate ne “Il Centauro” in un arco di tempo lungo tre mesi (novembre 1912-feb-braio 1913), ma non vedrà la luce in volume, nonostante la sua pubblicazione sia an-nunciata nello stesso periodico.
Questo lavoro è insomma la ricostruzione di un percorso attraverso la ricompo-sizione di vari tasselli. Si tratta di un’impresa alquanto complessa, in quanto l’evo-luzione del pensiero è tortuosa e a volte caratterizzata da elementi contraddittori.Inoltre, le tattiche del movimento devono essere ben presenti e guidare il lavoro cri-tico che, interpretando i toni polemici e provocatori, le dichiarazioni dettate da unastrategia mirante a far risaltare la novità delle proprie posizioni per contrasto, vada
16 Gloria De Vincenti

ad individuare i nodi essenziali di un percorso ideologico. Non sarebbe corretto vo-lere vedere a tutti i costi questo tracciato come definito e coerente in tutte le sueparti, è vero piuttosto che il gruppo tiene a sottolineare il carattere provvisorio delleproprie enunciazioni. Nel 1918, dunque verso la fine di una stagione estremamenteaudace e produttiva, Corra avrebbe affermato: “Noi siamo stati i primi a proclamareinsistentemente, in questa epoca in cui tutto è provvisorio ed instabile, la provviso-rietà e l’instabilità delle nostre ricerche. Siamo stati i primi a dichiarare la necessitàper noi, artisti immersi nel caos di un’epoca vecchia che si sfascia e già partecipidelle vibrazioni di un’epoca nuova che nasce, di progredire continuamente, di su-perarci senza tregua, di non adagiarci su nessuna conquista, di attribuire ad ogni no-stra opera il valore fuggevole di un tentativo, di un sondaggio nel vuoto da esplorare,di un passo verso la meravigliosa sintesi lontana alla quale si arriverà chissàquando”31.
Il caos, che come vedremo assume nel gruppo una connotazione positiva e cor-risponde ad uno stato produttivo e ricco di possibilità, si riferisce ad un momento sto-rico e culturale in grande fermento, ad un complesso clima ideologico-culturale,che vede coniugare l’eredità del positivismo al recupero di una dimensione spiri-tuale. Nel gruppo ciò si traduce in una molteplicità di interessi, che vede attingerea varie scuole di pensiero impegnate nel recupero e nell’esplorazione di una di-mensione occulta della realtà, esterna all’essere umano e a questi inerente, da scan-dagliare in tutte le sue pieghe. La volontà del gruppo di non adagiarsi, di superarsisenza tregua, di progredire costantemente, si riflette dunque nella maniera in cuiesso fa propri spunti offerti dai vari campi ai fini della propria indagine. La corri-spondenza, i taccuini, le testimonianze, in base ai quali si apprende che i fratelli Gi-nanni Corradini viaggiavano, partecipavano a mostre e conferenze, leggevanoavidamente, dimostra l’apertura internazionale e la voracità assimilativa del gruppo,dove gli stimoli venivano assorbiti e incanalati nella poetica.
Alcuni importanti apporti teorici sono sanciti e trovano riscontro nelle dichiara-zioni di esponenti del gruppo. Come si dimostrerà nel corso della trattazione, glistudi teosofici e antroposofici da parte dei Ginanni Corradini – di Arnaldo Ginna inparticolare – vengono dichiarati, e a testimoniarne il significato sono gli oltre trentavolumi di Rudolf Steiner compresi nell’archivio Ginanni Corradini32, curato dalladottoressa Lucia Collarile e di recente donato dagli eredi ai Musei Vaticani. Comeevidenziato a proposito della corrispondenza Corra-Settimelli, sono accertati gli in-teressi dei fratelli verso le scuole di pensiero che si richiamavano a discipline orien-tali sullo sviluppo del potenziale umano e verso le scienze occulte nelle sue varie
Introduzione 17
31 Bruno Corra, Prefazione a Per l’arte nuova della nuova Italia, Milano, Studio Editoriale Lom-bardo, 1918, p. 11.
32 Interessante l’osservazione di Daniela Carmosino: “Dalle pubblicazioni steineriane di proprietà diGinna risulta chiaramente la fedeltà con cui ne segue le uscite”, spiegando che sulla quarta di copertina diun libro di Steiner Ginna “spunta con una croce i volumi usciti e già acquistati”. In un altro punto dellostesso saggio la Carmosino parla della “meticolosità con cui annota e sottolinea i passaggi per lui piùinteressanti”. Daniela Carmosino, “Dalla coscienza intellettiva a quella veggente”: tardo simbolismoo pre-surrealismo?, in Micol Forti, Lucia Collarile, Mariastella Margozzi (a cura di), Armonie e disar-monie degli stati d’animo-Ginna Futurista, cit., p. 69.

ramificazioni. Come risulta dalla ricognizione della Collarile, si tratta di circa 35testi (a parte i volumi di Steiner) datati dal 1895 agli anni ’50, con alcuni volumi infrancese non datati ma databili tra il 1910 e il 1920. L’approccio teorico a questa ri-cerca attinge pertanto ampiamente a queste scuole di pensiero.
Un discorso a parte merita la possibile influenza di teorie freudiane e junghiane.Nell’indicare l’area presurrealista rappresentata dal nucleo fiorentino, Gianni Granasostiene che, per quanto “il gruppo dei giovani futuristi riteneva di aprirsi spazi diconoscenza intuitiva nella psiche ‘profonda’ [...]”, è da escludere un diretto richiamoa Sigmund Freud, come avverrà invece per il surrealismo, poiché in quegli anniFreud era ancora malconosciuto e non tradotto in Italia33. E in un altro capitolo dellostesso volume, riprendendo il discorso sulla diffusione delle teorie freudiane, ri-corda che la psicanalisi nasceva da premesse psichiatriche e si proponeva come te-rapia delle nevrosi, quindi non coincideva con una rivalutazione dell’inconscio inaccezione positiva34.
Intanto va precisato, senza contraddire Grana, che negli anni in questione alcuneteorie freudiane e junghiane erano per grandi linee state esposte in territorio ita-liano. Michel David parla di una prima fase divulgativa negli anni 1908-1915, a cuicontribuirono articoli di medici quali Luigi Baroncini, Gustavo Modena, EnricoMorselli e Roberto Assagioli su riviste di psicologia35. Assagioli viene designatocome “il primo in Italia ad introdurre parole e concetti freudiani in riviste di culturanon specializzate, o di larga volgarizzazione scientifica e con atteggiamento deci-samente positivo”36. Come ricorda David, è altresì di Assagioli il primo riferimentoall’applicazione estetica della psicanalisi in un articolo del 1910 su “La Voce” in ri-ferimento ad un saggio di Otto Rank del 190737. Ad interventi diretti vanno aggiuntii riferimenti indiretti, attraverso cenni bibliografici o recensioni ad altri lavori. Davidmenziona una recensione di Baroncini del 1910 a un lavoro sui sogni in cui questisi stupisce che “non vi siano accennati gli studi geniali di Freud intorno al mecca-nismo psicologico dei sogni”38.
Nella produzione teorica e negli articoli del nucleo fiorentino non mi risulta checi siano riferimenti a teorie freudiane o junghiane, ma ciò non esclude che vi sianostate delle influenze indirette. La diffusione per opera di altri studiosi contribuiva acreare nell’ambiente culturale tendenze e suggestioni, nell’ambito di un progettoche si proponeva di conoscere l’essere umano in tutte le sue manifestazioni e diesplorarne le parti nascoste. E comunque, come spesso accade, le teorie filtrano pas-sando da un ambito all’altro e attraverso canali diversi si riversano sul clima cultu-rale ed ideologico, producendo un impatto sul modo di rapportarsi alla realtà. Si
18 Gloria De Vincenti
33 Gianni Grana, Il surreal-futurismo fiorentino, cit., p. 559.34 Gianni Grana, Dal futurismo al surrealismo, cit., p. 509.35 Michel David, La psicanalisi nella cultura italiana, Torino, Boringhieri, 1966, pp. 144-162. 36 Ibid., p. 151.37 Roberto Assagioli, Le idee di S. Freud sulla sessualità, in “La Voce”, a. II, Firenze, 9 e 10 feb-
braio, 1910. Il saggio di Rank è Der Künstler.38 Michel David, La psicanalisi nella cultura italiana, cit., p. 146. Si tratta della recensione a P. Meu-
nier e R. Masselon, Les rêves et leur interprétation, in “Rivista di Psicologia”, vol. 6, 1910, p. 265.

pensi alle teorie sul sogno che, come vedremo nel quarto capitolo, vengono ripresedal filosofo francese Henri Bergson in occasione di una conferenza (“Le rêve”) te-nuta nel 1901 all’Institut Général Psychologique. In quella circostanza Bergson ri-badisce che i sogni rappresentano un metodo efficace per esplorare l’inconscio,ricollegandosi a teorie già avanzate nel diciannovesimo secolo da Alfred Maury e poiriprese e ulteriormente sviluppate da Freud.
Come inoltre suggerisce David, nel secolo precedente c’era stata un’immensa let-teratura esplorativa della “psiche in crisi” ad anticipare la sistematizzazione psica-nalitica, quindi è difficile stabilire le origini di influenze che vengono a coinciderecon le scoperte di quegli anni ma risalgono a fonti precedenti. David ricorda che“tante intuizioni letterarie antiche e moderne potevano fornire ‘fonti’ apparente-mente freudiane a scrittori affatto ignari di psicanalisi”39. D’altra parte, la sistema-tizzazione psicanalitica andava indubbiamente a porre enfasi sull’esistenza di unricco deposito psichico senza trascurare, come vedremo nel terzo capitolo, che ildiscorso sull’inconscio non nasce certo con la psicologia analitica.
È di interesse tuttavia rilevare che, in una riflessione retrospettiva sul futurismonell’ambito dello scritto L’uomo futuro (1933), Ginna dichiara, in riferimento al Ma-nifesto del Futurismo del 1909: “È da allora dunque che il movimento futurista puòdefinirsi un complesso movimento psicologico e filosofico. Se vogliamo studiarequesta attività, sorta e sviluppata in Italia, nell’ambito delle moderne teorie psicolo-giche e psicoanalitiche, dovremmo definirlo come un trasporto dell’istinto evolutivosubcosciente nella ragione cosciente”40. Mario Verdone, che ai Ginanni Corradini hadedicato molte pagine in Cinema e letteratura del futurismo, ha analizzato la rac-colta di Ginna Le locomotive con le calze41 in chiave psicanalitica, affermando: “Tuttele idee di queste novelle vengono dal subcosciente: sono sentimenti ‘refoulés’ – comediremmo con Freud – ‘refoulements’ dell’infanzia”42. E, a sostegno di questa inter-pretazione, Verdone riferisce che, in base a quanto riportato dallo stesso Ginna, “unopsicanalista svizzero allievo di Freud”, dopo avere letto le sue novelle “asseriva cheera tutta interessante materia di studio per la psicanalisi”43. Ginna ribadisce quantoriportato da Verdone in un’intervista dove racconta di avere inviato le novelle aJung44. In nessuno dei due riferimenti è specificato l’anno.
Sempre in Cinema e letteratura del futurismo Verdone indica il racconto SamDunn è morto di Corra come tinto di una “vena italiana surrealista” citando lo stral-cio in cui si legge: “La vera vita di Sam Dunn si è svolta appunto in questo sub-strato incosciente dinamitico, inesplorato sul quale è stratificata la realtàmateriale”45. E menziona una delle illustrazioni di Ginna che “traduce visivamente
Introduzione 19
39 Michel David, La psicanalisi nella cultura italiana, cit., p. 253.40 Arnaldo Ginna, L’uomo futuro, 1933, ora in Mario Verdone, Manifesti futuristi e scritti teorici,
cit., p. 226.41 Arnaldo Ginna, Le locomotive con le calze, Milano, Facchi, 1919.42 Mario Verdone, Cinema e letteratura del futurismo, Roma, “Bianco e Nero”, a. XXVIII, n. 10-
11-12, ottobre-novembre-dicembre 1967, p. 77.43 Ibid.44 Sergio Lambiase – G. Battista Nazzaro, Marinetti e i futuristi, cit., p. 86.45 Bruno Corra, Sam Dunn è morto, cit., p. 30.

proprio quest’ultima frase” spiegando: “Nel disegno appare anche una figuretta didonna ignuda: e la ricollegheremo al sessualismo del subconscio proprio in acce-zione psicanalitico-surrealista”. Subito dopo aggiunge: “È chiara qui la freudiana di-stinzione tra conscio e subconscio, e l’anticipazione di tutto quel lavoro discandaglio ed esplorazione del subcosciente, che poi i surrealisti realizzeranno”46.Ebbene, in una dedica apposta proprio su una copia di questo libro Ginna avrebbescritto di Verdone: “mio primo interprete”47.
Laddove si tratta di fonti conosciute e accertate (come si è visto per altre scuoledi pensiero) o di possibili sollecitazioni mediate per vie indirette, il sostrato teoricoche permea la produzione del secondo futurismo fiorentino riflette gli interessi eclet-tici del gruppo e il sincretismo dimostrato nel combinare innesti provenienti da variambiti a fini letterari ed artistici, riconducendoli entro il tracciato della singolareconcezione cerebralista dell’arte. Nel promuovere in uno dei primi articoli di “Ri-vista” il movimento di coltura umana diretto a studiare i metodi grazie ai quali svi-luppare le facoltà latenti nell’essere umano e la cui applicazione avrebbe portatoalla “creazione di un tipo umano superiore”, Corra insiste sulla necessità di “intro-durre in questi studi l’esattezza e l’oggettività della scienza positiva”48.
Occorre tenere presente il carattere provvisorio, talvolta frammentario, che que-sti innesti assumono nella produzione del gruppo. Si pensi che lo stesso Ginna haespresso delle riserve sui campi di interesse e studio a lui più vicini rivelando: “Ionon so se sia vera la teoria della filosofia-psicologica-religiosa indiana che ammettealtri mondi compenetranti nel nostro terreno. [...] Io non so neanche ammettere lateoria teosofica così vasta complicata e particolareggiata sebbene io, al dire di moltioccultisti credenti, sia già penetrato in questi mondi”49. E che dire della recensionedella futurista Eva Kühn Amendola (in arte Magamal) a Sam Dunn è morto nellaquale, elogiando il personaggio di Corra emblema dell’essere futurista con il qualel’Amendola si identifica, precisa: “[...] vorrei una volta per sempre chiarire che lanostra concezione futurista non ha nulla in comune nè colla magia, nè colla teoso-fia nè coll’occultismo” definite “cose passatiste al massimo grado”50. La recensioneappariva sulle pagine de “L’Italia Futurista” tre mesi dopo l’articolo Occultismo earte nuova di Irma Valeria, che proclamava: “Siamo infine degli occultisti”51. Cosapensare se non che il romanzo aveva sorpassato nella sua interpretazione influenzeed interessi ammessi dallo stesso autore? Come non notare che quella firma (Ma-gamal futurista) racchiude un proclama, richiama quel “progredire continuamente”
20 Gloria De Vincenti
46 Mario Verdone, Cinema e letteratura del futurismo, cit., p. 70. 47 Mario Verdone, Introduzione a Manifesti futuristi e scritti teorici, cit., p. 8.48 Bruno Ginanni Corradini, La coltura umana, in “Rivista” a. I, n. 1, Firenze, 6 aprile 1913, p. 2.49 Arnaldo Ginna, Pittura dell’avvenire, 1915, poi a puntate su “L’Italia Futurista” dal n. 16, 3 giu-
gno 1917 al n. 20, 1 luglio 1917, ora in Mario Verdone (a cura di) Manifesti futuristi e scritti teorici,cit., p. 201.
50 Magamal (futurista) Sam Dunn è morto, in “L’Italia Futurista”, a. II, n. 28, Firenze, 9 settembre1917, p. 3.
51 Irma Valeria, Occultismo e arte nuova, in “L’Italia Futurista”, a. II, n. 17, Firenze, 10 giugno1917, p. 2.

che Corra rivendica come peculiarità del movimento e si manifesta anche come ete-rogeneità delle proposte nell’ambito di un disegno omogeneo volto all’estrinseca-zione delle energie psichiche. Il movimento vive di questa discontinuità, che è segnodi ritmo e risorse, e in essa esprime il suo palpito vitale.
Questo studio si propone di interpretare il secondo futurismo fiorentino alla lucedella temperie culturale dei primi del Novecento, che permea e sollecita la produ-zione del nucleo fiorentino. Il primo capitolo è un’introduzione al secondo futuri-smo fiorentino. A partire dalla sua collocazione cronologica nell’ambito delmovimento futurista, si esaminano le caratteristiche del filone milanese e di quellofiorentino che lo ha preceduto, al fine di mettere in luce le peculiarità di questo nu-cleo ed evidenziare quale rilevante contributo abbia apportato nel quadro comples-sivo del movimento futurista. La discussione prende avvio dall’articolo di aperturade “L’Italia Futurista”, in cui la redazione prende distanza dal gruppo fiorentinoruotante attorno alla rivista “Lacerba” e dichiara il patrocinio marinettiano alla ri-vista. Dal momento che nel corso delle pubblicazioni precedenti il gruppo aveva as-sunto una posizione critica e polemica nei confronti del filone marinettiano, ènecessario ripercorrere le tappe di questi interventi per far luce sulla posizione delgruppo ed investigare le ragioni del sodalizio sancito sulle pagine della rivista. L’ana-lisi si snoda lungo un percorso costellato da considerazioni sul futurismo milanese,su Marinetti stesso e passa attraverso il simbolismo. Sulle orme di una strategia co-mune a tutto il movimento futurista, l’originalità delle proprie posizioni viene af-fermata per contrasti. Critiche, polemiche, toni provocatori costituiscono lapiattaforma da cui parte l’autoaffermazione. E tuttavia, un’analisi articolata, allaluce dell’intero quadro fornito dai documenti teorici, spiega quanto profonde sianole implicazioni di questo scambio e come l’apertura dimostrata dal secondo futuri-smo fiorentino verso l’ala legata a Marinetti vada al di là di un discorso contingente.Dalla discussione emergerà il profilo di un nucleo caratterizzato da una vorace vo-lontà di assimilazione, che non esita a far propri e sviluppare spunti provenienti daqualsivoglia direzione ai fini della propria esplorazione.
Per capire da quali presupposti parta l’esplorazione compiuta dal gruppo, deno-minato da Raffaello Franchi “pattuglia azzurra”52, nel secondo capitolo si procede aduna sua collocazione nel contesto storico, scientifico e culturale di quegli anni. La ri-voluzione tecnologica verificatasi nel mondo occidentale tra la fine dell’Ottocento ei primi del Novecento sancisce la presenza di zone inesplorate di realtà. La rivolu-zione avvenuta nel campo dei trasporti, della comunicazione e dell’informazione inseguito alle scoperte scientifiche, decretando l’accelerazione della vita moderna, pro-duce un impatto sul modo di percepire la realtà, vista nel suo dinamismo. D’altraparte il recupero del mondo onirico, a cui danno grande enfasi le scoperte freudiane,aggiunge un’ulteriore dimensione al reale, visto non solo come entità esterna all’es-sere umano, ma a questi inerente, da scandagliare in tutte le sue pieghe.
In risposta a queste sollecitazioni nasce l’esigenza di elaborare un’arte che possasondare e veicolare una realtà in fermento, percepita nel suo inarrestabile divenire.
Introduzione 21
52 Mario Verdone, Diario parafuturista, Roma, Lucarini, 1990, p. 92.

Il futurismo assume questo mandato, si propone di interpretare in chiave letterariaed artistica l’impatto prodotto dalle recenti scoperte e, attraverso i vari manifesti, in-neggia all’incursione nell’ignoto, all’esplorazione della realtà col fine di cogliernee rappresentarne la sua complessità. Alla costituzione occulta dell’universo corri-sponde una costituzione occulta dell’essere umano, soggetta allo stesso dinamismo,che l’arte si propone di esprimere.
In questo ambito si situa la ricerca portata avanti dalla “pattuglia azzurra”. Avva-lendosi di apporti derivati da più campi quali le ricerche esoteriche, lo studio dei fe-nomeni paranormali, la ricerca psichica, l’antroposofia, la pattuglia intraprende unoscandaglio nel profondo. L’inizio del ventesimo secolo vede le ricerche su più frontipartire da una stessa premessa: richiamare l’attenzione sull’esistenza di forze invisi-bili, da studiare partendo comunque da una prospettiva scientifica, consona ai tempi.La fenomenologia deve fare i conti con l’osservazione scientifica positiva, essere stu-diata chiamando in causa l’applicazione di leggi già accertate in altre discipline. Tut-tavia, per quanto riguarda la “pattuglia azzurra”, pur dichiarando l’intenzione diaffidarsi ad uno “scientifismo rigoroso”53, i protagonisti pubblicano un manifestocon il quale dichiarano battaglia alla scienza tradizionale ed elaborano una originaleconcezione di scienza futurista54. Nel capitolo verrà pertanto problematizzato il dua-lismo di questa ricerca che, da un lato, si prefigge carattere scientifico e, dall’altro,avversa la scienza tradizionale. Dall’analisi di questo contrasto, esaminato alla lucedi altri scritti teorici e della corrispondenza Corra-Settimelli, emergerà la singolarepoetica del gruppo e si profileranno obiettivi e strumenti alternativi.
Il terzo capitolo ricostruisce la posizione del movimento sugli strumenti di cui di-spone l’artista nella sua esplorazione. L’analisi si basa sulle dichiarazioni teoriche enun-ciate nel corso delle varie pubblicazioni. Queste vengono valutate in rapporto a scuoledi pensiero operanti in quegli anni nel campo filosofico e della ricerca psichica per di-mostrare come questi influssi abbiano permeato e legittimato la poetica del nucleo.
Prendendo spunto dalla figura simbolo del movimento – il centauro, l’essere cheè insieme uomo e bestia – si ricostruisce la posizione del gruppo sul rapporto traistinto e ragionamento. L’analisi si avvale ancora una volta del metodo contrastivo.Da un lato, vi è lo spettro del soggettivismo rappresentato dalla teoria estetica cro-ciana, dall’altro alcune formulazioni marinettiane sulla messa al bando del ragiona-mento. In un clima surriscaldato dalle polemiche, il nucleo si propone di dimostrareil carattere scientifico-cerebrale del prodotto artistico. Attraverso un sistema di equa-zioni, queste due facoltà vengono ricongiunte nell’ambito di una concezione chevede l’intuizione – definita “un ragionamento frammentario e più rapido”55 – come
22 Gloria De Vincenti
53 Bruno Ginanni Corradini, Il liberismo, in “Il Centauro”, a. I, n. 1, Firenze, 3 novembre 1912, p. 1. 54 B. Corra, A. Ginanni, R. Chiti, E. Settimelli, M. Carli, O. Mara, N. Nannetti, La scienza futurista,
in “L’Italia Futurista”, a. I, n. 2, Firenze, 15 giugno 1916, ora in Mario Verdone (a cura di), Manifesti fu-turisti e scritti teorici, cit., pp. 205-209.
55 Bruno Corradini – Emilio Settimelli, Pesi, misure e prezzi del genio artistico, Manifesto futurista,Milano, 1914; ora in Mario Verdone (a cura di) Manifesti futuristi e scritti teorici, ibid., p. 172. I caratteriin corsivo sono nell’originale. L’enfasi posta su parole o frasi facendo ricorso ai caratteri in corsivo, ne-retto o maiuscolo era pratica ricorrente nel movimento. Si precisa che in questo lavoro tutte le citazioniriportano l’enfasi posta dagli autori e non dalla sottoscritta.

lo strumento preposto a cogliere il dinamismo della realtà. Il capitolo passa quindiad esaminare a quale livello si esplica questo strumento esplorativo, addentrandosinel concetto di “subcoscienza cosciente”56, elaborato da Ginna.
Nel quarto capitolo e nel successivo si esaminano le condizioni che favorisconol’atto esplorativo e le dinamiche attivate in questi frangenti. In entrambi i capitoli siprocede all’analisi dei testi creativi. La parte introduttiva rileva una corrispondenzatra la scoperta e il distacco dai parametri che regolano la vita vigile, dove questo èconditio sine qua non dell’atto esplorativo. L’abitudine rivolta ad un fine utile vieneadditata quale criterio che regola il modo di collegare le idee nel ragionamento. Esi-ste tuttavia una zona franca, una zona cioè interdetta alla coscienza vigile e criticalegata all’espletamento delle nostre funzioni quotidiane, che favorisce e consentel’esplicazione di un ragionamento soggetto a dinamiche diverse.
La produzione teorica e creativa del gruppo punta alla dimensione onirica qualecondizione privilegiata che consente l’atto esplorativo. Teorie elaborate sui vari ver-santi avallano la posizione del gruppo e dimostrano come la poetica del movimentosi inserisca nella temperie culturale e scientifica di quegli anni. Sul versante della ri-cerca psichica si pone l’indagine freudiana che, partendo da quanto già esposto daisuoi predecessori, pone grande enfasi sullo stato onirico quale strumento grazie a cuiaccedere ad uno strato sottostante la soglia della vita vigile. A queste formulazioniseguono ulteriori sviluppi per opera di Jung. Sull’onda della ricerca freudiana sipone, in campo filosofico, l’intervento di Bergson sull’importanza della vita oni-rica quale mezzo per accedere ad un’altra dimensione. Dal canto delle teorie antro-posofiche, l’essere umano viene sondato nelle sue parti costitutive per illuminarnela parte in grado di accedere all’essenza profonda della realtà sia esterna all’indivi-duo che a questi inerente.
Le caratteristiche di questo stato vengono messe in risalto dall’analisi dei testi.L’esame si avvale di un corpus di liriche e scritti di Bruno Corra, Mario Carli, PrimoConti, Maria Ginanni, Irma Valeria, pubblicati tra il 1912 e il 1918. La selezione diqueste opere risponde al proposito di dimostrare, attraverso un’analisi incrociata deitesti, come il discorso venga sviluppato anche sul piano creativo dai vari autori ecome l’espressione individuale contribuisca a creare un quadro esauriente e coe-rente con gli scritti teorici.
Attraverso l’esame delle dinamiche attivate in questo frangente emergerà la ca-pacità dell’individuo di esercitare una facoltà associativa altra da quella che sot-tende il pensiero rivolto all’utile, in grado di scoprire inedite relazioni tra gli elementidella realtà. L’analisi dimostrerà come questa fase corrisponda alla riattivazione diuna condizione che affonda le radici in un’epoca precedente e quindi al recupero diun’attività già esplicata dall’individuo. L’infanzia si profila come stagione in cuil’anima, ancora “monda di esperienza”57, si offre alla percezione della realtà liberodagli schemi imposti da quest’ultima. La discussione sull’esperienza, vista comeostacolo alla novità, chiama in causa le più recenti riflessioni del filosofo Giorgio
Introduzione 23
56 Arnaldo Ginna, Pittura dell’avvenire, cit., p. 201.57 Bruno Ginanni Corradini, Leggenda, in “Il Centauro”, a. I, n. 8, Firenze, 22 dicembre 1912, p. 1.

Agamben sul rapporto che intercorre tra poesia moderna58 ed esperienza, per cui laricerca del nuovo comporta “un’eclisse e una sospensione dell’esperienza”59.
Nel quinto capitolo si esamina un’altra dimensione che favorisce l’atto esplora-tivo: la follia. I riferimenti alla pazzia sono frequenti nella produzione del gruppo,che ad essa associa la costituzione cerebrale dell’artista moderno. Partendo da alcuneanalogie tra questa condizione e lo stato onirico e seguendo l’evoluzione nella ma-niera in cui essa viene recepita in ambito culturale, si analizzano gli interventi delnucleo fiorentino per capire come il gruppo si rapporti a questa condizione. Si trattainfatti di dimostrare come uno stato che si richiama all’eclissi della ragione si con-cili con una concezione cerebralista dell’arte.
L’analisi prende avvio dalle dichiarazioni teoriche enunciate nel manifesto Pesimisure e prezzi del genio artistico60, che vede la pazzia corrispondere ad un’opera-zione produttiva volta alla costruzione di strutture più o meno complesse. La paz-zia viene ad assumere un valore direttamente proporzionale alla sua complessità. Sipassa quindi ad investigare il senso di tale affermazione per capire in cosa consistaquesto tipo di operazione.
L’analisi testuale si concentra sul romanzo Sam Dunn è morto di Bruno Corra.Il romanzo è una delle opere corriane più significative del periodo preso in esame:prova ne sono le varie edizioni che lo hanno riproposto tra il 1916 e il 1928, e quellasuccessiva curata da Mario Verdone nel 1970. Ritengo che, per quanto sia stata en-fatizzata l’importanza di questo romanzo, soprattutto da Mario Verdone, la chiavedi lettura fornita dagli strumenti teorici esposti in questo capitolo possa fare emer-gere elementi non ancora evidenziati dalla critica. Scopo di questo studio è dimo-strare come il personaggio creato da Corra ben sintetizzi la concezione del futurismofiorentino per la quale pazzia (in accezione futurista) e genialità rappresentano dueaspetti simmetrici di un approccio alla realtà inedito ma cerebrale.
Lo studio parte da una rassegna delle caratteristiche del protagonista del rac-conto – Sam Dunn – che vengono interpretate da chi lo circonda come segno di paz-zia. Il comportamento di Dunn e le sue inusuali reazioni sono valutati in base alloscarto esistente tra questi ed una serie di criteri esterni. Il deragliamento presupponeuna traiettoria, e questa è rappresentata dai rapporti logici, basati sull’abitudine e re-golati dalla realtà pratica. Alle caratteristiche che portano a definire Dunn al di fuoridalla logica ne corrispondono altre che si svolgono sullo stesso terreno incolto mapossiedono una valenza positiva e consegnano Dunn alla genialità. Attraverso il per-corso di Dunn emergerà il teorema che vede la follia, considerata come sconvolgi-mento dei rapporti logici, garante di scoperte geniali.
L’analisi si avvale principalmente delle teorie elaborate dalle scuole di pensieroimpegnate nello sviluppo delle facoltà latenti dell’essere umano che, come si di-mostra, erano conosciute e seguite da Bruno Corra. Uno spaccato sulla ricezione diqueste nozioni da parte del mondo culturale, attraverso una valutazione degli arti-
24 Gloria De Vincenti
58 “Da Baudelaire in poi”, specifica il filosofo. Giorgio Agamben, Infanzia e storia, Torino, Ei-naudi, 1978, p. 37.
59 Ibid., p. 38.60 Bruno Corradini – Emilio Settimelli, Pesi misure e prezzi del genio artistico, cit.

coli comparsi sulla rivista “Leonardo” nonché alla biografia intellettuale del co-di-rettore Giovanni Papini, dimostra che queste teorie permeavano il mondo culturaledi quel periodo. Nella discussione convergono altresì teorie sulla genialità svilup-pate nel campo delle scienze psichiche. Ciò dimostra come la produzione del grupporifletta il clima scientifico-culturale e al tempo stesso entri in dialogo con esso, ap-portando un contributo originale.
Il sesto e ultimo capitolo investiga il passaggio dal momento esplorativo a quelloespressivo. Sogno e follia corrispondono alla facoltà di penetrare al di là dei limitifisici della materia e di coglierne la sua essenza dinamica. Tuttavia, il processo crea-tivo non si esaurisce con la percezione ma culmina nella rappresentazione. Dal-l’esame degli scritti teorici emerge il proposito dell’artista di fissare l’oggetto dellavisione attraverso la forma artistica. Allo studioso spetta dunque il compito di pas-sare al vaglio i vari interventi per ricostruire il percorso che porta dalla percezionealla rappresentazione. Qual è la spinta che induce l’artista ad articolare la sua visionee imprimerla nel prodotto artistico e come avviene questo passaggio? Fondamentali,a questo scopo, sono i due scritti teorici sull’arte: Arte dell’avvenire del 1910 poi ag-giornato in Arte dell’avvenire. Paradosso nel 1911, firmato da Arnaldo e Bruno Cor-radini e Pittura dell’avvenire del 1915, di Arnaldo Ginna.
L’esame di questo percorso si avvale del racconto di Mario Carli Il Barbaro, cheviene esaminato in chiave programmatica. L’ipotesi da cui muove la scelta di que-sto racconto è che le varie fasi dell’itinerario compiuto dal protagonista riflettono laconcezione del movimento sull’evoluzione dell’artista dalla fase percettiva a quellarappresentativa. In parallelo, vengono esaminati altri lavori e gli scritti sull’arte so-pramenzionati, che vanno a convalidare l’esegesi del racconto di Carli, dimostrandocome scritti teorici e creativi si affianchino nell’indicare il percorso che conduce al-l’opera d’arte, così come viene concepito dai protagonisti del movimento.
L’indagine si articola in due parti. Nella prima parte si passano in rassegna glielementi che portano il nucleo futurista a collegare la propria disposizione esplora-tiva a quella dei primitivi. Associazione sottolineata, come vedremo, anche da Mau-rizio Calvesi, che osserva come questa poggi su una comune facoltà di vedere al dilà della superficie materiale61. L’analisi del percorso compiuto dal “barbaro”, aval-lata da studi teorici sui primitivi condotti nei primi del Novecento, mette in luce lecaratteristiche di questa figura per quanto concerne la percezione della realtà. Ilprincipio del Novecento vede confluire molti studi condotti sulla mentalità primi-tiva nell’ambito dell’antropologia e delle scienze psichiche. L’analisi portata avantiin questo capitolo si colloca all’interno di un clima culturale che influenza il futu-rismo e produce ulteriori sviluppi in teorie successive. L’apparato teorico che sot-tende questa parte del capitolo attinge altresì a queste ultime, laddove si tratta dellaripresa ed ulteriore elaborazione di teorie attecchite in prima istanza negli anni checoncernono il movimento futurista.
L’investigazione metterà in luce come, sul terreno della dimensione fantastica,
Introduzione 25
61 Maurizio Calvesi, L’écriture médiumnique comme source de l’automatisme futuriste et surréa-liste, cit., p. 47.

confluiscano primitività, dimensione onirica e universo infantile. La condizione dipensiero nella vita psichica del bambino, così come nella dimensione onirica dellavita adulta, riecheggia l’universo fantastico della primitività, che equivarrebbe quindiad un’infanzia dell’umanità.
Nella seconda parte si segue la fase che porta dalla visione alla rappresentazioneattraverso l’arte. Gli elementi che concorrono a questo processo vengono passati inrassegna in un esame congiunto di scritti teorici e interventi nelle riviste pubblicatedal nucleo fiorentino. Partendo dall’intenzione del “barbaro” di “svolgere le sue vi-sioni davanti a tutta l’umanità”62, si investigano le implicazioni di un progetto chesi colloca in una sfera pubblica. Attingendo a teorie elaborate su più fronti, lo stu-dio esplora i fattori che consentono la visibilità e indica come si articola nell’ambitodella poetica il percorso che, partendo dalla fase percettiva, culmina con la rappre-sentazione del pensiero.
26 Gloria De Vincenti
62 Mario Carli, Il Barbaro, V “Il canto delle parole”, in “Il Centauro”, a. I, n. 5, Firenze, 1 dicem-bre 1913, p. 2.

1.
IL SECONDO FUTURISMO FIORENTINO: GENESI, PROTAGONISTI E PECULIARITÀ
Il “secondo futurismo fiorentino” rappresenta una breve ma intensa stagione let-teraria, inaugurata da un gruppo compatto di giovani intellettuali. Essi danno vita allatestata d’avanguardia “L’Italia Futurista” nell’arco di tempo compreso tra il 1 giu-gno 1916 e l’11 febbraio 1918, sotto il patrocinio di Filippo Tommaso Marinetti. Dalmomento che il futurismo si presenta come un fenomeno plurimo, differenziato neiluoghi e nei tempi, occorre tracciare una mappa delle sue fasi per capire come nasceil secondo futurismo fiorentino e dove si colloca all’interno di questo eterogeneo pa-norama.
Nel futurismo vengono indicati due tempi: il “primo futurismo”, detto anche“futurismo eroico”, che va dal 1909, data di pubblicazione del manifesto, al 1920;e il “secondo futurismo” che dal 1920 giunge fino al 1944, data della morte di Ma-rinetti1. La prima fase corrisponde al momento di massima creatività innovativa, acui segue una seconda fase di assestamento. All’interno del “primo futurismo” sipossono individuare due filoni rappresentati dal futurismo milanese – i cui mag-giori esponenti sono Filippo Tommaso Marinetti, Umberto Boccioni, Carlo Carrà,Luigi Russolo – e dal futurismo fiorentino. Quest’ultimo ha come principali prota-gonisti Giovanni Papini, Ardengo Soffici, Aldo Palazzeschi, Italo Tavolato e ruotaattorno alla rivista “Lacerba” (Firenze 1913-1915). Quando poi nel 1916 un gruppodi giovani fonda il periodico “L’Italia Futurista”, si inaugura la stagione del “se-condo futurismo fiorentino”. Quest’ultimo viene definito “secondo” in quanto segue“Lacerba”, organo del primo futurismo fiorentino. Il termine sta quindi ad indicareuna successione cronologica nell’ambito del filone fiorentino del futurismo.
Avere stabilito questo rapporto di successione porta a chiedersi se il secondomomento del futurismo fiorentino erediti i caratteri che contraddistinguono il gruppodi “Lacerba” o se si differenzi da esso nell’elaborazione di una propria ideologia epoetica. La risposta al quesito ci farà capire quale importante contributo abbia ap-portato questo nucleo nel quadro complessivo del movimento futurista. Andrò dun-que ad evidenziare i caratteri principali del futurismo milanese e di quello fiorentino,delineando le differenze tra questi due filoni. Passerò poi a considerare il periodopreso in esame, ovvero il secondo futurismo fiorentino: indicherò da chi è formato
1 Luciano De Maria, La nascita dell’avanguardia, cit., p. 8.

il nucleo e spiegherò quali sono le sue peculiarità. Mi soffermerò quindi su alcunedichiarazioni espresse sia ne “L’Italia Futurista” che nelle riviste precedenti, per in-dividuare le intenzioni poetiche e ideologiche dei redattori.
Il futurismo milanese
Il futurismo milanese è indissolubilmente legato alla figura del suo fondatore, Fi-lippo Tommaso Marinetti, presente sulla scena letteraria italo-francese già dal 1898.Nato ad Alessandria d’Egitto, Marinetti frequentò il collegio della città retto da ge-suiti francesi e proseguì gli studi a Parigi, dove ottenne il baccalaureato in lettere.Anziché dedicarsi subito alla letteratura, si laureò in legge all’Università di Genovaper compiacere il padre. Durante gli ultimi anni del corso di laurea in legge iniziòa collaborare alla rivista italo-francese “Anthologie-Revue”, su cui avrebbe pubbli-cato nel 1898 Les viewx marins, poemetto in versi liberi premiato a un concorso dipoesia indetto a Parigi2. I primi del Novecento furono anni di grande fermento perMarinetti che, oltre a collaborare a riviste francesi, si fece promotore in Italia dellapoesia francese romantica e simbolista, organizzando conferenze e recitando versidi poeti francesi quali Baudelaire, Mallarmé, Rimbaud, Verlaine. Nel 1905 fondò larivista internazionale “Poesia”.
È verso la fine del 1908 che Marinetti matura l’idea di fondare un proprio mo-vimento, nella consapevolezza che le condizioni ideologiche e letterarie in cui ver-sava l’Italia avrebbero favorito la sua iniziativa. Come osserva Bruno Romani, lacultura italiana “non aveva conosciuto, nel corso del XIX secolo, delle rivoluzionie dei rivolgimenti paragonabili, per intensità e portata, a quelli prodottisi in Fran-cia”3. Nella replica ad un commento del giornalista di “Le Temps” – Joseph Bois –mettendo a confronto l’esperienza francese e quella italiana, Marinetti spiega comein Francia esista “una libertà di spirito” che si esprime nel modo in cui “l’arte an-tica a poco a poco si lascia penetrare dalle nuove nozioni”, in un processo evolutivoche assorbe lentamente gli elementi nuovi. In quel Paese “tutti gli elementi si fon-dono”, egli osserva, laddove in Italia ci si arresta nel passato “come in un cimitero”4.Marinetti, che pure si era ispirato ai valori romantici e simbolisti negli anni della suaformazione, si rese conto che in Italia occorreva un gesto rivoluzionario che demo-lisse la struttura di un passato sulle rovine del quale i futuristi avrebbero inalberatola giovane bandiera rinnovatrice. Ciò avrebbe consentito all’Italia di mettersi cultu-ralmente al passo con le altre nazioni.
Nell’ambito di questo contesto va collocato l’intervento di Marinetti. Egli capìche, nella situazione in cui versava la cultura italiana, occorreva un gesto esplosivoche facesse tabula rasa dei vecchi schemi ispirati all’ordine classico. Nei giovaniletterati ed artisti si era generato un diffuso senso di insofferenza verso i modelli, ita-liani o stranieri che fossero, e una smania di novità. Marinetti seppe quindi ben in-
28 Capitolo primo
2 Ibid., pp. 13-14.3 Bruno Romani, Dal simbolismo al futurismo, Firenze, Sandron, 1969, p. 116.4 Luciano De Maria, La nascita dell’avanguardia, cit., p. 19.

terpretare i sentimenti delle nuove generazioni e convogliò con maestria e tempismoperfetti queste giovani e fresche energie verso la rivoluzione futurista. Il manifesto,che venne presentato sulle pagine del prestigioso giornale parigino “Le Figaro” il 20febbraio 1909, anche per garantirgli una diffusione internazionale, equivalse ad unadichiarazione di clamorosa e aperta rottura nei confronti del passato, inteso comedato acquisito. Ad esso i futuristi opponevano una vita improntata al dinamismo,all’audacia intesa come possibilità di sperimentazione. Nella prefazione alle Revol-verate di Gian Pietro Lucini (1909), Marinetti spiega: “Nelle colonne del ‘Figaro’io riassunsi, con laconiche e violente affermazioni tutto quello che il futurismo si-gnifica, tutte le aspirazioni demolitrici della parte più giovane e migliore della no-stra generazione, stanca di adorare il passato, nauseata dal pedantismo accademico,avida di originalità letteraria e anelante verso una vita avventurosa energica e quo-tidianamente eroica”5.
Occorre tenere presente che tutto questo avveniva in un periodo di grande fer-mento generato dalla rivoluzione industriale dove il concetto di velocità, alla basedi tante invenzioni, era diventato una forma mentis e si prestava ad un’applicazionein vari campi. In questa prospettiva anche la parola doveva rinnovarsi e liberarsi dailegami sintattici, ricomporsi in nuovi schemi atti ad esprimere una realtà mutevolee in continuo divenire6. Nella concezione futurista di “poliespressività” la parolacostituiva uno dei possibili mezzi di espressione artistica volti a rappresentare per-cezioni di una realtà dinamica e quindi immagini sempre mobili. A questo fine do-vevano convergere tutte le arti.
Veniva dunque dichiarata battaglia all’immobilismo ideologico, in un atto dicontestazione mirante ad investire tutti gli aspetti della realtà: la letteratura e le artifigurative, il costume, la morale, la politica (nel 1909 venne altresì presentato ilPrimo Manifesto Politico). La caratteristica principale del movimento futurista va in-dividuata infatti nella sua “ideologia globale artistica ed extra-artistica, abbracciantetutti i settori dell’esperienza, dall’arte alla politica, dalla morale al costume”7, se-condo una concezione dinamica dell’arte che doveva entrare “in cortocircuito conla vita”8. L’esperienza artistico-letteraria doveva estendersi alla sfera socio-politicae diventare azione, marcia in direzione dell’eterno fluire della realtà.
Per veicolare questa visione dinamica di ideologia globale Marinetti sceglie il ter-mine “movimento”, fondato sull’affinità elettiva dei componenti animati da un co-mune intento espressivo. Come osserva Luciano De Maria, parlando del futurismoin generale, “l’idea di gruppo è fondamentale: il futurismo e il surrealismo costi-tuiscono due gruppi fondati sulla tendenziale affinità elettiva dei componenti”9. In
Il secondo futurismo fiorentino: genesi, protagonisti e peculiarità 29
5 Gian Pietro Lucini, Revolverate, 1909, ora in F.T. Marinetti, Teoria e invenzione futurista, a curadi Luciano De Maria, Milano, Mondadori, 1968, p. 27.
6 La teoria delle parole in libertà fu presentata nel Manifesto tecnico della letteratura futurista (11maggio 1912) e rappresentò un assalto dissacratorio all’organismo della lingua. In Luciano De Maria(a cura di), Marinetti e i futuristi, Milano, Garzanti, 1994, pp. 78-85.
7 Luciano De Maria, La nascita dell’avanguardia, cit., p. 15.8 Ibid., p. 52.9 Ibid., p. 50.

un altro punto lo studioso parla di “aspetto collegiale della ricerca” e di “comunanzadelle idee e di intenti”10.
I giovani italiani risposero all’appello del manifesto con ventiduemila adesionientusiastiche raccolte in un mese, quasi tutte di giovani fra i 20 e i 30 anni, come te-stimonia lo stesso Marinetti11. Alla schiera di poeti si aggiunse presto un nucleo dipittori ed artisti quali Boccioni, Carrà, Russolo, Severini, Balla, che videro nel fu-turismo una buona occasione per farsi strada12. Essi avevano puntato nella giustadirezione, in quanto il manifesto ebbe effettivamente una grossa diffusione sia inItalia che all’estero grazie alle doti di organizzatore e leader di Marinetti.
Va detto che queste sue qualità furono potenziate dalle risorse finanziarie di cuiegli potè disporre alla morte del padre, avvenuta nel 1907. Marinetti si trovò infattiad amministrare un notevole patrimonio, che gli fornì i mezzi per diffondere il mo-vimento e finanziarne i progetti. Il proclama venne fatto circolare attraverso volan-tini in varie lingue, secondo un tipo di approccio preso in prestito dalla propagandapolitica e dall’industria. Marinetti inaugura così un nuovo modo di condurre la bat-taglia culturale che, attraverso strumenti pubblicitari quali cartelloni, volantini, ma-nifestazioni, mira a creare un linguaggio di comunicazione per la società di massa.Le capacità manageriali di Marinetti portarono al movimento nuove adesioni, tracui l’importante sodalizio con il gruppo fiorentino di “Lacerba”.
Il futurismo fiorentino
Come già accennato, il gruppo fiorentino vedeva tra i suoi maggiori rappresen-tanti Papini e Soffici. Essi fondarono nel gennaio del 1913 la rivista artistico-lette-raria “Lacerba”, che due mesi dopo divenne organo del movimento futurista e vide,per circa un anno, una stretta collaborazione tra i suoi fondatori e il gruppo milanesefacente capo a Marinetti. Basata su una comune posizione antipassatista, l’intesaguardava al rinnovamento della cultura italiana e fu molto feconda di idee e opere.Arte e politica procedono di pari passo sulle pagine del giornale, che divenne unatribuna interventista per tanti intellettuali. Ma le divergenze di idee e di imposta-zione tra questi due rami del futurismo, divergenze presenti fin dall’inizio, avrebberoportato alla rottura del sodalizio.
Le differenze tra il gruppo milanese e il gruppo fiorentino vanno innanzitutto ri-condotte al loro diverso retaggio. Come ricorda Massimo Carrà, il futurismo eranato a Milano, città industriale in forte crescita. La rivoluzione tecnologica che scon-volse il mondo occidentale tra la fine dell’Ottocento e i principi del Novecento ebbeun forte impatto in area milanese e sul modo di sentire degli intellettuali. I fioren-tini operavano invece in una realtà, quella toscana, dominata ancora dalla società
30 Capitolo primo
10 Ibid., p. 16.11 F.T. Marinetti, L’introduzione del pugno nella lotta artistica, in “L’Italia Futurista”, a. II, n. 9, Fi-
renze, 15 aprile 1917, p. 2.12 Claudia Salaris ripercorre le vicende di questi artisti, riferendo che alcuni di loro erano pratica-
mente privi di propri mezzi finanziari e quindi l’incontro con Marinetti ha rappresentato “l’uscita dal-l’isolamento e dal bisogno”. Claudia Salaris, Storia del futurismo, Roma, Editori Riuniti, 1985, p. 36.

contadina e quindi “il sentimento della continuità e della tradizione, come radice emotrice del presente, erano presenze ben vive nel loro spirito”13. Di conseguenza i la-cerbiani non avrebbero mai fatta propria la foga rivoluzionaria totalizzante sbandie-rata dal futurismo milanese, rimanendo invece su posizioni più equilibrate e frenanti.
Anche Giorgio Luti individua nella posizione di aperta rottura rispetto al passatoassunta dal gruppo marinettiano un’importante ragione di divisione tra i due ramidel futurismo. Alla “fisionomia ideologico-tecnica dell’operazione modernizzantedel gruppo milanese”, si oppone quella “fondata sul rapporto avanguardia-tradizione”del gruppo fiorentino che ruota attorno a “Lacerba”14. Questo punto era stato già sol-levato da Bruno Romani, per cui “l’asserito ‘futurismo’ di Papini, Soffici e Palazze-schi [...] mirava a conciliare tradizione e rivoluzione, ordine e avventura”15. PerRomani, ciò che separava Papini e gli altri da Marinetti “dipendeva soprattutto da unfatto di cultura e di gusto”, pur essendoci alla base una comune radice simbolista16.
I fiorentini mantenevano uno stretto legame con la cultura francese che era allabase della loro formazione, ed erano influenzati dal modo in cui quella nazione re-cepiva le novità nel rispetto di un principio evolutivo del divenire. Come ricordaSergio Zoppi, in Francia la rivoluzione tecnologica non assunse i toni di una asso-luta modernolatria, in quanto le novità venivano in quel paese stemperate da un biso-gno di ordine e armonia17. Questo era il modello a cui si ispirava il futurismo fiorentino.A conferma del solido legame con la cultura francese vanno ricordate le traduzioni deitesti di Laforgue, Lautréamont, Mallarmé presenti sulla rivista. “Lacerba” apre inoltrele porte ai contributi internazionali e si avvale di un diretto apporto dell’avanguardia eu-ropea contemporanea, soprattutto francese, accogliendo interventi di amici operanti aParigi, e di personaggi quali Paul Fort, Max Jacob, Apollinaire nonché illustrazioni diPicasso e di Archipenko18.
Le diverse posizioni, espresse in un articolo uscito su “Lacerba” nel 1915 dal titoloFuturismo e Marinettismo19, avrebbero portato alla rottura del sodalizio. I fiorentini ri-vendicavano per sé il termine “Futurismo” e rimproveravano al “Marinettismo” la pro-duzione di opere che, essendo prive di basi teoriche, tendevano ad essere puramentetecniche. Vedevano insomma nel gruppo milanese un’attenzione verso le novità formalia scapito della sostanza. Per Papini, il rifiuto cieco del passato da parte di Marinettiportava ad un avvenire che, privo di radici, si presentava come “fenomeno isolato”20.
Il secondo futurismo fiorentino: genesi, protagonisti e peculiarità 31
13 Massimo Carrà, Convergenze e difficoltà fra Milano e Firenze, in Futurismo a Firenze 1910-1920, Sansoni, cit., p. 14.
14 Giorgio Luti, L’avanguardia francese e il futurismo fiorentino, in “Revue des Ètudes Italiennes”,vol. 43, n. 3-4, luglio-dicembre 1997, p. 133.
15 Bruno Romani, Dal simbolismo al futurismo, cit., p. 243.16 Ibid.17 Sergio Zoppi, L’avanguardia europea e il futurismo a Firenze, in Futurismo a Firenze 1910-
1920, Bi & Gi, cit., p. 25.18 Ibid., pp. 26, 30-31. Ne parla anche Giorgio Luti, L’avanguardia francese e il futurismo fioren-
tino, cit., pp. 137-138.19 Giovanni Papini, Futurismo e Marinettismo, in “Lacerba”, a. III, n. 7, Firenze, 1915, ora in Lu-
ciano De Maria (a cura di), Marinetti e i futuristi, cit., pp. 285-288. 20 Ibid., p. 287.

E spiegava in questi termini i limiti del Marinettismo: “Invece di superare e oltre-passare la cultura coll’assorbirla e l’approfondirla, esso l’odia di quell’odio che ilcontadino ha per la macchina che non ha mai visto, o la nega. Mancandogli quellafinezza che sola s’acquista coll’intelligente esplorazione delle teorie e dell’arti pre-cedenti, esso cade assai spesso in trovate programmatiche superficiali che non ri-pagano l’effettiva vuotezza con l’apparente novità esterna”21. La differenza tra le duecorrenti veniva riassunta in tavole sinottiche, dove alla “supercultura”, “sensibilitànuova”, “raffinatezza, rarità” del “futurismo” si opponevano l’ “ignoranza”, il “tec-nicismo nuovo” e “la pubblicolatria” del “marinettismo”22.
Nel maggio del 1915, con l’entrata dell’Italia in guerra, si conclude l’esperienzadi “Lacerba”. Il futurismo era fondato sul binomio arte-azione, aveva incitato al-l’azione, e la guerra rappresentava quindi lo “sbocco naturale” del movimento23.
Il secondo futurismo fiorentino
Ad un anno dall’inizio del conflitto, nella consapevolezza che è giusto interes-sarsi nuovamente all’arte “così necessaria alla spiritualità di un grande popolo”24,ha inizio la vicenda editoriale de “L’Italia Futurista” (giugno 1916-febbraio 1918)25.Come spiega Emilio Settimelli nell’articolo di apertura, al principio della guerra gliartisti sentirono il bisogno di accantonare la loro produzione con l’intenzione di ri-prenderla a guerra conclusa, rivelando: “tutti non volemmo altro che pensieri-pro-iettili e sentimenti di guerra. Fu il primo impulso”26. Tuttavia, nel momento in cuiil conflitto si presenta molto più arduo del previsto27, artisti e scrittori ritengono op-portuno riprendere il lavoro interrotto. Nelle affermazioni di Settimelli, così comel’influenza dei grandi artisti francesi aveva contribuito molto più degli statisti pari-gini “a che l’Italia marciasse con la Francia”, l’espressione del genio artistico “cheplasma le anime” avrebbe svolto una funzione risolutrice in quanto “è semprel’anima che fa e vince le guerre”28.
La rivista nasce ad opera di un gruppo di giovani intellettuali ed artisti sopran-nominati da Raffaello Franchi la “pattuglia azzurra”, e sotto il patrocinio di Mari-netti. Per questi giovani “L’Italia Futurista” rappresenta il momento culminante diun’attività di gruppo formatosi attraverso precedenti esperienze editoriali. Di que-sto gruppo fanno parte Emilio Settimelli; i fratelli ravennati Bruno ed Arnaldo Gi-
32 Capitolo primo
21 Ibid.22 Ibid., pp. 287-288.23 Bruno Romani, Dal simbolismo al futurismo, cit., p. 244.24 Emilio Settimelli, L’Italia Futurista, in “L’Italia Futurista”, cit.25 Prima quindicinale, dagli inizi di marzo 1917 diventa settimanale fino al numero 26 del 12 ago-
sto, poi torna ad essere quindicinale fino al numero 34 del 2 dicembre. I numeri successivi sarannoquelli del 9 dicembre, del 31 dicembre, del 15 gennaio 1918, del 27 gennaio e dell’ 11 febbraio.
26 Emilio Settimelli, L’Italia Futurista, in “L’Italia Futurista”, cit.27 Spiega Settimelli: “La guerra dura da un anno ed ha un carattere assolutamente diverso dal pre-
veduto. Si concepì, come è naturale, una guerra d’impeto”. E parla di “difficoltà atroci del nostro tea-tro di guerra quasi completamente alpino”. Ibid.
28 Ibid.

nanni Corradini, dal pittore Balla ribattezzati Bruno Corra (da correre) e ArnaldoGinna (da ginnastica), in tema con lo spirito dinamico del movimento29; Mario Carlie Remo Chiti. All’epoca de “L’Italia Futurista” si aggiunge il prezioso contributo dialtre personalità tra cui Primo Conti, Irma Valeria, Maria Crisi Ginanni (moglie diArnaldo), Rosa Rosà.
Per comprendere appieno il contributo apportato da questi giovani al movimentofuturista ripercorreremo la formazione di alcuni dei suoi componenti, in particolarequella dei fratelli Ginanni Corradini, a cui ha dedicato numerosi studi Mario Ver-done. I fratelli hanno svolto un ruolo di primo piano nel gruppo e l’originalità delloro contributo si ritrova sia nelle riflessioni teoriche che nella vasta produzione ar-tistico-letteraria. Verdone li definisce “intelligentissimi, animati da vari interessid’indole culturale, che si inserivano nel mondo intellettuale con una preparazionenon provinciale, cosmopolita piuttosto, accresciuta dalle intese letterarie e dai viagginelle capitali europee”30. L’accuratezza di queste affermazioni è sancita dalle affer-mazioni dello stesso Ginna, che nelle pagine di taccuini dichiara: “Io e Bruno Corrapartiamo per Parigi e Londra per renderci conto delle arti moderne e delle nuove ten-denze”31. E in un’altra pagina afferma: “Leggevamo i giornali e le riviste italiane edestere, eravamo al corrente di tutte le critiche d’arte”32.
Nella corrispondenza a Settimelli, Corra scrive da Parigi e dalle lettere emergeche è molto occupato a seguire la vita culturale e artistica del luogo, va a spettacoli,mostre, incontra gente. In un’altra lettera, scritta al rientro da un viaggio con il fra-tello, riferisce a Settimelli di avere trascorso 10 giorni a Parigi, 25 a Londra e 7 aBeyreuth33. La loro esposizione all’ambiente internazionale viene ribadita a più ri-prese da Mario Verdone, il quale osserva che i fratelli Ginanni Corradini, pur vi-vendo in un centro di provincia, non erano isolati, in quanto “leggevano avidamenterifornendosi anche in librerie straniere. Seguivano il giornalismo letterario e gli scrit-tori di punta (“Poesia” di Marinetti, Lucini, le riviste fiorentine), trattati di filosofiae teosofia. Si incontravano con i giovani artisti che avevano analoghi interessi”34. Traquesti il musicista futurista Balilla Pratella, e i futuristi del gruppo toscano che in-contravano a Firenze35. Arnaldo, che aveva molteplici interessi tra cui la scrittura,la scultura, la cinematografia, a Firenze frequentò l’Accademia di Belle Arti e ini-ziò a farsi conoscere come pittore astrattista, partecipando alla mostra internazionale
Il secondo futurismo fiorentino: genesi, protagonisti e peculiarità 33
29 Da notare che nel tempo i fratelli firmano i propri lavori in modi diversi: Arnaldo Corradini, A.Ginanni Corradini, A. Ginna, Arnaldo Ginna. Lo stesso fa suo fratello, che firma di volta in volta BrunoCorradini, B. Ginanni Corradini, B. Corra, Bruno Corra. Per citare un esempio il manifesto Arte dell’av-venire del 1910, firmato A. e B. Ginanni Corradini, nell’edizione riveduta ed ampliata del 1911 Artedell’avvenire. Paradosso porta la firma Arnaldo e Bruno Corradini.
30 Mario Verdone, Cinema e letteratura del futurismo, cit., p. 331 Arnaldo Ginna, A proposito di “Arte dell’avvenire” (e altre pagine di taccuini 1913-1967), in
Mario Verdone (a cura di) Manifesti futuristi e scritti teorici, cit., p. 262. Ginna si riferisce agli “Anni1909 ecc.”.
32 Ibid., p. 265.33 S.l. e s.d. Fondazione Primo Conti onlus, Fiesole, Fondo Settimelli, Corrispondenza B. Corra-E.
Settimelli.34 Mario Verdone, Cinema e letteratura del futurismo, cit., p. 5. 35 Ibid.

tenutasi a Roma da Sprovieri nel 1914, in cui esponevano anche Archipenko e Kan-dinsky. Come nota Mario Verdone, di Ginna è “il primo quadro astratto che si co-nosca in Italia” (Nevrastenia, 1908)36.
Per quanto riguarda l’adesione dei fratelli al movimento futurista, Ginna rac-conta di avere avuto i primi contatti con Marinetti attraverso la rivista “Poesia” e loscrittore Paolo Buzzi37. Marinetti parlò a Umberto Boccioni, Carlo Carrà e LuigiRussolo delle idee sull’arte elaborate dai fratelli e così, pur non conoscendosi per-sonalmente, si avviò uno scambio con il gruppo milanese. In seguito alla pubblica-zione di Arte dell’avvenire (1910), co-scritto dai fratelli, e inviato al gruppomilanese, i Ginanni Corradini furono invitati a Milano. L’incontro avvenne nel 1912nella Casa Rossa di Marinetti in Corso Venezia, dove commentarono lo scritto teo-rico38. Dal racconto di questo incontro, contrassegnato da un’accesa discussione, siintuisce che i giovani andavano maturando una concezione dell’arte che precorrevai tempi e avrebbe posto il gruppo in una posizione originale e autonoma rispetto allalinea ufficiale.
Nello stesso anno (1912) i Ginanni Corradini si recarono a Firenze per prenderecontatto con Emilio Settimelli, Mario Carli, Remo Chiti e Virgilio Scattolini39. Essicostituivano un gruppo di scrittori-giornalisti che avevano già espresso le loro ideesulla rivista di Virgilio Scattolini “La Difesa dell’Arte” (novembre 1909-dicem-bre1910). La collaborazione avrebbe portato alla nascita dei periodici artistico-let-terari “Il Centauro”40 e “Rivista”41, attraverso cui la fisionomia del gruppo avrebbeassunto un’impronta sempre più autonoma. I redattori elaboreranno infatti originalicriteri di valutazione di un’opera d’arte.
L’affiatamento dei due fratelli e i legami di profonda amicizia con gli altri com-ponenti cementano una collaborazione estremamente produttiva e armoniosa, in cuientrano a far parte altre figure importanti, come il giovanissimo Primo Conti, “en-fant prodige” che inizia il suo apprendistato futurista a soli 13 anni, quando si av-vicina al movimento futurista in occasione della mostra organizzata a Firenze da“Lacerba” nel 1913. Conti stesso riferisce di avere suscitato interesse e curiosità aquella mostra, mentre si aggirava entusiasta per i quadri, vestito con un abitino divelluto nero, ornato di trine, e con le gambe nude. Tra il gruppo di persone che loseguiva, sbalordite e divertite al tempo stesso, vi erano Palazzeschi, Papini, Soffici,Marinetti, Carrà. Qualche giorno dopo i futuristi andarono a trovare Conti nel suostudio e si avviò una bella intesa42.
All’interesse di Conti per la pittura si aggiunge quello per la letteratura, e nel1917 egli si impone all’attenzione con la sua prima opera letteraria dal titolo Im-
34 Capitolo primo
36 Mario Verdone, Introduzione a Manifesti futuristi e scritti teorici, cit., p. 12. 37 Arnaldo Ginna, A proposito di “Arte dell’avvenire”, cit., p. 266. 38 Ibid., pp. 266-267.39 Ibid., p. 267.40 Pubblicato tra il novembre 1912 e il febbraio 1913 e diretto da Bruno Ginanni Corradini ed Emi-
lio Settimelli. 41 “Rivista, settimanale d’arte, di scienza e di vita” (aprile-agosto 1913), è diretta dagli stessi autori. 42 Contributo di Primo Conti in occasione della “Tavola rotonda” su Primo Conti e la Pattuglia az-
zurra, in “Antologia Vieusseux”, a. X n. 39-40, luglio-dicembre 1975, p. 29.

bottigliature, pubblicata nelle Edizioni de “L’Italia Futurista”. Come ricorda MarioVerdone, del periodico Conti fu collaboratore letterario, poi redattore e affiliato algruppo pittorico. Come redattore ebbe mansioni di segretariato e diffusione che lovidero consegnatario di articoli e clichés e correttore di bozze. Ma si occupava anchedel fascettario, di attaccare gli indirizzi sulle copie e della spedizione43. Ciò indicacome l’attività del giornale si basasse su una piena e totale collaborazione di chi eracoinvolto nell’iniziativa.
Le informazioni emerse dalla valutazione dell’attività complessiva di questi gio-vani portano a fare delle considerazioni su alcune caratteristiche di questo nucleo.Nel presentare il volume Montagne trasparenti di Maria Ginanni, Emilio Settimellidefinisce il nucleo di cui fa parte “nostro gruppo di lirici esploratori”44. Già alcunianni prima la redazione di “Rivista” nell’articolo di apertura aveva affermato:“Siamo in gruppo [...] tutti convinti di una verità nuova”, precisando tuttavia di noncostituire “né un cenacolo né una scuola”45. Il carattere di collegialità già indivi-duato in riferimento al futurismo in generale, trova qui la sua massima espressionee si riflette nel modo in cui i protagonisti agiscono in collettivo. Mario Verdone parladi “straordinaria compattezza, anche nell’atto espressivo”. Ciò porta lo studioso asuggerire che si tratti di un “collettivo poetico”. L’ipotesi è sostenuta dal fatto che“credono nelle stesse cose; agiscono spesso in gruppo, firmando insieme giornali,manifesti, atti sintetici. Si scambiano il posto, senza che i risultati siano alterati”46.
In effetti, già guardando alla direzione de “L’Italia Futurista”, emerge quanto af-fermato da Verdone. La rivista, al principio diretta da Corra e Settimelli, passerà adessere diretta l’anno successivo da Ginna e Settimelli47, per poi tornare alla dire-zione di Corra e Settimelli48. Se si passa poi ad esaminare l’intero percorso delgruppo, si è colpiti dalla costanza collaborativa dei suoi componenti che passanoda “La Difesa dell’Arte” a “Il Centauro”, quindi a “Rivista” e successivamente a“L’Italia Futurista” mostrando una straordinaria compattezza e intenti comuni, sep-pure con punte individuali.
Per quel che riguarda le produzioni individuali, i protagonisti del movimento sidedicano l’un l’altro poemetti e capitoli e scrivono prefazioni e recensioni ai lavoridegli altri componenti. Pur nella probabilità che, per certi versi, questa pratica rien-trasse in un disegno pubblicitario, è innegabile che lo spirito coesivo del gruppo,rintracciabile anche nella poetica, portava l’uno a rivolgersi all’altro nella ripresa dicerti topoi già esplorati dai compagni di “pattuglia”. In questo modo veniva rico-nosciuto quanto fatto dagli altri e tracciata la mappa di un percorso coeso. Sulle pa-gine del giornale le recensioni trovano ampio spazio, con commenti entusiasti sulvalore della ricca produzione maschile e femminile, come avviene in occasione dellapubblicazione del volume Montagne trasparenti della poetessa Maria Ginanni.
Il secondo futurismo fiorentino: genesi, protagonisti e peculiarità 35
43 Mario Verdone, Diario parafuturista, cit., p. 96.44 Emilio Settimelli, Presentazione di “Montagne trasparenti”, Firenze, edizioni de “L’Italia Fu-
turista”, 1917, p. 10.45 La redazione, Il nostro programma, in “Rivista”, a. I n. 1, Firenze, 6 aprile 1913, p. 2.46 Mario Verdone, Prosa e critica futurista, cit., p. 21.47 A. II, n. 1, 10 febbraio 1917.48 A. II, n. 29, 23 settembre 1917.

Il riferimento alla produzione femminile porta a fare delle considerazioni sul-l’importante contributo apportato dalle futuriste. Come sottolinea Claudia Salaris,questa presenza rappresenta un’importante novità in quanto, per la prima volta nellastoria del futurismo, si raccoglie attorno al collettivo poetico del giornale un signi-ficativo gruppo di donne49. Riportando l’ipotesi della futurista Rosa Rosà, la Sala-ris spiega che ciò è dovuto alla situazione prodotta dal paese in guerra, che “haspinto le donne fuori di casa a cercare un lavoro, creando così le condizioni per unaradicale trasformazione della tradizionale situazione di soggezione economico-psi-cologica delle donne”50. Questa evoluzione viene riconosciuta anche da Marinettiche, a guerra finita, parlerà di “rovesciamento completo della famiglia” dove “lamoglie ha raddoppiato il suo valore umano e sociale”51.
La questione femminile viene trattata a lungo sulle colonne della rivista, chepubblica numerosi interventi in una rubrica dal titolo Donna-amore-bellezza dove,alle figure femminili esaltate nella letteratura del tempo, si oppone il modello didonna futurista, forte ed emancipata. Parlando della collaborazione femminile alla ri-vista, Settimelli (co-direttore de “L’Italia Futurista”) rende merito a questo gruppo di“scrittrici moderne, sensibili e antitradizionali”. Elencandole accanto al gruppo ma-schile, dice di loro “gareggiano con noi in genio e ardore di rinnovamento”52.
La partecipazione femminile vede effettivamente nomi di spicco, quali MariaCrisi Ginanni, al cui prestigio è in parte ascrivibile la cospicua adesione femminilea “L’Italia Futurista”53. La poetessa napoletana ha svolto un ruolo di primo piano nelgiornale, collaborando attivamente alla sua pubblicazione e promuovendo l’attivitàeditoriale dello stesso con la collana “Libri di valore”, da lei diretta (1917-1918)54.Il suo apporto al giornale è significativo, soprattutto attraverso la pubblicazione deisingolari frammenti poetici che saranno poi riuniti nel volume Montagne trasparenti.
Tra le futuriste si distingue la pittrice viennese Edith von Haynau, in arte RosaRosà55. Come ricorda Mario Verdone, l’opera grafica della Rosà presenta elementi dinotevole interesse soprattutto per affinità e parentele con l’attività pittorica di Alfred
36 Capitolo primo
49 Claudia Salaris, Storia del futurismo, cit., p. 98.50 Claudia Salaris, Le futuriste: donne e letteratura d’avanguardia d’Italia (1909-1944), cit., p. 59.51 Si vedano le riflessioni di F.T. Marinetti, Contro il matrimonio in Democrazia futurista, 1919.
Questa citazione in F.T. Marinetti, Teoria e invenzione futurista, cit., p. 371.52 Emilio Settimelli, Primo bilancio di “Montagne trasparenti” di Maria Ginanni, in “L’Italia Fu-
turista”, a. II, n. 19, Firenze, 24 giugno 1917, p. 1. Settimelli menziona Maria Ginanni, Rosa Rosà, EnifRobert, Fulvia Giuliani, Irma Valeria, Enrica Piubellini.
53 Di questo circolo fanno parte Rosa Rosà, Irma Valeria, Fulvia Giuliani, Fanny Dini, Marj Car-bonaro, Emma Marpillero, Enrica Piubellini, Enif Robert ed Eva Kühn Amendola (che adotta lo pseu-donimo “Magamal”).
54 Come si legge in ogni volume della collana “essa raccoglie le più significative espressioni dellamoderna letteratura italiana nel campo delle ricerche lirico-fantastiche. Essa costituisce quindi la puntapiù avanzata della nuova letteratura italiana”. Questa citazione da Stelio M. Martini, Le “novità” de“L’Italia futurista”, in Luciano Caruso (a cura di), Il “fronte interno” de “L’Italia Futurista”, cit., p. 56.
55 Discendente dal generale von Haynau, che era braccio destro del generale Radetsky, dovette sce-gliere uno pseudonimo per non essere associata alla famiglia che era contraria alla sua carriera artisticae si ispirò ad una cittadina del Veneto (aveva sposato un italiano). Dal momento che le piacevano i doppinomi scelse di essere Rosa Rosà. Lo racconta Mario Verdone in Diario parafuturista, cit., p. 55.

Kubin e Gustav Klimt56. È conosciuta soprattutto, insieme a Ginna, come fine illu-stratice di molti dei testi futuristi57, ma interviene anche con articoli sulla donna fu-turista e si dedica alla scrittura con la novella Romanticismo sonnambulo. Comeosserva ancora Verdone, nella sua produzione “sembrano rispecchiarsi e travasarsi,in ugual quantità di dare e avere”, la sensibilità della Ginanni, di Chiti, di Carli, diGinna58.
La compattezza del gruppo si ritrova quindi anche nell’atto espressivo, non nelsenso di un’uniformità che ingloba l’originalità delle espressioni individuali, bensìnel modo in cui i concetti si travasano da uno/a all’altro/a e vengono sviluppati daisingoli seguendo però un percorso comune. Si pensi altresì a Irma Valeria, che dàvoce al profondo interesse del gruppo per l’esoterico e l’occulto con l’importante do-cumento Occultismo e arte nuova59, nel quale riprende e sviluppa il concetto rim-baldiano del poeta veggente. Per la Valeria, la scoperta dell’universo nascostocoincide con l’appropriazione, da parte dell’anima, di “facoltà superiori di scopertee di sensazioni”60. Questa stessa sensibilità anima le sue prose liriche, poi raccoltenel volume Morbidezze in agguato per le Edizioni de “L’Italia Futurista” (1917).Questo continuo scambio a cui la donna partecipa in uguale misura con interventidi rilievo rappresenta una delle peculiarità più interessanti del secondo futurismofiorentino.
Il secondo futurismo fiorentino: derivazioni e distinguo
Per comprendere la posizione occupata dal secondo futurismo fiorentino nel-l’ambito del movimento futurista, occorre esaminare come esso si rapporta al primofuturismo fiorentino, dove con ciò si intende il futurismo lacerbiano, e al futurismomilanese. Andremo quindi ad esaminare alcune considerazioni espresse dal grupponon solo sulle pagine de “L’Italia Futurista” ma anche nel corso delle pubblicazioniprecedenti. Ciò consentirà di tracciare un quadro complessivo della posizione delgruppo lungo un ampio arco di tempo e quindi di cogliere l’importanza di questocontributo. Partiremo pertanto da alcune dichiarazioni espresse ne “L’Italia Futuri-sta” e le confronteremo con altre considerazioni enunciate nelle riviste anteriori.
Nell’articolo di apertura redatto da Emilio Settimelli “L’Italia Futurista”, quintoperiodico in sette anni, viene descritto come “il più forte, il più vasto, il più gio-vane, il più solido”61. Settimelli tiene a precisare che, per quanto sia edito a Firenzee diretto da poeti futuristi fiorentini62, il giornale non deve essere visto come conti-
Il secondo futurismo fiorentino: genesi, protagonisti e peculiarità 37
56 Ibid., pp. 54-55.57 Si ricordano l’edizione del 1917 di Sam Dunn è morto di Bruno Corra, Madrigali e grotteschi,
dello stesso Corra, Le locomotive con le calze di Arnaldo Ginna, Notti filtrate di Mario Carli. 58 Mario Verdone, Diario parafuturista, cit., p. 57. 59 Irma Valeria, Occultismo e arte nuova, cit.60 Ibid.61 Emilio Settimelli, L’Italia Futurista, in “L’Italia Futurista”, cit.62 Fiorentini di nascita o di adozione, visto che tra i direttori figurano anche Bruno e Arnaldo Gi-
nanni Corradini, ravennati. Come osserva Fabrizio Bagatti, con “L’Italia futurista” si crea “un nucleo

nuatore di “Lacerba”. I protagonisti di questa vicenda editoriale vengono infatti de-signati come “i primi veri futuristi fiorentini”63. E per chiarire spiega:
“Lacerba”, poco interessante e poco diffusa prima della conversione dei suoi fondatorial futurismo, acquistò grande valore e popolarità quando uomini come Marinetti, Boc-cioni, Russolo, Balla, Pratella, Buzzi, Cangiullo ecc. le regalarono le loro stupende ener-gie. Ma poi, essendosi ritirati questi vivificatori “Lacerba” benchè lanciata da Vallecchiuno dei più avanzati nostri editori, riprese la sua meschina vita fino alla morte che fumorte di tisi. L’iniezione futurista nel suo corpo fradicio di passatismo dette ottimi ri-sultati per un certo tempo, poi il morbo congenito finì col trionfare64.
Presa di distanza dai lacerbiani dunque, considerati futuristi solo nell’ambito delloro sodalizio con il filone milanese. Ciò si deduce dalle affermazioni di Settimelliche precisa, in riferimento a “Lacerba”: “Per tutto ciò questo giornale non è maistato integralmente futurista. Fu un soggetto su cui i futuristi tentarono uno stupe-facente esperimento”65.
D’altra parte, un abbraccio viene rivolto “al carissimo fratello F.T. Marinetti, ilgeniale poeta, il suscitatore meraviglioso, l’uomo nuovo pronto a tutte le audacie,che tanto ci ha aiutato nell’incanalare le nostre cospicue energie disordinate”66. E ineffetti la partecipazione di Marinetti è costante per l’intera durata della pubblicazionedella rivista. Questo tributo sorprende non poco, in quanto dall’analisi di alcune af-fermazioni in riviste precedenti emerge che il gruppo aveva preso distanza dal fu-turismo marinettiano. Tuttavia, da altre dichiarazioni enunciate nelle stesse riviste,affiorano degli elementi che portano a comprendere le ragioni del sodalizio sancitosulle pagine de “L’Italia Futurista”. Andremo dunque ad esaminare gli stralci in que-stione per capire come si posizioni il gruppo rispetto a quanto elaborato in prece-denza dal futurismo marinettiano.
Un distinguo rispetto al futurismo ortodosso risale alle pagine de “Il Centauro”,dove Marinetti viene apostrofato da Settimelli in questi termini:
Noi saremmo gli imitatori di un imitatore? È possibile una cosa simile? In tal caso pre-feriamo risalire all’origine e invece di essere chiamati discepoli del poeta milanese, vo-gliamo essere considerati seguaci di Baudelaire, Poe, grandi maestri. Ma neppure questoè giusto. Facciamo da noi. Non ci siamo imposti di continuare la scuola simboliste in Ita-lia. [...] Dunque niente Marinetti. Egli non è nella forma (e qui sopra tutto vi soffermate)che un discepolo dei simbolistes. E niente Marinetti perché mentre egli esclude dall’artela delicatezza, il sogno, il romanticismo, l’oziosità, noi non escludiamo che il vuoto, ilgià fatto, il non geniale67.
38 Capitolo primo
fiorentino futurista, intorno ad un rappresentativo organo culturale che, pur collaborando fianco a fiancocol gruppo milanese non rinunciasse alla propria indipendenza e sovranità locali”. Fabrizio Bagatti,Rapporti tra futurismo marinettiano e futurismo fiorentino, in Futurismo a Firenze 1910-1920, Sansoni,cit., p. 38.
63 Emilio Settimelli, L’Italia Futurista, in “L’Italia Futurista”, cit.64 Ibid.65 Ibid.66 Ibid.67 Emilio Settimelli, A proposito di futurismo, in “Il Centauro”, cit.

La denuncia viene reiterata tre mesi dopo nel primo articolo di “Rivista”, dovei futuristi vengono denominati “pseudo-innovatori”68. Eppure, la posizione che ilgruppo assume verso il passato è più articolata di quanto non emerga dalla citata af-fermazione. In polemica con lo stile chiassoso e plateale adottato da Marinetti ecompagni per attirare l’attenzione sul movimento, i redattori spiegano: “In questomomento nel campo artistico italiano si urla: noi non vogliamo urlare. Piuttosto cheurlare preferiamo non essere ascoltati. Ci svolgiamo febbrilmente tentando di co-struire cose nuove, spingendoci in campi di solitudine, inchinandoci però devota-mente dinanzi a tutto ciò che il Passato ha di grande”69.
L’accento sulla novità, non a scapito del passato, ma affondando in esso le radici,è posto in un altro stralcio dello stesso articolo dove si afferma: “Le nostre convin-zioni ci impongono il massimo rispetto al passato. Esso contiene molte grandezze.D’altra parte noi come tutti inevitabilmente abbiamo le radici nel passato e nonsiamo se non continuatori. Valiamo per quello che c’è di profondo e quindi di nuovoin noi, ma non per questo gettiamo via il vecchio ch’è la base di ogni novità”70. Siritrovano qui le caratteristiche individuate nel filone fiorentino prima esaminato,dove si delinea una concezione evolutiva del divenire che va a conciliare tradizioneed avanguardia.
Le ragioni della posizione critica vengono chiarite nel momento in cui, pren-dendo distanza dai futuristi “pseudo-innovatori”, la redazione spiega che essi “ri-posano ogni loro energia sulla divina intuizione che non si sono ancora liberati dallametafisica quale scienza, e che sono al nostro confronto dei retrogradi ostinandosiin una limitata reazione e costruendo un’arte di maniera”71. In un altro articolo delnumero successivo di “Rivista” Bruno Corra riprende a parlare dell’assenza di no-vità del futurismo marinettiano. Secondo Corra, ponendo l’enfasi sull’arte istintiva,Marinetti rispolvera una vecchia concezione e fa uso di frasi fatte72.
Indipendentemente dalla denuncia di plagio, pratica diffusa nell’ambito del fu-turismo, volta a valorizzare l’originalità delle proprie posizioni73, negli articoli so-pramenzionati vengono trattati punti importanti, chiarendo i quali si fa lucesull’originalità rivendicata dai giovani della “pattuglia azzurra”. Lo stesso limite in-dividuato nel futurismo marinettiano viene attribuito alla poetica simbolista, e dun-que la valutazione di quest’ultima serve a chiarire le problematiche legate allaconcezione del futurismo ortodosso.
Il secondo futurismo fiorentino: genesi, protagonisti e peculiarità 39
68 La redazione, Il nostro programma, in “Rivista”, cit., p. 2.69 Ibid.70 Ibid.71 Firmato “La redazione”, Il nostro programma, in “Rivista”, cit., p. 2.72 Bruno G. Corradini, Il Futurismo spiegato e discusso (Il passatismo del Futurismo) in “Rivista”,
a. I, n. 2, Firenze, 13 aprile 1913, p. 2. 73 A questo proposito sono interessanti due lettere di Corra a Settimelli in cui il primo tiene a riba-
dire l’autonomia delle loro posizioni, commentando i loro sforzi per sottrarsi alla denominazione di fu-turisti. Al punto che, in una delle lettere, Corra esclude “Liberismo” come possibile titolo per una lorotestata, spiegando che il pubblico assocerebbe Liberismo a Futurismo a motivo degli “ismi”. Entrambes.l. e s.d., Fondazione Primo Conti onlus, Fiesole, Fondo Settimelli, Corrispondenza B. Corra-E. Setti-melli.

Come spiega Settimelli, pur essendo stati innovatori e avendo ottenuto l’amplia-mento del campo estetico e della forma estetica, i simbolisti non sono stati dei ragio-natori. Sono arrivati al rinnovamento in modo casuale, affidandosi al soggettivismo,ad un modo di sentire anziché di ragionare. Non sono stati degli “innovatori coscienti”ma “singoli temperamenti nervosi che hanno casualmente imbroccata la via del pro-gresso [...]”74. Inoltre, pur innovando in maniera significativa, “non hanno saputo sot-trarsi all’istinto e talvolta al bisogno di limitare”75. Secondo quanto affermato daSettimelli, dai simbolisti è nato il futurismo, “che ci porta di nuovo ad un campo cir-coscritto governato da rigide esclusioni”76. Per la “pattuglia azzurra”, il limite del fu-turismo ortodosso consiste insomma nell’avere ricalcato le orme di un’arte soggettiva,legata al sentimento, anziché logica e oggettiva. A questa il gruppo contrappone laconcezione di un’arte cerebrale, libera da ogni vincolo estetico77.
In un altro articolo Corra afferma che il futurismo “non è altro che un’esplosioneclamorosa e plateale di idee vaghe, confuse, vecchie in gran parte, anormali e ascien-tifiche”, con la conseguenza che esso avrebbe in seguito generato “uno stato d’animoeminentemente favorevole allo svolgersi del movimento di pensiero chiarissimo, nor-malissimo e scientifico iniziato da noi”78. L’enfasi va quindi posta sul carattere scien-tifico-cerebrale dell’arte, grazie al quale il secondo futurismo fiorentino intende porsiin posizione originale rispetto al passato. A questo proposito si noti che Corra, in unalettera a Settimelli, dicendo di avere preparato del materiale per il manifesto La scienzafuturista commenta: “Così accentueremo di più la nostra posizione speciale di ragio-natori del futurismo”79. Dal tono della lettera emerge il proposito di ribadire il carat-tere distintivo di questo nucleo.
Sulla novità di questa concezione insiste Settimelli precisando che, nel porre l’en-fasi sul possessivo “nostro” in relazione a “armi nostre”, “forze nostre”, non intendefare “questione di nazionalismo, ma di originalità”80. E a questo punto conclude: “[…]in oggi l’unica strada artistica davvero indipendente, originale, rigorosamente logica[...] è quella tracciata e parzialmente seguita da noi”81. Va aggiunto che la mancanzadi originalità non era stata attribuita solo alla corrente milanese in generale, ma allaproduzione dello stesso Marinetti. In Commenti al capolavoro di F.T. Marinetti, BrunoCorra dichiara: “Sono assolutamente convinto della vostra inettitudine a creareun’opera veramente significativa e geniale”82.
40 Capitolo primo
74 Emilio Settimelli, Superare D’Annunzio e Croce, in “Rivista”, a. I, n. 16-17, Firenze, 27 luglio1913, p. 1.
75 Ibid.76 Ibid.77 Ibid.78 Bruno G. Corradini, Il Futurismo spiegato e discusso (La lussuria futurista; e anche: tutti ci vo-
gliono bene), in “Rivista”, a. I, n. 2, Firenze, 13 aprile 1913, p. 1.79 Datata Ravenna, 19 febbraio. Fondazione Primo Conti onlus, Fiesole, Fondo Settimelli, Corri-
spondenza B. Corra-E. Settimelli. 80 Emilio Settimelli, Superare D’Annunzio e Croce, in “Rivista”, cit., p. 1.81 Ibid. Settimelli precisa tra parentesi: “[…] finché qualcuno non ci verrà a dimostrare che ab-
biamo torto, è logico dichiarare ‘logico’ tutto ciò che abbiamo detto”. 82 Bruno G. Corradini, Commenti al capolavoro di F.T. Marinetti, in “Rivista”, a. I, n. 7, Firenze,
18 maggio 1913, p. 2. Questo intervento va collocato nell’ambito della discussione sulla critica valuta-tiva elaborata dal secondo futurismo fiorentino, che verrà discussa più avanti.

Viene allora da chiedersi su quali elementi si sia basata una collaborazione che,partendo da comuni interessi teatrali83, diverrà sempre più intensa per culminare nelsodalizio de “L’Italia Futurista”, che vede Marinetti in posizione di rilievo con i suoifrequenti interventi. Come spiegare le scelte del gruppo che, a partire dal 1914, sidefinisce futurista84, dopo avere assunto una posizione critica verso il futurismo ma-rinettiano? Per Arrigo Lora-Totino, che pure individua alcune ragioni, “il voltafaccianon si spiega, come non si spiega quello precedente ed analogo di Lacerba: l’intel-lettuale, soprattutto d’avanguardia, è l’animale più imprevedibile che si conosca edè vano cercare di razionalizzare sino in fondo un comportamento che procede il piùdelle volte in base a intuizioni e sensazioni del momento”85. Tuttavia, nonostante lavalidità di questa osservazione, da un attento esame di articoli e corrispondenza ine-dita, è possibile individuare diverse ragioni importanti alla base dell’intesa.
In primo luogo, si osservi che già in “Rivista”, dalla cui tribuna erano stati lan-ciati gli attacchi al futurismo marinettiano, Settimelli aveva riconosciuto a Marinettiil merito di essere stato “l’unico a tentare un progresso”, compiendo un movimento“parallelo” a quello del gruppo di cui Settimelli faceva parte e a spiegare che “la sen-sibilità è mutata e che quindi occorre una nuova arte”86. Tale atteggiamento è coerentealla linea tracciata nell’articolo di apertura della rivista, dove i redattori si propone-vano di prendere in esame quanto fatto dal futurismo milanese e apprezzare “ciò cheè di valore nelle loro cose”87. Dunque, seppure la poetica da esso elaborata non avevacarattere di novità, a Marinetti andava riconosciuta l’iniziativa di avere dato vita adun movimento che aveva operato un profondo cambiamento nella società e si pro-iettava con impeto verso l’avvenire.
L’urgenza di rinnovamento e la necessità di porre l’Italia al passo con le nazionistraniere più avanzate erano già state auspicate in un articolo apparso su “Il Cen-tauro”. In quell’occasione, Emilio Settimelli spiegava le ragioni dello scalpore su-scitato dal futurismo in questi termini: “In Italia non si conoscono i poeti formidabiliche allargarono il campo della letteratura coi loro voli demoniaci. Parlare di Baude-laire, di Poe, di Rimbaud, è come parlare di un mistero lontano, lontano, oltre lealpi”88. In un altro intervento sullo stesso periodico Settimelli metteva a confronto larealtà italiana rispetto alle innovazioni avvenute in Francia osservando che, mentrein quella nazione si assiste a “novità di mezzi, di espressione, di ritmo”, in Italia “fapena osservare come la nostra letteratura abbia risentito l’influsso del classicismo,schiacciante, opprimente”89. Il giovane futurista fiorentino incitava al rinnovamento
Il secondo futurismo fiorentino: genesi, protagonisti e peculiarità 41
83 È di F.T. Marinetti, Emilio Settimelli e Bruno Corra il Manifesto del teatro futurista sintetico, del1915, ora in Mario Verdone (a cura di), Manifesti futuristi e scritti teorici, cit., pp. 175-181.
84 Nel 1914 Bruno Corradini ed Emilio Settimelli definiscono “futurista” il manifesto Pesi misuree prezzi del genio artistico, cit.
85 Arrigo Lora-Totino, Lo sperimentalismo de “L’Italia Futurista”, in Luciano Caruso (a cura di),Il “fronte interno” de “L’Italia Futurista”, cit., p. 45.
86 Emilio Settimelli, Superare D’Annunzio e Croce, in “Rivista”, cit., p. 2. 87 La redazione, Il nostro programma, in “Rivista”, cit., p. 2.88 Emilio Settimelli, A proposito di futurismo, in “Il Centauro”, cit.89 Emilio Settimelli, Superare d’Annunzio e Croce, in “Il Centauro” a. II, n. 4, Firenze, 2 febbraio
1913, p. 1.

dicendo: “Sentiamo un po’ anche noi la libertà che in Francia si è tinta di colori ac-cecanti e peregrini, sentiamo anche noi questa fiumana di nuove concezioni, dinuove teorie!”90.
L’intesa parte quindi da una causa comune e si svolge all’insegna di un princi-pio di rinnovamento e progresso a livello globale, già avanzato dal futurismo orto-dosso. A testimonianza di ciò va l’ampio spazio che “L’Italia Futurista” dedica acampi quali letteratura, poesia, arte, musica, pittura, cinema, teatro, politica, scienza,architettura. Per Stelio M. Martini la rivista “occupa il periodo più intenso e fecondodel futurismo”91. Lo studioso parla di “anni di realizzazione ed elaborazione”, se siconsidera la ricchezza di contributi che vedono scritti creativi affiancare interventiteorici e manifesti su svariati ambiti artistici ed extra-artistici, in linea con il princi-pio di poliespressività caratterizzante il movimento92.
Come inoltre suggerisce Maria Carla Papini, un comun denominatore è rappre-sentato dalla posizione interventista93. E in effetti sulle pagine del giornale l’argo-mento politico è sempre presente, con molti articoli dedicati agli eventi bellici. Siconsideri tuttavia quanto afferma la studiosa sulla guerra da intendere “come sproneall’attività, come lotta al passatismo, come mezzo di rinnovamento vitale ed ener-gico del popolo e della nazione tutta”94. La Papini individua un altro nesso nella“rottura con D’Annunzio e Croce”95, teoria condivisa da Arrigo Lora-Totino, il qualeindica nella polemica anticrociana, oltreché nell’interventismo politico, un’altra ra-gione dell’incontro avvenuto sul fronte de “L’Italia Futurista”96. Si noti che già sullepagine de “Il Centauro”, con l’articolo di Settimelli Superare d’Annunzio e Croce,veniva difesa la necessità di non limitare l’ingegno a nessun campo estetico97.
Oltre a questi elementi evidenti e rintracciabili sulle pagine del giornale, esi-stono motivazioni meno trasparenti ma non meno significative. Un elemento deter-minante si delinea nello stesso articolo in cui Corra imputa a Marinetti la mancanzadi originalità della sua opera. Dopo avergli dato dell’inetto a produrre un’opera “ve-ramente significativa e geniale” afferma: “Con questo, io vi stimo”98. Osserva quindiche, nonostante la carenza di idee espresse nei suoi manifesti, idee tra l’altro “nénuove né chiare”, egli possiede delle caratteristiche non meno importanti. E si ri-volge a Marinetti dicendo: “Non ci sono idee. Ma c’è qualcos’altro. Sì. Che cosa?La vostra energia, la vostra risolutezza, la vostra fede, il vostro modo di camminare,di parlare, di ridere, di gestire, di agire...” 99.
42 Capitolo primo
90 Ibid.91 Stelio M. Martini, Le “novità” de “L’Italia futurista”, cit., p. 54.92 Ibid.93 Maria Carla Papini (a cura di), L’Italia Futurista (1916-1918), cit., p. 47.94 Ibid., p. 48.95 Ibid., p. 44. 96 Arrigo Lora-Totino, Lo sperimentalismo de “L’Italia Futurista”, cit., p. 45.97 Emilio Settimelli, Superare D’Annunzio e Croce, in “Rivista”, cit., p. 1. 98 Bruno G. Corradini, Commenti al capolavoro di F.T. Marinetti, in “Rivista”, cit.99 Ibid. Applicando la teoria di valutazione di un’opera d’arte, per cui il suo valore è direttamente
proporzionale alla quantità di energia impiegata a produrla, Corra si chiede se la somma di energia im-piegata per compiere le azioni che caratterizzano la vita e la personalità del fondatore del futurismo siasuperiore a quella fornita da un uomo comune.

Nonostante il tono ironico dell’articolo, che egli però smentisce affermando diparlare “con la più assoluta serietà”, si capisce che questa “energia”, la “risolutezza”e la “fede” sono attributi realmente riconosciuti a Marinetti. Si noti che, parlandodell’impatto che ebbe nella sua vita l’incontro con il fondatore del futurismo, PrimoConti afferma: “Sentivo di non essere più il ragazzo impacciato di una volta: Mari-netti aveva liberato in me una forza inedita, un coraggio capace di farsi beffa di ognimia timidezza: era come se avesse sfondato ogni porta davanti a me e mi avessesparato un riflettore addosso”100. Questo era Marinetti, soprannominato del resto“caffeina d’Europa”: uomo di grande energia ed entusiasmo, ispiratore e mecenate.La personalità di Marinetti, unita alle sue qualità di leadership, devono aver giocatoun ruolo non indifferente nella collaborazione. Luciano De Maria osserva che, puressendo “macerati di cultura” e avendo quindi “un atteggiamento di autosufficienzada un certo punto di vista culturale”, i giovani de “L’Italia Futurista” riconoscevanoin Marinetti “un maestro” e nutrivano nei suoi confronti “devozione”101.
La capacità manageriale di Marinetti, potenziata dalle risorse a sua disposizione,riveste senza dubbio una certa importanza nell’esame delle ragioni che hanno por-tato i giovani della “pattuglia azzurra”, provvisti di entusiasmo ma non di pari mezzi,ad affidarsi al patrocinio marinettiano. La teoria qui esposta è ulteriormente avallatadalle affermazioni di Settimelli nel primo articolo de “L’Italia Futurista”, già citato.Riprendendo lo stralcio, Settimelli si rivolge a Marinetti definendolo “genialepoeta”, “suscitatore meraviglioso”, “l’uomo nuovo pronto a tutte le audacie chetanto ci ha aiutati nell’incanalare le nostre cospicue energie disordinate”102. Dal mo-mento che, stando alle precedenti affermazioni di Corra, co-direttore de “L’ItaliaFuturista”, Marinetti non si distingueva per la genialità della sua produzione lette-raria, si capisce che le ragioni del sodalizio non sono da ricondurre a Marinetti “ge-niale poeta”. Ben più credibile è invece il tributo all’uomo in grado di “incanalare”le “cospicue energie disordinate” del gruppo.
Si pensi ai vantaggi di operare sotto l’egida di una figura carismatica come quelladi Marinetti, e con i mezzi a sua disposizione. Qualunque attività a cui egli prendesseparte aveva garanzia di enorme diffusione, grazie alle sue doti di organizzatore e diimpresario. Parlando de “L’Italia Futurista”, Mario Verdone nota che “nei momentidi maggiore fortuna del periodico, e di minori limitazioni nel paese in guerra, se nepotevano stampare almeno 2000-2500 copie. Se poi Marinetti ne ordinava 2000copie tutte per sé, la tiratura poteva anche essere raddoppiata”103. Marinetti aveva ca-risma, popolarità e mezzi per operare su larga scala e questo fattore deve aver gio-cato il suo ruolo. A sostegno di questa teoria si consideri la corrispondenza ineditadi Corra a Settimelli. In una lettera non datata Corra suggerisce di invitare Mari-netti a Ravenna per tenere una conferenza futurista sulla guerra di Tripoli, proget-
Il secondo futurismo fiorentino: genesi, protagonisti e peculiarità 43
100 Primo Conti, La gola del merlo (memorie provocate da Gabriel Cacho Millet), Firenze, Sansoni,1983, p. 124.
101 Luciano De Maria, nel dibattito seguito all’intervento di Sergio Zoppi, L’avanguardia europeae il futurismo a Firenze, in Futurismo a Firenze, 1910-1920, Bi & Gi, cit., p. 39.
102 Emilio Settimelli, L’Italia Futurista, in “L’Italia Futurista”, cit.103 Mario Verdone, Diario parafuturista, cit., pp. 96-97.

tando di usare parte del “buon” incasso per i loro progetti104.Del resto, come nota Massimo Carrà, anche nell’avvicinamento di “Lacerba” al
futurismo le differenze passarono inizialmente in secondo piano di fronte al van-taggio rappresentato “da una solida struttura organizzativa che garantiva ampia dif-fusione delle idee”105. Nella storia del futurismo era pratica frequente uniretemporaneamente le forze per trarre reciproco vantaggio dal sodalizio e garantire lacircolazione delle idee, trascurando le divergenze ideologiche. Si pensi a Gian Pie-tro Lucini che, pur avendo preso le distanze da Marinetti in seguito alla pubblica-zione del Manifesto tecnico della letteratura futurista106, gli chiese di stampareNuove revolverate, sapendo che l’organizzazione futurista ne avrebbe garantito unlancio in grande stile, come era già avvenuto per la pubblicazione di Revolverate107.Elemento quindi non marginale nell’analisi delle ragioni che avrebbero portato al so-dalizio.
I moventi fin qui esaminati rappresentano gli elementi alla base del connubiocon Marinetti, ma non spiegano il significato e il valore di questo connubio. Causecomuni, ragioni pragmatiche costituiscono il punto di partenza di un’operazione digrande interesse compiuta dalla “pattuglia azzurra”, per comprendere la quale oc-corre partire da “L’Italia Futurista”.
Come già rilevato, in apertura il gruppo prende ufficialmente le distanze da “La-cerba” per tornare apparentemente nell’alveo marinettiano, tutto compreso entro unnazionalismo teso a rivendicare con decisione l’autonomia del movimento futuristada ogni corrente straniera e “il primato culturale e artistico italiano”108. Con SergioZoppi possiamo affermare che, come in passato il futurismo milanese aveva riven-dicato con forza il “diritto di primogenitura” rispetto a quanto fatto oltralpe, pari-menti il gruppo de “L’Italia Futurista” reclama la novità del proprio prodottoartistico-letterario109. Si noti come, in risposta ai commenti poco benevoli ricevutida Guillaume Apollinaire sul manifesto La scienza futurista, Corra dichiari: “Noisiamo ammiratori entusiasti della miracolosa potenza artistica dell’ultimo secolofrancese, consideriamo col più alto interesse ciò che i nostri vicini hanno ricercatoe conquistato nei loro più recenti sforzi avanguardisti e attendiamo da loro con fi-ducia nuove rivelazioni. Con tutto questo, affermiamo che l’arte futurista italianava distaccandosi sempre più da ogni corrente straniera muovendo verso attuazioniche avranno carattere di assoluta novità”110.
È di interesse osservare come, preso dallo slancio nazionalista, Corra arrivi aparlare, in riferimento alle presunte “derivazioni” simboliste del futurismo, di “pa-
44 Capitolo primo
104 Fondazione Primo Conti onlus, Fiesole, Fondo Settimelli, Corrispondenza B. Corra-E. Setti-melli.
105 Massimo Carrà, Convergenze e difficoltà fra Milano e Firenze, cit., p. 12.106 F.T. Marinetti, Manifesto tecnico della letteratura futurista, 11 maggio 1912. Ora in F.T. Mari-
netti, Teoria e invenzione futurista, cit., pp. 46-54.107 Lo racconta Luciano De Maria in La nascita dell’avanguardia, cit., p. 25.108 Bruno Corra, Il primato artistico italiano, in “L’Italia Futurista”, a. II, n. 1, Firenze, 10 febbraio
1917, p. 1.109 Sergio Zoppi, L’avanguardia europea e il futurismo a Firenze, cit., pp. 28, 36.110 Bruno Corra, Il primato artistico italiano, in “L’Italia Futurista”, cit.

rallelismi casuali” se non addirittura di “allacciamenti e riferimenti voluti per potereessere meglio capiti e più presto considerati”111. A conferma dell’originalità diquanto elaborato dal movimento futurista, Corra adduce le “visioni artistiche bru-talmente originali” quali le parole in libertà, l’arte dei rumori, il teatro sintetico e lascienza futurista112. Sottratto quindi alla Francia lo scettro di posizione avanguar-dista, l’Italia odierna, “formidabile miniera di forza e di ingegno” darà vita ad“un’arte integralmente nuova”113. In linea con queste dichiarazioni, “L’Italia Futu-rista” si impone come prodotto nazionale e non si avvale di apporti stranieri. Cosìfacendo, il gruppo si distingue da “Lacerba” che, come si è visto, aveva invece ma-nifestato ampia apertura verso i contributi internazionali.
Tuttavia, se le dichiarazioni dei redattori e gli elementi soprammenzionati pun-tano in direzione di un’affiliazione de “L’Italia Futurista” alla corrente marinettiana,l’eterogeneità di contributi presenti nel periodico impongono un’analisi più attenta.Come già constatato, esso mostra una notevole ecletticità tematica. Dalla reboanteretorica nazionalista si passa agli scritti artistico-letterari. E, in quest’ambito, tro-viamo tavole parolibere da un lato e prose poetiche dall’altro, dove si assiste ad unrecupero della sintassi e della punteggiatura, ma aumenta l’arbitrarietà delle imma-gini. Risulta chiaro che, sulle pagine del giornale, oltre alla componente ortodossafuturista ne esiste un’altra più intimista, che si esprime attraverso la scrittura traso-gnata e visionaria delle prose poetiche, ricca di richiami simbolisti.
Come nota Luciano De Maria, la diffusione dell’opera di Arthur Rimbaud peropera di Ardengo Soffici “deve aver aperto a questi giovani la strada maestra delpoemetto in prosa, sia per mezzo dei brani critici che attraverso le traduzioni per laprima volta rese in italiano dal francese”114. È lo stesso Primo Conti a testimoniareil ruolo fondamentale svolto da Soffici nel far conoscere al gruppo l’opera dei sim-bolisti. In un’intervista rilasciata a Sergio Lambiase afferma: “Soffici è stato qual-cosa di così profumato nella nostra giovinezza: non si poteva più abbandonarlo. ConSoffici abbiamo letto Rimbaud. Attraverso Soffici abbiamo conosciuto Mal-larmé”115. Di ascendenza simbolista parla anche Dirk Vanden Berghe, precisandoche essa si ritrova tanto nella forma poetica praticata dal gruppo (il poema in prosadi ascendenza baudelairiana e rimbaldiana) quanto nella propensione all’introspe-zione e al magico116.
La matrice simbolista, pur essendo presente anche nella formazione di Marinettie quindi nell’ala del futurismo milanese da lui derivata, viene declinata dai giovanide “L’Italia Futurista” come interesse verso l’inconscio e l’onirico. Così facendo, ilgruppo prosegue lungo un percorso già avviato dal filone fiorentino precedente.Come afferma infatti Vanden Berghe nelle sue considerazioni sugli sviluppi del fu-
Il secondo futurismo fiorentino: genesi, protagonisti e peculiarità 45
111 Ibid.112 Ibid.113 Ibid.114 Luciano De Maria, La nascita dell’avanguardia, cit., p. 62.115 Sergio Lambiase, Gian Battista Nazzaro, Marinetti e i futuristi, cit., p. 95.116 Dirk Vanden Berghe, “L’Italia Futurista” e il Secondo Futurismo Fiorentino, in “Il Ponte”, vol.
44, n. 6, novembre-dicembre 1988, p. 166.

turismo fiorentino rispetto a quello milanese, a Firenze si assiste al “rifugio nel-l’individuale, nell’io profondo, lascito della cultura simbolista”, di cui l’interesseper l’esoterico e l’occulto, punto programmatico basilare della rivista “L’Italia Fu-turista”, rappresenta l’esito più singolare117.
Altri studiosi intervengono sulle peculiarità del futurismo fiorentino. Sandro Za-notto rileva come “dopo una prima matrice simbolista comune tra il futurismo to-scano e quello milanese, i toscani imbocchino una strada nettamente divergente, dicui il 1917 è l’anno cruciale”118. Queste riflessioni sono condivise da Maria CarlaPapini per la quale, pur partendo da una “identica matrice simbolista […] le stradedivergono o, piuttosto, l’una – quella del gruppo fiorentino – si immette nell’altraper poi procedere autonomamente verso esiti più che presaghi della prossima sta-gione surrealista”119.
Anche Ruggero Jacobbi interviene a proposito della posizione assunta dal futu-rismo fiorentino rispetto alla formazione simbolista. Egli afferma: “A Firenze le fasidel lavoro d’avanguardia [...] si svolgono in tre tempi: prima come simbolismo eso-terico e magico in senso stretto, poi come scoppio lacerbiano ed alleanza provviso-ria tra marinettiani e Soffici Papini Palazzeschi, poi – terza fase – come ritornoall’esoterico, al magico, al notturno, nell’ ‘Italia futurista’ [...]”120. Come esempioadduce le prose poetiche di Bruno Corra e di Mario Carli. Sequenza riconosciuta al-tresì da Silvia Porto, a proposito di uno studio sulla produzione di Arnaldo Ginna.Per la studiosa “Ginna riporta l’avanguardia fiorentina, dopo la parentesi di ‘La-cerba’, a moduli esoterici, magici e notturni, di chiara derivazione simbolista”121.
Va detto che tali moduli assunti da giovani quali i ravennati Corra e Ginna at-tecchiscono facilmente a motivo della fisionomia assunta dall’avanguardia in Emi-lia Romagna. Come osserva Anna Maria Nalini, quella regione si presenta come unambiente ad economia agricola, dunque diverso rispetto alla realtà industriale vis-suta dal futurismo milanese. La Nalini nota che nelle opere degli autori di questa pro-venienza “la direttrice dominante e più originale è quella psico-onirico-metafisica,che trova le sue radici culturali nel misticismo pascoliano e una espressione d’at-tualità locale nell’interesse per antroposofia e teosofia che si coltiva particolarmentenella Romagna del tempo”122.
Guardando alla produzione letteraria presente su “L’Italia Futurista” – poemettiin prosa di derivazione simbolista da un lato; tavole parolibere e manifesti di stampo
46 Capitolo primo
117 Ibid., p. 165.118 Sandro Zanotto, Motivi irrazionali ed esoterici nel futurismo toscano, cit., p. 114.119 Maria Carla Papini, Tra futurismo, surrealismo e oltre: il gruppo dell’ “Italia Futurista”, cit.,
p. 63.120 Ruggero Jacobbi, Ardengo Soffici fra tradizione e rinnovamento in Ardengo Soffici, L’artista e
lo scrittore nella cultura del 900, Atti del Convegno di studi, Firenze, Centro Di, 1976, pp. 24-25.Questa citazione è riportata da Piero Bigongiari, Il terzo futurismo fiorentino, presentazione a MariaCarla Papini (a cura di), L’Italia Futurista, cit., p. 21.
121 Silvia Porto, Esperienze del futurismo fiorentino nel settore delle arti visive, in Futurismo a Fi-renze 1910-1920, Sansoni, cit., p. 45.
122 Anna Maria Nalini Setti, Appunti per una lettura sistematica del futurismo in Emilia-Romagna,in Anna Maria Nalini (a cura di) Futurismo in Emilia Romagna, cit., p. 7.

marinettiano dall’altro – Dirk Vanden Berghe parla di “coesistenza di due scritturediverse, per non dire opposte”, come costante della rivista lungo tutto l’arco della suadurata123. Cosa rappresenta dunque questa scelta? Sancisce una separazione ideo-logica tra le due anime del futurismo o ne ammette l’esistenza mirando ad un su-peramento e ad una sintesi?
In realtà il gruppo de “L’Italia Futurista” assume una posizione autonoma sia ri-spetto all’ortodossia marinettiana che al gruppo di “Lacerba”, rimanendo coerenteal processo evolutivo iniziato nell’attività letteraria precedente. A questo riguardo,Maria Carla Papini parla di “autonomia di pensiero solo in superficie ossequiente aicanoni futuristi ed essenzialmente uguale a se stessa e coerente al processo evolu-tivo iniziato ne ‘La Difesa dell’Arte’, proseguito ne ‘Il Centauro’ e in ‘Rivista’”124.Mario Verdone osserva come il gruppo de “L’Italia Futurista” fosse distante sia da“Lacerba” che dal futurismo marinettiano, pur proclamandosi futurista. E aggiunge,come elemento distintivo rispetto a quest’ultimo, il fatto che esso rappresentava“l’ala magico-occultistica, con poca o punta idolatria per la macchina e, viceversa,una gran passione per le ‘attività inconsce dello spirito’”125.
Il lascito simbolista è dunque evidente nella produzione del gruppo che ne rac-coglie l’eredità ma va oltre nell’elaborazione di una propria poetica. Nel consegui-mento di questo obiettivo, il gruppo intende valersi di tutti i mezzi consentiti. Ciòera già emerso dalle dichiarazioni di Settimelli sulle pagine de “Il Centauro” dovesi legge: “Noi non escludiamo niente”126. E ancora: “Non vogliamo un colore, vo-gliamo averli tutti. Cerchiamo nelle nostre cose di dire del nuovo. Di pensare perconto nostro. Tutte le forme ci convengono; qualunque modo è buono”127. In que-sta prospettiva, la compresenza delle due scritture di cui parla Vanden Berghe sta adindicare un’apertura a tutto orizzonte. Si può supporre che la “pattuglia azzurra”vedesse le potenzialità insite nel concetto marinettiano delle parole in libertà, cheavrebbero acquistato valore se fossero riuscite a veicolare “del nuovo”. In questomodo il gruppo si dichiarava aperto a certe intuizioni presenti nel ramo milanesedel futurismo, da assimiliare e sviluppare ai fini della propria indagine.
In quello stesso articolo Settimelli era intervenuto a favore dell’indiscrimina-zione dei mezzi di espressione con queste parole: “Scrivete pure in quinari, in en-decasillabi sciolti, adoperate pure le forme più viete, se saprete chiudere entro questespoglie antipatiche un pensiero peregrino noi vi accoglieremo senza discussione”128.In base a queste dichiarazioni, la tecnica espressiva, qualunque essa sia, può costi-tuire un valido strumento atto a dare voce al pensiero profondo. In un altro articoloscritto il mese successivo sulla stessa rivista, Settimelli aveva aggiunto ulteriori con-siderazioni sull’apertura del movimento, spiegando che “il valore del pensiero puòstare in vecchie come in nuovissime vesti”129. Tuttavia, per contrastare il pregiudi-
Il secondo futurismo fiorentino: genesi, protagonisti e peculiarità 47
123 Dirk Vanden Berghe, “L’Italia Futurista” e il Secondo Futurismo Fiorentino, cit., p. 166.124 Maria Carla Papini (a cura di), L’Italia Futurista, cit., p. 47.125 Mario Verdone, Il futurismo fiorentino. Documenti per l’avanguardia, cit., p. 86.126 Emilio Settimelli, A proposito di futurismo, in “Il Centauro”, cit.127 Ibid.128 Ibid.129 Emilio Settimelli, Superare d’Annunzio e Croce, in “Il Centauro”, cit., p. 1.

zio con cui si limita il campo dell’arte, egli inneggiava a “una letteratura nuova e au-dace anche nella forma” per evitare che “con la limitazione di un campo si tronchi lagenialità di un artista”130. E alcuni anni dopo, commentando la novità apportata dal fu-turismo, Corra avrebbe ricordato “la tendenza verso forme e tecniche fatte di sintetismoveloce, di modernità disinvolta e di leggerezza intuitiva”, contrapposte a “lentezza me-todica” e “pedantismo” di forme e tecniche precedenti131.
In questa prospettiva, la presenza delle due anime del futurismo sulle pagine delgiornale deve essere vista come momento di assimilazione e convergenza, di supera-mento delle antitesi. La solida matrice simbolista, roccaforte dell’anima fiorentina,anima altresì la poetica del secondo futurismo fiorentino. Partendo da questa base, ilgruppo intraprende un’esplorazione negli spazi della psiche profonda, scandaglio svoltosul duplice piano della riflessione teorica e degli esiti poetici. A questo fine, il gruppoadotta l’audacia e l’impeto propri dell’anima milanese, per cui ogni mezzo è consen-tito nel perseguimento dell’obiettivo. Si può quindi affermare che l’assenza di vincolimetodologici contraddistingue questo secondo momento del futurismo fiorentino ri-spetto ai predecessori. Come afferma Vanden Berghe, “Pur se le posizioni futuriste delnucleo fiorentino contengono spunti antitetici all’atteggiamento dei milanesi, dobbiamoconstatare che nei due ‘campi’ proprio la volontà di assimilazione di idee sperimentalipiù divergenti fonde gli avversari nell’entità collettiva (il gruppo avanguardistico) incui continueranno comunque ad abbondare le soluzioni letterarie disuguali”132. Sullepagine de “L’Italia Futurista” questa “volontà di assimilazione” trova compiuta espres-sione.
L’atteggiamento di “autosufficienza” di cui parla De Maria a proposito dei giovanidel secondo futurismo fiorentino consente loro di esplorare piattaforme già impiegate,per volgerle ai fini della propria indagine. In questa prospettiva, la sopracitata affer-mazione di Verdone sul gruppo che nutriva “poca o punta idolatria per la macchina e,viceversa, una gran passione per le ‘attività inconscie dello spirito’” andrebbe ridi-scussa. Se il termine “macchina” va a simbolizzare il moto inarrestabile della realtà, nonsolo esterna all’individuo ma altresì quella interiore, nel momento in cui l’artista si ac-cinge a rappresentare le “attività inconscie dello spirito”, attività soggette allo stesso di-namismo che caratterizza la realtà esteriore, si deve avvalere di strumenti espressivi ingrado di rendere tale moto. I veicoli elaborati dal futurismo marinettiano per dareespressione al dinamismo rappresentato dalla “macchina” possono pertanto offrirespunti interessanti ai fini dell’espressione del moto interiore. In base a questa interpre-tazione “la macchina” e “le attività inconscie dello spirito” rappresenterebbero insommadue facce di una stessa medaglia, aspetti di uno stesso manifesto programmatico.
Per la capacità di convogliare con successo le due anime del futurismo verso unnuovo obiettivo, “L’Italia Futurista” costituisce una piattaforma originale. Le intuizionie le scelte del gruppo si sono rivelate brillanti, dal momento che la loro ricerca avrebbeprodotto esiti singolari considerati negli anni a venire come anticipazioni surrealiste.
48 Capitolo primo
130 Ibid.131 Bruno Corra, Per l’arte nuova della nuova Italia, cit., p. 8.132 Dirk Vanden Berghe, “L’Italia Futurista” e il Secondo Futurismo Fiorentino, cit., p. 168.

1 F.T. Marinetti, Distruzione della sintassi-Immaginazione senza fili-Parole in libertà, 11 maggio1913, ora in F.T. Marinetti, Teoria e invenzione futurista, cit., pp. 65-66.
2 Sergio Lambiase, Gian Battista Nazzaro, Marinetti e i futuristi, cit., p. 89.3 Si pensi alla tecnica del paroliberismo in letteratura, attraverso cui rendere l’irruenza del pen-
siero, o al dinamismo pittorico di Balla e Boccioni per esprimere la “sensazione dinamica eternata cometale”, come spiegheranno gli autori del Manifesto tecnico della pittura futurista, 11 aprile 1910. I fir-matari sono Giacomo Balla, Umberto Boccioni, Carlo Carrà, Luigi Russolo, Gino Severini. In LucianoDe Maria (a cura di), Marinetti e i futuristi, cit., p. 23.
II.
LA “PATTUGLIA AZZURRA”: IN ESPLORAZIONE
A partire dalla seconda metà dell’Ottocento, lo sviluppo delle scienze conobbeun enorme incremento sia nella ricerca teorica che nelle applicazioni tecniche. Laprospettiva di trovarsi di fronte a nuovi orizzonti esplorativi generò un clima di fi-ducia ed ottimismo ed ebbe un impatto sugli orientamenti spirituali ed intellettualidell’epoca, come avrebbe confermato Filippo Tommaso Marinetti, fondatore e capocarismatico del movimento futurista. In Distruzione della sintassi-Immaginazionesenza fili-Parole in libertà dell’11 maggio 1913 egli dichiarava infatti che il futuri-smo nasceva come risposta alle nuove sollecitazioni legate alle grandi scoperte scien-tifiche e osservava:
Coloro che usano oggi del telegrafo, del telefono e del grammofono, del treno, della bi-cicletta, della motocicletta, dell’automobile, del transatlantico, del dirigibile, dell’aero-plano, del cinematografo, del grande quotidiano (sintesi di una giornata del mondo), nonpensano che queste diverse forme di comunicazione, di trasporto e d’informazione eser-citano sulla loro psiche una decisiva influenza1.
Nel corso di un’intervista rilasciata molti anni dopo, Primo Conti avrebbe con-fermato questo carattere del futurismo, di avere cioè constatato che “la macchinastava prendendo un posto importante, anche nella sensibilità, negli affetti di tuttauna parte della psiche”2. Da qui nasceva il bisogno di elaborare un’arte nuova e di-namica che riflettesse la civiltà industriale e veicolasse il moto universale, secondol’equazione arte-vita propria dell’estetica futurista.
Se da un lato questa nuova disposizione speculativa condusse a forme letterarieed artistiche sperimentali atte a rendere il senso della velocità intesa come simulta-neità3, dall’altro si tradusse in un anelito ad esplorare gli spazi della psiche pro-

50 Capitolo secondo
fonda, fino a sfociare nelle ricerche esoteriche ed occulte. Questa ricerca venne con-dotta sul duplice piano della riflessione teorica e degli esiti poetici ed artistici, evide come massimi protagonisti il gruppo di giovani intellettuali ed artisti (la “pat-tuglia azzurra”) che avrebbero dato vita al secondo futurismo fiorentino. Il termine“pattuglia”, col suo rimando letterale ad un nucleo di soldati o agenti dell’ordine oc-cupati in compiti di perlustrazione, ben riflette lo spirito del gruppo, impegnato nell’“incursione” e “scandaglio”4 in una dimensione della realtà non percepibile attra-verso la normale attività dei sensi.
Nello spiegare la scelta dell’appellativo “azzurra”, Mario Verdone ricorda come ilcolore azzurro rinvii a tutta una tradizione: dal poeta francese simbolista Stephane Mal-larmé ai poemi di Paolo Buzzi. Nell’ambito del gruppo fiorentino, Primo Conti e RemoChiti fanno spesso riferimento all’azzurro come colore degli spazi metafisici. R. Notteaggiunge, a questo riguardo, che il Franchi così soprannominò il gruppo “forse in ri-cordo del ‘Blaue Reiter’ e forse perché l’azzurro è il colore dello spirituale”5.
È importante sottolineare che il percorso d’indagine del gruppo, pur presentandodelle caratteristiche distintive, è in linea con le tendenze espresse sin nei primi ma-nifesti futuristi, inneggianti alla conquista di nuove ed inesplorate zone di realtà. NelManifesto del Futurismo del 1909, l’incursione nell’ignoto viene considerata da Ma-rinetti fondamentale punto programmatico del movimento6. Il concetto verrà poi ri-preso in scritti successivi, dove ci si riferisce alla capacità dell’artista di percepirel’aspetto occulto, cioè nascosto, della materia. Nel Manifesto tecnico della pittura fu-turista del 1910 si definisce questa capacità una “potenza visiva che può dare risul-tati analoghi a quelli dei raggi X”7. Compito dell’artista non è dunque quello diriprodurre la realtà, per quanto filtrata attraverso i canali della propria sensibilità edello stato d’animo, ma di esplorarla, per carpirne l’aspetto segreto. In Ricostruzionefuturista dell’universo del 1915, Giacomo Balla e Fortunato Depero dichiarano in-fatti: “Daremo scheletro e carne all’invisibile, all’impalpabile, all’imponderabile, al-l’impercettibile”8. In un altro documento, i pittori futuristi si propongono di “renderel’invisibile che si agita e che vive al di là degli spessori [...]”9.
Ciò non valeva solo per la realtà esterna all’individuo, ma anche inerente a que-sto. Alla costituzione occulta dell’universo corrispondeva infatti una costituzione oc-culta dell’essere umano. Anton Giulio Bragaglia, noto per avere sviluppato il concettodi fotodinamismo, avrebbe osservato: “E per quella mirabile intuizione che è tutto nel
4 Sono termini chiave del gruppo. 5 R. Notte, Esoterismo, in Ezio Godoli (a cura di), Dizionario del Futurismo, Firenze, Vallecchi,
2001, p. 414. Il “Blaue Reiter” (tradotto “il cavaliere azzurro”) fu un gruppo di artisti espressionistiformatosi a Monaco di Baviera nel 1911.
6 “Diamoci in pasto all’Ignoto, non già per disperazione, ma soltanto per colmare i profondi pozzidell’Assurdo!”. F.T. Marinetti, Fondazione e Manifesto del Futurismo, pubblicato in francese sul “Fi-garo” il 20 febbraio 1909, ora in F.T. Marinetti, Teoria e invenzione futurista, cit., p. 9.
7 Manifesto tecnico della pittura futurista, cit., p. 24.8 Giacomo Balla, Fortunato Depero, Ricostruzione futurista dell’universo, Milano, 11 marzo 1915,
ora in Luciano De Maria (a cura di), Marinetti e i futuristi, cit., p. 172.9 Boccioni, Carrà, Russolo, Balla, Severini, Prefazione al Catalogo delle Esposizioni di Parigi,
Londra, Berlino, Bruxelles, Monaco, Amburgo, Vienna ecc, febbraio 1912, ora in Luciano De Maria (acura di), Marinetti e i futuristi, cit., p. 62.

La “pattuglia azzurra”: in esplorazione 51
10 Anton Giulio Bragaglia, Fotodinamismo futurista, 1911, Torino, Einaudi, 1970, p. 18.11 Per fenomeni sovrannaturali si intende tutta una gamma che va dagli stati alterati della coscienza
alla fenomenologia del sonno magnetico e della trance medianica. Per un approfondimento sui varirami delle scienze occulte si rimanda all’articolo di Germano Celant, Futurismo esoterico, cit., pp. 108-117.
12 Simona Cigliana, Futurismo esoterico, cit., p. 30.
nostro essere ultrasensibile di uomini viventi rapidamente e febbrilmente, abbiamocento voci in noi e cento visioni, ottiche cerebrali e sentimentali, che si mescolano,si compenetrano, si unificano con quella reale dell’attimo presente”10. La ricerca con-dotta dal movimento futurista si inseriva del resto in un ambiente scientifico proiet-tato già dagli inizi dell’Ottocento verso la scoperta di forze invisibili. Queste indaginiavrebbero portato sul finire del secolo alla scoperta, tra l’altro, delle onde elettroma-gnetiche e della radioattività.
Di pari passo e fecondato da quello stesso spirito esplorativo, andava crescendol’interesse verso i fenomeni occulti e sovrannaturali11. A cavallo tra i due secoli, l’am-biente scientifico europeo si mostrava particolarmente attento ai fenomeni occulti,come dimostrano le ricerche scientifiche sulle facoltà della mente condotte in queglianni nelle principali capitali europee, prime fra tutte Parigi, e il proliferare di circolimedianici nel cui ambito conducevano esperimenti studiosi di tutto rispetto, comeCarl Jung. Tra il 1899 e il 1900 egli organizzò infatti delle sedute spiritiche, i cui ri-sultati sarebbero andati a convergere nel saggio del 1902 Psicologia e patologia deicosiddetti fenomeni occulti. In quel torno di tempo si era costituita anche la presti-giosa angloamericana “Society for Psychical Research”. Come ricorda la studiosaSimona Cigliana, lo stesso Freud prese in considerazione la possibilità di presentarela sua “candidatura per l’elezione a membro corrispondente”, secondo quanto sievince da una lettera da lui inviata a Carl Jung nel 191112.
Su una linea parallela di ricerca volta ad esplorare le forze naturali sconosciute siponeva anche il lavoro di famosi astronomi quali Camille Flammarion e GiovanniSchiaparelli, interessati ad esaminare il possibile influsso delle forze occulte prodottedalla materia celeste sul comportamento umano. Ma già nella seconda metà del Set-tecento l’austriaco Franz Mesmer, laureatosi in medicina a Vienna con una tesi sugliinflussi dei corpi celesti sul corpo umano, aveva elaborato la teoria del “magnetismoanimale”. In base a questa teoria, un fluido magnetico pervadeva l’universo metten-done in relazione le parti. Il flusso armonioso di questo fluido presente in tutti i corpi,in armonia con quello universale, avrebbe garantito il corretto funzionamento delcorpo umano. Malattie e disturbi erano quindi da ricondurre all’alterazione della cir-colazione del fluido magnetico, da ristabilire attraverso l’applicazione di corpi me-tallici o liquidi magnetizzati o l’imposizione di mani irraggianti energie benefiche.Seppure controversa a causa delle fragili basi scientifiche su cui si fondava, la teoriamesmeriana avrebbe esercitato grande influenza non solo sulla cultura del suo tempoma anche nel periodo successivo. Mesmer sarebbe infatti stato considerato un pre-cursore nell’ambito delle ricerche al confine tra scienze naturali ed esoteriche.
Per quanto riguarda l’Italia c’è da dire che, come ricorda Ferruccio Giacanelli, lacomunità scientifica iniziò ad occuparsi di fenomeni paranormali più tardi rispetto al

52 Capitolo secondo
resto dell’Europa, presumibilmente per la scarsa diffusione del mesmerismo e l’as-senza di una profonda tradizione dello studio del magnetismo animale13. Tuttavia, aiprincipi del Novecento, numerosi scienziati titolari di cattedre di psichiatria e neu-rologia, fra i quali Enrico Morselli e Cesare Lombroso, studiavano la fenomenolo-gia paranormale, tra cui le forze soprannaturali agenti nell’ambito delle sedutespiritiche. Fu proprio grazie agli esperimenti condotti da Morselli e altri autorevolicolleghi che, tra il 1901 e il 1907, la medium napoletana Eusapia Paladino, già co-nosciuta nell’ultimo decennio dell’Ottocento, acquistò grande notorietà a livello eu-ropeo e fu al centro di numerosi studi sull’argomento, spesso accompagnati daaccese polemiche sull’attendibilità della stessa, come quella divulgata sulle paginedel “Corriere della Sera”14.
A conferma dell’esplosione dell’occultismo in quegli anni vanno ricordati nonsolo i numerosi congressi dedicati allo spiritismo, ma anche l’ampissimo spazio de-dicato a queste investigazioni nell’ambito di associazioni e circoli culturali e su ri-viste specializzate e non, rivolte ad un pubblico esteso15. Ciò era dovuto al fatto che,all’interesse mostrato in ambiente scientifico e parascientifico, faceva riscontro unclima culturale parimenti attento ai fenomeni magico-esoterici. Tali questioni nonpolarizzavano solo l’attenzione di fisiologi e psichiatri, ma anche di filosofi e dellapubblica opinione intellettuale più in generale.
Giovanni Papini, nel giustificare l’ampio spazio assegnato agli articoli sull’oc-cultismo in un fascicolo di “Leonardo”, il periodico da lui diretto con GiuseppePrezzolini tra il 1903 e il 1907, osserva come fosse ormai fenomeno diffuso richia-mare l’attenzione “sui problemi dell’aldilà, sul mondo soprasensibile, sui fenomeniocculti”16. Egli riconduce questo interesse ad una rinascita dello spiritualismo, aduna rinnovata attenzione verso i problemi della vita interiore, ad una riscoperta deivalori dello spirito. E rileva: “Malgrado il positivismo importato dall’Inghilterra,l’anticlericalismo importato di Francia e il materialismo importato di Germania,sembra che l’Italia cominci a ricordarsi che nel mondo ci sono anche le anime”17.
La coesistenza delle due forze apparentemente antitetiche rappresentate dall’ir-razionalismo, a cui rimandano le pratiche occultistiche, e il razionalismo che avevasotteso alle grandi scoperte scientifiche e alla conquista di nuovi spazi conoscitivi,acquista un senso se si colloca nel complesso clima ideologico-culturale dominatodalle contraddizioni inerenti al positivismo. Se è vero che esso aveva lasciato in ere-dità un metodo di indagine basato sull’obiettività, è anche innegabile che si era di-
13 Ferruccio Giacanelli, Il medico, l’alienista, in Delia Frigessi, Ferruccio Giacanelli, Luisa Man-goni (a cura di), Cesare Lombroso, Delitto, genio, follia: scritti scelti, Torino, Bollati Boringhieri, 1995,p. 37.
14 Si veda il “Corriere della Sera”, 25 settembre-12 ottobre 1892, A proposito di esperimenti spiri-tici, Lo spiritismo a Milano, Gli esperimenti spiritici di Eusapia Paladino. Il riferimento è tratto dal ca-pitolo di Simona Cigliana, Europa magica, in Futurismo esoterico, cit., pp. 17-46, p. 41.
15 Per un approfondimento sui circoli medianici costituitisi in quegli anni e le indagini ad essi de-dicate, si rimanda al capitolo della Cigliana sopracitato.
16 Giovanni Papini, Franche spiegazioni, in “Leonardo: rivista d’idee”, a. V, serie 3, Firenze, aprile-giugno 1907, p. 130.
17 Ibid., p. 133.

La “pattuglia azzurra”: in esplorazione 53
18 Ibid., pp. 131-133.19 Ibid., p. 129.20 Ibid., p. 142.21 Ibid., p. 143.22 Rudolf Steiner, conferenza tenuta a Dornach il 10 ottobre 1915, poi in Il movimento occulto nel
secolo diciannovesimo e il mondo della cultura, trad. Adele Crippa, Milano, Editrice Antroposofica,1993, pp. 17-19.
23 Ibid.24 Germano Celant, Futurismo esoterico, cit., pp. 109-111.
mostrato semplicistico nel suo determinismo materialista e incapace di dare delle ri-sposte soddisfacenti all’inquieta e complessa coscienza moderna. Da questi limitinasceva la crisi che avrebbe portato al riaffiorare delle istanze spiritualistiche careal romanticismo e al recupero di una dimensione trascendente. In questa prospettivasi capisce che l’interesse per il paranormale rappresentava uno dei tanti volti di unaricerca a tutto campo.
Come ricorda Papini, gli editori seppero farsi interpreti di questi fermenti conl’uscita di “sempre più numerosi libri di filosofia, di psicologia, di religione e per-fino di vero e proprio occultismo”, i quali testimoniavano “la vastità della rivolu-zione intellettuale che si va compiendo in Italia”. A questi si affiancarono “nasciteincessanti di riviste di pensiero”18. Per quanto consapevole che la pubblicazione diarticoli sull’occultismo avrebbe fomentato critiche e accuse di avere aperto le portedel Leonardo “alle più irrazionali e fantastiche chiacchiere”19, Papini difende la suadecisione spiegando che, non essendo egli “né dogmatico né intollerante”, si prestavolentieri a far conoscere gli occultisti, in quanto ritiene che “nell’occultismo visiano moltissime cose da utilizzare” e che sia quindi un male disprezzarlo per par-tito preso. Come inoltre aggiunge, “Esso allarga, prima di tutto, il nostro pensiero,suggerendoci che noi non viviamo soltanto di questa vita e che non soltanto noi esi-stiamo nel mondo ma che l’esistenza intelligente è molto più vasta, nello spazio enel tempo, di quel che noi crediamo”20. Lo spazio dedicato a questi scritti va intesodunque come un incoraggiamento a quella che egli definisce un’ “esplorazione”21.
Del resto, come avrebbe ricordato il teosofo tedesco Rudolf Steiner, la stradapercorsa dagli esoterici e i mezzi impiegati miravano proprio a richiamare l’atten-zione verso l’esistenza di un mondo spirituale e a rendere “exoterica”, quindi com-prensibile al pubblico, una parte del sapere esoterico22. Lo stesso medianesimo fuuno strumento, per quanto discutibile nelle modalità di impiego, attraverso cui gliesoterici cercarono di rendere evidente sul piano esteriore e fisico quanto provenivadalla sfera spirituale, in modo da assecondare le inclinazioni materialistiche del-l’epoca, per cui contava l’evidenza fattuale23.
Indipendentemente dai risultati conseguiti, più o meno discutibili, certo è che ilfascino del mondo occulto aveva investito i circoli culturali a vari livelli, come ri-corda Germano Celant: Roma arrivò infatti ad avere un sindaco occultista (ErnestoNathan) e in altre città, quali Torino e Milano, un folto pubblico seguiva le confe-renze di Angelo Marzorati e Cesare Lombroso24. Tra questi c’era Balla, partecipealla discussione su vari fronti: tra i suoi campi di interesse si contano infatti l’astro-nomia e la psicologia, tanto da attirarsi l’appellativo di “psichiatra”. Lo stesso Ma-

54 Capitolo secondo
rinetti aveva manifestato interesse verso le scienze occulte e, tra il 1902 e il 1907,aveva partecipato alle sedute spiritiche in casa di Enrico Annibale Butti. Egli fre-quentava inoltre l’ambiente occultistico parigino ed ebbe modo di entrare in contattocon personalità quali Edouard Schuré, autore di Les grands initiés25.
Valutando questi fermenti nella prospettiva della complessa temperie scientifico-culturale del periodo, è evidente che non si tratta di un riflusso passatista, ma del re-cupero di una tradizione rivista in ottica avvenirista. I fenomeni paranormalivenivano posti all’osservazione scientifica positiva, come qualunque altro fenomenonaturale. Ricorrendo alle parole di Simona Cigliana, la tradizione occulta era “ac-creditata dalle indagini scientifiche sul paranormale, sulla costituzione energeticadella materia, sui campi magnetici, ammodernata e laicizzata in una prospettivapragmatista [...]”26. I fenomeni che si verificavano in ambito di sedute medianichenon erano più circondati da un’aura di inviolabile mistero, ma venivano analizzatida scienziati che chiamavano in causa, oltre alle condizioni psichiche del medium,l’applicazione di leggi già accertate in altre discipline. Come sosteneva Cesare Lom-broso, se nel campo della fisica era riconosciuto il principio della trasformazione diuna forma di energia in un’altra, lo stesso si poteva ipotizzare per i fenomeni di me-dianità. In questo caso, affermava lo studioso, la forza psichica di un mediumavrebbe potuto, attraverso l’etere, trasformarsi in forza luminosa o motoria e dun-que generare delle alterazioni sull’ambiente, come sollevare un tavolo o provocaremanifestazioni di altro tipo27. Questi episodi andavano dunque visti come espres-sione dell’energia psichica che, se opportunamente incanalata, poteva condurre arisultati inaspettati.
In base a queste considerazioni si capisce come il futurismo, con il suo costanteriferimento alla carica energetica dell’universo e dell’essere umano (non si dimen-tichi che Marinetti aveva inizialmente preso in considerazione l’idea di chiamare ilmovimento “elettrismo” o “dinamismo”28), ben si prestasse ad interpretare in chiaveletteraria ed artistica gli esiti delle più recenti scoperte scientifiche e degli studi sulparanormale. Nello scritto L’uomo moltiplicato e il regno della macchina del 1910,il fondatore del futurismo fa infatti riferimento ai “fenomeni di volontà esterioriz-zata che si manifestano continuamente nelle sedute spiritiche”29, vedendo in essiun segno del potenziale insito nell’esteriorizzazione della volontà. Egli non ritenevaanzi lontano il giorno in cui essa si sarebbe prolungata fuori dell’uomo “come un im-menso braccio invisibile”30.
Allo sviluppo del potenziale umano nell’ambito di un percorso evolutivo ave-vano dedicato molte riflessioni i fratelli Ginanni Corradini con uno scritto del 1910
25 R. Notte, Esoterismo, in Dizionario del Futurismo, cit., p. 412.26 Simona Cigliana, Futurismo esoterico, cit., p. 88.27 Cesare Lombroso, Esperienze spiritiche, in Luigi Capuana, Mondo occulto, a cura di Simona
Cigliana, Catania, Edizioni del Prisma, 1995, p.196.28 Lo ricorda Bruno Romani in Dal simbolismo al futurismo, cit., p. 202.29 F.T. Marinetti, L’uomo moltiplicato e il regno della macchina, 1910, ora in F.T. Marinetti, Teo-
ria e invenzione futurista, cit., p. 300. 30 Ibid., p. 299.

La “pattuglia azzurra”: in esplorazione 55
31 A.B.C (Arnaldo e Bruno Corradini), Metodo, Ravenna, Tipo-lito Ravegnana, 1910. Ora in MarioVerdone (a cura di), Manifesti futuristi e scritti teorici, cit., pp. 49-79.
32 S.l e s.d., Fondazione Primo Conti onlus, Fiesole, Fondo Settimelli, Corrispondenza B. Corra-E.Settimelli.
33 Ibid.34 S.l. e s.d.35 Dal contenuto si evince che Corra si trova a Parigi e il contesto fa pensare che egli si riferisca alla
fondazione di “Rivista”.
dal titolo Metodo31, in cui affrontavano alcune questioni relative allo sviluppo del-l’individuo nella sua triplice valenza fisica, intellettuale e spirituale. Dalla corri-spondenza Corra-Settimelli si evince che alla base di queste riflessioni vi eral’apporto teorico di un movimento di Coltura umana affermatosi in Francia e inAmerica, che a sua volta affondava le radici nelle filosofie orientali e in particolareindiane, da sempre attente allo sviluppo delle facoltà mentali.
Partendo dal presupposto che l’essere umano utilizza solo in parte le sue ener-gie, questo movimento incitava a mettere a frutto i poteri della volontà per coltivaretutte le potenzialità dell’individuo, sia sul piano fisico che su quello delle facoltà psi-chiche, in armonia con il principio di evoluzione della materia, in vibrazione pe-renne. L’energia individuale era vista infatti come intrinsecamente connessa conl’energia cosmica e un tutt’uno con essa. In una delle lettere sopramenzionate, Corradescrive tale movimento come “diretto ad insegnare agli uomini il modo di cresceree di sfruttare meglio le loro energie a diffondere con una propaganda attiva unaquantità enorme di sistemi di sviluppo fisico e intellettuale dai sistemi di ginnasticacomuni, sino alle esercitazioni con cui arrivare alla possessione dei poteri occulti chedovrebbero permettere di operare i miracoli”32. E parla del successo “colossale” ot-tenuto da questo movimento in America, Inghilterra e in Francia, come dimostranole centinaia di migliaia di libri venduti e il successo dei corsi per corrispondenza, no-nostante il costo elevato. Corra spiega le ragioni di questo successo con il fatto che“ogni persona ha un grande interesse a svilupparsi”33.
A dimostrazione del fatto che non si trattava di teorie prese sommariamente aprestito, bensì di principi che essi intendevano ulteriormente sviluppare tramite unattento approfondimento, vanno alcune affermazioni di Corra il quale, in un’altra let-tera a Settimelli, scritta da Parigi nello stesso periodo, sostiene di frequentare laScuola di Psichismo sperimentale della Società Magnetica di Francia dove si stu-diavano “le forze misteriose mal definite esistenti nella natura, nei corpi, nel-l’uomo”34. Nell’esprimere il proprio consenso all’idea di fondare insieme un nuovogiornale35, Corra propone di annunciare nell’articolo-programma che il giornale“svolgerà un movimento che parte da tutto ciò che si è fatto nel campo dell’occul-tismo in Francia, in Inghilterra, in America e in India” senza però presentare il gior-nale come organo ufficiale di tale associazione, in quanto ciò ne avrebbe diminuitol’originalità. Si capisce che Corra è molto ferrato nella materia perché afferma: “Inquesto campo io sarei già in grado di scrivere dei volumi”.
E difatti, il primo numero di “Rivista” si apre con l’articolo La coltura umana,in cui si legge:

56 Capitolo secondo
In ogni uomo esiste la possibilità di un uomo più perfetto. Indubbiamente nelle partioscure di noi stanno nascosti germi di inquietudini ignote, nuclei di energie raffinate e in-calcolabilmente potenti. Quale studio più interessante di questa autointrospezione, diquesta tenace ricerca di ciò che vi ha in noi di quasi sovranaturale, di questo acuto e for-midabile modellamento della creta del nostro Io in fondo al quale sotto le dita si sente ri-velarsi il battito di un’anima più potente?36
Va ricordato che di principio evolutivo aveva già parlato un precursore di spicco,Luigi Capuana, nell’ambito di un intervento sui fenomeni medianici, a cui si era in-teressato già dai tempi del suo saggio Spiritismo?, pubblicato nel 188437. L’inter-rogativo non sembrava in realtà riflettere la posizione dello scrittore napoletano,pronto ad avvalorare i risultati dei recenti studi sul paranormale, come avrebbe in-fatti confermato nella prefazione ad un successivo scritto dal titolo Mondo occulto,del 1896. Qui si legge che quel punto interrogativo stava a rappresentare “prudenteriserbo”, necessario in un momento delicato in cui questi fenomeni non avevano an-cora assunto valore scientifico38. E si chiede se i diversi rami del paranormale nonsiano forse gradazioni di uno stesso fenomeno, spiragli di un “mondo superiore”che “ci si rivela a tratti, intermittentemente, senza leggi e senza ordine riconosci-bili”39. Spiega quindi quanto segue:
I confini del mondo naturale si spostano; il mondo naturale e il soprannaturale accennanodi confondersi insieme e formare una cosa sola, il mondo della realtà; realtà varia, infi-nita, che parte dall’atomo per elevarsi via via fino alla forma, dirò così, senza forma, allaspirituale, dove il fenomeno e il pensiero che lo studia si riconoscono identici40.
Si tratta di una realtà composita ma coesa dunque, dalle molte sfaccettature, al-cune facilmente accessibili, altre non immediatamente percepibili. Una matrice co-mune ad una dimensione altra operante sul piano fisico e all’essere umano, soggettoalle stesse leggi sovrasensibili che governano il mondo e in grado, affidandosi adesse, di accedere a questa dimensione altra. Ciò si riallaccia del resto al concetto didinamismo, visto come movimento simultaneo caratterizzante piani diversi di esi-stenza, visibili e invisibili.
Alcuni anni dopo Capuana ribadisce questo concetto in una lettera del 1906 ri-volta a Luigi Pirandello, anch’egli interessato in un primo tempo alle manifesta-zioni medianiche, affermando che esse dimostrerebbero l’esistenza di una realtà “dicui ancora i nostri sensi non hanno la percezione immediata”. E qui entra in giocoil principio evolutivo a cui avevamo fatto riferimento, in quanto Capuana chiarisceil senso di questa frase aggiungendo:
36 Bruno Ginanni Corradini, La coltura umana, in “Rivista”, cit., pp. 2-3.37 Luigi Capuana, Spiritismo?, Catania, Giannotta, 1884. Ora in Mondo occulto, a cura di Simona
Cigliana, cit., pp. 55-162.38 Luigi Capuana, Mondo occulto, Napoli, Pierro, 1896. Ora in Mondo occulto, a cura di Simona
Cigliana, cit., p. 165.39 Ibid., p. 167.40 Ibid., p. 168.

La “pattuglia azzurra”: in esplorazione 57
41 Luigi Capuana, Lettera aperta a Luigi Pirandello: a proposito di un fantasma. Credenti e mi-scredenti dello spiritismo, in “Gazzetta del Popolo”, Torino, 2 gennaio, 1906. Ora in Mondo occulto,cit., pp. 239-240. Ad una prima fase in cui Pirandello aveva manifestato interesse per i fenomeni me-dianici era seguito lo scetticismo. Da qui la polemica.
42 Simona Cigliana, Introduzione a Luigi Capuana, Mondo occulto, ibid., p. 41.43 A.P. Sinnett, The Occult World, London, Trubner & Co, 1881.44 Luigi Capuana, Mondo occulto, cit., p. 188.45 Elena Petrovna Blavatsky, Introduzione alla teosofia (prima edizione in inglese, 1889), trad. G.B.
Penne, Torino, Fratelli Bocca, 1911, p. 17.46 Rudolf Steiner, Goethe, padre di una nuova estetica, conferenza tenuta a Vienna il 9 novembre
1888, in Arte e conoscenza dell’arte (fondamenti di una nuova estetica), trad. Iberto Bavastro, Milano,Editrice Antroposofica, 1998, p. 19.
E dico ancora perché ho la convinzione che un giorno o l’altro, tra qualche secolo, traparecchi secoli – il tempo non fa nulla; la natura è lentissima nella sua evoluzione – lefacoltà medianiche, ora privilegio di pochi, diventeranno comuni, per eredità, per svol-gimento organico, come accade agli Anfiossi dei laghi sotterranei, che hanno gli occhi inembrione vivendo nell’oscurità, e che li aprono a poco a poco dopo di essere trasportatia vivere in acque illuminate dal sole41.
Egli proclama insomma l’avvento di un futuro in cui, grazie ad un graduale pro-cesso evolutivo, i poteri latenti nell’essere umano sarebbero diventati patrimoniocomune e quindi non più occulti. Come ricorda la Cigliana42, il titolo Mondo occultosi richiama al lavoro di un noto teosofo (Alfred Percy Sinnett) autore di uno scrittodel 1881 dal titolo The Occult World43, libro in effetti citato da Capuana44. Il riferi-mento è di rilievo in quanto lungo simili coordinate si muoveva appunto la societàteosofica, un’importante scuola di pensiero impegnata ad investigare una dimen-sione di realtà supersensibile. Fondata a New York nel 1875 da Helena PetrovnaBlavatsky, essa rappresentò un importante punto di riferimento anche in Europa, inseguito alla costituzione di numerose sedi nelle principali città. Come la stessa Bla-vatsky avrebbe spiegato, il nome “teosofia”, derivante dall’unione dei due terminigreci “theos” (essere divino) e “sophia” (saggezza), significava conoscenza o scienzadivina45. Alla base di questa scuola di pensiero vi era un sistema sincretistico di ele-menti cristiani, orientali e filosofici, teso a ricondurre l’essere umano alle fonti dellaconoscenza divina, a cui accedere attraverso la percezione delle sue qualità mani-feste nella natura e nell’individuo, che con essa è un tutt’uno. Nell’ambito della se-zione tedesca della società avrebbe acquistato crescente popolarità Rudolf Steiner.
Studioso di scienze naturali da un lato e di filosofia dall’altro, Steiner si sarebbeispirato a Goethe nell’elaborazione di un sistema che consentisse di coniugarescienza e spirito. Come Goethe, egli credeva in una dimensione sovrasensibile dellarealtà, nascosta alla comune percezione sensoriale. Nell’ambito di alcune osserva-zioni scritte per la conferenza tenuta nel 1888 a Vienna, si legge: “Soltanto oltre-passando la realtà, lo spirito umano rompe l’involucro, penetra nell’essenza e gli sipalesa quel che nell’intimo tiene insieme il mondo”46. Steiner sviluppò il concettodi “antroposofia”, dal greco “anthropos” (uomo), ad indicare l’attenzione posta sul-l’individuo e al suo percorso evolutivo in senso spirituale, grazie al quale accederealla conoscenza di questa realtà sovrasensibile. Secondo il filosofo tedesco in ogni

58 Capitolo secondo
persona sono latenti quelle facoltà che possono portare alla conoscenza dei “mondisuperiori”47, dove questo termine sta ad indicare una sfera che va oltre il campod’indagine delle scienze naturali, ma non per questo esente da metodi di ricerca og-gettivi.
Anche in Italia la società teosofica si affermò, come testimoniano le numerosesedi costituitesi a Taormina, Bologna, Roma, Milano e Firenze dove, nel 1905, la so-cietà teosofica sarebbe confluita nella Biblioteca Filosofica di Firenze. Come silegge nella rivista letteraria “La Voce” di Giuseppe Prezzolini, essa offriva circa5000 volumi su argomenti quali “filosofia, psicologia, teosofia, misticismo, storiadelle Religioni, scienze psichiche, magia, occultismo, Christian Science, NewThought”48. Oltre a vantare un eccellente servizio prestiti, la Biblioteca si fece pro-motrice di varie iniziative: dall’organizzazione di incontri pubblici al patrocinio divere e proprie conferenze; dai corsi sul pensiero filosofico e religioso dei vari po-poli all’istituzione di un Circolo filosofico. Quanto alla circolazione delle idee, la Bi-blioteca poteva contare sullo spazio ad essa dedicato dalle riviste fiorentine diretteda Papini e Prezzolini, che provvedevano a pubblicare estratti di conferenze tenuteda eminenti studiosi nell’ambito delle attività della Biblioteca. Tali iniziative con-tribuirono a sollevarne il profilo tanto da attirare su di essa anche l’attenzione delmondo accademico, in un primo momento riluttante.
Molti erano i giovani intellettuali su cui la società teosofica esercitò una notevoleinfluenza: tra questi c’erano i giovani futuristi fiorentini, come conferma ArnaldoGinna nel suo racconto al professore Mario Verdone:
Ci rifornivamo di libri spiritualisti ed occultisti, mio fratello ed io, presso gli editori Dour-ville e Chacormac. Leggevamo l’occultista Elifas Levi, Papus, teosofi come la Blavatskye Steiner, la Besant, segretaria della società Teosofica, Leadbeater, Edouard Schuré. Se-guivamo le conferenze della società Teosofica a Bologna e Firenze49.
I volumi conservati nel fondo Ginanni Corradini testimoniano questo interesse,come già rilevato nell’introduzione. Gli interessi eclettici del gruppo fiorentino, ilsincretismo dimostrato nel combinare e fare propri spunti offerti dai più svariaticampi e scuole di pensiero a fini letterari ed artistici, rappresentano senza dubbio unadelle caratteristiche più interessanti del gruppo e impongono un’apertura a tuttoorizzonte a chi intenda ricostruire la poetica del movimento. A questo fine va dun-que approfondito l’apporto delle scienze occulte, in quanto esse offrono una nuovaprospettiva rispetto alla scienza tradizionale.
Dal manifesto La scienza futurista50, apparso sul secondo numero de “L’ItaliaFuturista”, all’articolo di Arnaldo Ginna Il coraggio nelle ricerche di occultismo51,
47 Rudolf Steiner, L’iniziazione: come si conseguono conoscenze dei mondi superiori? (prima edi-zione in tedesco, 1904), trad. Emmelina De Renzis, Milano, Editrice Antroposofica, 2002.
48 “La Voce”, a. I, n. 1, Firenze, 20 dicembre 1908. 49 Mario Verdone, Cinema e letteratura del futurismo, cit., pp. 21-22.50 La scienza futurista, cit. 51 Arnaldo Ginna, Il coraggio nelle ricerche di occultismo, in “L’Italia Futurista”, a. II, n. 12, Fi-
renze, 6 maggio 1917, p. 2.

La “pattuglia azzurra”: in esplorazione 59
52 Irma Valeria, Occultismo e arte nuova, cit.53 La scienza futurista, cit., p. 208.54 Bruno Ginanni Corradini, Il liberismo, in “Il Centauro”, cit.55 La redazione, Il nostro programma, in “Rivista”, cit., p. 1.56 Arnaldo Ginna, Pittura dell’avvenire, cit., p. 195.
e a quello di Irma Valeria Occultismo e arte nuova52, è tutto un incitamento al-l’esplorazione delle scienze occulte, dalle quali ci si attendeva nuove rivelazioni. Silegge difatti nel manifesto: “Attiriamo l’attenzione di tutti gli audaci verso quellazona meno scandagliata della nostra realtà che comprende i fenomeni del mediani-smo, dello psichismo, della rabdomanzia, della divinazione, della telepatia ... In-dubbiamente da questo lato si sta per afferrare qualche cosa che arricchirà diimprevedibile la nostra vita”53.
Dal momento che fin dal principio della loro attività editoriale questi giovani siimpongono all’attenzione per la messa a punto di un programma basato su uno“scientifismo rigoroso”54, viene da chiedersi come si concilino gli interessi per lescienze occulte con questo obiettivo. E va notato che tali interessi non riguardanouna fase successiva, quella de “L’Italia Futurista”, in quanto già nel primo numerodi “Rivista”, i direttori Emilio Settimelli e Bruno Corra annunciano che passerannodalla scienza all’occultismo, ribadendo però ancora una volta il loro credo nel ra-gionamento e in ciò che è “scientifico e assoluto”55.
Nello scritto sull’arte del 1915 – Pittura dell’avvenire – , che precede di un annoil manifesto sulla scienza, Ginna aveva già vaticinato più ampi orizzonti per la ri-cerca scientifica e artistica grazie alle scoperte in questi nuovi ambiti:
L’arte considera qualche cosa di più complesso che non sia semplicemente la gravitàl’inerzia la velocità. L’arte considera qualche cosa che ci interessa più intimamente: le no-stre passioni. Sono anch’esse dei movimenti, ma movimenti interni, fissati in un grovi-glio di leggi più complicate non considerate ancora dalla scienza ufficiale. Tutto il mio sforzo nel tendere a dare esteso il mio concetto mi porterebbe a parlare dellascienza, diremmo così, non ufficiale: dell’occultismo. È evidente che questa sarà la scienza del domani. Non è ancora giunto il momento in cuile migliori energie dell’umanità siano incanalate e sospinte verso questi studi. Però noncredo di sbagliarmi nel pronosticare assai vicina l’epoca in cui nuove scoperte in campoinaspettato dai più porteranno la scienza e l’arte in un nuovo e più largo ordine di idee56.
Ginna si dichiarava fiducioso nel fatto che le scienze occulte avrebbero spalan-cato nuove prospettive. Il fatto che i fenomeni chiamati occulti, e cioè “spiritismo,medianismo, telepatia, alchimia, rabdomanzia, astrologia, magia, divinazione, ecc.”fossero già oggetto di studi da parte dell’École de Psychologie di Parigi, indicava laloro portata sul piano scientifico. Scoperte come quelle che avevano indotto a con-fermare l’esistenza del fluido magnetico, chiamato da Tromelin “force-byologique”,in grado di far girare un motore a fluido per il solo avvicinamento di una qualunqueparte del corpo, rappresentavano un risultato già molto importante; e tuttavia Ginnariteneva che “ancora restano molti misteri da delucidare”. Concludeva dicendo: “Eper ciò, malgrado le mie credenze personali, non posso parlare che di leggi-forze già

60 Capitolo secondo
ammesse da tutti e che non escono dalle constatazioni fisico-chimiche”57. Se l’in-dagine portata avanti dalla “pattuglia azzurra”, indagine dichiaratamente impron-tata al rigore scientifico, imponeva la necessità di riconoscere leggi-forze ammesseda tutti, l’auspicio andava in direzione dell’esplorazione di nuove energie.
Per Ginna, anche se alla scienza andava attribuito il merito di avere apportato ca-rattere di “positività”, precedentemente mancato all’arte, essa “per il difetto di que-sta stessa sua qualità” non ammetteva la possibilità che operassero “altre forze” e“altre leggi”58. Da un lato viene dunque riconosciuto il valore del lascito positivi-sta, identificato nella necessità di una ricerca condotta all’insegna del razionalismoe dell’obiettività; dall’altro la consapevolezza dei limiti imposti da esso impongonoall’artista di espandere la conoscenza in direzione di altre energie.
Come avrebbero dichiarato l’anno successivo i firmatari del manifesto La scienzafuturista, i limiti della scienza tradizionale erano da ricondurre al fatto che essa in-sisteva nella “ricerca di nuove proprietà di vecchie sostanze”, anziché lanciarsi nel-l’esplorazione di “nuove energie [...] dotate di un grado di intelligenza superiore” cheavrebbero agito nel corso dei fenomeni di medianismo, psichismo, telepatia59. Sitrattava di “energie più complesse che sanno passare dai ragionamenti semplicissimidei motori a fluido (Tromelin, Fayol) alle cerebrazioni intricate di un gabinetto me-dianico”60.
Su quest’aspetto si concentrava dunque l’attenzione dei giovani futuristi fioren-tini per i quali la scienza, nello sforzo di ricondurre i fenomeni paranormali entro isicuri confini delle leggi fisiche e psichiche, in realtà non faceva altro che metterein luce l’esistenza di zone di realtà difficili da circoscrivere. E se si pensa ai feno-meni medianici, se è vero che da un lato essi contribuivano ad allargare i campidello scibile, in quanto la necessità di “spiegarli” portava ad elaborare nuove teorie,dall’altro sancivano l’esistenza di un più ampio orizzonte della realtà circostante. Daquesto presupposto partiva la loro critica alla scienza tradizionale, accusata di pre-tesa alla onniscenza. Ad essa i giovani della “pattuglia azzurra” contestavano l’osti-nazione a voler sistematizzare dei fenomeni che sfuggono a una categorizzazioneassoluta e attestano al contrario la complessità del reale, il “mistero che pullula nellanostra realtà”61.
Queste critiche alla scienza erano condivise, tra l’altro, da altre personalità delmondo culturale, come Giuseppe Prezzolini, il quale aveva messo in evidenza i li-miti di essa nei confronti di alcuni fenomeni difficilmente spiegabili con i mezzi asua disposizione62. Anche Capuana, alcuni anni prima, si era espresso in questosenso a proposito delle sedute medianiche, richiamandosi al naturalista inglese Al-fred Russell Wallace, per il quale i fenomeni non potevano essere giustificati chia-
57 Ibid.58 Ibid., p. 194.59 La scienza futurista, cit., p. 208.60 Ibid., p. 209. 61 Ibid., p. 206.62 Giuseppe Prezzolini, Leggenda e psicologia dello scienziato, in “Rivista di psicologia applicata
alla pedagogia ed alla psicopatologia”, Bologna, Stabilimento Poligrafico Emiliano, marzo-aprile 1907,p. 93.

La “pattuglia azzurra”: in esplorazione 61
63 Luigi Capuana, Spiritismo?, cit., p. 59. 64 Ibid., p. 63.65 La scienza futurista, cit., p. 207. 66 Bruno Corra, Sam Dunn è morto, cit., p. 9.67 La scienza futurista, cit., p. 207.
mando semplicemente in causa una qualche patologia dei medium o la loro inaffi-dabilità. Resta il fatto che “rimane sempre nello spiritismo una grande quantità difatti intorno ai quali la scienza non può ancora pronunziare la sua ultima parola”63.Una cosa era accertare i fatti, altra scoprirne le leggi e qui, secondo Capuana, lascienza ufficiale mostrava i propri limiti e le proprie inibizioni rifiutandosi, a causadei propri pregiudizi e “per paura di vedersi crollare sotto gli occhi gli edifizi scien-tifici penosamente costruiti” di aprirsi al “mondo invisibile che già picchia forte al-l’uscio dei laboratorii, gridando: son qui anch’io!”64. Quest’osservazione troveràeco in La scienza futurista, dove i firmatari si riferiscono alla scienza “passatista”come basata sul “desiderio sedentario [...] di sentirsi sicuri, al riparo delle sorprese,stabilmente piazzati”65.
Le discussioni affrontate nell’ambito dei documenti teorici trovano riscontroanche negli scritti creativi. Nel 1915 Corra scrive un romanzo incentrato su un per-sonaggio, Sam Dunn, detentore di misteriosi poteri occulti, la cui energia fantasticasconvolgerà il corso degli eventi. In esso lo scrittore ravennate fa riferimento alla“vecchia scienza idiotamente presuntuosa che sino ad oggi ha preteso di incatenarciin una tutela di minorenni ai quali si proibisce di lanciarsi nell’orgia di possibilitàche l’ignoto offre”66. Vi è dunque coerenza nella messa al bando della scienza tra-dizionale, paralizzata dai suoi schemi mentali. Tuttavia occorre fare luce sulle ap-parenti contraddizioni presenti nella posizione del gruppo, in quanto una ricercaguidata dal ragionamento, come quella auspicata da questi giovani futuristi, si deveavvalere di un metodo, e tuttavia essi muovevano delle accuse alla pretesa di siste-matizzazione della scienza. Ritengo che l’analisi degli scritti teorici porti a conclu-dere che non era la necessità di un sistema logico di ricerca e valutazione ad esseremessa in discussione, quanto gli obiettivi prefissi dalla scienza tradizionale e glistrumenti adottati a questo scopo.
Per quanto riguarda gli obiettivi, La scienza futurista auspicava l’avvento di unascienza animata da uno scopo del tutto inconsueto: “ingigantire sempre più l’ignotoprecisando e frastagliando la zona di realtà che ci è meno sconosciuta”; e ancora“approfondire la visione che gli uomini hanno del mondo in cui vivono, per arric-chirla di nuovi sbocchi verso l’ignoto; scandagliare il buio con fasci di luce semprepiù numerosi e più intensi per darci sempre più esattamente la sensazione della suainesauribilità”67. È evidente come queste espressioni richiamino una serie di oppo-sti appartenenti ai due campi semantici della luce e del buio, del noto e dell’ignoto.Ognuna di esse raffigura l’illuminazione di una zona con il solo effetto di rivelarnel’oscurità circostante, che però in questo modo si impone all’attenzione. Ciò che sirivela alla nostra conoscenza viene in qualche modo eclissato dall’emergere di unapiù vasta zona di realtà non ancora esplorata. Ciò non implica rinuncia alla ricercaintesa come impegno ad indagare i fenomeni, piuttosto consapevolezza del rapporto

62 Capitolo secondo
dialettico esistente tra noto e ignoto: non esiste punto solido che non lasci scorgereun vicino smottamento, un’acquisizione che non palesi al tempo stesso l’inesauri-bilità e la complessità del reale. Non ha senso quindi parlare di rapporto inversa-mente proporzionale tra conosciuto e ignoto, per cui ad una continua crescita delprimo corrisponde una costante decrescita dell’altro. Invero:
[...] lo slargamento continuo della nostra vita rende necessaria la creazione di una scienzafuturista audacemente esploratrice, sensibilissima, vibratile, influenzata da intuizionilontanissime, frammentaria, contraddittoria, felice di scoprire oggi una verità che di-strugga la verità di ieri, tutta inzuppata d’ignoto, tutta protesa sensitivamente verso ilvuoto che le sta davanti68.
Una scienza anticonvenzionale come questa deve mettere a punto degli strumentiche ben si prestino a questa funzione. Difatti, ai rigidi “metodi invariabili” dellascienza passatista, essi oppongono la messa a punto di “nuovi metodi di ricerca e diesposizione, nuovi strumenti di indagine e di espressione, più moderni, più liberi, piùintonati alla pluricomprensività dei fenomeni ch’è propria delle nostre sensibilitàvelocizzate”69. Ricerca ed esposizione scientifica si prefigurano “capricciose, pienedi svolte e di balzi, ineguali, burrascose, continuamente scardinate da scoppi dinuove intuizioni”70.
In Pittura dell’avvenire, dove scienza ed arte condividono la disposizione esplo-rativa verso “un nuovo e più largo ordine di idee”, Ginna vede l’arte come spazioespressivo per “nuovi organismi nati nella plastica plasmabilissima del pensieroumano, secondo l’intuizione sensibilissima di nuove possibilità”71. La domanda chesi pone a questo punto è: quali strumenti si prestano a questo percorso e come operano?
68 Ibid., p. 206. 69 Ibid., p. 208.70 Ibid.71 Arnaldo Ginna, Pittura dell’avvenire, cit., pp. 195-196.

III.
TRA ISTINTO E RAGIONAMENTO: STRUMENTI ESPLORATIVI
Nel capitolo precedente si è visto come l’esplorazione condotta dal secondo fu-turismo fiorentino vada collocata nel più ampio contesto scientifico-culturale ca-ratterizzante l’Europa a cavallo tra i due secoli. La rivoluzione industriale etecnologica aveva generato un clima di conquista verso quanto rimaneva di ine-splorato, sia sul piano fisico che su quello psichico. Da un lato la sfera scientifica,nella sua duplice componente tradizionale e sperimentale, dall’altro quella filoso-fico-spirituale, con l’apporto di filosofie e religioni orientali attente allo sviluppo difacoltà latenti, era tutto un protendersi verso nuovi orizzonti conoscitivi.
Sul piano letterario-artistico l’apporto di queste due sfere cognitive si traducevanell’elaborazione di una concezione estetica che, pur appellandosi al ragionamento,riconduceva la genesi del processo creativo a dinamiche altre da quelle imposte dalpensiero logico-consequenziale proprio del sapere scientifico. In questa parte ver-ranno analizzati alcuni scritti teorici in cui i protagonisti del secondo futurismo fio-rentino prendono in esame gli strumenti di cui dispone l’artista nell’esplorazionedella realtà ultrasensibile. Queste considerazioni verranno valutate nell’ambito delcontesto culturale e letterario dell’epoca, per capire a quali filoni sia lecito ricondurreil loro pensiero. Verranno quindi analizzate le affermazioni che si riferiscono alpiano su cui operano questi strumenti esplorativi.
Fin dai primi interventi apparsi su “La Difesa dell’Arte”1, e nella “Collezione disaggi critici”2, quindi ne “Il Centauro”3, e per finire in “Rivista”4, appare chiaro chegli strumenti di ricerca sono improntati al rigore scientifico. L’atto creativo va intesocome prodotto di energia cerebrale. Ne “La Difesa dell’Arte” Settimelli contestache l’arte sia un mistero o un qualcosa di indefinibile5. In polemica con un interlo-cutore (identificato solo come “signor Criscuoli”6), il quale sosteneva che l’opera
1 Rivista diretta da Virgilio Scattolini e pubblicata tra il novembre 1909 e il dicembre 1910.2 Diretta da Bruno Ginanni Corradini e Emilio Settimelli nel 1912.3 “Il Centauro” segue la “Collezione di saggi critici” e viene pubblicato tra il novembre 1912 e il feb-
braio 1913, diretto altresì da Bruno Ginanni Corradini e Emilio Settimelli. 4 “Rivista, settimanale d’arte, di scienza e di vita” (aprile-agosto 1913), è diretta dagli stessi autori. 5 Emilio Settimelli, La bestia umana, in “La Difesa dell’Arte”, a. II n. 17, Firenze, 15 maggio 1910, p. 2.6 Il sottotitolo riporta, in grassetto e tra parentesi, “risposta a molti signori in generale e al signor Cri-
scuoli in particolare”. Dall’articolo si capisce che il signor Criscuoli aveva scritto a Settimelli conte-stando la sua teoria.

d’arte non è suscettibile ad analisi ma si accetta o meno, in quanto va vista nel suo in-sieme, egli afferma: “Ma perché l’opera d’arte non si può analizzare? Che cos’è l’arteda non poter essere soggiogata dalla scienza? Deriva essa da cose ignote, è compostada cose ignote, non si può determinare? [...] L’arte è il prodotto del cervello”. E an-cora, più avanti: “L’opera d’arte è il prodotto del cervello, non è istinto! L’artistaquando scrive, pensa. No? E di cos’è composta una poesia? Di pensieri: non è un mo-vimento, una sensazione, è una concezione”7. Dunque “la bestia umana”, intesa comesopravvento degli impulsi istintivi, “muore, viene vinta”8, a favore della logica.
Questa posizione viene ribadita nella “Collezione di saggi critici”, dove nellostesso volume intervengono sia Corra che Settimelli in due saggi diversi. Toni sar-castici per Corra che, contestando la critica valutativa legata ad una concezione sog-gettiva, commenta: “I nostri poeti scrivono d’ispirazione, loro, quindi nessuna criticascientifica può valutarli, scrivono d’ispirazione, appena si mettono a tavolino sof-fiano e muggono, cantano e ruggono, diventano bestie insomma”9. Così non sia;l’artista, qualunque scelta espressiva faccia, “dimostri sempre di avere ingegno”10.
A tutela del carattere scientifico dell’arte interviene anche Settimelli nell’altro ar-ticolo, affermando che l’opera d’arte è pensiero e quindi ragionamento11. Questateoria è ulteriormente confermata ne “Il Centauro” dove si afferma: “L’arte è pen-siero. L’arte è cervello. [...] l’arte è una sola cosa con la scienza con tutto ciò che pen-siamo”12. In “Rivista” si legge altresì: “L’uomo non conosce se non ragionando eci bisogna accettare questo mezzo. E accettandolo, solo ciò che è scientifico e as-soluto. Facciamo quindi della scienza e non della metafisica”13. Ancora in “Rivista”,nell’ambito della polemica nei confronti del futurismo marinettiano già trattata nelprimo capitolo, Bruno Corra precisa la posizione del gruppo che oppone “alla de-crepita e sterile concezione dell’arte istintiva” la “nuova fecondissima e sicura con-cezione dell’arte cerebrale, scientifica”14.
Come si è visto, i limiti riscontrati nel futurismo marinettiano consistevano nelsuo carattere di imitazione e mancanza di innovazione. Imitazione nel ripercorrerele orme di un’arte soggettiva, quale quella attribuita al simbolismo. Già nella “Col-lezione di saggi critici”, a proposito della teoria valutativa dell’arte, parlando deisimbolisti, Corra aveva osservato che “creavano d’intuizione, affidandosi quasiesclusivamente alla loro sensibilità, senza rendersi ragione scientifica, senza ap-poggiarsi a idee ben nette [...]”15. E a sostegno della sua teoria adduceva il com-
64 Capitolo terzo
7 Ibid.8 Ibid., p. 3.9 Bruno Corradini, Il liberismo, in “Collezione di saggi critici”, vol. II, Bologna, Beltrami, 1912,
p. 142. 10 Ibid., p. 15311 Emilio Settimelli, La critica di Benedetto Croce, in “Collezione di saggi critici”, vol. II, Bolo-
gna, Beltrami, 1912, p. 68.12 Bruno Ginanni Corradini, Due parole franche a Sem Benelli, in “Il Centauro”, a. II, n. 5, Firenze,
9 febbraio 1913, p. 3.13 La redazione, Il nostro programma, in “Rivista”, cit., p. 1.14 Bruno G. Corradini, Il Futurismo spiegato e discusso (Il passatismo del Futurismo), in “Rivista”, cit.15 Bruno Corradini, Il liberismo, in “Collezione di saggi critici”, cit. p. 161.

mento dei critici sull’arte simbolista che “si sente ma non si capisce”16. A questo mo-dello Corra oppone quello di un’arte basata sul ragionamento. Da questo presup-posto parte quindi il biasimo al fondatore del futurismo per aver congedato i rapportilogici a cui fa invece ricorso l’energia cerebrale “più o meno grande, a seconda del-l’individuo, [...] per giungere con sicurezza ad un risultato”17.
La veemenza di queste affermazioni va collocata nell’ambito di un dibattito sca-tenato dall’intervento di Benedetto Croce su questioni di estetica. Nel numero 18-19 di “Rivista” compare un articolo di Settimelli intitolato Scienza crociana escienza (pardon!) mia. In questo documento Settimelli contesta il punto di vista delCroce, riallacciandosi a considerazioni già fatte ne “La Difesa dell’Arte” e nelloscritto La critica di Benedetto Croce, pubblicato nella “Collezione di saggi critici”.Settimelli osserva come il Croce, discutendo di estetica18, avesse operato una di-stinzione tra “conoscenza intuitiva” e “conoscenza logica”, cioè tra “conoscenzaper la fantasia” o “conoscenza per l’intelletto”, laddove la prima sarebbe produt-trice di immagini e la seconda di concetti19. Da questa premessa, aggiunge Setti-melli, il Croce “passa a dividere l’opera d’arte dall’opera scientifica, dicendo che laprima è opera di fantasia, la seconda di intelletto. La prima di intuizione, la secondadi pensiero”20. Per Settimelli, ciò equivale a negare che l’opera d’arte sia opera dipensiero21.
Contestando la teoria sopracitata, Settimelli afferma che la conoscenza umana èuna: essa non crea, nel senso che “nulla sorge dal nulla”, secondo quanto già avva-lorato da Lucrezio e confermato da molti secoli di esperienze, ma è “produttrice discoperte”. Infatti, “se palesa a sé e agli altri una cosa che esiste e che rimane sino almomento della rivelazione ignorata, in uno stato relativo a noi di inesistenza, vuoldire che scopre”. Ciò avviene grazie al ragionamento. La conoscenza umana è dun-que data dal ragionamento22. Settimelli aveva già spiegato sulla rivista di Scattoliniche il pensiero, unico di costituzione, assume tuttavia caratteri differenziati e operasu terreni diversi. Esiste pertanto il pensiero filosofico, quello rappresentativo e ilpensiero poetico. Quest’ultimo “trasforma immaginosamente l’universo” e lo fa“scoprendo la somiglianza di una cosa con un’altra”23. Che questa forma di pen-siero sia comunque ragionamento viene ribadito in “Collezione di saggi critici” doveSettimelli afferma: “L’opera d’arte non è se non ‘pensiero’, il pensiero è ragiona-
Tra istinto e ragionamento: strumenti esplorativi 65
16 Ibid., p. 142.17 Bruno G. Corradini, Il Futurismo spiegato e discusso (Il passatismo del Futurismo), in “Rivista”, cit.18 Al principio dell’articolo Settimelli cita il testo crociano Teoria dell’estetica scienza del-
l’espressione. Il titolo completo del testo è Estetica come scienza dell’espressione e linguistica gene-rale, Bari, Laterza, 1902. A questo seguirà Problemi di estetica e contributi alla storia dell’esteticaitaliana, Bari, Laterza, 1910.
19 Emilio Settimelli, Scienza crociana e scienza (pardon!) mia, in “Rivista”, a. I, n. 18-19, Firenze,10 agosto 1913, p. 1.
20 Ibid.21 Ibid., p. 2.22 Ibid., p. 1 23 Emilio Settimelli, La seconda parte del nuovo sistema di critica, in “La Difesa dell’Arte”, a. II,
n. 22-23, Firenze, 19-26 giugno 1910, p. 1.

mento, e il ragionamento opera per via di raffronti ed ha per risultato la scoperta”24.La fruizione si avvale essa pure del ragionamento, in quanto “Capire vuol dire
rifare per conto nostro i ragionamenti di un altro: ragionare. Se dunque l’opera d’artenon fosse opera del ragionamento, come la si potrebbe capire? Se le opere d’arte nonfossero un fatto intellettivo, sarebbero come il discorso di un pazzo che non si com-prende”25. L’impressione che dà l’arte è un riflesso di questa e cambia a seconda del-l’individuo, mentre “Il ragionamento c’è e c’è sempre per tutti gli individui”26,sostiene Settimelli. In “Collezione di saggi critici” anche Corra interviene sulla que-stione affermando: “Noi rinneghiamo quella critica personale, soggettiva, intuitiva,che espone un’opera d’arte a essere esaltata o vituperata a seconda del buono o delcattivo umore”27. Alla critica legata a impressioni soggettive, a un’affermazionequale “questo mi piace” si contrappone l’oggettività di una dichiarazione quale “que-sto ha valore”28.
A sostegno del concetto di un’unica conoscenza umana si pone altresì l’inter-vento di un medico dal nome Luciano Luziani, il quale firma un articolo su “Rivi-sta” dal titolo Benedetto Croce-Ohime-Scienziato29. La pertinenza della prospettivamedica in una questione che riguarda il campo artistico è giustificata, secondo ildottor Luziani, dalle stesse premesse scientifiche poste da Settimelli nei suoi inter-venti. In questo articolo egli ribadisce che la differenziazione operata dal Croce traconoscenza intuitiva e conoscenza logica non è avallata dalla scienza medica, per laquale la conoscenza umana è unica. Non ha senso parlare di due diverse forme diconoscenza, in quanto esse godono delle stesse proprietà e sono il prodotto dell’ac-cordo più o meno ordinato di diversi concetti semplici. Come afferma il Luziani,“l’uomo non inventa, scopre; combina nelle maniere più disparate e più numerose,a seconda della quantità e della qualità delle sue cellule e fibre cerebrali dei centriintellettivi, quello che i sensi gli hanno portato e che egli, per dire una frase impro-pria, ha immagazzinato nel cervello”30.
Tuttavia, ad un’attenta lettura degli interventi pubblicati nelle testate successive,risulta che la rigida posizione assunta verso la “bestia umana” sulle pagine de “LaDifesa dell’Arte”, viene mitigata. Già a partire dalla “Collezione di saggi critici”, altermine dell’arringa in difesa dell’arte-ingegno, per cui bisogna combattere le im-pressioni e i sentimenti nemici di una valutazione obiettiva, Settimelli osserva: “Conquesto io non voglio cancellare la passione, la bestia umana (e chi lo potrà?), ma vo-glio limitarla, voglio respingerla dal ragionamento, non voglio che turbi le serene,superiori concezioni dell’intelletto”. E conclude: “Fin dove ragionare? Fin dove‘sentire’? È il problema”31. Viene dunque riconosciuta questa componente, da porre
66 Capitolo terzo
24 Emilio Settimelli, La critica di Benedetto Croce, in “Collezione di saggi critici”, cit., p. 68.25 Emilio Settimelli, Scienza crociana e scienza (pardon) mia, in “Rivista”, cit., p. 2.26 Ibid.27 Bruno Corradini, Il liberismo, in “Collezione di saggi critici”, cit., p. 147.28 Ibid.29 Luciano Luziani, Benedetto Croce-Ohimé-scienziato, in “Rivista”, a. I n. 2, Firenze, 13 aprile
1913, pp. 4-5.30 Ibid., p. 4.31 Emilio Settimelli, La critica di Benedetto Croce, in “Collezione di saggi critici”, cit., p. 99.

tuttavia sotto tutela dell’intelletto. Un’ulteriore elaborazione avviene nell’articolo introduttivo de “Il Centauro”
dove il gruppo elegge a simbolo rappresentativo del nucleo la figura mitologica delcentauro, “l’essere che è insieme uomo e bestia, che raffigura materialmentel’unione dell’intelligenza con la passionalità”, connubio di intelligenza ed istinto.Come spiega Corra, ad una fase precedente in cui il gruppo aveva negato la “bestiaumana” per affermare che “l’uomo deve essere ragionamento” seguiva la consape-volezza dell’esistenza di quella parte istintiva e nella lotta tra il ragionamento el’istinto veniva individuato “uno dei maggiori e più immanenti problemi umani”32.
Il rapporto tra queste due forze va incontro a successivi sviluppi teorici. In Pit-tura dell’Avvenire Arnaldo Ginna così spiega a quali strumenti fa ricorso l’artista:
Ma l’artista, sappiamo, fu sempre l’esploratore formidabilmente potente dei segreti dellanatura. L’intuizione e la sensibilità degli artisti, di tutte le epoche divinò quello che moltopiù tardi la scienza conchiuse. Con questo non voglio dire che l’arte sia il prodotto della facoltà chiamata intuizione eistinto piuttostoché di un’altra chiamata ragionamento e intelligenza. Lontano dal ca-dere come molti nell’errore di dividere troppo le facoltà umane dirò chiaro che noi cre-diamo soltanto nella genialità, facoltà creativa che si esplica coscientemente osubcoscientemente.Perciò se l’arte può antidivenire la scienza non vuol dire che questa usi dei mezzi diffe-renti da quelli usati dall’arte.Gli scienziati hanno un metodo ristretto di considerazioni e di scoperta: pedanteria pro-fessionale più che mai insita nello studio della matematica, della fisica, della chimica, del-l’astronomia ecc.33.
Questo estratto contiene delle dichiarazioni importanti. In base alle affermazionidi Ginna, all’artista viene riconosciuta la facoltà chiamata “intuizione e istinto” gra-zie a cui aprirsi un varco nei segreti della natura. Tale facoltà non deve essere vistacome del tutto separata dall’altra rappresentata da “ragionamento e intelligenza”, inquanto entrambe concorrono all’espressione della genialità. Pur chiamando in causal’istinto, grazie al quale divinare e aprirsi un varco, viene ribadito lo statuto scien-tifico della ricerca futurista, che va a corroborare quanto emerso nell’esercizio del-l’altra facoltà. Difatti, quando nella frase successiva Ginna afferma, a proposito dellascienza: “non vuol dire che questa usi dei mezzi differenti da quelli usati dall’arte”intende fare riferimento a questo comune terreno rappresentato dal ragionamento.E tuttavia Ginna opera un distinguo tra “mezzi” e “metodo”. Pur avvalendosi di unmezzo comune, la scienza si discosta dall’arte nell’applicazione di questo mezzo,cioè nel metodo seguito: un metodo “ristretto di considerazioni e di scoperta”.
In questo passaggio Ginna non mette a confronto il metodo della scienza tradi-zionale con quello auspicato dai futuristi fiorentini, ma nel manifesto La scienza fu-turista, dell’anno successivo, i firmatari dedicano più spazio a questa divergenza,opponendo ai “metodi invariabili” della scienza passatista la messa a punto di “nuovi
Tra istinto e ragionamento: strumenti esplorativi 67
32 Bruno Ginanni Corradini, Il liberismo, in “Il Centauro”, cit. 33 Arnaldo Ginna, Pittura dell’avvenire, cit., p. 192.

metodi di ricerca e di esposizione, nuovi strumenti di indagine e di espressione, piùmoderni, più liberi, più intonati alla pluricomprensività dei fenomeni che è propriadelle nostre sensibilità velocizzate”34. Bisogna dunque capire come il ragionamentopossa mettersi al servizio di questo tipo di indagine e quale sia l’interazione di que-st’ultimo con l’istinto. Il chiarimento è necessario vista la posizione critica prece-dentemente assunta dal gruppo verso l’istinto, associato al dominio animale,sprovvisto di pensiero. Su quali basi avviene questo recupero e come si concilia conla concezione cerebralista dell’arte?
A questo scopo è utile fare riferimento al filosofo francese Henri Bergson inquanto, nel corso dei suoi scritti, egli dedica molte riflessioni all’istinto, visto comestrumento cognitivo. Il riferimento è pertinente in quanto l’influenza di Bergson sulmovimento futurista è stata ampiamente riconosciuta. Nella lettera di Enrico Pram-polini a Bino Sanminiatelli datata 03 febbraio 1917, Prampolini menziona lo scrittodi Bergson Filosofia dell’Intuizione del 1911 “da dove poi i futuristi trassero granparte dei concetti che svolsero in poesia e in arte”35. Del resto Bergson presentòquesto saggio proprio in Italia, nell’ambito del congresso filosofico tenutosi a Bo-logna il 10 aprile 1911.
La diffusione del pensiero bergsoniano passa anche attraverso la rivista “Leo-nardo”. Nell’agosto del 1907 compare una recensione di Papini a L’evoluzione crea-trice, libro che egli considera degno di tutte le precedenti opere bergsoniane e “unodei più belli usciti negli ultimi tempi”36. Papini ne raccomanda la lettura “a tutti co-loro che provano ancora una certa voluttà nel pensare le bellissime pagine sull’élanvital, sull’idea di disordine, sull’istinto e sull’intelligenza, sul divenire [...]”37. Pre-sentando un estratto del libro, Papini commenta come l’intelligenza, immaginatageneralmente come la cosa più elevata e universale, non sia per Bergson che unacomponente della realtà, non idonea a “internarsi nel movimento incessante e con-tinuamente nuovo del pensiero e della vita”38. L’intuizione – osserva Papini – è vistadal filosofo francese come mezzo che consente di avvicinarsi maggiormente al realee “anche non riuscendo a sentirlo tutto, intravederne abbastanza per negare che lapseudorappresentazione che ne dà la scienza sia la sola possibile”39. È opportunodunque risalire alla fonte diretta per capire meglio come si snodi il rapporto tra in-telligenza e istinto.
Al centro della filosofia bergsoniana vi è una concezione della vita basata su di-versi piani conoscitivi. Tra questi va individuata una dimensione spirituale della re-altà, che sottende quella materiale e partecipa di un principio vitalistico simile aquello del mondo dell’interiorità. Nello scritto del 1907 L’evoluzione creatrice egli
68 Capitolo terzo
34 La scienza futurista, cit., p. 208.35 In Archivi del Futurismo, vol. II, raccolti e ordinati da Maria Drudi Gambillo e Teresa Fiori,
Roma, De Luca Editore, 1962, p. 53.36 Giovanni Papini, Alleati e nemici. L’evoluzione creatrice. H. Bergson, L’évolution créatrice,
Paris, F. Alcan, 1907, in “Leonardo: rivista d’idee”, a. V, serie 3, Firenze, Agosto 1907, p. 307.37 Ibid.38 Ibid., p. 306.39 Ibid., pp. 306-307.

parla di “intelligenza” e “istinto” come di due diversi sistemi dell’attività psichica,opposti e allo stesso tempo complementari, nel senso che l’una e l’altro sono fa-coltà preposte all’interazione degli esseri viventi con la realtà, per quanto operinoin modo diverso. Mentre l’istinto si avvale di strumenti naturali già organizzati, l’in-telligenza “è la facoltà di fabbricare oggetti artificiali e in particolare utensili attia produrre altri utensili”40. L’istinto opera prevalentemente in maniera inconscia,l’intelligenza in modo cosciente.
Per capire meglio come si snodi il discorso, occorre fare un passo indietro, al sag-gio del 1903 Introduzione alla metafisica, dove il filosofo aveva dedicato molte ri-flessioni al rapporto tra “analisi” e “intuizione”. Partendo dal presupposto che lavita è movimento, divenire, continuo sviluppo, Bergson ritiene l’analisi insufficientea cogliere questo flusso, a motivo della sua abitudine a procedere secondo un’ “ope-razione che riporta l’oggetto a elementi già conosciuti, vale a dire comuni a questooggetto e ad altri”41. Per il filosofo, analizzare consiste dunque in “una rappresen-tazione presa da punti di vista successivi, da cui si segnano altrettanti punti di con-tatto tra l’oggetto nuovo, che si è incontrato, e altri che si crede già di conoscere”42.Così facendo, l’analisi estrae gli elementi della realtà dal loro flusso vitale e li isola,per poi esaminare il rapporto che esiste tra loro secondo un rigido processo di sche-matizzazione. Questo è il modo di procedere della scienza positiva. Partendo daisingoli elementi, l’indagine analitica elabora concetti, fornendo però una rappre-sentazione della realtà statica e artificiale, in quanto essi simbolizzano alcuni aspettigenerali e, dunque, impersonali. I diversi concetti che indicano le proprietà di unacosa tracciano attorno ad essa tanti cerchi più larghi, che la includono ma non le siadattano perfettamente43.
Il modus operandi dell’intuizione, d’altra parte, consiste nel porsi nel cuore dellarealtà anziché adottare dei punti di vista su di essa. L’intuizione coglie l’oggetto nellasua sintesi, unicità, essenza, nel divenire del suo flusso vitale e con esso stabilisce unrapporto di “simpatia”. Afferma Bergson: “Chiamiamo qui intuizione quella simpa-tia per cui ci si trasporta all’interno di un oggetto, in modo da coincidere con ciò cheesso ha di unico e, per conseguenza, di inesprimibile”44. Non si tratta di negare ilconcetto, quanto di spogliarlo della sua rigida connotazione attribuitagli dall’uso e daisui fini pratici e di dissolverlo in rappresentazioni “agili, mobili, fluide quasi, sem-pre pronte a modellarsi sulle forme fuggevoli dell’intuizione”45. Più avanti ribadisceche si tratta di “concetti fluidi, capaci di seguire la realtà in tutte le sue curve e di adot-tare il movimento stesso della vita interna delle cose”46. Secondo il filosofo, questorapporto di simpatia si attua nell’intuizione estetica, grazie a cui l’artista penetra al-
Tra istinto e ragionamento: strumenti esplorativi 69
40 Henri Bergson, L’evoluzione creatrice (prima edizione in francese, 1907), trad. Fabio Polidori,Milano, Cortina, 2002, p. 117.
41 Henri Bergson, Introduzione alla metafisica (“Revue de métaphysique et de morale”, Janvier1903), in Pensiero e movimento, trad. Francesca Sforza, Milano, Bompiani, 2000, p. 151.
42 Ibid., p. 152. 43 Ibid., p. 157.44 Ibid., p. 151.45 Ibid., p. 158.46 Ibid., p. 179.

l’interno dell’oggetto47. E tuttavia, pur svolgendo funzioni diverse, i due strumenti non sono del tutto estra-
nei l’uno all’altro: l’intuizione viene infatti vista come fase evolutiva dell’istinto che,sotto l’impulso dell’intelligenza, diventa “disinteressato, cosciente di sé, capace di ri-flettere sul proprio oggetto e di estenderlo all’infinito”48. Come spiega Bergson: “Nonc’è intelligenza in cui non si scoprano tracce di istinto, né, soprattutto, istinto chenon sia contornato da una frangia di intelligenza”49. Attraverso questo processo di svi-luppo, l’istinto ottiene la capacità di ampliare il suo campo di interesse e la coscienzapropria dell’intelligenza conservando, allo stesso tempo, la capacità di seguire la cor-rente della vita. Per quanto l’intuizione trascenda l’intelligenza, da questa riceve l’im-pulso ad evolvere in uno stadio superiore rispetto a quello istintivo50. Si può pertantoparlare dell’intuito come di “un istinto conscio, rifinito, spiritualizzato”51.
Riportando il discorso al secondo futurismo fiorentino, osserveremo che nella ri-vista “Il Centauro” Bruno Corra vede il cammino dell’arte svolgersi lungo un trac-ciato che va “dall’incosciente al cosciente, dall’istintivo al volontario, dall’animaleallo spirituale”52. E Remo Chiti, riflettendo sull’arte in Misteri Michelangioleschi, de-finisce l’arte un “istinto della ragione”53. Per capire come venga vista l’interazionetra istinto e ragionamento occorre ripercorrere alcune tappe del pensiero futurista.Dal momento che Marinetti è polemicamente chiamato in causa dallo stesso Corrasul rapporto che intercorre tra queste due facoltà, è opportuno riassumere quanto ela-borato dal fondatore del futurismo nel Manifesto tecnico della letteratura futurista.
In esso, il fondatore e capo carismatico del futurismo elogia “la divina intuizione”,invitando ad afferrare l’essenza della materia “a colpi di intuizione, la qual cosa nonpotranno mai fare i fisici né i chimici”. E a questa oppone “il piombo della logica”,mettendo in guardia i poeti dal farsi condizionare da quest’ultima nella costruzionedelle reti di metafore e invitandoli quindi a “odiare l’intelligenza”54. Tre mesi dopoarriva Risposte alle obiezioni55, fioccate numerose e da più parti in seguito alla pub-blicazione del manifesto. Innanzitutto, ribattendo a quanti avevano voluto vederenelle sue osservazioni l’influenza di Bergson, Marinetti ricorda come invece già inun poema del 1902 avesse citato Dante56, il quale nell’XI canto del Paradiso avevaparlato di “difettivi sillogismi” che “ti fanno in basso batter l’ali”. E aggiunge una
70 Capitolo terzo
47 Henri Bergson, L’ evoluzione creatrice, cit., p. 147.48 Ibid. 49 Ibid., p. 114.50 Ibid., p. 148.51 Henri Bergson, Life and consciousness, conferenza tenuta all’università di Birmingham il 29
maggio 1911, poi pubblicata in “Hibbert Journal”, Oct.,1911. Trad. della sottoscritta.52 Bruno Corra, Strauss il funambulo, in “Il Centauro”, a. II, n. 1, Firenze, 12 gennaio 1913, p. 4.53 Remo Chiti, Misteri Michelangioleschi (indagini intuitive), in “Il Centauro”, a. I n. 2, Firenze,
10 novembre 1912, p. 1.54 F.T. Marinetti, Manifesto tecnico della letteratura futurista, cit., pp. 50-54. I caratteri in neretto
sono dell’autore. 55 F.T. Marinetti, Risposte alle obiezioni, supplemento al Manifesto tecnico della letteratura futu-
rista, 11 agosto 1912, ora in F.T. Marinetti, Teoria e invenzione futurista, cit., pp. 55-59.56 Si riferisce a La Conquête des Étoiles. F.T. Marinetti, Risposte alle obiezioni, ibid., p. 55.

citazione di Edgar Allan Poe sulla “ragione inferma e solitaria”57. Dunque, con-clude, questi due geni creatori coincidono col suo genio “affermando nettamente illoro odio per l’intelligenza strisciante, inferma e solitaria e accordando al contrariotutti i diritti all’ immaginazione intuitiva e divinatrice”58.
A questa precisazione segue una spiegazione che tende a smorzare i toni della po-lemica. Egli afferma infatti: “Quando parlo d’intuizione e di intelligenza non in-tendo già parlare di due dominii distinti e nettamente separati. Ogni spirito creatoreha potuto constatare, durante il lavoro di creazione, che i fenomeni intuitivi si fon-devano coi fenomeni dell’intelligenza logica. È quindi impossibile determinare esat-tamente il momento in cui finisce l’ispirazione incosciente e comincia la volontàlucida”59. E cercando di fare chiarezza osserva: “Per intuizione, intendo dunque unostato del pensiero quasi interamente intuitivo e incosciente. Per intelligenza, intendouno stato del pensiero quasi interamente intellettivo e volontario”60. Dunque, in basea queste affermazioni, l’intuizione appartiene alla sfera inconscia mentre l’intelli-genza a quella conscia, e tuttavia non costituiscono dominii distinti e nettamenteseparati, anzi, essi si fondono nel processo creativo.
Per certi versi sembra che questa posizione non sia poi sostanzialmente diversarispetto a quella formulata da Ginna nel testo sulla pittura. Pronunciandosi controla netta distinzione delle facoltà umane, Ginna aveva visto intuito ed istinto da unlato, ragionamento ed intelligenza dall’altro concorrere nel processo creativo. Tut-tavia, come emerge da una valutazione di altri estratti, presso il gruppo fiorentino ildiscorso viene sviluppato con più sistematicità ed evolve in una direzione che portala “pattuglia azzurra” ad assumere una posizione innovativa ed originale.
È di Corra l’ipotesi che segna una svolta nel dibattito sul rapporto tra intuito eragionamento. In un articolo di grande interesse, dallo stile che oscilla tra il diari-stico e il teorico, Corra apre una breccia avviando una discussione a cui si inneste-ranno successivi interventi teorici.
Egli afferma:
Voglio dare un’analisi quanto più sia possibile completa della coscienza umana. Se arri-verò a descrivere il contenuto di una coscienza d’uomo, a dimostrare che questo conte-nuto è tutto composto di elementi ricavati sperimentalmente dal mondo e a rendereevidente l’identità essenziale del sentimento e del ragionamento, dell’intuizione e delsillogismo avrò fatto parecchie cose utili al nostro movimento61.
Viene dunque ventilata l’ipotesi di una “identità essenziale” tra le due facoltà.Tuttavia, alla luce di altre affermazioni, risulta chiaro che quest’equivalenza ha sensoa patto che si riveda il concetto di sillogismo nella sua accezione scientifico-conse-quenziale. Difatti più avanti nell’articolo, parlando di ricordi di infanzia, Corra fa ri-
Tra istinto e ragionamento: strumenti esplorativi 71
57 Nel Colloquio fra Monos e Una, ibid.58 Ibid.59 Ibid., pp. 55-5660 Ibid., p. 56.61 Bruno Ginanni Corradini, Leggenda, in “Il Centauro”, a. I, n. 8, Firenze, 22 dicembre 1912, p. 1.

ferimento a “nuovi rapporti logici più elastici e più misteriosi”62. Qualche mesedopo, nel già citato intervento sul futurismo marinettiano, Corra riprende il discorsocommentando le dichiarazioni di Marinetti sulla messa al bando dell’intelligenza afavore dell’intuizione. Nel corso della discussione, Corra mette in dubbio il princi-pio per cui “il ragionamento non possa non essere calmo, lento, freddo”63. Anche seCorra non sviluppa il discorso in questo contesto e non delucida quanto affermato,è evidente che il suo pensiero va alla concezione di un ragionamento che non ri-sponde agli attributi prima elencati (“calmo, lento, freddo”). Alla luce di altre di-chiarazioni precedenti e posteriori, si profila la posizione del gruppo sullaconcezione di un ragionamento soggetto a dinamiche altre rispetto a quelle del ra-gionamento scientifico inteso in senso tradizionale.
In un intervento di qualche anno prima un altro futurista del gruppo, Mario Carli,già rivendicava il diritto ad una “logica” di tipo diverso: quella “intima, misteriosa,bizzarra del pensiero” portato a “balzare velocemente, quasi a furia, verso i punti piùdistanti, e non è mai possibile porre un freno ai suoi salti”64. Il più elevato atto crea-tivo si realizzerebbe proprio in seguito ad una deviazione dalla “linea diritta e ra-zionale del pensiero” quando, attraverso la “pura facoltà intuitiva”, il pensieroprocede per “voli pindarici”, i quali non sarebbero altro che “passaggi rapidi delpensiero da una cosa all’altra”65.
Due diversi modelli di pensiero emergono da questo articolo: il pensiero lineareche congiunge un punto ad un altro in maniera consequenziale e un altro tipo dipensiero, portato a saltare di palo in frasca secondo un percorso fatto di “deviazioni,spezzature, aneuritmie, che costituiscono la vera vita profonda del pensiero”66. Que-st’ultimo è indotto dalla facoltà intuitiva. Esso pure è espressione di un’attività ce-rebrale, in quanto “nessuna cosa è in noi più viva che il cervello, organo centrale divita, unico e più valido informatore d’ogni nostra attività”67. Se accostiamo questeriflessioni alle affermazioni di Settimelli sull’opera d’arte vista come opera di pen-siero, è evidente che il riferimento è a questo genere di pensiero, fecondato da in-tuizione, in grado di esprimere il dinamismo futurista inteso come incessantesvolgimento della vita interiore, di dare voce a quelle “sensibilità velocizzate” dicui parleranno gli autori de La scienza futurista.
A conferma di questa tesi vanno le dichiarazioni di Corra e Settimelli, i qualispiegano nel manifesto Pesi, misure e prezzi del genio artistico che “L’intuizionenon è altro che un ragionamento frammentario e più rapido; tra ragionamento ed in-tuizione non c’è diversità essenziale e quindi ogni prodotto dell’una è controllabilecon l’altro”68. Rispetto a quanto elaborato dal futurismo marinettiano, si assiste dun-
72 Capitolo terzo
62 Ibid.63 Bruno G. Corradini, Il Futurismo spiegato e discusso (Il passatismo del Futurismo) in “Rivista”,
cit.64 Mario Carli, Tesi di un’arte nuova, in “La Difesa dell’Arte”, a. II, n. 22-23, Firenze , 19-26 giu-
gno 1910, p. 3.65 Ibid.66 Ibid., p. 4.67 Ibid., p. 3.68 Bruno Corradini – Emilio Settimelli, Pesi, misure e prezzi del genio artistico, cit., p. 172.

que ad una reinterpretazione dell’intuizione in chiave cerebralista: essa non è altroche un tipo di ragionamento. Quando gli autori del manifesto dichiarano che “tra ra-gionamento ed intuizione non c’è diversità essenziale” si riferiscono al fatto che leproprietà logiche sottendono il modo di procedere dell’una come dell’altro, e la dif-ferenza consiste appunto nel percorso, nel modus operandi. Ciò emerge del restonel manifesto La scienza futurista, dove, come si è visto, l’attacco alla scienza uf-ficiale avveniva proprio sul terreno del metodo. Non è il carattere cerebrale della ri-cerca ad essere messo in discussione.
Se si colloca questa trattazione nell’ambito delle polemiche suscitate dalla teo-ria crociana su questioni di estetica, il significato di questi interventi emerge in tuttala sua portata. Per il nucleo fiorentino la teoria crociana aveva posto, da un lato, laconoscenza intuitiva e, dall’altro, la conoscenza logica. Alla seconda era legata laproduzione intellettiva e concettuale. Contestare questa teoria affermando, al con-trario, l’equivalenza dell’intuizione e del ragionamento e precisando che “ogni pro-dotto dell’una è controllabile con l’altro” significava porre il ragionamento a garantedella validità intellettuale del prodotto artistico e dare a quest’ultimo statuto uni-versale e imperituro. Alla luce di queste considerazioni si capisce anche come, die-tro il veemente attacco di Corra a Marinetti per avere privilegiato l’intuizione ascapito del ragionamento69, posizione che secondo Corra rinverdiva la vecchia con-cezione dell’arte istintiva, ci fosse la preoccupazione di salvaguardare la validità delprodotto artistico.
L’enfasi data al carattere scientifico del processo creativo viene ribadita ancorauna volta nella corrispondenza Corra-Settimelli, in cui il primo afferma di averepreparato del materiale per il manifesto La scienza futurista, precisando: “Così ac-centueremo di più la nostra posizione di ragionatori del futurismo”70. In un’altralettera egli fa inoltre appello alle loro qualità di “genialità cosciente e lucida abi-lità”71.
Il richiamo allo stato cosciente sollecita una riflessione sul rapporto che inter-corre tra questo e la dimensione inconscia nel processo creativo. Ricorderemo inbreve la posizione marinettiana e vedremo quali sviluppi assume la discussionepresso la “pattuglia azzurra”. Come si è visto, nel Manifesto tecnico della lettera-tura futurista Marinetti riconduce lo stato intuitivo del pensiero alla sfera dell’in-conscio. A questo viene contrapposto il carattere volontario dell’intelligenza.Tuttavia, essi non costituiscono “dominii nettamente separati”, in quanto sono com-presenti nell’atto creativo, che si affida tanto all’ “ispirazione incosciente” quantoalla “lucida volontà”, al punto da non potere stabilire il momento in cui finisce l’unae inizia l’altra. Nel processo creativo si assiste infatti ad una fusione tra “fenomeniintuitivi” e “fenomeni dell’intelligenza logica”72.
Tra istinto e ragionamento: strumenti esplorativi 73
69 Bruno Ginanni Corradini, Il Futurismo spiegato e discusso (Il Passatismo del Futurismo), in “Ri-vista”, cit.
70 Ravenna, 19 febbraio, s.a., Fondazione Primo Conti onlus, Fiesole, Fondo Settimelli, Corri-spondenza B. Corra-E. Settimelli.
71 Pesaro, 5 luglio, s.a.72 F.T. Marinetti, Manifesto tecnico della letteratura futurista, cit., p. 56.

Passando ai giovani della “pattuglia azzurra”, si noterà come, sotto l’influenzadelle letture teosofiche, venga elaborato il concetto di “subcoscienza cosciente”73. ÈArnaldo Ginna a spiegare in cosa consista nella sua trattazione sulla Pittura dell’av-venire. Parlando della condizione in cui si deve porre l’artista nel suo processo esplo-rativo egli afferma quanto segue:
L’artista e l’inventore devono sviluppare enormemente il subcosciente. Lo stato di sub-co-scienza non è affatto incoscienza, ma invece coscienza superiore; è coscienza e cono-scenza di un vero più lontano, più nascosto ed occulto74.
Nel capitolo precedente abbiamo osservato come il pensiero teosofico e gli scrittidi Rudolf Steiner abbiano influenzato Ginna e compagni, secondo quanto affermatodagli stessi appartenenti al gruppo, riscontrato nel fondo bibliotecario dei Ginanni Cor-radini e confermato da Mario Verdone. Per la verità Ginna, che pure ha affermato diavere seguito, insieme a suo fratello, le conferenze della società teosofica e di leggerecon grande interesse i libri dei principali teosofi dell’epoca, il cui pensiero spesso rias-sumeva in fitti quaderni di appunti75, ha poi dato ad intendere in Pittura dell’avveniredi non essere del tutto padrone di queste teorie:
Io non so se sia vera la teoria della filosofia-psicologica-religiosa indiana che ammette altrimondi compenetranti nel nostro terreno. Non so se sia realtà o immaginazione il pianoastrale, il piano mentale, e il piano Buddico...Io non so neanche ammettere la teoria teosofica così vasta complicata e particolareggiata seb-bene io, al dire di molti occultisti credenti, sia già penetrato in questi mondi.Dal primo giorno in cui cominciai a vedere, come dicono i teosofi e gli occultisti, volli di-segnare dipingere e fermare sulla carta e sulla tela queste visioni76.
Pur non essendo certo di afferrare del tutto la teoria teosofica, Ginna abbraccial’idea dell’esistenza di una dimensione spirituale interna alla realtà, un “vero più lon-tano, più nascosto ed occulto” rispetto a quanto percepito dai sensi ordinari e indivi-dua in un livello di coscienza più profondo, la sub-coscienza, la chiave di accesso aquesta realtà. Ciò era in sintonia con il percorso indicato dal sistema teosofico, per ilquale il cammino che conduce alla conoscenza della realtà ultrasensibile sottrae l’es-sere all’influenza della coscienza ordinaria e lo pone in uno stato di coscienza supe-riore nel quale raggiunge uno stato di assoluta concentrazione spirituale. Questo tipodi cognizione supersensibile consente di afferrare esseri e fatti spirituali non acces-sibili ai sensi ordinari. Secondo Steiner, oltre la conoscenza basata su quanto perce-pito dai sensi ordinari esistono infatti livelli cognitivi più elevati, grazie ai qualipercepire le emanazioni di realtà spirituali: l’Immaginazione, l’Ispirazione e l’Intui-zione. Lo stadio cognitivo più elevato sarebbe appunto quello rappresentato dall’In-
74 Capitolo terzo
73 Arnaldo Ginna, Pittura dell’avvenire, cit., p. 201.74 Ibid., p. 200.75 Alcuni di questi appunti sono citati da Mario Verdone nel saggio Ginna e Corra, in “Il lettore di
provincia”, a. 18, n. 69, settembre 1987, pp. 69-80.76 Arnaldo Ginna, Pittura dell’avvenire, cit., pp. 200-201.

tuizione, attraverso cui penetrare nell’intima essenza di queste realtà77. In un saggio sui fratelli Ginanni Corradini, Verdone riporta altre riflessioni di
Ginna che sembrano fare da appendice a quanto espresso nel testo sulla pittura echiariscono in che modo lo stato di “subcoscienza cosciente” rappresenti un gra-dino successivo e più evoluto rispetto a quello medianico:
Gli antichi avevano sviluppato il senso di penetrazione sul piano spirituale. Lo facevanoin uno stato incosciente, come medium che cadono in “trance”. L’evoluzione porta ad ac-quistare coscienza di questo stato, e noi dobbiamo cercare di seguire ed aiutare l’evolu-zione in questo senso, senza perdere la forza di penetrazione, anche secondo gliammaestramenti di Rudolf Steiner. Il quale affermava che la nostra epoca deve esserecosciente nell’incoscienza. Non ci possono essere più medium incoscienti. Dobbiamoessere medium coscienti. Ecco perché, nei miei quadri, la coscienza si mescola all’inco-scienza e, nei racconti, come in “Strano e documentato racconto di Arnaldaz”, la realtàsi mescola al sogno78.
Queste riflessioni si riallacciano a quelle di Corra sul cammino dell’arte. Si ri-cordi che, in un articolo sul musicista Strauss già citato, Corra vede l’arte avviatalungo un percorso evolutivo: “dall’incosciente al cosciente, dall’istintivo al volon-tario, dall’animale allo spirituale”79. Il concetto di evoluzione nel pensiero futuristaè fondamentale e sta ad indicare che ogni fase è soggetta a svolgimento e supera-mento sulla scala evolutiva. Il gruppo, in particolare i fratelli Ginanni Corradini,avevano seguito con interesse i fenomeni che riguardavano il paranormale e gli epi-sodi medianici. Anche negli scritti teorici questi ultimi vengono citati a dimostra-zione delle immense potenzialità dell’energia psichica e delle funzioni cerebrali,grazie a cui varcare stadi più profondi di conoscenza80. Tuttavia, come avrebbe af-fermato Ginna in L’uomo futuro, la “conoscenza futurista sospinge coscientementein una linea evolutiva”. E chiarisce questo passaggio spiegando che “il movimentofuturista può definirsi un complesso movimento psicologico e filosofico. Se vo-gliamo studiare questa attività, sorta e sviluppata in Italia, nell’ambito delle mo-derne teorie psicologiche e psicanalitiche, dovremmo definirlo come un trasportodell’istinto evolutivo subcosciente nella ragione cosciente”81.
Eppure, tornando all’estratto da Pittura dell’avvenire e agli appunti riportati daVerdone, si nota che, dopo avere apparentemente congedato lo stato di incoscienzaa favore della subcoscienza cosciente, Ginna spiega che nei suoi quadri “la coscienzasi mescola all’incoscienza”. Come già osservato nel capitolo precedente, la lettura
Tra istinto e ragionamento: strumenti esplorativi 75
77 Si veda La conoscenza dei mondi superiori in Rudolf Steiner, La scienza occulta nelle sue lineegenerali (prima edizione in tedesco, 1910), trad. E. De Renzis e E. Battaglini, Milano, Editrice Antro-posofica, 2005, pp. 226-298, in particolare p. 269.
78 Mario Verdone, Ginna e Corra, cit., pp. 72-73.79 Bruno Corra, Strauss il funambulo, in “Il Centauro”, cit.80 Nel manifesto Pesi misure e prezzi del genio artistico Corradini e Settimelli affermano che “ra-
gionamento ed intuizione sono funzioni cerebrali spiegabili e seguibili sino nelle loro più sottili parti-colarità, mediante un’analisi futurista del contenuto della conoscenza sino nelle sue profonditàmedianiche”. Cit., p. 172.
81 Arnaldo Ginna, L’uomo futuro, cit., p. 226.

delle fonti primarie e secondarie porta a concludere che non sia strano, in un climaestremamente sensibile alle più svariate influenze provenienti sia dal campo filoso-fico e spirituale che da quello psicanalitico, e soggetto a rapidi sviluppi concettuali,assistere alla confluenza di spunti derivanti da varie direzioni. L’inconscio rappre-senta la sede degli istinti e rivela che esiste un campo di attività psichica incessante.A questo deposito attinge l’artista, mantenendo il controllo cosciente nell’elabora-zione estetica.
Come osserva Bruno Romani, la rappresentazione del “pensiero-associazione”di contro al “pensiero-frase”, corretto e lineare, costituisce l’essenziale obiettivodella letteratura e dell’arte d’avanguardia. Mentre quest’ultimo si trova sul pianosuperficiale della coscienza, il pensiero-associazione è riposto in uno strato più pro-fondo e “oscilla perennemente tra il cosciente e il sub-cosciente”82. Quest’immaginedell’oscillazione pare davvero riflettere la dinamica del processo creativo e sta ad in-dicare il rapporto dialettico esistente tra occulto e disoccultazione. L’inconscio rap-presenta ciò che è occulto, ma in grado di essere riportato alla luce e con l’uso deltermine “subcosciente” o “subcoscienza cosciente” i futuristi pongono l’accentoproprio sul palesamento, la scoperta consapevole di questa dimensione più profonda,proposito fondamentale della poetica futurista. In un modo o nell’altro veniva rico-nosciuto il valore di questa ricca zona in ombra, le cui caratteristiche erano state in-vestigate nel corso degli anni.
Come ricorda Carl Jung, il discorso sull’inconscio non nasce certo con la psico-logia analitica, ma muove i primi passi già dai tempi della rivoluzione francese,anche se allora si parlava piuttosto di “magnetismo animale”. Esso è andato incon-tro a successivi sviluppi prestandosi, da un lato, a speculazioni sul piano filosofico-spirituale, come si osserva nel pensiero teosofico mentre, dal punto di vista dellescienze sperimentali, ha gettato le basi della psicopatologia francese. Da qui si èpoi arrivati alla psicologia analitica83. L’esplorazione dell’inconscio ha fortementepermeato la sfera culturale, letteraria e artistica, non già nella sua piena portata scien-tifica, quanto piuttosto come affermazione dell’esistenza di un prezioso depositopsichico.
Nella prefazione a La psicanalisi nella cultura italiana di Michel David, lo psi-cologo e psicanalista Cesare Musatti riflette sulla penetrazione della psicanalisi pervie altre da quelle ufficiali del movimento psicanalitico. Riconosce che “si tratta diun certo tipo di penetrazione che non può soddisfare lo specialista, il quale conce-pisce la psicanalisi come un insieme di teorie, di concetti e di tecniche precise, e nonsoltanto come alcune indeterminate suggestioni e tendenze riguardanti vagamenteil modo di rappresentarsi la vita interiore”. E tuttavia “nel campo dell’arte, della let-teratura e della cultura non specializzata, le influenze che una dottrina scientifica puòesercitare si operano precisamente attraverso quelle suggestioni e non attraversoconcetti”84.
76 Capitolo terzo
82 Bruno Romani, Dal simbolismo al futurismo, cit., p. 43.83 Carl Gustav Jung, Inconscio (prima edizione in tedesco, 1918), in Inconscio, occultismo e magia,
trad. Celso Balducci, Roma, Newton Compton Italiana, 1971, p. 201.84 Cesare L. Musatti, Prefazione a Michel David, La psicanalisi nella cultura italiana, cit, p. VIII.

Secondo Maurizio Calvesi, gli stessi psichiatri avevano messo in evidenza le po-tenzialità dell’inconscio nelle sue applicazioni in ambito estetico. Cesare Lombrosoaveva infatti affermato che l’inconscio porta alla chiaroveggenza, all’ispirazione ge-niale, a dei risultati superiori a quelli della coscienza85. Ciò trova riscontro nelle af-fermazioni di Marinetti, Corra e Settimelli, i quali, nel Manifesto del teatro futuristasintetico, si propongono di “Porre sulla scena tutte le scoperte (per quanto invero-simili, bizzarre ed antiteatrali) che la nostra genialità va facendo nel subcosciente,nelle forze mal definite, nell’astrazione pura, nel cerebralismo puro, nella fantasiapura, nel record e nella fisicofollia”86. L’uso del gerundio (“va facendo”), in riferi-mento alle scoperte da parte della mente geniale, sta ad indicare la frequenza del-l’azione, un processo in continuo svolgimento, dove le scoperte sembrano comelava di un cratere perennemente attivo. Tale è la condizione dell’artista.
Ecco schierati, sotto il vessillo della scoperta geniale e la sua espressione in am-bito teatrale, Marinetti, Corra e Settimelli. La posizione del gruppo fiorentino si di-stacca da quella marinettiana per l’originalità della concezione cerebralista dell’arte,che vede l’intuito ricondotto al ragionamento e, in quanto tale, garante della validitàdel prodotto artistico. Al pensiero intuitivo – “un ragionamento frammentario e piùrapido87 – è concesso di cogliere l’inarrestabile flusso della materia, il suo dinami-smo. Chiarite le posizioni, operati i distinguo necessari a far emergere la propriaposizione, messo in salvo il carattere scientifico dell’arte dalle insidie della criticaestetica, le forze vengono congiunte nell’atto esplorativo, preludendo all’intesa si-glata l’anno successivo sulle pagine de “L’Italia Futurista”. Resta da vedere qualicondizioni consentono l’esplicazione di questo tipo di pensiero e che dinamiche siattivano in questi frangenti.
Tra istinto e ragionamento: strumenti esplorativi 77
85 Maurizio Calvesi, L’écriture médiumnique comme source de l’automatisme futuriste et surréa-liste, cit., p. 45.
86 F.T. Marinetti – Emilio Settimelli – Bruno Corra, Manifesto del teatro futurista sintetico, cit., p.180.
87 Bruno Corradini – Emilio Settimelli, Pesi, misure e prezzi del genio artistico, cit., p. 172.


IV.
LA DIMENSIONE ONIRICA
Nel capitolo precedente si è esaminato il ruolo dell’intuizione e del ragiona-mento nel processo creativo, dimostrando come per i futuristi fiorentini essi sianodue facoltà equivalenti. “L’intuizione non è altro che un ragionamento frammenta-rio e più rapido” 1, avevano affermato Corra e Settimelli, intendendo con ciò cheesso è portato a seguire il filo discontinuo e tortuoso proprio del pensiero profondo.A questo deposito psichico attinge l’artista, facendo delle scoperte che andrà poi arappresentare nelle varie forme artistiche. Ma queste scoperte, paragonate da BrunoCorra a “germogli”2 e da Primo Conti a “una curiosa fiorita”, non si palesano nelcorso della vita vigile, bensì affiorano in un’altra dimensione: “[...] si affaccia nellasospensione dell’anima una curiosa fiorita di cose intime che ci apparivano nasco-ste dall’abitudine, prima [...]”3. Due informazioni emergono da questo estratto: laprima riguarda la condizione che favorisce la rivelazione, identificata da Conti nella“sospensione dell’anima”, e la seconda offre indicazioni su quanto impediva questafioritura di cose intime: “l’abitudine”.
Per il futurista Mario Carli la scoperta è associata ad una “distrazione”, un mo-mento di deviazione dal corso dei pensieri4. Di “distrazione” parla anche BrunoCorra, riflettendo sulla dinamica che scatena l’esperienza fantastica raccontata nellaprosa Avventure5. La distrazione fa pertanto da contraltare al pensiero lineare alquale siamo soggetti per abitudine. Nel manifesto Pesi, misure e prezzi del genioartistico, Corra e Settimelli identificano infatti nell’abitudine l’elemento determi-nante il modo in cui colleghiamo le idee nel ragionamento. In esso si parla dei rap-
1 Bruno Corradini – Emilio Settimelli, Pesi, misure e prezzi del genio artistico, cit., p. 172.2 Bruno Corra, Per l’onnipotenza, in Con mani di vetro, Milano, Studio Editoriale Lombardo, 1916.
Questa raccolta comprende liriche composte tra il 1910 e il 1914, poi nuovamente raccolte in Madri-gali e grotteschi, Facchi, Milano, 1919. La presente citazione è tratta da quest’ultima edizione, p. 93.La data di questa lirica non è specificata.
3 Primo Conti, Coscienze in Imbottigliature, Firenze, Edizioni de “L’Italia Futurista”, 1917. Que-sta citazione dalla raccolta antologica Zig zag, il romanzo futurista, a cura di Alessandro Masi, Milano,il Saggiatore, 1995, p. 188.
4 Mario Carli, Tesi di un’arte nuova, in “La Difesa dell’Arte”, cit., p. 3. 5 Bruno Corra, Avventure, Parigi, 4 novembre 1912, in Con mani di vetro, poi Madrigali e grotte-
schi, cit., p. 108.

porti logici come imposti dall’ambiente secondo il principio dell’utilità6. Questa teoria trova riscontro negli scritti di Henri Bergson, per cui la vita ri-
chiede che stabiliamo un rapporto con le cose basato sul bisogno. “Vivere significaagire: vivere significa accettare degli oggetti le impressioni utili per rispondervi conappropriate reazioni”7. Questa tendenza è generata dal bisogno pratico, dagli inte-ressi materiali. Riprendendo il discorso in uno scritto successivo, il filosofo osservache la vita richiede un percorso diretto e funzionale verso il punto in cui siamo di-retti, senza deviazioni o distrazioni. Ciò va a limitare il campo visivo, in quanto lanostra attenzione è rivolta esclusivamente al lato utile delle cose, ignorando il restoe impedendoci di vederle per se stesse8. Ricorrendo alle parole di Donato Valli, con-dizione necessaria al ripristino di questo contatto è per Bergson il “disinteresse ri-spetto alla realtà circostante”, “il distacco dalla vita pratica, la quale è sempreincrostata di interessi, fossilizzata nella routine, impastoiata dalla prassi”9. Di que-sto tipo di impedimenti parla anche Corra, precisando che i “raffinamenti spirituali”si svolgono in uno spazio “estraneo a tutto ciò che è materiale”10.
In un ironico intervento sulle pagine de “Il Centauro”, Settimelli parla della ri-vista chiedendosi: “Che cos’è questa rivista così oziosa, così poco accessibile? Qualeutilità vera porta con sè? Nessuna. È solo per noi, per noi tormentati dal desideriodi esprimere noi stessi, bisognosi di mettere alla luce quello che gli uomini lascianononcuratamente sotto gli abiti, incuriosi di un tesoro nascosto”11. E ancora: “È soloper la persona elevata che attraverso il tramestio ritmico e noioso della vita quoti-diana senta il bisogno di contemplare qualcosa di estraneo, qualcosa di vergine,qualcosa di inesplorato”12. Più avanti, si legge: “Nella vita il virtuosismo non è pos-sibile: la praticità, l’utilità schiaccia il geniale”13.
La vita ordinaria con le sue abitudini imposte dalla necessità pratica impediscedunque di cogliere i “germogli”, che emergono però in una zona interdetta alla co-scienza vigile e critica legata all’espletamento delle nostre funzioni quotidiane. Inquesto capitolo e nel successivo verranno prese in considerazione rispettivamente ladimensione onirica e la follia, così come vengono trattate dal nucleo fiorentino, e ve-dremo come esse condividano delle peculiarità che rispondono ai criteri necessariall’atto esplorativo. La valutazione di queste caratteristiche ci permetterà di capirecosa si verifica in questi frangenti.
Negli scritti teorici e creativi del gruppo fiorentino l’onirico occupa un posto dirilievo e viene visto come condizione naturale dell’artista, teso nello sforzo di ren-
80 Capitolo quarto
6 Bruno Corradini – Emilio Settimelli, Pesi, misure e prezzi del genio artistico, cit., p. 167.7 Henri Bergson, Il carattere comico (“Revue de Paris”, 1er février, 1er mars 1899), in Il riso: sag-
gio sul significato del comico, pref. Beniamino Placido, Bari, Laterza, 1982, p. 98.8 Henri Bergson, La percezione del mutamento, due conferenze tenute all’università di Oxford il 26
e il 27 maggio 1911, in Pensiero e movimento, trad. Francesca Sforza, Milano, Bompiani, 2000, p. 128.9 Donato Valli, Vita e morte del frammento in Italia, Lecce, Milella, 1980, p. 47.10 Bruno Corra, Per l’onnipotenza, cit.11 Emilio Settimelli, L’inutilità del “Centauro”, in “Il Centauro”, a. II, n. 3, Firenze, 26 gennaio
1913, p. 1.12 Ibid.13 Ibid.

dere queste visioni attraverso le varie espressioni artistiche. In un articolo su “IlCentauro” Corra così spiega al lettore le sue intenzioni, parlando dei prossimi libri:“Questo io farò: immetterò in ogni pagina l’essenza di una mia visione [...]”14. Nelmanifesto Pittura dell’avvenire Ginna parla della fatica di tradurre “tutta la propriaanima galoppante sfrenatamente nei sogni”15, e più avanti nel manifesto si riferisceancora all’arte come strumento attraverso cui “evocare nella realtà più reale le vi-sioni che fin’ora furono sogno”16. Commentando poi la storia sul suo doppio inStrano e documentato racconto di Arnaldaz, Ginna indica come qui “la realtà si me-scola al sogno”17. Questa interpretazione del processo artistico viene estesa ad unambito più generale, come si evince dalle affermazioni di Remo Chiti che, parlandodi Michelangelo, lo definisce un “fenomenale artista, di una straordinaria raffina-tezza, che impasta i suoi sogni con una sinfonia di fatica insostenibile [...]”18.
Un altro futurista del gruppo, Mario Carli, elegge il sogno a condizione privile-giata, chiave di accesso a “un’altra realtà”, come afferma in Allucinazioni, dove sug-gerisce di “socchiudere gli occhi... ascoltare con fiducia... leggere nel proprioguanciale come nel più profondo dei libri...”19. E ancora, in Un urlo, parla del “guan-ciale saturo di risonanza”20, in riferimento alla dimensione fantastica corrispondenteallo stato onirico. Nel corso di alcune riflessioni ispirate da Edgar Allan Poe, egliparla del sogno e della vita sonnambulesca come uno stato in cui “si sa tutto, si sentetutto, si vede tutto, con una coscienza spaventevole”, e ci si sente “avviluppati da unasilenziosa sensibilità”21. A questo è contrapposto il giorno, che “con una rastrellatabrutale” sradica dall’anima “tutte le filature di bontà e di benessere che la notte viha depositato”22. Per Carli il risveglio coincide con un brusco ritorno, che assume itoni di un amaro rammarico: “Ma perché anch’io non mi disperdo con i miei sogni?Io muoio un poco tutte le mattine, con loro”23.
In Bruno Corra, dove lo stato onirico coincide con la percezione dell’ “abisso su-breale, aperto sotto il mondo”24, più simile ad una voragine dove si agitano forzeignote, questa dimensione è vissuta in modo più inquietante, come incapacità di sot-trarsi ad una forza che lo sovrasta. Sia Avventure che Accordi Medianici, raccontidove alla trascrizione del vissuto segue la riflessione analitica, sono pervasi dal tur-bamento di colui che, riscuotendosi dal sogno, ha un senso di vertigine: “Perchémai non provo ad aggrapparmi alla realtà per rinsaldare questa mia vita spiritica,ormai troppo crivellata di sogni?”25. Lo stesso tono si ritrova in qualche misura nelle
La dimensione onirica 81
14 Bruno Ginanni Corradini, Chantecler, in “Il Centauro”, a. I n. 6, Firenze 8 dicembre 1912, p. 2.15 Arnaldo Ginna, Pittura dell’avvenire, cit., p. 199.16 Ibid., p. 202.17 Mario Verdone, Ginna e Corra, cit., p. 73.18 Remo Chiti, Misteri Michelangioleschi, in “Il Centauro”, cit., p. 2.19 Mario Carli, Allucinazioni, 1916, ora in Mario Carli, La mia divinità, Roma, Berlutti, 1923, p. 68.20 Mario Carli, Un urlo, 1916, ibid., p. 69.21 Mario Carli, Il mio Poe, in “Il Centauro”, a. I n. 9, Firenze, 29 dicembre 1912, p. 1.22 Ibid.23 Ibid., p. 2.24 Bruno Corra, Accordi Medianici, Londra, luglio 1912, in Con mani di vetro, poi Madrigali e grot-
teschi, cit., p. 101.25 Ibid.

lettere inviate a Settimelli, dove confida all’amico e collega il bisogno di recuperareil controllo per far fronte alla realtà, intesa questa volta come esistenza materiale,fatta di impegni propri di un co-direttore di testata, protagonista della vita culturale,firmatario di numerosi documenti teorici.
La dimensione onirica è dunque un leitmotiv della produzione del gruppo, comegià osservato dagli studiosi del movimento, i quali rilevano come il secondo futuri-smo fiorentino si discosti dalla corrente milanese per indagare i campi del subco-sciente, dello psichico occulto e dell’onirico. Per citarne alcuni, Mario Verdone parladi “senso dell’onirico”, evidente in molte composizioni del gruppo26. In un altrocontesto, dedicando alcune riflessioni al movimento visto come precursore del sur-realismo, parla di “largo margine concesso al sogno, alla visione, all’allucina-zione”27. Laura Dondi ribadisce che questo nucleo esplora, tra le altre cose, i luoghipoetici dell’onirico28, e Claudia Salaris identifica nello sperimentalismo del gruppo“una via dell’avanguardia all’interno di un discorso interiore, onirico”29. Parimenti,Sandro Zanotto parla di un interesse del gruppo fiorentino verso “l’inconscio e l’oni-rico”30. Gli studiosi concordano poi nel ricondurre il discorso all’influenza eserci-tata dal simbolismo francese.
Il sogno occupa sicuramente un posto importante nella produzione artistica eletteraria del periodo romantico e simbolista, senza per questo dimenticare, comeprecisa Tom Conner, che fin dall’inizio dei tempi esso è stato considerato ricco disignificato, strumento attraverso il quale gli dei (o i demoni) si mettevano in contattocon gli uomini per guidare il corso della loro vita futura o annunciare sciagure. Adesso veniva dunque attribuita una funzione premonitrice e profetica. Pur andando in-contro a diverse fasi che ne hanno rivisitato il significato, Conner individua lo slit-tamento principale nel fatto che, mentre gli antichi riconducevano il sogno ad unafonte esterna, per i moderni esso è espressione del mondo interiore31. La matrice di-vina lascia il posto ad una matrice umana. Da essere ritenuto veicolo di una veritàreligiosa trascendente, esso diventa varco di accesso al profondo, rivelatore di un’at-tività psichica sottostante la soglia della coscienza vigile. In Aurélia, il poeta fran-cese Gérard de Nerval esordisce con queste parole: “Il sogno è una seconda vita”,uno spazio in cui “l’io, sotto altra forma, continua l’opera dell’esistenza”32. Il sognodiventa strumento di scoperta e conoscenza di una dimensione altra, e per il poetal’atto creativo coincide con la trasposizione della visione onirica, laddove il sim-bolo poetico mira a rendere visibile l’invisibile.
82 Capitolo quarto
26 Mario Verdone, Prosa e critica futurista, cit., p. 22.27 Mario Verdone, Cinema e letteratura del futurismo, cit., p. 71.28 Laura Dondi, Dal “secondo futurismo fiorentino”del periodo eroico al “secondo futurismo”, in
Luciano De Maria (a cura di) Marinetti e i futuristi, Milano, Garzanti,1994, p. XLV.29 Claudia Salaris, Storia del futurismo, cit., p. 95.30 Sandro Zanotto, Motivi irrazionali ed esoterici nel futurismo toscano, cit., p. 115.31 Tom Conner, Introduction, Tom Conner (edited by) Dreams in French Literature: The Persistent
Voice, Amsterdam-Atlanta, Rodopi, 1995, pp. 10-12.32 Gérard de Nerval, Aurélia (prima edizione in francese, 1855), questa citazione tratta da Le figlie
del fuoco, La Pandora, Aurelia, trad. Renata Debenedetti, Milano, Garzanti, 1983, p. 203.

L’inizio del ventesimo secolo vede un vasto proliferare di studi e riflessioni sullavita onirica e le sue modalità operative nel campo della ricerca psichica, oltreché inambito filosofico e teosofico. L’interpretazione dei sogni, monumentale opera diSigmund Freud che vede la luce nel 1900, dà grande impulso agli studi sul sogno,considerato via regia alla comprensione della mente inconscia, riscuotendo consensianche in campo filosofico. In questo importante trattato e nel saggio del 1907 Ilpoeta e la fantasia, Freud indica come prodotto dell’attività fantastica tanto i sogniad occhi aperti che i sogni notturni33. Ma l’indagine freudiana va oltre e applicaqueste scoperte all’esplorazione dei rapporti tra estetica e psicanalisi, gettando lebasi di un nuovo approccio teorico.
Nella parte che segue verranno esposte alcune teorie elaborate sui vari versanti.Alla luce di queste considerazioni saranno analizzati alcuni scritti di Bruno Corra,Primo Conti, Maria Ginanni e Irma Valeria, dove l’incursione onirico-fantasticaviene sovente esposta in forme diaristiche. L’analisi metterà in luce come apporti di-versi provenienti dalle teorie sviluppate in quegli anni influenzino la produzionepoetica degli autori sopramenzionati. In un clima soggetto alle varie influenze nonsorprende che sollecitazioni diverse abbiano avuto un impatto sulla produzione degliautori, che hanno risposto a tali influenze in base alla sensibilità individuale.
Ci soffermeremo in particolare su una selezione dalle seguenti raccolte: Conmani di vetro, prose poetiche scritte da Corra tra il 1910 e il 1914; Imbottigliaturedi Primo Conti, Montagne trasparenti, di Maria Ginanni e Morbidezze in agguato,di Irma Valeria. A parte la raccolta di Corra, le altre sono state tutte pubblicate trail 1917 e il 1918 nella collana “Libri di valore”, diretta da Maria Ginanni, Edizionide “L’Italia Futurista”. Verrà inoltre esaminato lo scritto di Corra Leggenda apparsosu “Il Centauro” nel dicembre del 1912. Una lettura incrociata dei testi ci consen-tirà di individuare gli elementi di un percorso comune, seppure con punte individuali,volto all’estrinsecazione del pensiero intuitivo.
In una conferenza tenuta all’Institut Général Psychologique nel marzo 1901, ilfilosofo Henri Bergson espone le sue teorie sul processo onirico. Per il filosofo fran-cese, i sogni rappresentano un metodo efficace per esplorare l’inconscio, indagine
La dimensione onirica 83
33 Ne L’interpretazione dei sogni Freud dedica alcune riflessioni ai rapporti intercorrenti tra que-ste due forme del sogno, affermando quanto segue: “L’esame più attento delle caratteristiche delle fan-tasie diurne ci mostra quanto giustamente dovremmo dare a queste formazioni lo stesso nome cheattribuiamo al prodotto del nostro pensiero notturno, cioè il nome di “sogni”. Esse dividono molte pro-prietà con i sogni notturni e il loro studio avrebbe potuto effettivamente costituire il più breve e il mi-gliore avvicinamento alla comprensione dei sogni notturni”. Sigmund Freud, L’interpretazione dei sogni(prima edizione in tedesco, 1900). Questa citazione tratta dalla traduzione di Antonella Ravazzolo,Roma, Newton Compton editori, 1988, p. 362. La presenza di una matrice comune viene ribadita ne Ilpoeta e la fantasia, dove Freud rimanda esplicitamente, tramite una nota a piè di pagina, a quanto af-fermato nell’altra opera. Egli dice infatti: “I nostri sogni notturni – come si ricava dall’interpretazione– altro non sono che fantasie. Il linguaggio, nella sua sapienza infallibile, ha da gran tempo risolto il pro-blema dell’essenza dei sogni, indicando come ‘sogni ad occhi aperti’ anche le aeree crezioni della fan-tasia. [...] I sogni notturni sono appagamenti di desideri, al modo stesso dei sogni ad occhi aperti, e cioèdelle fantasie note ad ognuno”. Sigmund Freud, Il poeta e la fantasia (prima edizione in tedesco, 1907),ora in Saggi sull’arte, la letteratura e il linguaggio, trad. Cesare L. Musatti, Torino, Boringhieri, 1969,vol. I, pp. 54-55.

di una tale rilevanza da fargli accettare l’incarico come presidente della British So-ciety for Psychical Research nel 1913. Bergson afferma di non aver dubbi sul fattoche straordinarie scoperte sarebbero state fatte in questo campo, probabilmente“tanto importanti quanto lo sono state, nei secoli precedenti, quelle delle scienze fi-siche e naturali”34.
In linea con le teorie elaborate in ambito psicanalitico, Bergson sostiene che lavita onirica è resa possibile dal fatto che ad un certo punto si diventa disinteressatiall’occupazione del momento presente e in questo modo si rimuovono gli ostacoliche impedivano l’accesso del materiale onirico al “sottosuolo della coscienza”35.Durante la veglia, l’attenzione è rivolta al mondo esterno, verso i rapporti sociali equesta preoccupazione inibisce la tensione verso la realtà interiore. Al contrario,colui che sogna non presta al mondo esterno quell’attenzione che nella veglia regolaanche la vita interiore.
Queste riflessioni echeggiavano quanto veniva enfatizzato nel campo della ri-cerca psichica, dove il “distacco dal mondo esterno” veniva identificato quale fat-tore fondamentale della vita onirica36. Come ricorda Sigmund Freud, già neldiciannovesimo secolo il francese Alfred Maury parlava di “rilassamento della ten-sione dell’attenzione”37. Nel sogno l’essere è libero dalle leggi della coscienza di ve-glia e dalle norme del suo raziocinio.
Restando nello stesso campo, Carl Jung fa riferimento a “due forme del pen-sare”, ovvero “il pensare regolato” e il “sognare o fantasticare”. Il pensiero rego-lato coincide con l’attività vigile della coscienza, mentre il secondo si accompagnaad una condizione di distacco dalla realtà circostante ed è del tutto ripiegato sulmoto interiore. Come spiega Jung, “il primo lavora per la comunicazione, con ele-menti linguistici, ed è faticoso e spossante. Il secondo invece lavora senza sforzo –per così dire, spontaneamente – con le reminiscenze. Il primo crea nuove acquisi-zioni, adattamenti, imita la realtà e cerca di agire su di essa. Il secondo si allontanainvece dalla realtà, libera i desideri soggettivi, ed è del tutto improduttivo per quantoriguarda l’adattamento”38.
Passando all’antroposofia, noteremo che il termine “ostacoli” impiegato da Ber-gson compare anche negli scritti di Rudolf Steiner. Il sogno rappresenta un intersti-zio attraverso il quale intravedere altri mondi, diversi da quello ordinario esperitodagli esseri umani nella veglia39. Ciò è possibile perché in questa dimensione tuttigli “ostacoli” che impacciano l’essere e lo àncorano alla terra si infrangono40. I mec-
84 Capitolo quarto
34 Henri Bergson, Il sogno (“Bulletin de l’Institut Général Psychologique”, mai 1901), in L’ener-gia spirituale, trad. Giuseppe Bianco, Milano, Cortina, 2008, p. 82.
35 Ibid., p. 72.36 Sigmund Freud, L’interpretazione dei sogni, cit., p. 45.37 Ibid., p. 30.38 Carl Gustav Jung, La libido: simboli e trasformazioni, contributi alla storia dell’evoluzione del
pensiero (prima edizione in tedesco, 1912), trad. G. Mancuso, Roma, Newton Compton, 1975, pp. 17-18.39 Rudolf Steiner, La vita onirica, conferenza tenuta a Penmaenmawr, North Wales, il 22 agosto
1923, ora in Conoscenza Iniziatica, Editrice Antroposofica, Milano, 1985, p. 64. Ma già a partire dal1910 Steiner aveva espresso delle teorie sul sogno in La scienza occulta nelle sue linee generali, cit.,pp. 61-70.
40 Ibid., p. 69.

canismi che regolano la vita quotidiana ed ubbidiscono alle leggi vigenti nel mondodei sensi vengono in qualche misura spezzati nel processo onirico, allorché l’entitàanimica si separa dal corpo fisico e dal corpo eterico ed entra in un regno affrancatodalle leggi naturali41.
Per comprendere cosa avviene in questo stato, bisogna premettere che nella con-cezione teosofica l’essere umano è un’entità quadruplice, costituita da corpo fisico,corpo eterico, corpo astrale e “io”, che si compenetrano. Il corpo eterico (detto anchevitale) interpenetra il corpo fisico e ad esso dà vita, forma e capacità di crescita.Con il corpo astrale l’essere assume invece coscienza delle sollecitazioni e a questerisponde con sensazioni e sentimenti. L’“io”, infine, che risiede nell’anima, rappre-senta la parte che conserva il ricordo della conoscenza e le conferisce durata. L’“io”sperimenta la sensazione di qualcosa che permane. Nell’uomo il corpo astrale èstrettamente legato con la parte dell’anima che conferisce durata alla conoscenza42.
Quanto più si allontana dall’oggetto della percezione sensoriale per elaborare leimpressioni ricevute e di cui conserva memoria, tanto più l’anima può raggiungerelivelli elevati. Nella fase più alta l’“io” trascende la percezione ed elaborazione deglioggetti esterni per dedicarsi alla percezione di se stesso. Questa attività superioreviene ricondotta ad una parte dell’anima definita da Steiner “anima cosciente”43.Per percepire se stesso, l’“io” deve “estrarre dalle sue profondità la propria essenza,per poterne acquistare coscienza”44. Si capisce meglio ora a quali principi si ispirasseGinna coniando l’espressione “subcoscienza cosciente”. La parte celata di tutto ciòche è manifesto, sia nell’uomo che nella realtà circostante, costituisce lo spirito, conil quale si collega l’anima cosciente45.
Questa esposizione era utile per capire cosa avviene nello stato onirico secondoil pensiero teosofico. Come spiega Steiner, “nel sogno l’uomo è libero dalle leggidella coscienza di veglia, che lo incatenano alla percezione sensoria e alle norme delsuo raziocinio”46. Mentre viviamo nel corpo fisico ed eterico, il corpo astrale el’“io”, in quanto uniti alle altre componenti, sono soggetti alle leggi che regolano ilmondo dei sensi e occupati nell’osservazione del mondo esterno. Avviene però che,durante il sonno, essi si distaccano dagli altri due corpi ed entrano in un universo re-golato da leggi supersensibili. Il risveglio corrisponde ad un ritorno alle leggi natu-rali. L’impulso alla vita onirica è dunque dato dall’entità animica che necessita distaccarsi dalla componente soggetta alle leggi naturali per ristabilire il contatto conla realtà supersensibile47.
In relazione alla teoria qui esposta, si consideri un frammento della poetessaMaria Ginanni, che pure si riferisce al sonno come ad un momento in cui l’animasi distacca dall’involucro materiale. Nella breve lirica Fra due dita si legge: “Lecose si sono addormentate malcaute sulla riva e sono cadute nell’acqua coi loro ri-
La dimensione onirica 85
41 Ibid., p. 72. 42 Rudolf Steiner, La scienza occulta nelle sue linee generali, cit., pp. 41-50.43 Ibid., p. 52.44 Ibid., p. 53.45 Ibid., p. 54.46 Rudolf Steiner, La scienza occulta nelle sue linee genrali, cit., p. 68.47 Rudolf Steiner, La vita onirica, cit., pp. 76-77.

flessi. Fuori, la parte mortale del loro corpo appesantito perché rimasto sen-z’anima”48. Rinviando la discussione sul significato dei “riflessi”, conta qui la di-stinzione tra anima e parte mortale, dove la prima si distacca dalla seconda perentrare in una dimensione “di fantasia”, come risulta dal seguito del frammento.Come sostiene Steiner: “Dietro ad ogni oggetto esteriore materiale spaziale dob-biamo cercare qualcosa di simile a quel che vive nella nostra anima stessa”49. Inbase alla teoria teosofica, ciò che viene percepito del mondo esterno grazie ai sensinon è altro che l’espressione esteriore di una spiritualità interiore.
Va detto che il riferimento all’acqua in relazione al processo fantastico richiamal’analogia steineriana tra acqua e sogno, visto che il teosofo compara quest’ultimoal mare. Egli ci invita ad immaginare la vita onirica come un mare: uno spazio in-distinto e ribollente a cui in realtà apparteniamo, pari al mondo supersensibile, daicui flutti riemergiamo ogni mattina, passando al regno della legge intellettuale emateriale. E si ha l’impressione che ogni cosa vista da svegli in contorni definitiemerga da uno stato fluido, come se il mondo dalle linee definite della nostra co-scienza ordinaria fosse nato da questo sottofondo amorfo. Steiner si serve dell’im-magine dell’onda che, emergendo dal mare, va ad assumere le forme della realtàquotidiana50.
Guardando agli antecedenti storici, Steiner indica come i Greci fossero deposi-tari di queste verità, già parte dei popoli antichi, con la loro ricchezza di miti e leg-gende intrisi di immaginazione, circondati da un’aura indistinta rispetto alla nostrachiara percezione della natura. Per i Greci esisteva un “qualcosa” alla base delmondo e da cui sarebbero sorte le forme definite, ma accessibile soltanto nello spa-zio onirico, quando ci si lascia alle spalle il mondo dei sensi. I Greci chiamavanoquesta sostanza “caos”51. Steiner si appropria di questo termine, individuando inesso una proprietà della dimensione onirica.
Tornando alla produzione poetica della “pattuglia azzurra”, osserveremo che di“caos” parla anche Corra nella prosa Spiraglio. È il racconto di “cinque minuti im-prevedibili [...] trovati in fondo a una notte comune”, durante i quali egli si sente per-vaso da una “sensibilità nuova”. In questo breve lasso di tempo si trova dinanzi a“una visione interna”, una “serie di scoperte rapidissime e monche”, a quella che loscrittore chiama “concezione di un caos di meraviglie deliziose che stia elaboran-dosi in uno spazio attento”52.
Altri componimenti corriani descrivono in forma diaristica le sue avventure spi-rituali, dove alla dimensione onirica corrisponde lo stato fluido e volatile. Il ritornoalla vita materiale equivale invece ad una cristallizzazione. Questa caratteristicadella vita onirica viene messa in evidenza anche dalla letteratura scientifica sul
86 Capitolo quarto
48 Maria Ginanni, Fra due dita, in “L’Italia Futurista”, a. II, n. 37, 15 gennaio 1918, p. 2.49 Rudolf Steiner, conferenza tenuta a Hannover il 29 dicembre 1911, in Il mondo dei sensi e il
mondo dello spirito, trad. Lina Schwarz, Milano, Editrice Antroposofica, 1970, p. 69.50 Rudolf Steiner, La vita onirica, cit., p. 73.51 Ibid., p. 74.52 Bruno Corra, Spiraglio, Torino, dicembre 1913, in Con mani di vetro, poi Madrigali e grotteschi,
cit., p. 86.

sogno, dove si apprende che le strutture oniriche si presentano disgregate, “sollevatedal terreno della nostra vita psichica”; esse “vagano nello spazio psichico come nu-vole in cielo, disperse dal primo soffio di vento”53.
Nella prima parte di Avventure, Corra racconta quanto gli è successo in “un at-timo” di “incoscienza”, di “distrazione”, scatenato dall’avere fissato una stella at-traverso la finestra spalancata della sua camera. Riferisce di avere provato unasensazione di estraniamento da “ogni cosa terrestre” e di essersi sentito catapultatoin un vortice celeste54. Egli parla di una sensazione di “sgretolamento” del corpo checosì illustra: “Il mio corpo, divenuto una nuvola d’atomi gonfia d’anima, vagavaper l’universo. […] Nuove cadute, nuovi sventolii, nuovi viaggi nel vuoto”. Il ri-torno alla materialità viene di contro rappresentato come una riaggregazione: “[…]ed ecco che gli atomi del mio corpo piano piano han cominciato a scivolare versoquel punto in cui persisteva la mia personalità. Così, in un rapido aggregarsi di mo-lecole, mi sono sentito rinascere alla vita materiale”55. Al termine di quest’espe-rienza Corra si riscuote chiedendosi: “che cosa mi era accaduto in quell’attimodurante il quale non avevo avuto coscienza di me stesso?”56. Ma nel corso del rac-conto rammenta episodi precedenti in cui aveva esperito qualcosa di simile: “altrevolte mi era accaduto di sentirmi afferrare dalle braccia fluidiche della materia”57.Il riferimento a questo stato si ritrova ancora nell’immagine usata per descriverequest’esperienza: “Qui una fiumana di fantasia mi s’è rovesciata sulla vita”58, dovela fantasia si configura come un corso di sostanza fluida.
Tornando alla produzione di Maria Ginanni, noteremo che il frammento primaesaminato non è il solo in cui la poetessa associa la dimensione notturna alla scor-revolezza. In Come una danza, lirica apparsa su “L’Italia futurista” e raccolta nel vo-lume Montagne trasparenti59, la poetessa confida: “Sono entrata sottilmente nellanotte. Filtrata dalla notte. Attraverso i pori delicatissimi dell’aria”60. Più avanti, de-scrive il paesaggio onirico in questi termini:
Si entra in un mondo nel quale è abolita la concretezza: toccare.Sono imbevuta dalla fluidità della notte che penetra in me ed ipnoticamente vengo a so-migliarle.Scivolo svaporando in zone occulte di vita-tremito, dove l’atmosfera è fatta di brividi, ele idee sono la cipria e ci profumano e ci sfiorano. [...]Ascensione suprema: sono tesa tutta nel mio desiderio di sollevarmi, le mani sfuggonoindietro, mi stringe solo la terribile volontà di salire...di salire...[...]In tanta evanescente dolcezza non è possibile camminare...ma scorrere, scorrere...dive-nire dolcemente dell’acqua...61.
La dimensione onirica 87
53 Sigmund Freud, L’interpretazione dei sogni, cit., p. 39.54 Bruno Corra, Avventure, cit., p. 105.55 Ibid., pp. 105-106.56 Ibid., p. 108.57 Ibid., p. 106.58 Ibid., p. 108.59 Maria Ginanni, Montagne trasparenti, Edizioni de “L’Italia Futurista”, Firenze, 1917.60 Maria Ginanni, Come una danza, in “L’Italia Futurista”, a. II, n. 4, Firenze, 11 marzo 1917, p. 2.61 Ibid.

L’alba coincide invece con il ritorno allo stato solido: “la terra che mi riprendenella sua vita concreta”62. Questo estratto mette in risalto la contrapposizione tra idue stati: solido da una parte, liquido e aeriforme dall’altra. Come già per Corra,l’atto esplorativo è possibile solo in uno spazio esterno alla morsa della realtà ma-teriale che, con la sua troppo rigida struttura, non consente il movimento. L’aria,che tra tutti gli elementi è il meno atomico, il più dematerializzato, con la sua ver-ticalità, il suo moto ascensionale rappresenta al meglio l’induzione dinamica. L’ac-qua veicola altresì il dinamismo della materia. Nello stato fluido le forze molecolarinon sono tali da impedirne lo scorrimento, con la conseguenza che la realtà assumecontorni indefiniti. Gli oggetti non sono mai fissi ma assumono di volta in volta unaspetto alterato, dilatato.
L’assenza di una forma definita degli oggetti viene rilevata da Primo Conti, chein questi termini riferisce le sensazioni provate durante “i sogni vaghi dei dormive-glia pomeridiani”63:
A ondate inafferrabili sembra dilatarsi il senso stilistico della mia tormentata sensibilità:cose senza forma, indecise: vapori vaghi di idee…A volte intravedo lo scorcio di unalontana verità, e nel rimpianto il ricordo del suo essere s’incarna talmente nel mio statod’animo, che quasi mi pare una riconquista64.
In questo estratto ritroviamo alcuni degli elementi già ravvisati in Corra. Se ac-costiamo queste righe a quelle di Spiraglio, osserveremo che la “sensibilità nuova”,di cui parla Corra, diventa qui “tormentata sensibilità”. Per Corra questa sensazioneapre un varco alla “serie di scoperte rapidissime e monche”, realizzate in uno spa-zio definito come “caos”; per Conti le idee si configurano come “vapori vaghi” e lecose appaiono “indecise”. Questo aggettivo richiama il “monche”, nel senso che inentrambi i casi ci troviamo davanti a qualcosa di incompleto, indefinito, frammen-tario. Le “ondate inafferrabili” a cui si riferisce Conti rinviano ancora una volta altopos del fluido. Eppure, qui ci troviamo in presenza di un nuovo elemento, inquanto la percezione attuale rimanda al passato, al ricordo di una lontana verità chesi impone prepotentemente all’attenzione dell’autore.
Il tema del ricordo compare di frequente nella produzione del gruppo. Nella li-rica Coscienze, dedicata a Corra, Primo Conti parla di “una curiosa fiorita di coseintime” che si affaccia “nella sospensione dell’anima” nel corso di episodi che eglidefinisce “momentanee demenze involontarie”65. Queste ultime ci inducono a “pro-seguire ciò che avevamo tralasciato” e quindi a riscoprire un passato che così riaf-fiora: “La leggerezza di questo vostro rifiorire contiene esattamente il volo,l’abbraccio leggero dei panorami!” esclama Conti66. Il poeta si riferisce agli stuporiche sempre si provano davanti a una rivelazione: “stupori di bambino” riconducibiliall’infanzia, a quello stato di “primiera verginità” in cui tutto è una sorpresa e ogni
88 Capitolo quarto
62 Ibid.63 Primo Conti, Pagine sentimentali in Imbottigliature, cit., p. 201.64 Ibid., p. 200.65 Primo Conti, Coscienze, cit., p. 188.66 Ibid.

scoperta genera stupore e godimento. Ci troviamo di fronte ad una realtà che rie-merge dal profondo intatta, “fresca come un fiore sotto la stoppa”67.
In base alla letteratura freudiana, la materia prima della formazione dei sogniaffonda le radici nella memoria e va individuata in quanto abbiamo già esperito este-riormente o interiormente. La memoria rappresenta infatti una delle facoltà più no-tevoli della vita onirica. I sogni però non riproducono le esperienze nella lorointerezza ma privilegiano frammenti, dettagli strappati dal contesto psichico nelquale esse sono ricordate da svegli. Succede così che la dimensione onirica riportaalla luce dettagli della nostra vita a cui avevamo cessato di pensare. Illustrando condovizia di particolari il funzionamento dell’apparato psichico, Freud spiega il ruolosvolto dalla memoria nella vita onirica e le sue modalità operative. Stabilendo un in-timo nesso tra percezione attuale e memoria inconscia, egli arriva ad affermare chela forza motrice dei sogni va individuata nei desideri che risalgono all’infanzia68.
Già altri studiosi avevano riconosciuto il ruolo primario svolto dall’esperienza in-fantile nel processo onirico. Freud ricorda come già Johannes Volkelt e FriedrichWilhelm Hildebrandt si fossero soffermati sul modo in cui i ricordi dell’infanzia siinseriscono nei sogni, rammentandoci di continuo cose a cui abbiamo cessato dipensare nell’attività mentale della vita da svegli69. Ludwig Strümpell – ricorda Freud– aveva osservato che “a volte i sogni portano alla luce, dal di sotto dei più alti stratisotto i quali le prime esperienze della giovinezza vengono sepolte col passare deglianni, immagini di località particolari, cose e persone completamente intatte e contutta la loro originale freschezza”70.
I riferimenti all’infanzia sono una costante della produzione del gruppo. In Comeuna danza la Ginanni associa il suo passaggio nella notte alla regressione infantilequando afferma: “Mi sono immersa nel filtro profumatamente titanico con le mieansie, le mie complicatezze di donna e ne sono uscita bambina”71. La notte corri-sponde ad una nuova nascita: “Così rinasco nella notte”72.
La condizione infantile vista come istigatrice del presente ispira anche la produ-zione di Corra. Tornando ad Avventure, nell’atto di collegare l’esperienza appena vis-suta ad altri momenti in cui si era sentito “afferrare dalle braccia fluidiche dellamateria”, Corra racconta proprio un episodio della sua infanzia, allorché aveva attri-buito alla porta rossa di un granaio, in cima a quattro scale, una prepotente vitalità:
Riempiva di sé i miei sogni, metteva riflessi rossi nei miei giochi più azzurri, in tutta lamia vita: a volte, da lontano, senza che la vedessi, mi imponeva di andare da lei; salivole scale, arrivavo, mi accoccolavo ai suoi piedi, e la mia piccola coscienza in pochi istantispariva nella vampata prepotente di lei, per molte ore. Non ricordo nella mia vita comu-nione più intima, possesso e dedizione più completa73.
La dimensione onirica 89
67 Ibid.68 Sigmund Freud, L’interpretazione dei sogni, cit., pp. 184-186.69 Ibid., p. 18.70 Ibid.71 Maria Ginanni, Come una danza, cit.72 Ibid.73 Bruno Corra, Avventure, cit., pp. 106-107.

Si possono individuare in questo racconto i due elementi descritti negli studi suimeccanismi che scatenano l’onirico: la percezione presente e il ricordo passato. Laprima, rappresentata dal bagliore della stella, si collega al ricordo di un’esperienzaanteriore, in questo caso la vampata della porta rossa del granaio. Ora come allora,Corra prova la sensazione di essere attirato nei meandri di una materia mobile e vi-brante.
Una simile percezione della materia si riscontra nel poema Mendicanti d’azzurrodi Irma Valeria. La poetessa immagina di potersi destare “con l’incoscienza” dellasua “vita scientifica, perfettamente nuova ai fenomeni naturali”. In tal caso, si sen-tirebbe “a un tratto scagliata nell’ineffabile e paurosa ebbrezza di un mondo fanta-stico e divino”74. È l’auspicio di una rinascita che corrisponde al ripristino di uncontatto con la sensibilità e il dinamismo della materia:
Se ci potessimo fermare ad ogni albero, per capire ciò che significano le sue vecchierughe imbottite di muschio, ad ogni porta, per intuire il mistero ch’essa nasconde, adogni filo d’erba eretto e felice, per conoscere i legami invisibili, che irradiano il substratodella terra, ad ogni piuma brillante, per sentirla parlare delle sue ebbrezze ricche d’az-zurro, noi certo non saremmo che dei mendicanti, ma dei mendicanti di soavità scono-sciute [...]75.
La prosa assume a tratti il tono di un’invettiva contro la scienza, che pone “tropposolidi ceppi” ai “nostri piedi impazienti”, laddove occorrono “limpide ali” per li-brarsi nel “cielo smagliante di visioni sovrapposte”. La percezione della vitalitàdella materia viene collocata in un mondo dove regnano “deità giocattolone”. Sianella lirica di Corra che in quella della Valeria la capacità di avvertire il dinamismodella materia viene ricondotta alla predisposizione dello spirito tipica dell’universoinfantile. Quell’universo costituisce un deposito psichico di immagini sempre prontea riaffiorare quando ci si abbandoni alla dimensione fantastica. A questa è contrap-posta “la noia di un confine realistico e staccato, come il muro bianco di un parcofitto e misterioso, che spezza volgarmente la fiaba, attesa con ansia dai nostri troppograndi occhi di eterni bambini morbosamente nostalgici”76.
All’importanza del deposito psichico rappresentato dall’infanzia Freud dedicanel 1907 il saggio Il poeta e la fantasia77, dove stabilisce un’equazione tra gioco in-fantile, sogno ad occhi aperti e processo creativo. Per capire il dinamismo intrinsecoin questo rapporto ci si soffermi sul titolo originale del saggio: Der Dichter und dasPhantasieren. Il termine “phantasieren” non è un sostantivo (fantasia) bensì un verbo(fantasticare) e indica l’operazione intrinseca all’atto di scrittura creativa: il poetafantastica, la sua creazione prende vita nel momento in cui si mettono in moto imeccanismi che caratterizzano l’attività fantastica. Freud traccia un parallelo tra lacostruzione poetica e quella dei castelli in aria propria dell’adolescente e poi del-
90 Capitolo quarto
74 Irma Valeria, Mendicanti d’azzurro, in Morbidezze in agguato, Edizioni de “L’Italia Futurista”,Firenze, 1917, p. 6.
75 Ibid., p. 7.76 Ibid.77 Sigmund Freud, Il poeta e la fantasia, cit., pp. 47-59.

l’adulto, indicando che entrambe queste costruzioni sono un prodotto di fantasia,proprio come il gioco infantile di cui sono sostituti.
Come sostiene Freud, il bambino costruisce un mondo di fantasia partendo daglioggetti reali a cui dà un nuovo assetto per mezzo dell’immaginazione78, e da que-sto gioco ricava gran piacere. Il passaggio all’adolescenza e poi all’età adulta ri-chiede una rinuncia al gioco infantile e impone l’obbligo di affrontare la realtà dellavita con la serietà che essa richiede79. L’essere umano però difficilmente rinuncia alpiacere una volta provato e si costruisce uno spazio privato e privilegiato in cui rie-sercitare l’attività fantastica. “Così anche l’adolescente – egli afferma – quandosmette di giocare abbandona soltanto l’appoggio agli oggetti reali: invece di gio-care ora fantastica. Egli fabbrica castelli in aria, costruisce quelli che si dicono sogniad occhi aperti”80. Freud spiega così che “il sogno ad occhi aperti o fantasia” rap-presenta la realizzazione di un desiderio e affonda le radici nel ricordo di un’espe-rienza precedente, risalente generalmente all’infanzia, quando il desiderio venivaesaudito81.
Tuttavia, accostando queste considerazioni alle liriche qui esaminate, risulta chel’infanzia, più che assumere valore individuale, va vista nell’accezione attribuitaglida Jung e ripresa in seguito da Gaston Bachelard, come cioè un archetipo, uno statomentale, una realtà collettiva e impersonale prima che soggettiva e personale82. L’in-fanzia è un’immagine custodita nel nostro essere, ma affonda le radici oltre i nostriricordi personali. Come osserva Bachelard, la nostra infanzia personale comprovaed è improntata sull’infanzia dell’uomo, dell’essere “toccato dalla gloria di vi-vere”83. Egli spiega che questa infanzia primigenia “rimane in noi, come principiodi vita profonda, di vita sempre aperta alla possibilità di ricominciare”84: un sognoci riporta indietro all’archetipo che rimane lì “immutabile e immobile sotto la me-moria”85. Questa concezione è condivisa da Luca Somigli il quale, in un articolo suImbottigliature di Primo Conti, parla di “fusione tra futurismo e uno stato di primi-tiva innocenza dell’individuo”86.
L’eco di queste ipotesi si ritrova in uno scritto di Corra apparso su “Il Centauro”,intitolato Leggenda87. La prima parte si presenta come un articolo teorico che nellaseconda parte assume carattere diaristico, dove l’esperienza personale andrebbe ad
La dimensione onirica 91
78 Ad uno studio attento dell’opera freudiana risulta che l’immaginazione è un’attività mentale,mentre la fantasia è la costruzione edificata con l’apporto dell’immaginazione. Freud infatti usa spessoil plurale “fantasie”.
79 Ibid., p. 50. 80 Ibid., p. 51. 81 Ibid., p. 53.82 C.G. Jung, La libido: simboli e trasformazioni, cit., p. 28.83 Gaston Bachelard, La poetica della rêverie (prima edizione in francese, 1960), trad. Giovanna Sil-
vestri Stevan, Bari, Dedalo, 1972, p. 130.84 Ibid.85 Ibid., p. 131.86 Luca Somigli, Imbottigliature di Primo Conti: un romanzo futurista?, in “Forum Italicum”, vol.
33, n. 2, Fall 1999, p. 348.87 Bruno Ginanni Corradini, Leggenda, in “Il Centauro”, cit. Dal momento che l’intero scritto oc-
cupa una pagina, tutte le citazioni successive relative a Leggenda sono tratte dalla stessa pagina.

avallare l’esposizione teorica. Lo scrittore annuncia infatti l’intenzione di fare l’ana-lisi di se stesso, anziché scegliere uno spirito immaginario, in quanto il suo lavoroci avrebbe guadagnato “in esattezza”, “in verità” e presumibilmente anche “in inte-resse”. Va detto che Corra non trae le conclusioni in quest’articolo e rinvia il lettoread una trattazione successiva, a sottolineare il carattere unitario e coerente dei variinterventi. Corra inizia riprendendo le fila di quanto aveva già trattato in precedentidocumenti sul rapporto tra intuizione e ragionamento, prefiggendosi di dimostrarnel’identità, e passa a descrivere il suo trapasso nel “di là”, cioè nel “fantastico”, inquesti termini:
Vado verso la mia leggenda socchiudendo gli occhi per vedere le cose sfumate o sem-plicemente lasciandomi andare indietro nel tempo, tra i ricordi. Per ogni uomo i ricordidella fanciullezza hanno carattere di leggenda.
Segue un viaggio a ritroso, tra sensazioni che si proiettano nella vita da adulto,in uno spazio dove le persone appaiono ingigantite, sorta di eroi o numi tutelari e glianimali ispirano soggezione; al bambino che si lascia guidare da “una scura ed osti-nata intuizione”, gli oggetti sembrano animati da una segreta vitalità (si pensi allaporta rossa del granaio descritta in Avventure), e assumono i caratteri più strani. Èinteressante osservare come, proseguendo nel racconto, Corra passi dall’uso dellaprima persona singolare al si impersonale, a sottolineare che le caratteristiche del suomondo infantile sono comuni all’infanzia collettiva:
Retrocedendo ancora, tutta la realtà aumenta di interesse. I ricordi divengono frammen-tati: si cammina per città e per paesi chiazzati di dimenticanza, coperti quà e là da alla-gamenti di silenzio. Qui nuovi rapporti logici, più elastici e più misteriosi, intercedonotra fatti e cose.
Se colleghiamo questo passaggio all’osservazione junghiana sulle due forme delpensare, la seconda delle quali è costituita dal “sognare o fantasticare”, ribadendoche questa lavora spontaneamente, con le reminiscenze, si capisce che anche per ifuturisti fiorentini le reminiscenze trascendono la dimensione individuale per as-surgere a uno stato di infanzia dell’anima. Si tratta di una condizione dello spiritoin cui il pensiero, non ancora soggetto ai vincoli del percorso lineare, e libero di la-sciarsi guidare dall’intuizione, è recettivo a cogliere i nessi più inusitati tra le cose,quelli che vengono definiti da Corra “nuovi rapporti logici, più elastici e più miste-riosi”. Ciò avviene in quanto l’anima, al suo stadio iniziale, è “monda di esperienza”,come viene spiegato nelle righe successive:
Scendendo più giù ancora s’arriva dove le sensazioni si fanno fatue, immateriali, inaf-ferrabili: soffi ondoleggianti, globuli di niente, palpiti fuggitivi e svanevoli sulla super-ficie nitida, vuota, monda di esperienza dello spirito.
Secondo questa linea interpretativa, l’infanzia è la stagione in cui l’essere si offrealla realtà libero dai vincoli imposti dalla logica del pensiero reale-razionale. Inquell’universo in cui tutto è possibile sopraggiungerà l’esperienza col suo bagagliodi conoscenza attraverso cui filtrare il mondo. In un racconto successivo, questa
92 Capitolo quarto

volta di Arnaldo Ginna, sottotitolato dall’autore “racconto psicanalitico”, si legge diun episodio fantastico provocato, ancora una volta, dall’atmosfera notturna. Ginna de-scrive la sua avventura psichica dicendo ad un certo punto: “I miei passi non fannorumore, e se non sapessi che occorre fare dei passi per muoversi io penserei di esseretrasportato da un vento lieve che non si avverte”88, confermando proprio questa con-dizione dell’individuo razionale portato, in virtù dell’esperienza, a deviare le sensa-zioni provate per ricomporle entro uno schema logico che abbia un senso convenuto.
In un intervento sul rapporto che intercorre tra poesia moderna ed esperienza, ilfilosofo Giorgio Agamben osserva: “Far esperienza di una cosa significa: toglierlela sua novità, neutralizzare il suo potenziale di choc. [...] In questa prospettiva, la ri-cerca del ‘nuovo’ non appare come la ricerca di un nuovo oggetto dell’esperienza,ma indica, al contrario, un’eclissi e una sospensione dell’esperienza”89. Ciò è quantola poesia moderna mira a recuperare, sostiene il filosofo, e spiega come da Baude-laire in poi lo choc stia alla base del lavoro artistico, in quanto l’artista si offre allaricezione degli choc senza alcun argine. Questo atteggiamento caratterizza anche ilpersonaggio creato da Corra (Sam Dunn), di cui parleremo nel prossimo capitolo.Ciò ci darà modo di riprendere ed ampliare il discorso sulla sospensione dell’espe-rienza e le conseguenze che ne derivano.
La superficie dello spirito non incisa dall’esperienza, così come viene descrittada Corra in Leggenda, si dischiude a tutte le possibili combinazioni, che non di-ventano mai definite. I “palpiti fuggitivi e svanevoli” in questo racconto ricordanogli aggettivi evidenziati nelle altre prose poetiche. Come le “cose indecise” di Contie le “scoperte rapidissime e monche” dello stesso Corra, hanno il sapore di un sus-sulto, una realtà in continuo fermento, dove la materia è vista nel suo inarrestabilesvolgimento e il divenire non diventa mai divenuto.
Su queste basi si fonda l’analogia tra dimensione onirico-fantastica e infanzia,nel senso che la prima presenta delle peculiarità che consentono l’attivazione di que-gli stessi processi che animano l’universo infantile. Così come nel gioco infantiletutto è possibile, nel sogno le operazioni logiche della mente, basate su rigide rela-zioni e nessi stabiliti dalla mente vigile, vengono sostituite da libere associazioni,come insegna la letteratura scientifica90. Nella premessa alla sua raccolta Notti fil-trate, Mario Carli annuncia che “sono dieci momenti di lirico sonnambulismo, neiquali i ricordi e le immagini si coagulano in essenza, lasciando filtrare la inutile za-vorra dei legamenti coordinatori”91.
Ad un’ulteriore messa a fuoco sui meccanismi che caratterizzano questa di-mensione contribuiscono altre liriche del gruppo. Tra quelle di Maria Ginanni spiccaLe lucciole, poi raccolta in Montagne trasparenti. Sotto la suggestione di uno sce-nario notturno, la poetessa dedica alcune riflessioni alle lucciole, associate a “fine-
La dimensione onirica 93
88 Arnaldo Ginna, Attimi occulti (racconto psicanalitico), 1929, ora in Mario Verdone, Il misteriosoGinna, “Il Caffè”, n. 1, febbraio 1968, p. 61.
89 Giorgio Agamben, Infanzia e storia, cit., pp. 37-38.90 Sigmund Freud, L’interpretazione dei sogni, cit., p. 48.91 Mario Carli, Notti filtrate, Edizioni de “L’Italia Futurista”, Firenze, 1918, ora in Luciano Caruso
(a cura di), Dossier futurista 1910-1919, Firenze, S.P.E.S, 1995.

stre che le forze dello spirito si aprono fiammando sulla staticità della vita”92. Comeosserva Emilio Settimelli recensendo il poema, esso “è tutto fatto di accensioni im-maginose incalzanti e improvvise”93. La poetessa vede nell’ “aria lucciolata” una“slegata consistenza” che corrisponde alla percezione della realtà:
Ho trovato una completezza assoluta afferrando la tua slegata consistenza, aria luccio-lata: dissociando, scompaginando totalmente gli atomi del mio cervello col vostro abba-gliante riddico brulichio portate ad esso la rarefazione completa, la distruzione perfettadi ogni limite esatto. Salpo in regioni svuotate da ogni consistenza-mi sfumo in una as-senza completa, il Nulla. Ed è attraverso questo abolirsi di ogni coscienza, di ogni esat-tezza, a questo ridurre la forza pensante al suo minimo che posso afferrare l’essenza deltutto: l’Infinito. […] Ogni vostro colpetto luminoso spezza il filo associativo che lega lemie idee ed esse brillano autonome, salde, definitive, nella loro forza istintiva. [...] la lo-gica meccanica, legatrice è sconfitta: rimangono gli indistruttibili, formidabili nucleidella intuizione94.
Alla percezione dell’ “essenza del tutto: l’Infinito” corrisponde la riduzione della“forza pensante” ad un minimo livello. Dal seguito del frammento si intuisce che per“forza pensante” la Ginanni intende “la logica meccanica, legatrice”. L’aria luccio-lata coincide con la “sconfitta” di questo tipo di logica, a vantaggio della “intui-zione”. La poetessa parla di “cervello della Notte”, spiegando che esso consiste di“una massa d’aria nera, fonda, cerebrale, e tante accensioni lucciolari”. E in questocontesto colloca “i pensieri isolati, liberi dai legami della meschina logica umana”.Che si tratti di un processo cerebrale è chiaro laddove la Ginanni rivela di affidarsiall’ “acume più lucido del mio genio”. Il binomio notte-genialità è racchiuso nel de-siderio espresso dalla poetessa che, rivolgendosi alla notte, dice: “Voglio così porresulla mia testa enorme l’elmo fantastico della tua genialità”.
Le lucciole rappresentano “fulmini di poesia” che si abbattono su “le leggi esi-stenti”. Per effetto di questa sorgente luminosa che brucia i fili della rete logica, larealtà, intesa come sistema precostituito di immagini, si sfalda nei suoi elementi,che si ritrovano liberi e isolati, in nuove posizioni da cui riallacciare accostamentiinusitati, nuove imprevedibili combinazioni. La Ginanni dice infatti: “Così armatapotrò veramente costruire un nuovo universo!”. Il risultato è un “Poema [...] tutto asbalzi e a luci staccate”, a sottolineare il carattere discontinuo e frammentario delpensiero intuitivo, che è quindi un tipo di pensiero errante, instabile, in continuaevoluzione. A questo tipo di pensiero si riferiva Settimelli coniando l’espressione“pensiero peregrino”95.
La ricostruzione possibile in questa dimensione è oggetto di uno scritto succes-sivo dal titolo Trasparenze. I ponti delle cose. Qui si evoca un universo in cui la ma-teria allarga le braccia per allacciare nuove e fugaci correlazioni: “Io amo, in fondo,
94 Capitolo quarto
92 Maria Ginanni, Le lucciole, in “L’Italia Futurista”, a. I, n. 9, Firenze, 1 novembre 1916, p. 2. 93 Emilio Settimelli, Maria Ginanni, prima grande scrittrice italiana, in “L’Italia futurista”, a. II,
n. 3, Firenze, 4 marzo 1917, p. 1. 94 Maria Ginanni, Le lucciole, cit. Le citazioni che seguono sono dalla stessa p. 2.95 Emilio Settimelli, A proposito di futurismo, in “Il Centauro”, cit.

i ponti delle cose. Non la creazione, ma l’atto della creazione [...]”96. L’immagine èveicolata nella copertina del volume (Montagne trasparenti), dove è illustrata unacatena di montagne stilizzate. Nel punto più alto di ogni cima vi è disegnato un oc-chio, ad indicare la veggenza del poeta che attraversa la solidità della materia e nefuga l’opacità.
Io vedo al di là...sempre al di là di tutte le cose, di tutti i sentimenti, di tutte le anime, nonposso fermarmi spiritualmente...vedo al di là...sempre al di là...Non incontro mai una parete opaca, una parete definitiva dinanzi alla quale debba fer-marmi, un’altezza dalla quale non possa vedere altri orizzonti...97.
L’allusione al poeta veggente si ritrova in Occultismo e arte nuova, dove Irma Va-leria afferma: “le nostre anime si tendono e si arcuano nello spazio come quelle deiveggenti [...]”. Nello scritto, “l’anima dell’universo nascosto” va “scoperta” con “fa-coltà superiori di scoperte e di sensazioni”98.
Si è già parlato nel primo capitolo della matrice simbolista del gruppo e della dif-fusione della produzione di Arthur Rimbaud da parte di Soffici. In Arthur Rimbaud(1911) Soffici evidenziava la veggenza del poeta, la sua facoltà di “sentire fra sé ele cose, e nelle cose fra loro, delle corrispondenze e degli urti segreti e inusitati”99.Soffici descrive la dinamica per cui, allo sviluppo del sistema sensorio divenutoestremamente impressionabile, la realtà prima avvertita come un nesso di elementi“assembrati in un ordine logico per abitudine, e per ciò prevedibile”, si mette a vi-brare sfaldandosi nelle sue parti costitutive, che si ritrovano quindi sganciate e liberedi rapportarsi le une alle altre secondo il “moto rapidissimo” della “fantasia” delpoeta. Questi, vedendo tutto da un’altra angolazione, “è colpito da analogie e ri-chiami ignorati prima: nel ravvicinamento di cose lontane, nella sovrapposizione diapparenze eterogenee, ciò che era sfumatura è divenuto color vivo, ciò che parevaopposto s’è sposato in una novissima armonia”100.
È evidente che l’eredità simbolista si riflette nell’immagine della realtà dina-mica percepita e rappresentata attraverso la produzione del gruppo. Il riferimentodella Ginanni ai “riflessi” delle cose nel frammento Fra due dita va interpretato allaluce di queste considerazioni. Quando la poetessa parla delle cose “addormentatemalcaute sulla riva” e “cadute in acqua coi loro riflessi”101, sganciate dalla zavorradel loro guscio materiale, si riferisce al riverbero emanato dagli oggetti. Come spiegasubito dopo, “I riflessi sono i sogni delle architetture e dei profili”. Così pure, nellostesso frammento, i fanali che, per effetto della nebbia che li “assonna e fa sognare[...] ostentano tanto di raggi e di iridescenze, si ammiccano l’un altro [...]”102. Il li-
La dimensione onirica 95
96 Maria Ginanni, Trasparenze. I ponti delle cose, in “L’Italia Futurista”, a. I, n. 11, Firenze, 1 di-cembre 1916, p. 2. Poi inserita in Montagne trasparenti, cit.
97 Ibid.98 Irma Valeria, Occultismo e arte nuova, in “L’Italia Futurista”, cit.99 Ardengo Soffici, Arthur Rimbaud, 1911, ora in Opere, vol. I, Vallecchi, Roma, 1959, p. 116.100 Ibid.101 Maria Ginanni, Fra due dita, cit.102 Ibid.

mite dell’oggetto non coincide con quello del suo profilo materiale, ma deborda perstabilire contatti.
La stessa analogia tra sogno e movimento viene evocata da Mario Carli, che inuna delle sue “scoperte”103, osserva:
L’ombra proiettata dalle cose, al crepuscolo, è un’atmosfera immateriale formata dai lorosogni solitari, dalle loro tristezze indecise, dal languore dell’immobilità che si stiracchiae vorrebbe la liberazione, il movimento: questa sagoma ripetuta non è che il primo passoverso il movimento104.
Come i “riflessi” delle cose, i “raggi” e le “iridescenze” dei fanali percepiti dallaGinanni, così “l’ombra proiettata dalle cose” individuata da Carli rappresenta unpreludio di liberazione da una rigida struttura e quindi un principio di “movimento”.Nella sagoma dell’oggetto è espressa la sua animazione. Per effetto della percezioneimmaginativa, i contorni delle cose sono visti nel loro potenziale di flessibilità esconfinatezza.
Parlando della matrice simbolista del gruppo, Mario Verdone osserva: “Il sim-bolo provoca l’analogia e la regala al futurismo, che la porta alle estreme conse-guenze”105. Vero è che Marinetti non aveva esitato a distruggere la sintassi perveicolare “l’immaginazione senza fili”, cioè la “libertà assoluta delle immagini oanalogie”106. Spiegando che “L’analogia non è altro che l’amore profondo che col-lega le cose distanti, apparentemente diverse ed ostili”107 aveva inneggiato a tecni-che espressive in grado di cogliere gradazioni analogiche sempre più vaste.L’oggetto viene così visto nella sua potenzialità stornante, nella sua insubordina-zione rispetto ad una logica che lo vede asservito all’abitudine.
Il secondo futurismo fiorentino, pur attingendo all’eredità simbolista, afferma lapropria autonomia convogliando le relazioni analogiche lungo i binari del cerebra-lismo. Laddove Soffici aveva indicato la facoltà del poeta di “sentire fra sé e le cose,e nelle cose fra loro, delle corrispondenze e degli urti segreti e inusitati”, il secondofuturismo fiorentino insiste che non di “sentire” si tratta, bensì di “scoprire”. Comeevidenziato nel primo capitolo, il nucleo contesta la poetica simbolista proprio sullabase del sentimento, a cui oppone il ragionamento. Il pensiero scopre la somiglianzatra elementi della realtà rivelando così una cosa ignorata, ma già potenzialmenteesistente. Il pensiero è in ogni caso ragionamento, esso procede per via di raffrontied ha per esito la scoperta.
Si noti che Settimelli, valutando Montagne trasparenti della Ginanni, aveva par-lato di opera “puramente cerebrale”, obiettivo perseguito da tutto il gruppo e rea-lizzato dalla poetessa108. La presentazione in grande stile certo puntava sul solito
96 Capitolo quarto
103 Mario Carli, Scoperte da 10 lire l’una, in “L’Italia futurista”, a. II, n. 2, Firenze, 25 febbraio 1917,p. 2.
104 Ibid.105 Mario Verdone, Prosa e critica futurista, cit., p. 10.106 F.T. Marinetti, Distruzione della sintassi-Immaginazione senza fili-Parole in libertà, cit., p. 72.107 Ibid.108 Emilio Settimelli, Primo bilancio di “Montagne trasparenti” di Maria Ginanni, in “L’Italia Fu-
turista”, a. II, n. 19, Firenze, 24 Giugno 1917, p. 1.

potere d’impatto caro alla tecnica pubblicitaria futurista, che tendeva ad attirare l’in-teresse del pubblico verso un prodotto presentato in veste assolutamente innovativa.Soprattutto se si pensa che il volume usciva per la collezione di “Libri di valore”(Edizioni de “L’Italia Futurista”), di cui la Ginanni era direttrice. Resta il fatto chel’opera della Ginanni aveva posto grande enfasi sul “cervello della Notte”, sul ca-rattere cerebrale della costruzione di un nuovo universo.
Il percorso tracciato in questo capitolo indica dunque come la dimensione oni-rica sia complice della scoperta grazie a vari fattori: primo fra tutti, il distacco dallarealtà circostante e la sospensione dei parametri della vita vigile, regolati in base aibisogni pratici e ad un fine utile. La rimozione di questi ostacoli è condizione ne-cessaria all’atto esplorativo.
L’analisi dello stato onirico ne ha evidenziato la natura fluidica e volatile. Lestrutture oniriche si presentano disgregate, consentendo quindi lo scorrimento dellamateria, altrimenti impedito da una rigida struttura di relazioni e nessi stabiliti dallamente vigile. La materia straripa così dagli argini e viene vista da Corra come prov-vista di “braccia fluidiche”, a denotare la sua natura scorrevole e palpitante, portataad allacciare libere associazioni.
L’esame di alcune liriche, avvalorato dalla ricerca in ambito scientifico, ha messoaltresì in luce come la dinamica attivata nella dimensione onirica corrisponda allariconquista della facoltà immaginativa, già esercitata durante l’infanzia. Lo statoonirico consente al poeta di scoprire nuovi rapporti tra le cose del mondo, propriocome per il bambino non ci sono limiti nella costruzione del suo universo. Nellostato onirico il poeta è messo in condizioni esplorative simili a quelle di allora, ingrado di cogliere quelle stesse relazioni fluide, che costituiscono l’essenza vera dellavita della materia.
La dimensione onirica 97


V.
FOLLIA E GENIALITÀ: SAM DUNN È MORTO DI BRUNO CORRA
Nel capitolo precedente si è visto come la dimensione onirica presenti delle ca-ratteristiche che consentono l’estrinsecazione del pensiero intuitivo. Nel presentecapitolo verrà esaminata un’altra dimensione altrettanto consona all’esercizio diquesto tipo di pensiero. Si tratta della follia, vista come costituzione cerebrale del-l’artista, propellente del processo creativo.
Il riferimento alla pazzia è frequente nel gruppo e il termine viene adoperato siain relazione ad una persona fuori dal comune, che in un’accezione più profonda. Nelcorso di un’intervista dove Arnaldo Ginna racconta come avvennero i contatti con ilfuturismo milanese, si legge che i primi incontri risalgono al 1910: “Fu pressapocoin quel periodo che Boccioni scrisse a Pratella: ‘Possibile che in Romagna non cisiano dei pittori, degli artisti di eccezione? Mandami gli indirizzi di quelli che sonopiù matti, più esaltati’. E tra questi c’eravamo naturalmente io e mio fratello BrunoCorra”1. Boccioni li invitò a Milano e l’incontro avvenne nella casa rossa di Marinetti,in Corso Venezia. Parlando poi dei suoi rapporti con il pittore futurista Emilio Notte2,Ginna osserva: “Ed un matto simpaticissimo era Emilio Notte. Quello era proprio unmatto, e siccome ero matto anch’io, ne combinavamo di tutti i colori”3.
Nell’intervista sopracitata, Ginna racconta alcuni aneddoti per spiegare che ilfuturismo attirava tipi strambi e stravaganti, e ciò non sorprende se si pensa alla na-tura anticonvenzionale del movimento, caratterizzato dalla volontà di stupire, inci-tante alla ribellione, alla deviazione dalle norme. “Il Futurismo aveva questo dispeciale: attirava come niente i matti” ricorda Ginna, ed ancora: “I matti venivanotutti incontro al Futurismo”4. Come prova lo stesso Ginna con la sua testimonianza,gli stessi protagonisti del movimento si fregiano di questo appellativo. Suo fratelloBruno lo usa anche in riferimento ad alcuni membri della loro famiglia, passando
1 Sergio Lambiase e G. Battista Nazzaro, Marinetti e i futuristi, cit., p. 80.2 Emilio Notte aderisce al futurismo nel 1914. È firmatario, con Lucio Venna, dello scritto Fonda-
mento lineare geometrico (In continuazione al dinamismo plastico), pubblicato ne “L’Italia Futurista”il 21 ottobre 1917 (a. II, n. 31).
3 Sergio Lambiase e G. Battista Nazzaro, Marinetti e i futuristi, cit., p. 85.4 Ibid.

in rassegna alcuni ritratti di famiglia nel brano Antenati, ambientato nel salotto dellanobile casa Ginanni Corradini5.
Al di là di quest’accezione comune la follia, intesa come “sconvolgimento dirapporti logici”6, viene vista come condizione cerebrale dell’individuo moderno epropellente del processo creativo: “Ogni artista potrà inventare un’arte nuova laquale sia l’espressione libera delle idiosincrasie particolari della sua costituzionecerebrale modernamente pazza e complicata e nella quale si trovino mescolati, connuova misura e modalità, i mezzi di espressione più diversi [...]”7. Eppure, viene dachiedersi su quale terreno si incontrino il cerebralismo, magnificato dal movimentocome contrassegno dell’essere razionale, e la follia, generalmente intesa come eclissidella facoltà razionale. Per far luce su questo punto occorre prendere in considera-zione le caratteristiche di questa condizione e la maniera in cui viene recepita incampo culturale e letterario.
Come sostiene lo studioso Sass, nel corso dei secoli e con poche vere eccezioni,la follia è stata vista come “irrazionalità, una condizione che comporta il declino operfino la scomparsa del ruolo dei fattori razionali nell’organizzazione della condottaed esperienza umana”8. A motivo di questa deficienza, determinante l’incapacità didominare i propri impulsi, di esercitare il controllo dei propri pensieri, essa è stataequiparata ad un ritorno al regno animale, una sorta di regressione dalla cultura allanatura, agli impulsi arcaici9. Alcune caratteristiche, quali la ridotta o annullata capa-cità di stabilire una corretta sequenza di idee, l’hanno vista associare al sogno. La teo-ria che stabiliva delle analogie tra il sogno e la follia ha percorso il diciannovesimosecolo, estendendosi anche al ventesimo. Occorre anzi tenere presente che, nel di-ciannovesimo secolo, sotto l’emblema del “sogno”, rientrava anche l’alienazionementale. Tony James ricorda come il francese Alfred Maury, nel suo autorevole librosui sogni del 186110, che rappresenta la sintesi della ricerca di quei decenni sul sognoe i fenomeni ad esso collegati, raggruppasse insieme allucinazioni, alienazione men-tale, delirio, sonnambulismo, estasi, ipnotismo, catalessi e mesmerismo11.
Come si è visto nella sezione sul sogno, alla base dello stato onirico vi sono al-cuni fattori quali il distacco dal mondo esterno e la sostituzione delle operazioni lo-giche della mente con libere associazioni. La follia condivide tali peculiarità, dalmomento che anche in questa dimensione il soggetto cessa di essere attento alla re-altà circostante e perde il controllo dell’ordine logico dei suoi pensieri. La ricercapsichica aveva indicato queste analogie, come si osserva nell’ultima sezione del primo
100 Capitolo quinto
5 Bruno Corra, Antenati, agosto 1914, in Con mani di vetro, poi Madrigali e grotteschi, cit., p. 11. 6 Bruno Corradini – Emilio Settimelli, Pesi misure e prezzi del genio artistico, cit., p. 171.7 Ibid., pp. 169-170.8 “Madness is irrationality, a condition involving decline or even disappearance of the role of rational
factors in the organization of human conduct and experience”. Louis A. Sass, Madness and Modernism:Insanity in the Light of Modern Art, Literature, and Thought, Cambridge, Massachusetts, Harvard Uni-versity Press, 1994, p. 1. Trad. della sottoscritta.
9 Ibid., p. 4.10 Louis Ferdinand – Alfred Maury, Le sommeil et les reves, Paris, Didier, 1861. 11 Tony James, Dream, Creativity, and Madness in Nineteenth-Century France, Clarendon Press,
1995, pp. 7-8.

capitolo de L’Interpretazione dei sogni, dove vengono trattati i rapporti tra sogni e di-sordini mentali.
L’affinità tra i due stati viene basata su alcuni elementi, quali l’eclissi o riduzionedell’autocoscienza, l’alterazione della percezione degli organi sensori, il modo in cuile rappresentazioni si associano tra loro e il riaffiorare dei ricordi di un lontano pas-sato. Per quanto riguarda la loro forza motrice, entrambi gli stati sono mossi da si-mili meccanismi psichici, da un analogo impulso inconscio tendente all’“appagamento dei desideri”12. Questi elementi hanno indotto Paul Radestock a di-chiarare, come riportato da Freud, che “la pazzia, fenomeno patologico anormale,deve essere considerata un’intensificazione della normale condizione del sogno pe-riodicamente ricorrente”13. Con queste parole – osserva Freud – Radestock espri-meva non solo la sua opinione ma quella di molti altri scienziati.
Tuttavia, come ricorda Sass, la corrente antirazionalistica del diciannovesimo eventesimo secolo determina un’inversione di tendenza, non già nella definizione dellafollia ma nel giudizio negativo con il quale, fino a quel momento, si era stigmatizzataquesta condizione. Diversi pensatori e artisti di matrice romantica, nietzchiana, sur-realista e poststrutturalista hanno denunciato i limiti di una visione totalmente in-centrata sull’elogio della ragione, tendente a negare la complessità e autenticitàdell’essere umano, la sua spinta immaginativa14. In Geneologia della morale, Frie-drich Wilhelm Nietzsche parla degli esseri umani sganciati dalle proprie forze istin-tive e ridotti a “pensare, dedurre, calcolare, combinare cause ed effetti, alla loro‘coscienza’, al loro più miserevole organo, il più esposto ad ogni errore!”15.
L’esplorazione dell’inconscio, considerato parte integrante della psiche umana,era alla base di questa rivalutazione dell’essere visto nella sua globalità di spinte nonsolo razionali, a cui affidarsi nella percezione della realtà. Nelle sue propaggini piùestreme, tale recupero doveva portare ad uno squilibrio dovuto al totale dominio diqueste pulsioni, al prevalere della vita immaginativa sulla vita reale. Basti pensare acome, per Nerval (1808-1855), internato più volte a causa della sua malattia, l’im-maginazione sia l’unico strumento con il quale entrare in contatto con l’essenza dellarealtà. Per il poeta francese, la follia coincide con la lucidità, corrisponde ad un’acu-tezza delle facoltà percettive, diventa tramite alla scoperta, alla rivelazione. Nel-l’atto di trascrivere le impressioni vissute durante la malattia mentale, egli osserva:“[...] non so perché io mi serva di questo termine malattia, perché mai, per quantomi concerne, io mi ero sentito meglio. Qualche volta mi sembrava che la mia forzae la mia attività fossero raddoppiate; mi pareva di sapere tutto, di capire tutto: l’im-maginazione mi era apportatrice di delizie infinite”16. L’immaginazione, contrap-posta alla ragione, assume il timone del processo cognitivo.
Follia e genialità: Sam Dunn è morto di Bruno Corra 101
12 Sigmund Freud, L’interpretazione dei sogni, cit., pp. 70-73.13 Ibid., p. 73.14 Louis A. Sass, Madness and Modernism, cit., p. 4.15 Friedrich Nietzsche, Genealogia della morale (prima edizione in tedesco, 1887), trad. F. Masini,
Milano, Adelphi, 2006, p. 74.16 Gérard de Nerval, Aurélia, cit., p. 203.

Il surrealismo coglie quest’eredità, riconoscendo in Nerval un precursore. AndréBreton, fondatore del movimento inaugurato con il manifesto del 1924, osserva:“Nerval possedette a meraviglia lo spirito cui noi intendiamo riferirci”17, intendendocon ciò la capacità di affidarsi all’immaginazione nella percezione di una “realtàsuperiore”18. Per Breton, il razionalismo è un mezzo limitato, in quanto si applicaa fatti strettamente correlati alla nostra esperienza, fondata sull’utile immediato e go-vernata dal buonsenso. Egli denuncia come “In nome della civiltà, sotto pretesto diprogresso, si è arrivati a bandire dallo spirito tutto ciò che, a torto o a ragione, puòessere tacciato di superstizione, di chimera; a proscrivere qualsiasi modo di ricercadella verità che non sia conforme all’uso”19. Pur ammettendo che i folli sono “vit-time della loro immaginazione”, Breton celebra il recupero di questa facoltà, graziealla quale l’individuo è in presa diretta con le sue pulsioni, e rende grazie alle sco-perte di Freud che legittimano l’investigazione nelle profondità dello spirito. Con ilproposito di ristabilire questo tipo di contatto, i surrealisti mettono a punto delletecniche di scrittura basate sul ruolo passivo dello scrittore che si limita a trascrivere“il dettato del pensiero, in assenza di qualsiasi controllo esercitato dalla ragione”20.In questo modo viene data voce al “funzionamento reale del pensiero”.
Il secondo futurismo fiorentino, considerato precursore del surrealismo per l’in-teresse a indagare i campi dell’inconscio e dare voce al pensiero profondo, anche at-traverso esempi di automatismo (soprattutto per opera di Mario Carli), si ponetuttavia in una posizione diversa rispetto al movimento di Breton a motivo dell’in-fluenza esercitata dal positivismo, che impone di affidarsi a criteri oggettivi e scien-tifici. Prodotto di questo approccio è il manifesto Pesi misure e prezzi del genioartistico, basato sul concetto dell’arte come “secrezione cerebrale esattamente mi-surabile”21. In questo scritto, che ripropone e sviluppa teorie già espresse alcunianni prima22, l’atto creativo è considerato il prodotto di energia nervosa. Partendodal presupposto che il cervello umano è paragonabile ad una macchina, dai mecca-nismi più complessi, Corra e Settimelli arrivano ad affermare che l’energia azionatanel trovare dei nessi inediti tra gli elementi della realtà determina il valore della sco-perta. Dunque, il valore sarà direttamente proporzionale alla quantità di energia im-piegata a produrre la scoperta e l’energia sarà tanto maggiore quanto più gli elementimessi in rapporto erano prima distanti gli uni dagli altri23.
102 Capitolo quinto
17 André Breton, Manifesti del Surrealismo (prima edizione in francese, 1924), trad. Liliana Magrini,Torino, Einaudi, 1987, p. 29.
18 Ibid., p. 30.19 Ibid., pp. 16-17.20 Ibid.21 Bruno Corradini – Emilio Settimelli, Pesi, misure e prezzi del genio artistico, cit., p. 172.22 Emilio Settimelli, Il nuovo sistema di critica, in “La Difesa dell’Arte”, a. I n. 2, Firenze, 11 no-
vembre 1909, p. 1. Dello stesso autore La seconda parte del nuovo sistema di critica, in “La Difesadell’Arte”, cit. Bruno Ginanni Corradini, Il Liberismo in “Il Centauro”, cit. Ancora Settimelli in La cri-tica di B. Croce, in “Collezione di Saggi critici”, cit. Emilio Settimelli, Scienza crociana e scienza (par-don!) mia, in “Rivista”, cit. I vari interventi sono stati passati in rassegna nei capitoli precedenti.
23 Bruno Corradini – Emilio Settimelli, Pesi, misure e prezzi del genio artistico, cit., p. 168.

La valutazione dell’opera d’arte si basa sugli stessi criteri validi per la sua rea-lizzazione:
Misurazione futurista di un’opera d’arte vuol dire determinazione esatta, scientifica,espressa in formule, della quantità di energia cerebrale rappresentata dall’opera stessa, in-dipendentemente dalle impressioni buone, cattive o nulle che dall’opera possa riceverela gente24.
Questa concezione dell’arte, definita dagli stessi firmatari “moderna, spregiudi-cata e brutale”, bandisce dal giudizio i sentimentalismi, le emozioni, che non pos-sono valere come criterio in quanto non legati a parametri oggettivi. Ciò che vale èla rarità ricercata lucidamente. Pur ricco di provocazioni, il manifesto si pone inlinea con una concezione moderna dell’arte, secondo quel binomio arte-vita propu-gnato dal futurismo milanese, che vede l’arte “dentro la vita”, integrata alla societàe ai suoi ritmi produttivi, e prende le distanze dallo “snobismo passatista dell’arte-ideale, dell’arte sublimità-sacra-inaccessibile [...]”25. Come afferma Antonio Sac-cone: “Messa al bando la parassitaria, antisociale separatezza, su cui si fondava neltempo preindustriale, la sublimazione della creatività, il ruolo dell’artista viene ri-definito in termini di status professionale e collocato ‘dentro la vita’, all’internodelle attività economicamente utili [...]”26.
Nell’ambito di questo discorso anche la figura del folle viene riabilitata. Nel mo-mento in cui i parametri di giudizio vedono il valore dell’arte unicamente legatoalla quantità di energia esteriorizzata, saranno concesse all’artista “TUTTE le stra-nezze, TUTTE le pazzie, TUTTE le illogicità”27. Messe da parte le qualità estetichesoggettive in base alle quali esaminare un’opera d’arte, viene dato spazio alla piùsfrenata libertà di espressione, purché vi si riconosca un valore. Tuttavia, è impor-tante sottolineare che per “stranezze, pazzie e illogicità” non si deve intendere un in-coerente assemblaggio di elementi, ma una complessa operazione che vede l’artistaimpegnato in uno sforzo cerebrale. Infatti, come si legge nel manifesto, “un indivi-duo che riesca a costruire nel proprio cervello una pazzia complicata assume un va-lore”28. Quest’affermazione riveste grande importanza, in quanto la pazzia viene adassumere un ruolo attivo, efficiente e produttivo. Il folle diventa lucido artefice dellasua realtà, anziché subirla. Ma per capire la valenza assunta dalla follia per il mo-vimento, occorre esplorare il senso di tale dichiarazione e capire cosa significhi co-struire nel proprio cervello una pazzia complicata.
A questo fine, concentreremo la nostra attenzione su una particolare caratteristicadella follia, quella che riguarda l’associazione di idee. Nel tracciare un’analogia trala vita onirica e alcuni disordini mentali, Maury afferma che, in entrambi i casi, siha “un’associazione di idee non valida e irregolare”29. Radestock aveva parlato di
Follia e genialità: Sam Dunn è morto di Bruno Corra 103
24 Ibid., p. 169.25 Ibid.26 Antonio Saccone, Primordi dell’ “Italia Futurista”: Corra, Settimelli e la “misurazione” del-
l’opera d’arte, in Luciano Caruso (a cura di), Il “fronte interno” de “L’Italia Futurista”, cit., p. 80.27 Bruno Corradini – Emilio Settimelli, Pesi misure e prezzi del genio artistico, cit., p. 169.28 Ibid., p. 172.29 Sigmund Freud, L’interpretazione dei sogni, cit., p. 49.

“eccentriche serie di pensieri”30. Così come agli occhi della coscienza vigile i sognisi presentano sconnessi nella loro concatenazione, l’alienazione mentale è caratte-rizzata da un deragliamento dalla traiettoria del pensiero logico-consequenziale.Come osserva lo psichiatra Emile Laurent, l’alienato “è assalito da una moltitudinedi idee che si scontrano e si confondono nel suo cervello, senza ordine e senza nesso[...]”31. Occorre soffermarsi su questo aspetto, in quanto ciò che per la scienza vieneconsiderata caratteristica rivelatrice di una condizione patologica della mente, ele-mento diagnostico, diventa nel futurismo metodo di ricerca teso a dischiudere nuoviorizzonti conoscitivi.
Come già accennato, gli autori di Pesi misure e prezzi del genio artistico so-stengono che i rapporti logici della mente umana sono strutturati in base al princi-pio dell’abitudine: “Il ragionamento è un’abitudine di concatenare le idee in un certomodo”32. Essi sono regolati dalla maniera in cui si svolgono i fenomeni nella realtàin cui viviamo e si basano su una relazione di causa-effetto. Corra e Settimelli usanocome esempio dimostrativo l’associazione di idee messa in moto dalla neve: “neve-bianco-freddo-inverno”, per dimostrare che tale nesso ha senso in quanto tratto dallarealtà che ci circonda, ma perderebbe il suo significato se questa realtà fosse di-versa. Ebbene, sostengono gli autori, “vi sono pezzi di conoscenza tra i quali è dif-ficile stabilire un rapporto perché non sono mai stati associati, perché non esistonosomiglianze evidenti tra loro”. L’energia nervosa che si applica ad un lavoro cere-brale, si trova dinanzi particelle di conoscenze, alcune vicine e affini, altre distantie diverse, su cui agisce trovandosi a “scoprire dei rapporti e istituire delle relazionitra di esse, cioè accozzarle, disgiungerle, crearne delle combinazioni”33.
L’anno prima, in un articolo di “Rivista” volto a ribadire l’esistenza di un’unicaforma di conoscenza contro le due diverse forme suggerite dal Croce (conoscenzaintuitiva e conoscenza logica), il dott. Luciano Luziani aveva illustrato i diversi ri-sultati ottenuti nelle varie modalità di “accozzo” in questi termini:
Se io accozzerò più concetti in modo stranissimo o magari mi regolerò nelle mie azioniin quel modo, al di fuori delle comuni consuetudini, sarò un pazzo; se accozzerò concettidistanti fra loro ma con una certa analogia farò magari un’opera colossale, o non faròniente; se accozzerò concetti che hanno stretta analogia, farò un ragionamento usuale, oun ragionamento matematico34.
Per i futuristi l’elogio dell’insensatezza diventa l’emblema di una campagnavolta all’appropriazione di una facoltà: scoprire dei nessi inusitati tra le cose, se-
104 Capitolo quinto
30 Ibid., p. 72.31 “L’aliéné, en proie au délire, est assailli par une multitude d’idées qui se heurtent et se confon-
dent dans son cerveau, sans suite et sans liaison”. Emile Laurent, La poésie décadente devant la sciencepsychiatrique, Paris, Ed. Maloine, 1897, p. 20. Laurent fa queste considerazioni nell’ambito dell’ana-lisi della poesia decadente, individuando in alcune composizioni le stesse espressioni incoerenti, lostesso scontro di immagini e idee che caratterizzano l’alienato mentale. Trad. della sottoscritta.
32 Bruno Corradini – Emilio Settimelli, Pesi misure e prezzi del genio artistico, cit., p. 167.33 Ibid., p. 168.34 Luciano Luziani, Benedetto Croce-ohimé-scienziato, in “Rivista”, cit., p. 5.

condo principi altri da quelli della logica comune, soggetta ai dettami della coscienzacritica che presiede alla nostra vita vigile. In Ricostruzione futurista dell’universo,i firmatari promuovono un’arte concepita come espressione astratta degli elementidell’universo combinati insieme secondo “i capricci dell’ispirazione”35. Come os-serva giustamente Simona Cigliana, l’esaltazione della follia diventa allora la “pro-mozione di un sapere ‘altro’”, la “valorizzazione della attività intuitiva e analogicadella psiche, capace di varcare i limiti del pensiero razionale e ‘oggettivo’”36. Comeper la dimensione onirica, anche nella pazzia il criterio che regola la maniera di as-sociare le idee nel ragionamento viene scalzato da un altro tipo di logica.
Nel manifesto Il teatro di varietà Marinetti elenca, come elementi del meravi-glioso futurista, “tutta la gamma della stupidaggine, dell’imbecillità, della balor-daggine e dell’assurdità, che spingono insensibilmente l’intelligenza fino all’orlodella pazzia”37. L’elogio dell’insensatezza non ha il solo fine di stupire e spiazzarelo spettatore, ma è un incitamento alla temerarietà, promossa dal futurismo nellavita come nella sperimentazione artistica. La rivendicazione della follia intesa comeapparente nonsenso, provocazione al nuovo, rifiuto dei canoni dell’esperienza, di-venta punto cardine di un progetto di ricerca volto a sondare la realtà in tutte le suepossibili relazioni associative. Quest’accezione di follia, vista come privilegiato mo-mento creativo, si ritrova anche a conclusione del manifesto sul genio artistico diCorra e Settimelli (1914), allorché i firmatari annunciano che il futurismo sta per fareirruzione nelle scuole e nei laboratori della scienza passatista, “camere di torturadella libera pazzia creatrice”38.
Nel capitolo precedente si è esaminata una lirica di Maria Ginanni – Le lucciole– che aveva messo in evidenza la “slegata consistenza” della realtà così come sipresenta per effetto della notte lucciolata39. In questo contesto va notato che la liricaapre un breve spaccato anche sulla valutazione della dimensione esaminata nel pre-sente capitolo. Descrivendo l’impatto sulla realtà prodotto dalle lucciole la poetessaattribuisce loro la volontà di “dare nuove pazzie all’universo, scompigliare le leggiesistenti, attaccare fulmini di poesia penetranti a zig-zag nell’anima della vita”40.
Mentre il percorso del pensiero logico-consequenziale si svolge lungo un asse li-neare, la pazzia, equiparata ad uno scompiglio delle “leggi esistenti”, procede persecchi cambiamenti di direzione, fende l’universo per restituirgli l’irregolarità, latortuosità che gli appartiene. La Ginanni auspica di potersi insinuare “nei cervelliumani liberandoli dalle catene logiche” per produrre lo stesso fenomeno in lei ope-rato dalle “scie taglienti delle lucciole”. Questa dinamica corrisponde alla creazione,racchiusa nelle parole: “Così armata potrò veramente costruire un nuovo uni-verso!”41.
Follia e genialità: Sam Dunn è morto di Bruno Corra 105
35 Giacomo Balla – Fortunato Depero, Ricostruzione futurista dell’universo, cit., p. 172.36 Simona Cigliana, Futurismo esoterico, cit., p. 216.37 F.T. Marinetti, Il teatro di varietà, 1913, in F.T. Marinetti, Teoria e invenzione futurista, cit., p. 82.38 Bruno Corradini – Emilio Settimelli, Pesi, misure e prezzi del genio artistico, cit., p. 173.39 Maria Ginanni, Le lucciole, cit.40 Ibid.41 Ibid.

Eppure, non si può fare a meno di notare un’apparente incoerenza nella manierain cui il gruppo si rapporta alla follia. Se le molte dichiarazioni ad essa inneggiantivanno in direzione di una rivendicazione di alcune proprietà implicite in questostato, altre sembrano rivelare sentimenti contrastanti. Già a partire dal Manifestodei pittori futuristi, esprimendo il loro disprezzo verso il culto del passato ed esal-tando di contro ogni forma di originalità, i firmatari incitano a “trarre coraggio edorgoglio dalla facile taccia di pazzia con cui si sferzano e s’imbavagliano gl’inno-vatori”42. In questo contesto sembra prevalere un atteggiamento di orgoglio sprez-zante verso chi non è in sintonia con lo spirito del movimento, ma con il passare deltempo cresce l’animosità verso i critici che, davanti alla produzione artistica, scuo-tevano la testa in segno di incomprensione. Infatti, cinque anni dopo la pubblicazionedi quel manifesto, in un altro scritto teorico sulla pittura, i toni si esasperano e Ginnaaccusa la critica di essere priva della sensibilità necessaria per capire la pitturad’avanguardia, da qui l’accusa ai futuristi di essere dei pazzi. Egli precisa di non es-sere un pazzo, in quanto “i pazzi sono quelli che non hanno una linea logica nelleloro idee”43.
L’accostamento di questa definizione della pazzia a quella data in Pesi misure eprezzi del genio artistico l’anno prima, dà modo di comprendere la posizione delgruppo. In questo scritto sulla pittura Ginna prende le distanze dal termine dicendoche i pazzi sono coloro che “non hanno una linea logica nelle loro idee”, mentrenello scritto precedente la follia veniva spiegata come “sconvolgimento di rapportilogici”. È evidente che lo sconvolgimento dei rapporti logici non equivale all’as-senza degli stessi. Il manifesto sul genio artistico era impostato su una concezionedell’arte il cui “valore” era considerato direttamente proporzionale alla follia in essaespressa. Più la pazzia era “complicata”, più assumeva un “valore”. Il termine paz-zia designava la maniera insolita, irregolare, stramba di associare le idee, secondouno schema volto a cogliere nessi inavvertiti alla comune percezione. La scopertadi questi rapporti era fondata su uno sforzo cerebrale, tanto maggiore quanto piùinusitati erano i legami. Tale esercizio si basava su operazioni logiche, sebbene di-verse dai parametri del ragionamento-abitudine. Come osservato nel terzo capitolo,i futuristi avevano operato una distinzione tra il pensiero lineare e il pensiero in-dotto dalla facoltà intuitiva. La follia futurista era espressione di un certo tipo dipensiero, non la negazione del pensiero.
Facendo ancora un passo indietro, al Manifesto tecnico della pittura futurista, incui viene esaltata la “potenza visiva che può dare risultati analoghi a quelli dei raggiX”, e la “acuita e moltiplicata sensibilità”44, i firmatari avevano concluso dichia-rando: “Voi ci credete pazzi. Noi siamo invece i Primitivi di una nuova sensibilitàcompletamente trasformata”45. Gli strumenti di cui si avvale l’esplorazione futuri-sta sono innovativi, inusuali, deragliano dai binari del percorso consueto, e perciò
106 Capitolo quinto
42 Boccioni, Carrà, Russolo, Balla, Severini, Manifesto dei pittori futuristi, 11 febbraio 1910. In Lu-ciano De Maria (a cura di), Marinetti e i futuristi, cit., p. 22.
43 Arnaldo Ginna, Pittura dell’avvenire, cit., p. 187.44 Manifesto tecnico della pittura futurista, cit., p. 24.45 Ibid., p. 26.

non possono che generare sconcerto ed essere visti come espressione di follia. An-cora una volta si è portati a riflettere sull’ambivalenza del termine: rigettato da unlato, assunto dall’altro, a seconda che venga inteso come negazione della logica, ocorrisponda all’affermazione di una logica differente, quella al servizio del pensieroprofondo. Già in questo scritto compare il termine “sensibilità”, ripreso poi da Ginnain riferimento ai critici che ne erano invece privi e dunque incapaci di rapportarsi ailavori che di questa erano espressione.
Nella parte che segue verrà esaminato un racconto di Bruno Corra, Sam Dunn èmorto, considerato uno dei lavori più interessanti prodotti dal secondo futurismofiorentino. Il romanzo è incentrato su un personaggio che ben interpreta la condi-zione espressa negli estratti dei manifesti sopracitati. Come vedremo, egli presentadelle caratteristiche che lo fanno apparire come uno squilibrato, tuttavia il suo ine-dito approccio alla realtà scatenerà una profonda rivoluzione.
Sam Dunn è morto è un racconto avvenirista. La storia, scritta nel 1914, si svolgenel 1943-195246. La proiezione nel futuro indica il rifiuto del passato, la negazionedell’esperienza e l’anelito verso il nuovo, verso l’esplorazione di possibilità inusi-tate. Ciò è in sintonia con lo spirito antipassatista del movimento. Sebbene il sensodell’umorismo e l’ironia pervadano il racconto e l’atmosfera rievochi certe dinami-che ludico-nichilistiche proprie del movimento dadaista, sconfinanti nel grottesco,sarebbe errato non vedere il romanzo come espressione della poetica del movimento,in quanto vengono qui trasposti quegli stessi temi che gli autori affrontano negliscritti teorici, sia nei manifesti che negli articoli delle riviste co-dirette da Corra. Di“felice esempio di una poetica” parla anche Elio Gioanola47.
Il romanzo ebbe successo, prova ne sono le varie edizioni che lo riproposero trail 1916 e il 1928, e poi ancora nel 1970 a cura di Mario Verdone48. Nella prefazioneall’edizione del ’17, a cura dello Studio Editoriale Lombardo, lo stesso Corra af-ferma che la prima edizione si era esaurita rapidamente e aveva riscosso consensi po-sitivi sia da parte del pubblico che della critica, precisando però di non avere ricevuto
Follia e genialità: Sam Dunn è morto di Bruno Corra 107
46 Mario Verdone, Introduzione a Manifesti futuristi e scritti teorici, cit., p. 16.47 Elio Gioanola, Bruno Corra, in G. Mariani e M. Petrucciani Letteratura italiana contemporanea,
vol. II, Roma, Lucarini, 1980, p. 792.48 Il romanzo fu pubblicato a puntate su “L’Italia Futurista” dal 1 giugno al 25 agosto 1916. Il set-
timo numero della rivista (1 ottobre 1916) riporta: “D’imminente pubblicazione: Sam Dunn è morto,Romanzo Futurista di Bruno Corra”. E a partire da novembre compare la pubblicità e l’invito ad ac-quistarlo presso le Edizioni Futuriste di “Poesia”, Milano. Siamo però nel novembre 1916. È possibileche, volgendo l’anno al termine, la casa editrice abbia voluto anticipare il nuovo anno mettendo comedata 1917. La seconda edizione in volume è a cura dello Studio Editoriale Lombardo, Milano, 1917. Neln. 27 della seconda annata de “L’Italia Futurista” (26 agosto 1917) si legge: “Sam Dunn è morto, primaedizione esaurita. Prossimamente seconda edizione di lusso con disegni fantastici di Rosa Rosà”. Con-ferma nel n. 30 del 7 ottobre 1917, dove viene annunciata l’uscita della seconda edizione del romanzo,in vendita “presso i librai e presso lo Studio Editoriale Lombardo”. Dunque, prima edizione per le Edi-zioni Futuriste di “Poesia” nel 1917 e seconda edizione a cura dello Studio Editoriale Lombardo, an-ch’essa del 1917, in realtà circa un anno dopo rispetto alla prima. Il racconto viene quindi incluso nellaraccolta Madrigali e Grotteschi, Milano, Facchi, 1919. Sia quest’edizione che quella del 1917 a curadello Studio Editoriale Lombardo si avvalgono delle illustrazioni di Rosa Rosà. L’edizione successivaè del 1928, a cura delle edizioni Alpes, Milano, e questa volta è illustrata da Arnaldo Ginna. L’ultima,curata da Mario Verdone, viene pubblicata da Einaudi, Torino, nel 1970.

il riconoscimento dovuto sul lato tecnico, che individuasse cioè il carattere sinteticodel romanzo49. Il sintetismo, nell’ambito del teatro futurista, era stato elaborato daCorra, Settimelli e Marinetti nel Manifesto del teatro futurista sintetico. La sintesiviene qui teorizzata come essenzialità, celerità, simultaneità, contrazione, compe-netrazione, in base al principio secondo cui “la realtà ci vibra attorno assalendoci conraffiche di frammenti di fatti combinati tra loro, incastrati gli uni negli altri, confusi,aggrovigliati, caotizzati”50.
Dell’impegno di Corra in direzione del sintetismo testimonia Verdone, preci-sando che, mentre le prime quattro edizioni sono sostanzialmente invariate, la quintaedizione, che è anche quella a cui si rifà quest’ultimo, si presenta ritoccata e corretta.Verdone parla di correzioni di tipo sostitutivo e abrogativo che vanno “nel senso diun alleggerimento, di un disegno più nitido e preciso, di una più ricercata ele-ganza”51, ma anche di “una maggiore concisione”, una “asciuttezza espressiva” euna “maggiore sintesi”52. Si capisce che l’intenzione di Corra è di non distrarre illettore con dettagli inutili, di non distoglierlo dal fulcro del racconto.
Nella prefazione all’edizione del ’28 il successo dell’opera viene riconfermatoe Corra afferma che “le due precedenti edizioni (tremila copie in tutto) ebbero unsingolarissimo successo”53, anche se il consenso della critica menzionato nella pre-fazione all’edizione del ’17 cede qui il posto al rammarico per un’accoglienza menofavorevole54. Tra le recensioni maggiormente entusiastiche a Sam Dunn è morto siricorda quella della futurista Eva Kühn Amendola, che firma con lo pseudonimoMagamal (dal nome del personaggio del marinettiano Mafarka il futurista). Nel-l’articolo, pubblicato sulle pagine de “L’Italia Futurista”, Amendola fa più volte ri-ferimento al “coraggio” dimostrato da Corra nel presentare una “realtà veramentenuova sotto apparenze quotidiane”, dando prova di possedere “una psiche non piùterrestre, ma ‘cosmica’ [...]”55.
Secondo Verdone, il personaggio sarebbe basato sullo stesso Corra e, per alcunitratti, su suo fratello Ginna56. Si possono in effetti ravvisare diverse affinità tra Corrae Dunn, affinità che emergono sia da un’attenta lettura delle lettere inviate da Corraa Settimelli, che dalle prose poetiche. Anche Dunn, come Corra, è un poeta. Inol-tre, dalla corrispondenza, ma anche da alcune prose dal tono diaristico, trapela unacerta difficoltà di Corra a gestire il quotidiano, un disadattamento rispetto all’am-biente circostante. Si legge in una lettera: “Mi accorgo di essere in condizioni di as-
108 Capitolo quinto
49 Spiega Corra: “esso è il primo romanzo sintetico, vale a dire il primo romanzo senza capitoli dipreparazione, senza squarci riempitivi, senza particolari oziosi, senza luoghi comuni diluiti e ripo-santi...ecc., ecc.”. Bruno Corra, Prefazione a Sam Dunn è morto (Romanzo Futurista), Milano, StudioEditoriale Lombardo, 1917, p. 12.
50 F.T. Marinetti – Emilio Settimelli – Bruno Corra, Manifesto del teatro futurista sintetico, cit., p.178.
51 Nota di Mario Verdone a Sam Dunn è morto, cit., p. 77.52 Ibid.53 Bruno Corra, Prefazione a Sam Dunn è morto (Racconto insolito), Milano, Alpes, 1928, p. 9.54 Ibid., p. 10. 55 Magamal, Sam Dunn è morto, in “L’Italia Futurista”, cit., p. 3.56 Mario Verdone, Cinema e letteratura del futurismo, cit., p. 63.

soluta insufficienza per affrontare la realtà”57. Nel corso della trattazione vedremocome simili caratteristiche si riscontrino anche in Dunn.
Lo scarso savoir faire di Dunn con le donne, che lo vede vittima di situazioni in-verosimili e umilianti, ricorda un articolo dove Corra parla della timidezza che lorendeva impacciato e delle sue reazioni convulse e ingiustificate non appena unadonna gli mostrava delle attenzioni58. Come avvenne una sera a Firenze, in un risto-rante dove aveva appena finito di cenare, allorché una signora iniziò a fissarlo. Corra“impazza” completamente: ordina liquori, caffè, vini, gelati, tè, in preda al più totalesconvolgimento e fuma una sigaretta dopo l’altra, con gli occhi spalancati59.
Tornando a Dunn, nel romanzo è scritto che aveva avuto solo due avventure didonne, e che non veniva per niente notato dalle più giovani. La prima lo aveva seguitoper diversi mesi, “non bramosa forse d’altro che di sbranare la sua strana infantilitàdi sognatore squilibrato”60. Lo scarso successo si unisce ad un modo assurdo e in-giustificato di reagire agli eventi. Si legge per esempio di quanto successo nel pa-lazzo del principe Dimitreff, allorché la principessina diciannovenne mostra ad ungruppo di giovani ospiti un timbro in platino con le sue iniziali, reso rovente al toccodi un bottone. Mentre si cerca un oggetto in legno su cui provare il timbro, Sam Dunnsi lancia sull’oggetto e si applica la sigla arroventata sull’avambraccio nudo, senzaquasi rendersene conto, urlando: “Clara, io vi amo!”61. Il narratore, un artista amicodi Dunn, introduce l’aneddoto dicendo di lui: “Ne ha fatta una delle sue”62, ad indi-care che questo non era un caso isolato, ma uno dei molti episodi comprovanti lastranezza di Dunn.
Un altro episodio si svolge proprio in casa del narratore suo amico, di notte. Du-rante il sonno, questi sente una detonazione molto forte e si solleva di scatto, urlandoinspiegabilmente: “Geroncà più”, o qualcosa del genere. Quindi, sveglio, accende laluce e vede Dunn che, inginocchiato accanto al suo letto, lo scruta in modo molto at-tento con il monocolo poggiato sull’occhio sinistro. Sbalordito, l’amico gli chiedespiegazioni e Dunn dice con grande naturalezza di avergli sparato una revolveratavicino agli orecchi, mostrandogli appunto la pistola. Quindi Dunn si scusa e spiega,con calma, che si tratta di un esperimento. Gli chiede di aprire la busta che gli avevadato il giorno prima e sul bigliettino l’amico vede scritto: “soluzione: geronlápiù”.Dunn apre la porta e se ne va immerso nella sua “solita aria trasognata”, senza ri-spondere all’amico che lo chiama. Questi si ripromette di domandare a Dunn un chia-rimento, ma poi aggiunge: “mi risponderà certamente in modo incomprensibile”.Concludendo il racconto, commenta: “Hanno ragione gli altri: è pazzo!”. E poi an-cora: “Però agisce come un vero demente; è pazzo, malgrado tutto!”63.
Follia e genialità: Sam Dunn è morto di Bruno Corra 109
57 Ravenna, 18 febbraio, s.a. Fondazione Primo Conti onlus, Fiesole, Fondo Settimelli, Corrispon-denza B. Corra-E. Settimelli.
58 Bruno Ginanni Corradini, Replica a Hopkins, in “Il Centauro”, a. I, n. 9, Firenze, dicembre 1912,p. 2.
59 Ibid. 60 Bruno Corra, Sam Dunn è morto, cit., p. 16.61 Ibid., p. 24.62 Ibid., p. 23.63 Ibid., pp. 22-23.

Dunn viene descritto come privo delle qualità necessarie per avere successo nellavita e dominare nei salotti parigini. Egli dimostra di avere “una estrema debolezzadi carattare, una quasi inconcepibile inettitudine ad affrontare virilmente i problemidella vita reale”64. Ma, quando gli si chiede se si rende conto che con questi limitiè “una vera e propria pazzia” pensare di raggiungere una posizione di prestigio, ri-sponde senza esitazione: “No”. E, a chi ribatte: “Ma insomma, tu sei fuori dalla lo-gica!” risponde affermativamente. Alla prossima osservazione con la quale gli sichiede di ammettere che in questo modo non può pervenire ad un esito pratico, ri-sponde nuovamente: “No”. L’interlocutore allora obietta: “Ma così sragioni dinuovo!”. Dunn risponde: “Si”. A questo punto il narratore conclude: “Strana dia-lettica! Causata forse anche dal fatto che mentre pronunciava questi monosillabi isuoi occhi erano fissi, in attitudine di intensa osservazione, sulla spira di fumo chedalla sigaretta turca stretta tra le sue dita pallide si insinuava nel tepore dell’atmo-sfera”65.
La follia di Dunn si svolge su un triplice piano. Innanzitutto, le sue dinamichedi comportamento e le reazioni alle sollecitazioni del mondo esterno esulano dallenorme che regolano il comportamento sociale: in quanto tali vengono interpretatecome segno di squilibrio. Nel racconto, molti sono i riferimenti alle “stravaganze,illogicità di azione, pazzie”66 imputate a Dunn da quanti lo circondano. Il narratorespiega che “egli perdeva di vista gli avvenimenti dell’esistenza quotidiana, i pro-blemi della comune vita sociale, i concetti e le leggi a cui deve informarsi la nostraattività normale”. Per questo motivo, si trovava spiazzato di fronte agli eventi ma-teriali più comuni, agendo “nelle più illogiche e più ridicole maniere”67.
Come affermato nel manifesto sul genio artistico, i rapporti logici sono basati sul-l’abitudine e regolati dalla realtà pratica. Un percorso che deragli da questi binarinon può che essere addebitato ad un malfunzionamento della ragione. Il narratorefa riferimento a “concetti” e “leggi” su cui si modella l’ “attività normale”. Ne con-segue che un comportamento che non si attenga a tali parametri viene consideratoanormale, definito stravagante se non folle.
Nel romanzo di Corra si legge che gli amici di Dunn riferiscono di averlo vistoin più di un’occasione provare in modo ostinato a passare per una porta senzaaprirla68. Inoltre, “Egli stesso confessava di essersi molte volte alzato da tavola senzamangiare perché non riusciva a ricordare quale metodo si debba seguire per far pas-sare le vivande dal piatto alla bocca”69. Laddove il metodo comporta seguire un per-corso secondo un ordine precedentemente stabilito che conduca ad un risultatoprevisto, il distacco dal metodo equivale all’abolizione delle nozioni acquisite, alrifiuto dell’esperienza, ad una sorta di ritorno al grado zero della realtà che, comevedremo, consentirà a Dunn di rapportarsi ad essa in modo nuovo. Secondo Mario
110 Capitolo quinto
64 Ibid., p. 19.65 Ibid., p. 20.66 Ibid., p. 27.67 Ibid., p. 28.68 Ibid.69 Ibid.

Verdone, il “senso di arbitrarietà ostentato nel proposito [...] di infrangere ogni cer-tezza e esperienza” costituisce “il vero nucleo del romanzo”70. Come osserva ancoralo studioso: “Il libro è proprio in questa provocazione a un continuo al di là di abi-tudini, di idee ricevute e di pensieri creduti, a un senso e dimensione della fantasiacapace di agir da sé in un libero movimento [...] che tiene in scacco ogni tema e ter-mine ritenuto probabile”71.
L’altro aspetto che porta a considerare Dunn “fuori dalla logica” riguarda la suaconvinzione di potere raggiungere risultati nonostante la mancanza di mezzi. A mo-tivo della sua personalità, Dunn viene visto come incapace di emergere. Gli amicirimarcano: “Non arriverà mai, non riuscirà ad imporsi, non è tempra di lottatore,sarà un vinto”72. Come abbiamo visto da un estratto precedente, Dunn non respingele critiche alla sua personalità, non ci sono neppure elementi per capire se ne sia ri-sentito, ma nega che ciò sia un impedimento dando prova, ancora una volta, di sra-gionare. Difatti, se la razionalità viene intesa come capacità pragmatica di collegarefini a determinati mezzi, Dunn ne sembra privo. Nel momento in cui il traguardoviene individuato nel successo, inteso come leadership, capacità dell’individuo su-periore di guidare il corso degli eventi nell’ambiente circostante, non è forse irra-gionevole pensare di poterlo raggiungere senza le qualità ritenute necessarie dallacollettività? Dunn é convinto di no. Anche in questo caso, ci troviamo davanti ad unadeviazione rispetto alle norme sancite dalla società73.
Il terzo elemento a deporre a favore della follia consiste nella incapacità di Dunndi seguire il filo del discorso in modo coerente e logico, dal punto di vista dell’in-terlocutore. Pur convenendo di “essere fuori dalla logica” e “sragionare” per bendue volte, Dunn respinge le implicazioni di quest’ammissione, che cioè la sua fol-lia sia un ostacolo al raggiungimento di un risultato pratico, dimostrando dunque,proprio in questo frangente, di essere senza ombra di dubbio un folle. In realtà, l’at-teggiamento di Dunn sembra, piuttosto, quello di un essere totalmente proiettatoverso la sua meta. In tutta serenità, non riconosce che la sua personalità sia un im-pedimento e nega che i suoi mezzi non possano condurlo ai risultati prefissi: se que-sto significa essere fuori dalla logica, secondo degli schemi prestabiliti, allora lui loè. Accetta dunque l’accusa di follia se con questo termine si intende la scelta dimezzi non convenzionali. Dunn è consapevole del fatto che, agli occhi degli altri, ilsuo modo di procedere non può essere interpretato diversamente e sembra accet-tare, per nulla turbato, la “facile taccia di pazzia con cui si sferzano e s’imbava-gliano gli innovatori”74 denunciata dai pittori futuristi. Né le deficienze imputate
Follia e genialità: Sam Dunn è morto di Bruno Corra 111
70 Mario Verdone, nota (retro copertina) a Bruno Corra Sam Dunn è morto, cit.71 Ibid.72 Bruno Corra, Sam Dunn è morto, cit., p. 15.73 Interessanti le più recenti considerazioni dello psichiatra ungherese Thomas Szasz sulla malat-
tia mentale considerata tale in base al contesto etico e sociale. Szasz avanza l’ipotesi che la salute men-tale venga fatta coincidere con l’abilità di un individuo di aderire alle norme della società. La malattiamentale, di contro, corrisponderebbe al rifiuto di adattarsi a tali norme. Thomas Szasz, The Myth ofMental Illness, in James Fadiman and Donald Kewman (edited by), Exploring Madness: Experience,Theory and Research, Monterey, California, Brooks/Cole Publishing Company, 1973, pp. 87-96.
74 Manifesto dei pittori futuristi, cit., p. 22.

alla sua personalità, né l’accusa di follia lo distolgono dal suo obiettivo. A questopunto occorre capire in cosa consista tale obiettivo e come Dunn intenda raggiun-gerlo, dal momento che le dinamiche convenzionali non sembrano confacenti al suoapproccio alla realtà.
Al fine di esplorare il mondo di Dunn, è opportuno tornare all’altro manifesto incui i pittori futuristi avevano dichiarato: “Voi ci credete pazzi. Noi siamo invece i Pri-mitivi di una nuova sensibilità completamente trasformata”75. Prendendo quest’af-fermazione come chiave di lettura del comportamento di Dunn, andremo adanalizzare i particolari del suo atteggiamento che gettano luce sul percorso da lui in-trapreso e puntano in direzione del suo obiettivo. Quest’indagine ci consentirà dicogliere appieno il senso della proclamazione dei pittori futuristi.
Si legge che per Dunn era una cosa naturale stare immobile per diverse ore di se-guito “silenzioso, imbambolato, estatico”. Il narratore aggiunge che “la sua perso-nalità era quasi sempre ottenebrata” e “si risvegliava e viveva e fremeva solo quandodiceva qualcuna delle sue brevi liriche stravaganti e profonde”, ricadendo subitodopo nel suo abituale “letargo”. Ciò che colpiva in Dunn era “l’immobilità, un’im-mobilità totale che evidentemente gli penetrava anche lo spirito”76. Tuttavia, era ingrado di ripetere precisamente un discorso lungo e complesso che gli venisse fatto.A questo punto troviamo nel racconto un’affermazione forte, da approfondire: “Chilo conosceva bene, in fondo, lo stimava un forte cervello. Certe sue frasi incisive ri-velavano una genialità originale e profonda”. I suoi amici dicevano di lui: “È un ra-gazzo di genio”77, aggiungendo però che non sarebbe mai arrivato, a causa di quellecarenze nella personalità già esaminate.
Questo elemento porta ad esaminare i rapporti che esistono tra follia e genialità.Dunn è considerato un folle, eppure da alcuni particolari emerge un acume che in-duce chi lo conosce bene a consegnarlo alla genialità, sancendo così il suo ipoteticoriscatto. Infatti, mentre la follia si accompagna ad una connotazione negativa, la ge-nialità suscita rispetto ed ammirazione. Eppure, la demarcazione tra i due stati nonera così netta e i futuristi dimostrano di esserne consapevoli riconoscendo, nel ma-nifesto Pesi misure e prezzi del genio artistico, che “L’artista geniale è stato ed è an-cora oggi socialmente uno spostato”78.
Quest’affermazione va letta alla luce delle considerazioni già fatte sulla follia inrelazione ai parametri di comportamento. Il genio, come il folle, si discosta dalla vi-sione comune, proiettato com’è verso una percezione più profonda e inedita dei rap-porti tra gli elementi della realtà. Per Dunn, follia e genialità sono i due risvolti diun unico approccio originale alla realtà. Ma con quest’affermazione sull’artista ge-niale considerato “uno spostato”, i futuristi dimostrano di essere al corrente del-l’ambiguità di giudizio implicita nel binomio genialità-follia. Infatti, numerosi sonogli studi dedicati a questo rapporto.
112 Capitolo quinto
75 Manifesto tecnico della pittura futurista, cit., p. 26.76 Bruno Corra, Sam Dunn è morto, cit., p. 14.77 Ibid., p. 15.78 Bruno Corradini – Emilio Settimelli, Pesi misure e prezzi del genio artistico, cit., p. 170.

Come ricorda Dean Keith Simonton, già ai tempi dell’antica Grecia la genialitàè stata spesso associata al disturbo mentale. Simonton cita Aristotele e Seneca, ri-portando le loro affermazioni a sostegno di questa tesi, laddove il primo individuain molti filosofi, uomini politici, artisti, poeti una comune tendenza alla melanconiae il secondo riscontra in ogni grande genio “un tocco di follia”79. Entro la fine deldiciannovesimo secolo, molti scienziati condividevano simili teorie, come lo psi-chiatra francese Jacques Moreau de Tours il quale, come ricorda Adrianna M. Pa-liyenko, negli anni ’50 avanza la controversa ipotesi che il genio, come la follia, siaun tipo patologico di funzionamento mentale80.
Passando all’Italia, nel 1864 viene pubblicata l’opera del criminologo CesareLombroso, Genio e follia81. Questo celeberrimo lavoro, tutto impostato su una con-cezione positivistica, si basa sulla teoria che le caratteristiche degli uomini di genioandrebbero ricondotte alla loro anormalità psichica. La genialità consisterebbe in re-altà in una psicosi degenerativa. In questa categoria Lombroso include scrittori, arti-sti, filosofi e musicisti, tra cui Baudelaire e Newton, Rousseau e Schopenhauer, Pascaled Edgar Poe, Mozart e Beethoven, Verlaine e Mallarmé. La sua teoria suscitò durepolemiche. I suoi oppositori rilevarono come quest’opera soffrisse delle stesse ge-neralizzazioni già applicate agli studi sulla criminalità, che assimilavano le devia-zioni del comportamento a fattori fisiologici e morfologici, ad alterazioni cerebrali.
L’eco di queste accese dispute iniziate in campo scientifico rimbalzava sulle pa-gine di riviste letterarie, come si evince dagli articoli presenti in periodici quali “Leo-nardo” e “La Difesa dell’Arte”. Nel primo caso si tratta di un articolo dai tonitaglienti, in cui Mario Missiroli denuncia sarcasticamente “l’ultima gaffe” del pro-fessore in materia di criminologia e fa riferimento alle sue teorie che “si sono rive-late come longitudinali bestialità pseudo-antropologiche”, menzionando anche glianni trascorsi dal Lombroso a studiare, tra le altre tipologie, “i geni e i matti”82. Ilsecondo articolo, dal titolo “Cesare Lombroso”, pubblicato in occasione della suamorte, è introdotto da una nota di redazione in cui si legge che, per quanto non in-tonato al programma della rivista, l’articolo va inteso come “ultimo e rispettosoomaggio” ad “un pensatore che tanto vivamente interessò l’arte e gli artisti”. Perquesto motivo si avverte l’obbligo di “sospendere per un istante la lotta”83. Al Lom-broso, il dott. Luziani attribuisce il merito di avere sottratto la pazzia a falsi concettiper trattarla allo stesso modo delle altre patologie del corpo umano, consegnandolacosì all’osservazione scientifica. Senonché egli passò a formulare “una delle con-cezioni più ardimentose” avvicinando il genio alla pazzia, con risultati deleteri in
Follia e genialità: Sam Dunn è morto di Bruno Corra 113
79 Dean Keith Simonton, Origins of Genius, New York-Oxford, Oxford University Press, 1999, p. 95.80 Adrianna Paliyenko, Margins of Madness and Creativity: Nineteenth-Century French Psychi-
atric and Literary Discourses on Dream, in Tom Conner (edited by), Dreams in French Literature, cit.,p. 15.
81 Cesare Lombroso, Genio e follia, Milano, Tipografia Chiusi, 1864. 82 Mario Missiroli, L’ultima gaffe di G. Lombroso in “Leonardo”, a. V, serie 3, Firenze, agosto
1907, pp. 301-304. L’errore nell’iniziale del nome G. anziché C sembra trascurabile, in quanto nell’ar-ticolo il nome Cesare appare per intero.
83 Luciano Luziani, Cesare Lombroso, in “La Difesa dell’Arte”, a. I, n. 2, Firenze, 11 novembre1909, p. 3.

quanto i suoi seguaci, “basandosi su leggi che, in fin dei conti, erano teorie, e quindidiscutibilissime, trassero conclusioni false nella pratica di tutti i giorni, o almenoenormemente esagerate”84.
Tra le critiche, quella del berlinese Georg Wendel che, nel 1910, contesta le pre-messe sulle quali si poggia la teoria lombrosiana, considerandole non fondate. Wen-del rimprovera al Lombroso di avere fatto ricorso a “somiglianze casuali edesteriori” per provare la natura pazza del genio, mentre in realtà esse non dimo-strano niente. La stessa melanconia riscontrata negli uomini di genio sarebbe, perWendel, una conseguenza della loro maggiore sensibilità, anziché un tratto com-provante la loro patologia. Essa sarebbe da attribuire alle condizioni sociali: “am-biente ostile, sensazione di non essere compreso dai contemporanei, amarezza di unospirito rivolto verso l’alto, cui si oppongono la ribelle deficienza intellettuale dellemasse”85.
L’esposizione di quanto avveniva negli ambienti scientifici e letterari dell’epoca facapire su quale sostrato teorico Corra abbia costruito polemicamente il suo personag-gio. Il riferimento alla genialità non è isolato a Sam Dunn è morto, ma il fatto chevenga usato in relazione a Dunn offre l’occasione di esplorare da vicino il senso di que-sto termine, molto ricorrente tra i futuristi. Partendo da alcune considerazioni di ca-rattere generale, vedremo come esso viene declinato dal secondo futurismo fiorentino.
Partendo dalle stesse considerazioni di Cesare Lombroso, il carattere distintivodel genio consiste nella “cerebrazione incosciente rapidissima non arrestata da osta-coli logici, o da presupposti scientifici per cui confluendo liberamente, associan-dosi senza freno le idee e le immagini, si vanno stabilendo tra esse, d’un tratto,rapporti nuovi”86. Già anni prima lo psicologo William James descriveva “il geniodella scoperta” come un processo molto diverso dal pensiero che si occupa dellecose concrete seguendo un circuito lineare suggerito dall’abitudine. Nella scopertageniale, si hanno infatti “bruschi passaggi trasversali da un’idea all’altra, [...] le piùinedite combinazioni di elementi, le più sottili associazioni analogiche [...]”87. E an-cora, spiegando quanto avviene, osservava: “Insomma, sembra di entrare improv-visamente in una ribollente caldaia di idee, dove tutto spumeggia e gorgoglia in unostato di confusa attività, dove le associazioni possono allacciarsi e slacciarsi in unistante, la più noiosa routine è estranea e l’inatteso sembra l’unica legge. A secondadelle idiosincrasie dell’individuo, le scintille avranno un carattere o un altro”88.
114 Capitolo quinto
84 Ibid. 85 Georg Wendel, Teoria sul genio e follia: Georg Wendel contro C. Lombroso, trad. R. Bazardjian,
Padova, Fratelli Drucker editori, 1911, p. 16.86 Cesare Lombroso, L’incosciente nel genio, in “Rivista d’Italia”, aprile 1901, fascicolo 4, p. 645.87 “Instead of thoughts of concrete things patiently following one another in a beaten track of ha-
bitual suggestion, we have the most abrupt cross-cuts and transitions from one idea to another, […] themost unheard-of combinations of elements, the subtlest associations of analogy […]”. William James,Great men, great thoughts and the environment, in “Atlantic Monthly”, vol. 46, n. 276, October 1880,p. 456. Trad. della sottoscritta.
88 “In a word, we seem suddenly introduced into a seething caldron of ideas, where everything isfizzling and bobbing about in a state of bewildering activity, where partnerships can be joined or loos-ened in an instant, treadmill routine is unknown, and the unexpected seems the only law. According tothe idiosyncrasy of the individual, the scintillations will have one character or another”. Ibid.

Questo carattere della genialità continua ad essere evidenziato in tempi più re-centi. Come spiega Simonton, la parola “genio” sta ad indicare una qualche spe-ciale predisposizione, abilità o talento naturale, specialmente quando oltrepassa digran lunga la norma. Dal momento che nell’esercizio di queste speciali attitudinil’individuo sembra impiegare uno straordinario livello di intelletto o talento, ne con-segue che il genio è qualcuno che dimostra di possedere uno speciale potenziale in-tellettuale o creativo89. Nel secondo caso, una componente fondamentale checonferisce alla creatività il carattere geniale è l’originalità, sarebbe a dire, la capa-cità di combinare le idee secondo un percorso inusuale, procedendo per sottili ca-tene analogiche, cogliendo associazioni remote tra idee separate90. A veicolarequesto processo è il pensiero intuitivo, che porta a seguire quanto originariamenteavvertito in modo fulmineo, al di sotto della soglia della coscienza vigile, nello spa-zio di un attimo di distrazione dal corso dei pensieri ordinari91.
La riflessione sembra del tutto consona alla concezione futurista del processocreativo. Si ricorderà che, per Mario Carli, la scoperta è associata ad una digres-sione dal corso dei pensieri. Nella sua Tesi di un’arte nuova, riflettendo sulla dina-mica della scoperta effettuata dall’artista così come dallo scienziato, Carli osserva:“basta una breve sensazione estranea, alla riflessione attuale, perché una folla dinuove idee si succedano nel cervello dello scienziato”92. Secondo il poeta, la ten-denza alla digressione è da ricondurre alla natura del cervello “rapido e instabilenel suo oscillio”, alla sua capacità di “passare da una cosa all’altra, traverso ad unaserie di concetti legati tra loro da un vincolo quasi insensibile”93. Proseguendo nell’illustrazione della sua teoria, egli aggiunge: “Lo svolgersi del pensiero non è mai lo-gico, esso tende a balzare velocemente, quasi a furia, verso i punti più distanti, e nonè mai possibile porre un freno ai suoi salti”94.
Per Carli, tale tendenza è tanto maggiore quanto più sviluppata è la facoltà im-maginativa, per cui un minimo stimolo può dar luogo ad una sequenza di concettidistanti tra loro passando “per ponti sottilissimi”95. Il livello di sviluppo dell’im-maginazione è direttamente proporzionale alla rapidità di passaggio tra le idee:“Quanto più l’immaginazione è sviluppata, tanto più sarà rapido il passaggio, sot-tile il tramite intercedente tra le idee, lontano e bizzarro il fine a cui il pensiero giun-gerà”96. A questo punto avanza un’ipotesi piuttosto ardita, sostenendo che “lostupido è il più vicino alla logica mentale, l’artista è il più lontano”97. Vi sarebbedunque un rapporto inversamente proporzionale tra intelligenza e logica mentaleintesa come corso ordinario dei pensieri.
Follia e genialità: Sam Dunn è morto di Bruno Corra 115
89 Dean Keith Simonton, Origins of Genius, cit., p. 2.90 Ibid., p. 28.91 Ibid., p. 32. 92 Mario Carli, Tesi di un’arte nuova in “La Difesa dell’Arte”, cit., p. 3.93 Ibid.94 Ibid. 95 Ibid.96 Ibid.97 Ibid.

Se accostiamo questa affermazione a quella del manifesto sul genio artistico, latesi acquista un senso e si dimostra coerente alla linea programmatica del gruppo.In quel manifesto gli autori ammettevano “TUTTE le stranezze, TUTTE le pazzie,TUTTE le illogicità”, riconoscendo in esse l’enorme potenziale, in quanto espres-sione di scoperte del tutto originali98. L’ “illogicità” va intesa come agitazione, scon-volgimento, scompiglio rispetto alla sequenza dei concetti tipica del corso ordinariodei pensieri, come attività analogica della psiche, e si accompagna ad una menteimmaginativa. In questa prospettiva, essa non corrisponde alla negazione del ragio-namento, che è anzi alla base del “cerebralismo” magnificato dal gruppo, ma vavista come motore di ricerca alternativo che, pur affidandosi agli stessi mezzi, li uti-lizza secondo un percorso diverso, pervenendo in questo modo a scoperte geniali.Carli riprende questo discorso in un altro articolo, individuando nel pensiero “ciò cheveramente può distinguere la fantasticheria di un uomo d’ingegno da quella di unqualunque visionario salta-cicli”99. Nell’ambito di questo teorema vengono dunquericonciliati pazzia e genialità, dove la prima è alleata della seconda e ne consentel’estrinsecazione.
Nella lirica di Maria Ginanni, la notte lucciolata fornisce gli strumenti per “co-struire un nuovo universo”. Rivolgendosi alle lucciole, la poetessa afferma: “Le ditapiù esili della mia anima vogliono sorreggere i vostri fili impalpabili ed intrecciarlicon la delicatezza più tenue e l’acume più lucido del mio genio, per formarne il tes-suto miracoloso di una nuova esistenza”100. La genialità si esplica producendo scom-piglio nell’universo, per ricostruirlo secondo altre leggi.
I sostantivi “genialità”, “genio” e l’aggettivo “geniale” compaiono spesso nelledediche che si fanno i futuristi fiorentini e nelle recensioni alla produzione dei col-leghi. Basta scorrere le pagine de “L’Italia futurista” per trovarne conferma attra-verso numerosi esempi. Dedicando Frammento di novella colorata al maritoArnaldo Ginna sul primo numero della rivista, Maria Ginanni scrive: “al grovigliocaotico della sua genialità creatrice-alla pazzia meravigliosa della sua fantasia iri-descente”101, accostando quindi genialità e follia. E nel numero successivo la poe-tessa dedica un altro segmento “Alla genialità di Bruno Corra”102. Trasparenze,sempre della Ginanni, verrà invece dedicata “Al genio futurista Oscar Mara”103. El’elogio sarebbe poi stato ricambiato dai colleghi, come dimostra la pagina di re-censioni al suo libro Montagne trasparenti. Infatti, qui Marinetti si riferisce alla Gi-nanni come al “più formidabile genio femminile che abbia l’Italia...”104. A sua volta,
116 Capitolo quinto
98 Bruno Corradini – Emilio Settimelli, Pesi misure e prezzi del genio artistico, cit., p. 169.99 Mario Carli, C’era una volta il pensiero, in “La Difesa dell’Arte”, a. II, n. 36-37, Firenze, 2 ot-
tobre 1910, p. 2.100 Maria Ginanni, Le lucciole, cit.101 Maria Ginanni, Frammento di novella colorata, in “L’Italia Futurista”, a. I, n. 1, Firenze, 1 giu-
gno 1916, p. 2.102 Maria Ginanni, Frammenti di novelle colorate, in “L’Italia Futurista”, a. I, n. 2, Firenze, 15 giu-
gno 1916, p. 2.103 Maria Ginanni, Trasparenze, in “L’Italia Futurista”, a. I, n. 11, Firenze, 1 dicembre 1916, p. 2.104 Giudizi su “Montagne trasparenti” di Maria Ginanni, a. II., n. 6, Firenze, 25 marzo 1917, p. 4.

Marinetti viene definito, insieme a Settimelli, “spirito geniale” da Magamal nella re-censione a Sam Dunn è morto, allorché la futurista fa notare che già Marinetti e Set-timelli avevano espresso tutta la loro ammirazione per il romanzo corriano105. Nellaprefazione ad una raccolta di scritti, Corra parla dei periodici creati e diretti “in sim-patica collaborazione con Marinetti con Settimelli e con gli altri amici geniali[...]”106.
Per quanto riguarda le dediche e recensioni, si riscontra la presenza di elementirilevati nelle considerazioni generali di carattere scientifico sulla scoperta geniale.Si è già citata la Ginanni che, dedicando il frammento a Ginna, dice: “al grovigliocaotico della sua genialità creatrice”. Un’altra dedica interessante ai fini della no-stra osservazione è quella di Conti che, riferendosi al collega, scrive: “Alla crea-zione imprevista-Al genio di Bruno Corra”107. Riaffiora dunque il concettodell’imprevisto, dell’inatteso, del caos associativo.
L’uso frequente del termine (“geniale”, “genio”, “genialità”) non deve quindiindurre a sminuirne la portata, in quanto è evidente che il gruppo gli attribuiva unsignificato profondo, da ricondurre alla concezione cerebralista dell’arte. Proce-dendo nell’analisi, si vede come la genialità sia considerata una vera e propria fa-coltà da impiegare nell’esplorazione dell’ultrasensibile, e ciò emerge dalleaffermazioni presenti negli scritti teorici. Ricorderemo che in Pittura dell’avvenire,parlando di intuizione e ragionamento in merito al processo creativo, Ginna si eraespresso contro la divisione delle facoltà e aveva affermato: “noi crediamo soltantonella genialità, facoltà creativa che si esplica coscientemente o subcosciente-mente”108. In quella circostanza Ginna non spiega in cosa consista di preciso e comesi esplichi, ma la definisce una “facoltà creativa”.
Dal momento che lo scritto verte sul ruolo dell’artista, visto come “scopritore chesi serve di una sensibilità raffinata per forare il velo che copre la natura”109, è evi-dente che la genialità è da collegare all’atto della scoperta ed implica un certo gradodi sensibilità. Infatti, se andiamo a vedere il manifesto Pesi misure e prezzi del genioartistico scritto l’anno prima, il termine è contenuto nel titolo stesso e indica l’in-gegno dimostrato dall’artista nella sua creazione, frutto dell’energia cerebrale im-piegata nella scoperta di nuovi rapporti. La genialità consisterebbe dunque in uncerto livello di energia cerebrale impiegata a questo scopo. E ancora, in La scienzafuturista, si fa riferimento allo “scopritore geniale che trova nella realtà nuovi rap-porti logici, nuove architetture di legami”110. Ma va detto che già nella “Collezionedi Saggi Critici” del 1912, diretta da Corra e Settimelli, si affermava: “Associare lecose più diverse, più impensabili, costituisce l’ingegno”111.
Follia e genialità: Sam Dunn è morto di Bruno Corra 117
105 Magamal, Sam Dunn è morto, cit.106 Bruno Corra, Per l’arte nuova della nuova Italia, cit., p. 9. Corra specifica che si tratta de “Il
Centauro”, “Rivista”, “L’Italia Futurista”.107 Primo Conti, Coscienze, cit.108 Arnaldo Ginna, Pittura dell’avvenire, cit., p. 192.109 Ibid., p. 196.110 La scienza futurista, cit., p. 206.111 Emilio Settimelli, La critica di Benedetto Croce, in “Collezione di saggi critici”, cit., p. 74.

In Sam Dunn è morto vari sono gli indizi che fanno luce sulle condizioni atte afavorire la scoperta. Essi puntano in direzione del silenzio, della concentrazione,della contemplazione: pratiche che porteranno Dunn a essere artefice del fermentorivoluzionario descritto nel capitolo Parigi impazzita. Il progetto di Dunn non in-clude ambizioni di potere materiale: egli vuole rivelare agli uomini una “vasta lo-gica fantasiosa”112. Per questa ragione, intraprende un percorso alternativo rispettoa quello normalmente legato al raggiungimento della gloria e del potere, all’insegnadi discipline che mirano a sviluppare nell’essere la facoltà veggente, grazie allaquale aprirsi ad una logica non ristretta entro i confini del pensiero lineare, una “lo-gica fantasiosa” che ci riporta al concetto espresso da Carli.
Si è già visto come per Dunn fosse naturale l’immobilità, un’ “immobilità totale”protratta anche per diverse ore, accompagnata da un atteggiamento “silenzioso, im-bambolato, estatico”. Dunn viene inoltre descritto in “attitudine di intensa medita-zione”113 al cospetto di tutto quanto è ramificazione: dagli incroci di strade aigrovigli di rami degli alberi, alle radici delle piante. Per quanto riguarda lo sguardo,si legge di occhi “fissi, in attitudine di intensa osservazione” sulla spirale di fumoche dalla sua sigaretta “si insinuava” nell’atmosfera114. Ciò avviene, come si ricor-derà dalla citazione precedente, mentre risponde in modo apparentemente contrad-dittorio alle domande sugli obiettivi in relazione ai mezzi. Il narratore spiega chel’accento particolare posto sul verbo “si insinuava” è in realtà da attribuire ad unaltro amico di Dunn, anch’egli artista, che in una pagina di diario descrive Dunn inquello stesso atteggiamento:
Ho passato la sera con Dunn. Era più taciturno del solito! Avrà fumate, in poche ore, al-meno cento sigarette, osservando sempre con fissità da allucinato il modo in cui la spi-rale di fumo si innalzava insinuandosi nell’aria. Da ultimo ha cominciato a fumarne duecontemporaneamente, aspirandole, prima una e poi l’altra, con un ritmo da pazzo115.
Da questi estratti si intuisce che il silenzio, l’immobilità e la concentrazione sonofunzionali all’osservazione attenta della realtà, vista nella molteplicità di possibilitàinterattive tra i vari elementi che la compongono. Va detto che il raccoglimento e laconcentrazione costituiscono pratiche fondamentali di varie scuole di pensiero col-tivate dai fratelli Ginanni Corradini. Anche se Eva Khün Amendola, proprio nella suarecensione al romanzo di Corra, prende polemicamente le distanze dalla teosofia,così come da magia e occultismo, negando che la concezione futurista abbia qual-cosa in comune con queste discipline “passatiste”, l’influenza esercitata da taliscuole di pensiero è evidente e viene dichiarata dagli stessi Ginanni Corradini. Si ègià avuto modo di constatare come, tra le letture dei fratelli ravennati, vi fossero gliscritti di Rudolf Steiner. Tra le pratiche fondamentali allo sviluppo dei “sensi supe-riori”, presenti allo stato latente in ogni individuo, Steiner pone la concentrazione,
118 Capitolo quinto
112 Bruno Corra, Sam Dunn è morto, cit., p. 75.113 Ibid., p. 25.114 Ibid., p. 20.115 Ibid., p. 21.

grazie alla quale penetrare attraverso la superficie delle cose e scoprire gli “arcaniinsospettati” di esse116.
Un’altra influenza, accertata e confermata dalla corrispondenza, deriva dai mo-vimenti costituitisi in quegli anni in America, il cui comun denominatore consistevanell’impegno a sfruttare le potenzialità insite nell’essere umano, attraverso un usotenace della volontà. Tali scuole di pensiero erano molto seguite da Bruno Corra,come si è avuto modo di notare attraverso le lettere inviate a Emilio Settimelli. Siricorderà che, in una di queste, Corra aveva proposto al collega di presentare al pub-blico il nuovo periodico, annunciando che esso prendeva le mosse dalle correnti svi-luppatesi all’estero. Come programmato, in uno degli articoli del primo numero di“Rivista”, Corra fa riferimento a quanto fatto in Francia, in Inghilterra e in Americasui “diversi metodi atti a sviluppare le innumerevoli facoltà ed attitudini esistenti nel-l’uomo” per “pervenire alla creazione di un tipo umano superiore”, ponendosil’obiettivo di introdurre però in questi studi “l’esattezza e l’oggettività della scienzapositiva”117.
Per capire su cosa si basassero tali metodi, è utile fare riferimento ai vari articolipubblicati su “Leonardo”, in quanto la rivista seguiva da vicino i movimenti che an-davano costituendosi in quegli anni. Lo stesso Giovanni Papini, co-direttore della te-stata, si era dedicato con grande passione allo studio dei sistemi atti ad accrescereil potere della volontà. In Un uomo finito, dove narra il suo percorso intellettuale, eglidescrive il desiderio di ascesa verso le più alte vette del potere. Un potere non giàrivolto a scopi umani, ma teso al raggiungimento di un obiettivo molto più inusitato,che così spiega:
In me sorgeva allora il sogno taumaturgico: il bisogno, il desiderio di purificare e raffor-zare lo spirito per farlo capace d’agir sulle cose senza strumenti e intermediari e giungerecosì al miracolo e all’onnipotenza. Attraverso la “volontà di credere” tendevo alla “vo-lontà di fare” – alla possibilità di fare. Se la volontà potesse estendere il suo cerchio dicomando dal corpo proprio alle cose che lo circondano – e far sì che tutto l’universofosse il suo corpo, obbediente in ogni sua parte a un ordine suo, come ora sono obbedientiquesti pochi fasci di muscoli!118
Papini è insomma convinto che lo spirito, la più nobile, perfetta e raffinata forzadella natura, possa essere anche la più potente a patto che venga intesa e diretta nelmodo opportuno119. Con questo obiettivo, si rivolge a religione e scienze occulteche, seppure seguendo percorsi diversi, avevano già dimostrato l’esistenza di poterinon comuni, di volontà fuori dall’ordinario. Per Papini, tuttavia, entrambe questestrade non si dimostrano idonee al suo scopo. Il limite dell’esperienza mistica con-
Follia e genialità: Sam Dunn è morto di Bruno Corra 119
116 Rudolf Steiner, L’iniziazione: come si conseguono le conoscenze dei mondi superiori, Milano,Editrice Antroposofica, 1904. Questa citazione tratta dall’edizione del 1977, p. 23.
117 Bruno Ginanni Corradini, La coltura umana, in “Rivista”, cit., p. 2.118 Giovanni Papini, Un uomo finito, pubblicato a Firenze nel gennaio 1913 nei “Quaderni della
Voce” diretti da Giuseppe Prezzolini per la la “Libreria della Voce” (quaderno n. XVIII-XIV). Citiamodall’edizione Firenze, Ponte alle Grazie, 1994, p. 89.
119 Ibid., p. 132.

siste nell’abdicazione della volontà individuale a favore di quella universale, a unarinuncia all’io e ai desideri, laddove egli non crede nella rinuncia di sé, ma all’azioneguidata dal pensiero e dalla coscienza. D’altra parte, le scienze occulte, pur coltivateattraverso frequentazioni, letture ed esperienze personali, non soddisfano il suo bi-sogno di sistematicità e rigore. Eppure, egli considera i fenomeni paranormali “ef-fetti fisici di cause spirituali”120 e ritiene che, tra tanta incertezza e confusione, ci sianondimeno “il nucleo, il seme, il primo frammento di un’arte del miracolo”121. PerPapini, questi fenomeni dimostrano possibilità trascendenti, indicano che è possibileuna padronanza psichica sul mondo dell’inerte. Questi “miracoli”, compiuti da in-dividui fuori dal comune in stati straordinari, dovevano diventare possibili a tutti enegli stati ordinari. Da involontari quali a volte erano, dovevano trasformarsi in vo-lontari. Crede inoltre nella validità di alcune pratiche raccomandate per l’acquisi-zione di poteri non comuni.
Si convince che il successo del sogno taumaturgico richieda un arduo percorsointeriore, un intenso sforzo cerebrale, un raccoglimento nella profonda intimità delsuo essere, l’educazione al dolore e la pratica del silenzio, il distacco dalla mate-ria122. Per intraprendere la sua missione dovrà tramutarsi in un genio. Ma Papininon guarda certo al genio inteso nel suo senso più comune, quanto “al genio vero,all’anima grande, all’eroe gigante e solitario come un monte di notte”123. E con-fessa: “[...] voglio, disperatamente voglio, diventare un grand’uomo davvero – di-ciamo addirittura la parola che fa paura: un genio!”124. Immaginando il piacere disentirsi l’anima “tesa verso qualcosa di assurdo e di maestoso”, spiega che: “Il genioè fanciullo e pazzo, ed è genio perché ha il coraggio di essere fanciullesco e pazze-sco e non può fare a meno di fare qualche volta la figura dell’ignorante e dell’idiota,di quello che si meraviglia di tutto e fa dei discorsi senza senso comune”125.
Questo concetto di genialità legata alla realizzazione di un impresa maestosaquanto inconcepibile e la risposta dell’ambiente nel quale il genio si trova ad ope-rare, sono rapportabili al personaggio creato da Corra. Il percorso di Dunn, le pra-tiche seguite in vista del suo scopo, generano fraintendimento. Il suo comportamentoviene interpretato come segno inequivocabile di squilibrio e disadattamento.
Non sorprende scoprire che, anche per Papini, la pratica per lo sviluppo di nuovefacoltà passi per l’America, un paese aperto a tutte le novità e fecondo di scuole dipensiero aventi questo obiettivo. Papini si prefigge di prepararsi in quella terra per
120 Capitolo quinto
120 Ibid., p. 137.121 Ibid.122 Ibid., p. 121.123 Ibid., p. 119.124 Questo passaggio ricorda quello di Corra che, sulle pagine de “Il Centauro”, aveva confidato:
“[...] il mio destino è di andare verso il mio grande sogno di solitudine lucida e sicura. Diventerò ungrand’uomo, un grandissimo uomo. Sono sulla buona strada”. E, in un percorso che ben si inseriscenell’ambito delle pratiche seguite a questo scopo, prosegue dicendo: “Avanzo piano, mi arrampico conle unghie e con i denti. Non bevo più eccitanti. Ho i muscoli del corpo sviluppati, armoniosamente.Non ho più una sola fibra di grasso in tutto il corpo”. Bruno G. Corradini, Replica a J.W.Hopkins, in “IlCentauro”, cit.
125 Giovanni Papini, Un uomo finito, cit., p. 120.

qualche anno, in solitudine, per concentrarsi sul potere dell’anima, rafforzare la vo-lontà, scoprire i segreti dell’azione spirituale. Come spiega nella sua autobiografia:“Il mio scopo immediato era uno solo: accrescere all’infinito il potere della mia vo-lontà; far si che il mio spirito potesse comandare a uomini e cose senza bisogno diatti esterni. Cioè: far miracoli. Null’altro”126.
Come anticipato, alcuni articoli pubblicati su “Leonardo” aggiungono nuovi ele-menti sulle discipline coltivate in quegli anni e di cui è lecito supporre Corra fosseal corrente, come si è appreso dalla corrispondenza a Settimelli. Illustrando i prin-cipi del “Nuovo Pensiero Americano”, Roberto Assagioli parla della concentrazionecome metodo per sviluppare la volontà, la quale non sarebbe altro che una forza,“dell’energia che si sprigiona” a patto che vi sia un punto di applicazione sul qualeagire127. Tale punto di applicazione consisterebbe in una rappresentazione, “un’im-magine mentale” la quale, per effetto della volontà riversata su di essa, sarebbe ingrado di produrre delle modificazioni prolungate.
Attraverso un uso corretto della concentrazione, definita come “l’atto di fissarel’attenzione su una sola idea o immagine mentale e di tenerla così per un certo pe-riodo di tempo senza interruzione”128, la volontà condurrebbe dunque la coscienzaa “stati completamente differenti ed enormemente superiori a quelli ordinari”129.Con ciò si deve intendere la capacità di “entrare in comunione con parti sempre piùvaste del mondo”, fino ad arrivare ad uno stato di “coscienza cosmica”, che sarebbeuna condizione di “comunione” con le cose e gli esseri partecipi tutti di un unico spi-rito di vita. A questo riguardo, si ricorda che recensendo Sam Dunn è morto sulle pa-gine de “L’Italia Futurista”, Amendola aveva parlato di “psiche non più terrestre macosmica” dimostrata da Corra nel suo romanzo. Tornando alla teoria del “NuovoPensiero Americano”, questo stato di coscienza cosmica si accompagna ad un au-mento generale di potenza, tanto più forte quanto più l’essere entra in sintonia conil tutto universale, dal momento che ne condivide le caratteristiche130.
Anche Papini parla della “compenetrazione” col tutto come condizione neces-saria perché il tutto ci obbedisca. Per incidere sulla realtà è necessario entrare e fon-dersi in essa. Diversamente, non saremmo in grado di dare ordini a ciò che èdisgiunto da noi, di fare in modo che la nostra volontà particolare diventi volontàuniversale e riesca a muovere ogni elemento del mondo nella stessa maniera in cuisi comanda un arto del corpo. Papini parla di una volontà che riesce a demolire “lepiù rigide barriere dei fisici”131.
Sullo stesso tono dell’articolo di Assagioli è quello di Arturo Reghini, pubblicatol’anno precedente. Traducendo una conferenza tenuta a New York, Reghini parladella concentrazione della mente umana come potente strumento per penetrare nei
Follia e genialità: Sam Dunn è morto di Bruno Corra 121
126 Ibid., p. 134.127 Roberto Assagioli, Il nuovo pensiero americano, in “Leonardo”, a.V, serie 3, aprile-giugno 1907,
p. 202.128 Ibid.129 Ibid., p. 207.130 Ibid., p. 209.131 Giovanni Papini, Un uomo finito, cit., p. 136.

segreti della natura. Qui si legge che “i poteri della mente sono come i raggi di lucediffusa; quando vengono concentrati essi illuminano ogni cosa”132. Quanto più lamente è concentrata, tanto più sviluppa il potere di incidere su di un punto. Il RajaYoga è visto come esercizio atto a sviluppare tale capacità. A questo genere di pra-tiche è dedicato anche un intervento dello psichiatra William James. Parlando dellanecessità di esercitare la volontà a forzare le barriere che l’abitudine ha costruito at-torno ai suoi strati più profondi, James parla dello Hatha Yoga, che condurrebbe allagraduale attivazione di energie non ancora adoperate133.
Questa esposizione è rilevante ai fini della nostra analisi, in quanto anche perDunn il raccoglimento e la concentrazione sono mezzi attraverso i quali incideresulla realtà. Parimenti, la volontà di Dunn ha un punto di applicazione. Dalla letturadel racconto si capisce come, per Dunn, la concentrazione equivalga ad uno sforzo“intenso, continuo, accanito, stremante”. Tale impegno è teso a cogliere “un caos dipossibilità meravigliose” che egli vuole “ad ogni costo afferrare e dominare [...]”134.Elio Gioanola osserva a questo proposito: “Il protagonista non è un operatore dimodificazioni magiche, ma un centro d’inerzia psichica, che fa scoppiare il reale invirtù di un’enorme concentrazione di energie: al contrario di un medium dominatoda forze che lo sovrastano, Sam Dunn scatena energie perché ‘vuole’ il mondouguale al suo desiderio, scardinato da ogni obbedienza alle leggi fisiche, alla logica,alla ‘normalità’ [...]”135. Lo studioso rileva quindi come Parigi diventi “epicentro diquesta fantastica mutazione”136. Dunn è consapevole artefice dello scardinamentooperato in una Parigi che viene per questa ragione definita “impazzita”137 e inizia a“fermentare di fantasia”138. Il narratore parla infatti di “corrente fantastica impostaa Parigi dal suo sforzo psichico”139.
Non è un caso che come punto di applicazione della concentrazione di energiedi Dunn Corra scelga Parigi, capitale della nazione che aveva vissuto la grande sta-gione simbolista, città all’avanguardia nella sperimentazione artistica. In uno scrittodal titolo Cose inutili, dove un sarcastico Corra sferra l’attacco ai perbenisti e con-servatori volti all’utilità delle cose, Parigi viene proposta come contraltare dell’uti-lità. In essa, i futuristi ammirano “la più pazza vetrina di inutilità che il genere umanoabbia saputo creare e radunare per il necessario esilaramento del suo spirito”140. Nelsuo intervento Corra afferma:
I moralisti e i benpensanti affermano che il nostro sforzo progressivo deve essere rivoltoverso l’utilità. Essi sono convinti che le cosidette cose utili posseggano veramente il mi-
122 Capitolo quinto
132 Arturo Reghini (a cura di), Georgica Animi (La Raja Yoga), traduzione di una conferenza diSwami Vivekananda, tenuta a New York nell’inverno 1895-1896, in “Leonardo”, a. VI, serie 3, Firenze,aprile 1906, p. 185.
133 William James, Le energie degli uomini, in “Leonardo”, a. V, serie 3, Firenze, febbraio 1907, p. 16.134 Bruno Corra, Sam Dunn è morto, cit., p. 28.135 Elio Gioanola, Bruno Corra, cit., p. 790.136 Ibid.137 Bruno Corra, Sam Dunn è morto, cit., p. 31.138 Ibid., p. 35.139 Ibid., p. 74.140 Bruno Corra, Per l’arte nuova della nuova Italia, cit., p. 110.

rifico potere di aumentare la felicità degli uomini e la serietà del mondo. Da questa fedederiva la coscienza del dovere assoluto di dedicare ogni energia umana ad aumentare ilnumero e la grandezza di queste tali cose utili. [...] Ma non possiamo certo contentarcenenoi, lucidi futuristi affacciati sulle più vertiginose possibilità141.
Come evidenziato nel capitolo precedente, già in un articolo apparso su “Il Cen-tauro” dal titolo L’inutilità del “Centauro” Emilio Settimelli (co-direttore della te-stata) aveva rivendicato alla rivista una funzione non ricondotta a nessun tipo di“utilità vera” e avente piuttosto il carattere di un’esplorazione142. La rivista venivapresentata come veicolo espressivo atto a portare alla luce “un tesoro nascosto” e ri-volto alla “persona elevata” desiderosa di “contemplare qualcosa di estraneo, qual-cosa di vergine, qualcosa di inesplorato”. L’utilità legata a fini pratici viene vistacome ostacolo alla percezione della realtà nelle sue pieghe più profonde. Nello stessoarticolo, riflettendo sul valore dato alle cose pratiche e materiali a scapito della poe-sia e dell’arte, mettendo in discussione il rilievo dato alla “normalità” rispetto all’“anormalità”, Settimelli chiede: “Nessuno sa la gioia ineffabile dello strappareun’immagine appesa ad un oggetto comune, dello scoprire un’affinità peregrina edinutile?”. È evidente che quest’immagine corrisponde a quella del “pensiero pere-grino”143, volto a cogliere rispondenze tra gli elementi della realtà non collegate aisuoi aspetti pratici e funzionali.
In risposta alla spinta fantastica imposta dallo sforzo psichico di Dunn, la mate-ria tutta inizia ad agitarsi, a ribollire: “La materia respirava e fantasticava. […] L’ariaera piena di sorprese […]”144. La rivoluzione fantastica è descritta da Bruno Corrain pagine riuscitissime. Parigi è invasa da una corrente di energia che si manifestaattraverso il dinamismo degli oggetti, la loro capacità di volo, di sparpagliamento.Liberandosi dalla gabbia delle leggi fisiche, ribellandosi alle strutture imposte lorodal pensiero logico e coerente, dai fili conduttori, sottraendosi al principio dell’or-dine stabilito, gli oggetti si animano riappropriandosi delle naturali facoltà che la ri-voluzione futurista restituisce loro: rumore, peso, odore. Ed ecco che la giacca dellosmoking assume vita propria: “la vidi partire dalla mia mano ad una velocità stra-ordinaria, […] perdersi nel cielo in pochi secondi”145; nel bar la macchina da caffèinizia a versare il liquido bollente nelle sale e poi ancora fuori per la strada senza chenessuno l’abbia messa in azione; i negozi dei gioiellieri si spalancano contempora-neamente per liberare i preziosi che “si raggrupparono in un unico sciame sfolgo-rante e sonoro”146: un vortice di movimenti, una “metropoli sinfonizzata”147. Ilsegnale è arrivato. La materia tutta esplode rispondendo a un richiamo a catena. Unfenomeno ne genera un altro in una rete di rapporti che altera la natura stessa delle
Follia e genialità: Sam Dunn è morto di Bruno Corra 123
141 Ibid.142 Emilio Settimelli, L’inutilità del “Centauro”, in “Il Centauro”, cit.143 Emilio Settimelli, A proposito di futurismo, in “Il Centauro”, cit.144 Bruno Corra, Sam Dunn è morto, cit., pp. 40-41.145 Ibid., p. 34.146 Ibid., p. 36. 147 Ibid., p. 40.

cose. La materia respira, si dilata, si espande, si trasforma: “La torre Eiffel germo-gliò come un arbusto”148.
Al sovvertimento degli oggetti si accompagna quello degli individui, che ini-ziano a comportarsi irragionevolmente, “nella maniera più pazza che sia dato di im-maginare”149. Così accade che una guardia lancia il berretto in aria e inizia asaltellare come un passero150. Il prefetto di polizia, garante dell’ordine e del rispettodelle regole, esce a passeggio nudo con la consorte ugualmente nuda151. Gli indivi-dui si sottraggono all’abitudine, alle aspettative, alle consuete leggi di causa ed ef-fetto, per cui una reazione ne genera un’altra inconsueta, se non del tutto anomala.Alla sequela di ingiurie con la quale un operaio reagisce ad un oltraggio subito, l’al-tro risponde intonando “La Marsigliese”152.
E tutti si riversano sulle strade: un “ribollimento di folla”153 che marcia com-patta e convinta “verso un fine ignoto”154. Ad un tratto, da questa moltitudine di es-seri, si sente emettere un unico grido compatto “che era lo scopo, che era il culminedella frenetica vertigine dalla quale erano stati trascinati”155. Questo “grido fanta-stico” scaglia verso il cielo, per cinque volte, un nome: “Sam Dunn! Sam Dunn!Sam Dunn! Sam Dunn! Sam Dunn!”156. Il sommovimento indotto da Dunn rag-giunge il climax in questo frangente, che tuttavia non rappresenta un punto di arrivo,ma solo l’inizio di un progetto su più larga scala. All’inizio del capitolo successivosi legge infatti:
Lo scatenamento di energie occulte operato da Sam Dunn poteva sembrare, durante l’in-tera giornata del cinque giugno, trionfalmente avviato. C’era veramente nella realtà losmarrimento di chi si sente assalito da una forza gigantesca e ignorata. La più complessadelle rivoluzioni era iniziata. Le vecchie apparenze materiali crollavano. Nel mondo degliuomini si aprivano crateri di imprevedibilità, emergevano foreste di capricci, irrompevanotorrenti di nuove leggi e di nuove logiche. La decrepita immobilità della materia era sulpunto di venir sostituita da una viva elasticità multiforme [...]157.
Le “foreste di capricci”, così come il “colossale vortice di energie capricciose”158
attribuito a Parigi, ricordano “i capricci dell’ispirazione” rivendicati dai futuristicome canone della “ricostruzione futurista dell’universo”159. Si tratta di una conce-zione dell’arte vista come espressione astratta degli elementi dell’universo combi-nati secondo la bizzarria del momento, la rivelazione inattesa e fulminea,
124 Capitolo quinto
148 Ibid., p. 40.149 Ibid., p. 44.150 Ibid., p. 35.151 Ibid., p. 37.152 Ibid., p. 35.153 Ibid., p. 42.154 Ibid., p. 44.155 Ibid., p. 45.156 Ibid.157 Ibid., p. 49.158 Ibid., p. 42.159 Giacomo Balla, Fortunato Depero, Ricostruzione futurista dell’universo, cit.

l’associazione repentina. È la realtà in movimento che si può allacciare e slacciarein tante relazioni inusitate. Il moto liberatorio si ritrova nella definizione di Parigi“impazzita”, dove l’aggettivo indica la ribellione di oggetti e persone all’ordine sta-bilito, a favore di un ritmo frenetico e imprevedibile. L’alterazione, l’anomalia vannodi pari passo con l’atto esplorativo, nel momento in cui esso è rivolto a captare pos-sibili interazioni, allacciamenti inconsueti tra gli elementi della realtà. Si ricorderàche Dunn è descritto nell’atto di fumare due sigarette contemporaneamente, aspi-randole a turno “con un ritmo da pazzo”, osservando la maniera in cui la spirale difumo si eleva “insinsuandosi nell’aria”. La pazzia ha un suo ritmo ed è questo ritmoche porta alla scoperta.
Questo approccio alla realtà fa parte di un’indagine multidisciplinare che inve-ste varie espressioni artistiche, come testimonia il film Vita Futurista, girato da Ar-naldo Ginna nel 1916160. Nel commentare alcune sequenze del film, Giovanni Listaosserva: “Illustrando una ‘discussione fra un piede, un martello e un ombrello’, op-pure presentando ‘oggetti stranamente accozzati per vederli sotto nuovi aspetti’, ilfilm Vita Futurista metteva in opera un estraniamento visivo sulla base di quei ‘nuovirapporti tra le cose del mondo’ che Corra annoverava tra le indagini percettive dasvolgere in funzione di una ‘energia cerebrale’ rinnovata”161.
Del resto questa materia che respira e fantastica, caratterizzata da una “viva ela-sticità multiforme”, era stata oggetto dell’investigazione non solo di Corra, già a par-tire dalla produzione dei primi anni ’10, ma anche dei compagni di “pattuglia”, qualiMaria Ginanni, Primo Conti, Mario Carli, come si è visto nel capitolo precedente,sulla dimensione onirica. Come il sogno rappresenta una condizione privilegiata gra-zie a cui avvertire il flusso della materia, così la follia, rivisitata in senso futuristacome costituzione cerebrale dell’individuo moderno consente, grazie ai suoi ritmi, diveicolare l’incessante attività interagente tra i vari elementi che la compongono. Taleattività si svolge all’insegna delle più inedite associazioni ed è per questo motivovista come “una vasta logica fantasiosa” che Dunn vuole rivelare agli uomini.
Come aveva affermato lo stesso Corra qualche anno prima in un documento teo-rico: “per fantasia intendiamo la facoltà di accozzare”162, di scoprire cioè nuove re-lazioni. Si può dunque affermare che, nel romanzo di Corra, i numerosi riferimentialla fantasia, sia come sostantivo (Parigi inizia a “fermentare di fantasia”163) checome verbo (“la materia respirava e fantasticava”164) e aggettivo (Parigi permeata dauna “corrente fantastica”165), stabiliscono un rapporto di equivalenza tra l’attività
Follia e genialità: Sam Dunn è morto di Bruno Corra 125
160 La pellicola è purtroppo andata persa.161 Giovanni Lista, I caratteri specifici del futurismo emiliano-romagnolo e le loro ripercussioni nel
campo dello spettacolo, in Anna Maria Nalini (a cura di), Futurismo in Emilia Romagna, Modena, Ar-tioli, 1990, p. 98. In Leggenda, apparso su “Il Centauro”, cit., Corra osserva: “Determinare esattamente,scientificamente le condizioni dell’ uomo che applicando la sua energia intellettuale scopre nuovi rap-porti tra le cose del mondo, sembra a me uno dei problemi più interessanti e di più immediata utilitàche un critico possa proporsi”.
162 Bruno Corradini, Il liberismo, in “Collezione di saggi critici”, cit., p. 165.163 Bruno Corra, Sam Dunn è morto, cit., p. 31.164 Ibid., p. 40.165 Ibid., p. 74.

fantastica e quella analogica: fantasticare significa scoprire analogie tra cose appa-rentemente remote.
Nel corso della trattazione si è preso in considerazione l’ascendente esercitato suCorra dalle scuole di pensiero impegnate nello sviluppo delle facoltà latenti, ma èimportante sottolineare altresì, come già fatto da alcuni studiosi, l’effetto dell’im-patto prodotto dalla società tecnologica. Secondo Gian Battista Nazzaro, la spintarinnovatrice operata da Dunn sarebbe stata alimentata dai ritmi della nuova era edin sintonia con essi. Per lo studioso, il mondo di Sam Dunn è anche il prodotto del-l’interazione tra inconscio e linguaggi tecnologici166.
Questo tipo di scambio è alla base della sperimentazione futurista e si può indi-viduare già a partire dal paroliberismo, che combina l’acceleramento prodotto dallavita moderna con la consapevolezza di un’identica irruenza del mondo interiore, al-lacciato all’universo intero. Marinetti vede infatti nelle parole in libertà la possibilità,per l’individuo moderno, di rendere le “vibrazioni del proprio io”167 così come na-scono, senza “fili conduttori”168, che andrebbero a interferire con il ritmo della psi-che caratterizzata da idiosincrasie. Nazzaro tiene conto di questi precedenti quandoafferma: “La rivitalizzazione dei linguaggi prodotti dall’ambiente tecnologico attra-verso scambi continui di energie tra l’inconscio e il reale è uno dei nodi, non solo delparoliberismo marinettiano, ma dello stesso sintetismo narrativo corriano [...]”169.
Alla luce di queste considerazioni andrebbe forse elaborata l’affermazione di San-dro Zanotto il quale, parlando del racconto di Corra, lo definisce “un romanzo di in-tonazione decisamente antimarinettiana e legato all’esperienza onirica”170. Per quantoil futurismo milanese sia caratterizzato da una certa solarità implicita nel suo “aspettovitalistico e dinamico”171 legato alla civiltà tecnologica, il dinamismo della materiapercepito a livello cerebrale come incessante attività interagente tra i suoi vari ele-menti costitutivi raccorda le due sfere nell’ambito di un unico disegno volto a son-dare e rappresentare una realtà in fermento.
Alle riflessioni di Nazzaro vanno aggiunte quelle di Anna Maria Cioni, la qualepure individua una stretta corrispondenza tra il mondo di Dunn e le energie esterne.Secondo la studiosa “incanalando le energie fantastiche della multiforme realtà dellavita moderna nel suo spirito, Dunn arriva allo scatenamento di tutte le forze occulte eall’instaurazione di ‘nuove leggi e di nuove logiche’”172. A questo proposito, la Cioniricorda l’attenzione di Dunn verso gli ingorghi di folla che richiamano il tema di spi-rali e vortici, figure caratteristiche dell’avanguardia e ricorrenti presso i futuristi173.
126 Capitolo quinto
166 Gian Battista Nazzaro, Nel mondo di “Sam Dunn”, in “Es”, n. 2, ottobre-gennaio 1975, p. 110.167 Filippo Tommaso Marinetti, Distruzione della sintassi-Immaginazione senza fili-Parole in li-
bertà, cit., p. 70.168 Ibid.169 Gian Battista Nazzaro, Nel mondo di “Sam Dunn”, cit., p. 110.170 Zanotto Sandro, Motivi irrazionali ed esoterici nel futurismo toscano, cit., p. 113.171 Ibid., p. 111.172 Anna Maria Cioni, Teoria e pratica della scrittura esoterica nel futurismo, cit., p. 684.173 Ibid. La Cioni menziona, tra gli altri, il romanzo di Paolo Buzzi L’ellisse e la spirale (Edizioni
di “Poesia”, Milano, 1915) e la rivista di Anton Giulio Bragaglia “La Ruota”, fondata nel 1916.

Come si è già avuto modo di notare, al centro dell’ interesse di Dunn vi era tuttoquanto rappresentava ramificazione, incroci, grovigli. Si capisce che il soffermarsisu questi intrecci andava al di là della semplice osservazione. Parlando dell’interessedi Dunn a fermarsi nel punto di incrocio tra due o più strade, il narratore conclude:“Mi sembra che egli debba sfruttare questi vasti ingorghi di folla fermentanti di stre-piti e di colori incanalandoli nel suo spirito”174. La sua tendenza a convogliare ener-gie altre si ritrova in un altro punto del racconto, dove si legge che Dunn “venivacostruendo nel buio, a tentoni, il ponte di esperimenti che doveva permettergli, in se-guito, di incanalare nella nostra realtà energie proprie di un mondo di fenomeni piùcomplessi”175. Corra avrebbe poi rafforzato questo punto in un documento del ’19,dove afferma: “La potenza infallibile ed invincibile della concentrazione degli sforzigiunge a operare tali prodigi che non si può fare a meno di pensare che essa agiscanon solo per forza propria ma anche raccogliendo attorno a sé la collaborazione at-tiva di energie ancora ignote sparse ovunque nella realtà”176.
Ciò si riallaccia alle formulazioni teoriche espresse sia in La scienza futurista chein Pittura dell’avvenire, dove gli autori fanno riferimento a “nuove energie”, a “ener-gie più complesse” che si affacciano alla nostra conoscenza manifestandosi in feno-meni quali il medianismo e lo psichismo, la divinazione e la telepatia177. Esse, giàoggetto di studio, avrebbero portato la scienza e l’arte in un nuovo e più largo ordinedi idee178. In altri documenti si parla dell’esistenza di “forze mal definite” dissemi-nate nella realtà, che esercitano un’influenza nella nostra vita. Ad esse l’artista vieneinvitato ad attingere per pervenire a scoperte geniali che andrà poi a rappresentare179.
Tuttavia, quando sembra che, in seguito allo scatenamento di tali forze, la rivo-luzione sia ormai trionfalmente avviata e inarrestabile, si legge di questa “formida-bile marea rinnovatrice” perduta “nella più sterile delle deviazioni”180. In effetti,questa spinta di rinnovamento fallisce a causa di un contropotere magico avente il suoepicentro in Portorosa. Questa località viene associata a Parigi nel senso che en-trambe rappresentano “i due poli di irrealtà della nostra realtà”181. Si tratta di un pic-colo golfo poco conosciuto della riviera ligure chiamato Bogliano e ribattezzatoPortorosa dallo stravagante cav. Angelo Santerni che, capitatoci per caso, decide dicostruire sul suo terreno il “Portorosa Hotel”, inusuale sia nella forma che nella ge-stione, frequentato da tipi altrettanto eccentrici. L’hotel, ribattezzato “hotel manico-mio” a motivo delle “conversazioni strampalate e le scene di imprevedibileillogicità”182 che avvengono tra i clienti dell’albergo, vede come principale presenza
Follia e genialità: Sam Dunn è morto di Bruno Corra 127
174 Bruno Corra, Sam Dunn è morto, cit., p. 25.175 Ibid., p. 28.176 Bruno Corra, O rinnovarsi o morire (sviluppate la vostra personalità), Milano, Facchi, 1919, pp.
40-41. 177 La scienza futurista, cit., pp. 208-209. 178 Arnaldo Ginna, Pittura dell’avvenire, cit., p. 195.179 F.T. Marinetti – Emilio Settimelli – Bruno Corra, Manifesto del teatro futurista sintetico, cit., p.
180.180 Bruno Corra, Sam Dunn è morto, cit., p. 51.181 Ibid., p. 73.182 Ibid., p. 67.

la moglie del cavalier Santerni, certa Giuseppina chiamata anche, probabilmente amotivo della sua imponenza fisica, Peppona.
La signora Giuseppina, la quale trascorre intere giornate sdraiata su una poltronanella hall dell’albergo, è conosciuta per le sue “spiccatissime attitudini mediani-che”183. Si legge di un fluido benefico emanato dal suo corpo, allo stesso tempo cal-mante e vivificante, che agiva sugli ospiti dell’albergo, particolarmente attivo quandoquesti prendevano posto sulla poltrona precedentemente occupata dalla Peppona, adimostrazione del fatto che il fulcro di tale fluido magnetico andava individuato nel-l’enorme posteriore della signora. Il narratore spiega che non è chiaro se questaenergia venisse generata dalla Peppona o se non fosse piuttosto attirata dall’esternoe cumulata per essere usata al momento opportuno184. Di fatto, l’hotel Portorosa eradiventato gradualmente un “gigantesco serbatoio di quelle sfuggevoli e fosforeeenergie avviluppanti il nostro mondo che da cinquant’anni le scienze nuove si sfor-zano di dominare”185. Per questa ragione, non sorprende il fatto che l’hotel Porto-rosa, in attività già da quattro anni, non restasse estraneo a quanto avveniva a Parigiper opera di Dunn.
Nel racconto è scritto che, per quanto la massa di energie proiettate da Portorosasu Parigi doveva essere stata considerevole, non si può dire che a Dunn mancasseroi mezzi per neutralizzarla o in qualche modo incanalarla “nella corrente fantasticaimposta a Parigi dal suo sforzo psichico”186. Eppure, egli non interviene e anzi èpreso da grande ilarità nell’intuire che la “barocca banalità stava per strangolare lasua rivoluzione lirica”187. La rivoluzione fantastica di Dunn fallisce nel momento incui il flusso magnetico emanato dalla Peppona entra in circolo ad interferire con ilpotere dunniano e converte l’esito di questa rivoluzione nella frenesia di una molti-tudine che si trova a compiere compatta un gesto volgare ed assurdo. Un minutodopo che il delirio della folla parigina culmina nell’invocazione a Sam Dunn, unterribile terremoto colpisce la riviera ligure e distrugge Portorosa. Con essa, l’hotele tutti i suoi clienti, inclusi i coniugi Santerni. A due minuti di distanza da questoevento, gli effetti del magnetismo della Peppona si avvertono sulla moltitudine pa-rigina che, rispondendo ad un impulso irresistibile, inizia a pizzicare il deretanodelle signore vicine.
Commentando l’accaduto, il narratore osserva: “Una impreveduta corrente dienergie astrali aveva soffocato lo slancio lirico di una realtà che stava per elevarsiad un superiore piano di vita [...]”188. Il giorno dopo Sam Dunn viene colpito a mortedalla sua cameriera che, legatolo ad una poltrona, si abbatte ripetutamente su di luilanciandosi dallo scrittoio, colpendolo con il fondoschiena. “Sam Dunn è morto”189
e ciò porta a chiedersi come interpretare questo epilogo.
128 Capitolo quinto
183 Ibid., p. 67.184 Ibid., p. 67.185 Ibid., p. 73.186 Ibid., p. 74.187 Ibid., p. 75.188 Ibid., p. 77.189 Ibid., p. 85.

Secondo Elio Gioanola, lo scacco di Dunn rappresenterebbe il risvolto della suavittoria, in una lettura che va ad individuare in questo personaggio l’erede della tra-dizione superomistica fiorentina, culminata nel papiniano Uomo finito e nel Lem-monio Boreo di Soffici190. Il lettore assiste alla vicenda di un eroe che vuolecompiere qualcosa di veramente smisurato e inaudito, ma quanto più alta è la cimaa cui intende giungere, tanto più precipitosa è la caduta. Eppure, non si può fare ameno di osservare che, mentre la disfatta di Papini coincide con la sua incapacità dioperare il miracolo tanto auspicato, dal momento che le cose rimangono sorde allesue invocazioni, Sam Dunn riesce ad incidere la sua volontà su cose e persone. Egliottiene che la realtà risponda alla spinta messa in atto dal suo sforzo di volontà. Cio-nonostante, la rivoluzione di Dunn non va al di là di un processo di avvio e si perde“nella più sterile delle deviazioni”191.
Il nucleo attorno al quale condurre questa analisi va individuato nella scelta diDunn di non intervenire nel gioco di forze che vede Portorosa compromettere l’esitodella rivoluzione lirica da lui avviata. Come specifica il narratore, pur essendo nellecondizioni di neutralizzare o convogliare le energie emanate da Portorosa ai finidella sua rivoluzione, Dunn non fa nulla per arrestare le conseguenze di questo im-prevedibile contraccolpo. È su questo punto che occorre soffermarsi.
Recensendo il romanzo, Rossana Verdone individua una struttura narrativa com-posta di quattro sezioni. La parte inziale e quella finale sono scritte dall’autore inprima persona, a denotare la volontà di Corra di “raccontare delle idee, fare un ‘sag-gio’”192. Tra queste sono collocati i due blocchi centrali formati da due azioni di-stinte, la prima incentrata su Sam Dunn e la seconda sul cavalier Santerni. Nellaprima si assiste allo scatenamento della fantasia, nella seconda al cumulo di bana-lità e volgarità. La prima e l’ultima azione convergerebbero a conclusione dei dueblocchi. Nel momento in cui l’influsso negativo derivato dall’esito disastroso di Por-torosa si sposta su Parigi, va ad interferire con la rivoluzione lirica dunniana annul-landola e culminando con la morte di Dunn. Per la Verdone, lo scontro tra i dueblocchi narrativi rappresenterebbe la collisione tra due idee opposte evidenziate dal-l’autore: rivoluzione lirica da un lato e banalità del terrestre dall’altro. Il fatto cheCorra stia chiaramente dalla parte di Dunn e la sconfitta di quest’ultimo riflette-rebbe l’atteggiamento rinunciatario di Corra. A dimostrazione di ciò, la Verdone ad-duce le scelte dello scrittore che, nella produzione posteriore, passerà infatti apubblicare romanzi di facile consumo193. Dunque, “il suo messaggio è racchiusonel Sam Dunn e lì si conclude”194.
In base a queste osservazioni, sembra legittimo supporre che Sam Dunn incarniil punto di vista dello stesso Corra e che questi affidi la sua concezione al perso-
Follia e genialità: Sam Dunn è morto di Bruno Corra 129
190 Elio Gioanola, Bruno Corra, cit., p. 791.191 Bruno Corra, Sam Dunn è morto, cit., p. 51.192 Rossana Schiavina Verdone, Bruno Corra tra futurismo e surrealismo, estratto da “Teatro Con-
temporaneo”, rivista quadrimestrale diretta da Mario Verdone, a. III, n. 5, ottobre 1983-gennaio 1984,Roma, Lucarini, p. 206.
193 Ibid., p. 207.194 Ibid.

naggio da lui creato. Tale ipotesi è avallata dalle considerazioni di Mario Verdone,sicuramente non estraneo ai contenuti della recensione scritta da sua moglie Ros-sana. La prefazione al romanzo ripubblicato nel 1970 a cura di Mario Verdone e larecensione presentano infatti molti punti in comune, tanto da far pensare ad un la-voro congiunto, ma nella recensione questi punti vengono ulteriormente elaborati.Come si ricorderà, anche nella sua prefazione Mario Verdone punta in direzione diun parallelo tra Sam Dunn e Corra, confermando una linea esegetica già tracciata inuna precedente nota relativa al romanzo195.
Avanzando lungo il filone interpretativo delineato dai Verdone, si andrà dunquead esaminare il risultato della rivoluzione dunniana partendo dal profilo del perso-naggio in relazione all’ambiente nel quale questi opera. Nel contempo, si indivi-dueranno gli elementi che comprovano l’identificazione di Corra con il suopersonaggio. Commentando la scelta di Dunn di non contrastare il fallimento dellasua rivoluzione lirica, il narratore spiega che Dunn era dotato di “una intelligenzaagile, acuta, modernissima: spalancata quindi verso tutti gli scetticismi”196. A con-ferma di ciò, egli indica la nota scritta da Dunn prima di morire, composta da quat-tro brevi periodi, le cui parole iniziali, messe insieme, formano la frase: “Io me nefrego”197.
Vari sono i fattori responsabili della reazione dunniana qui descritta. Come rile-vato da Mario Verdone, Dunn opera nella Parigi operettistica e manieristica degliinizi del secolo e si trova dunque a condurre un’impresa che appare assurda in unambiente non consono a ricevere questa spinta. Ciò spiegherebbe in parte l’atteg-giamento provocatorio e allo stesso tempo scettico del personaggio. La società, tuttacompresa negli schemi dell’abitudine e della convenzione, non è pronta ad acco-gliere la rivoluzione lirica dunniana. La mediocrità dei tempi, l’indifferenza dei piùsi frappongono al successo dell’impresa e dunque il protagonista assisterebbe senzaintervenire al fallimento del suo progetto. A sostegno di questa tesi vanno le consi-derazioni con cui si apre il brevissimo capitolo conclusivo del romanzo, dal titolo“Sam Dunn è morto”, in cui si legge:
Morto, a consolazione di tutti i quietisti, senza rivelarci niente di tutto ciò che ha dovutosapere. Morto, da buon scettico, senza curarsi affatto di regalare i suoi tesori spirituali aquesta umanità che continua, da secoli, beatamente, ad evolversi198.
Per Rossana Verdone, il contrasto tra tradizionale e avveniristico crea i presup-posti per un’azione contrassegnata dall’ironia e affidata alla massima arbitrarietà emancanza di certezze199. Lo scontro dialettico dei contrari – aggiunge la Verdone –è l’elemento che maggiormente contraddistingue il romanzo e lo distacca dal prag-
130 Capitolo quinto
195 Mario Verdone, Cinema e letteratura del futurismo, cit., p. 63. L’estratto è stato già riportato inquesto capitolo.
196 Bruno Corra, Sam Dunn è morto, cit., p. 74.197 Ibid., p. 88.198 Ibid., p. 87.199 Rossana Schiavina Verdone, Bruno Corra tra futurismo e surrealismo, cit., p. 205.

matismo del futurismo ortodosso, per avvicinarlo a certi stilemi propri del surreali-smo200.
A questi elementi ne vanno aggiunti altri che attingono alle vicende personalidell’autore. Come osserva la Verdone, Corra sta chiaramente dalla parte di Dunn, mala sconfitta di quest’ultimo rifletterebbe l’atteggiamento rinunciatario di Corra. Sa-rebbe a dire che Corra, in quanto autore del romanzo, avrebbe potuto far trionfarela rivoluzione lirica sulla banalità, eppure opta per lo smacco di Dunn, per quantoquesto sia accettato dal protagonista e si accompagni anzi ad una reazione di ilarità.Mario Verdone, nella sua prefazione, parla di “scettico disincanto” con cui viene ri-solto lo scontro tra i due poli rappresentati da Parigi e Portorosa201. Alla luce del-l’analisi delle fonti primarie e secondarie, appare chiaro che il disincanto è corrianoe Dunn si fa portavoce di questa disillusione. Il romanzo rifletterebbe il sentimentodel suo autore, il quale traspone nell’esito del racconto la sua personale visione. Inbase a questa lettura, Dunn si profila come controfigura di Corra e ne assume loscettico disincanto.
Quest’analisi sembra coerente con il profilo emergente da certe liriche dal tonodiaristico e dalla lettura della corrispondenza. In Antenati, parlando di sé, Corraaveva detto: “E son nato così: coi due ginocchi inchiodati alla mia croce feroce discetticismo anarchico ironista”202. In una lettera a Balilla Pratella Corra scrive: “Haicapito il mio libro meglio di chiunque altro. Hai capito soprattutto la sofferenza tor-mentosa che c’è sotto l’apparente stramberia spensierata”203. Pur non avendo spe-cificato il titolo del libro, la lettera riporta la data completa (13 gennaio 1917), cherisale a circa due mesi dopo l’uscita del romanzo in volume. Dalla corrispondenzacon Settimelli si deducono inoltre alcuni tratti caratteriali di Corra, soggetto ad altie bassi, portato ad alternare slanci di entusiasmo e momenti di scoramento; un Corrache conta sulla forza di carattere del suo amico per mantenere desta la sua visione,sia che si tratti di progetti comuni quali la fondazione di un giornale che di propo-siti individuali204.
A questo proposito, va notato come la fragilità corriana non appaia molto dissi-mile da quella lamentata da Papini nell’indicare le cause del fallimento della suaimpresa. Nel capitolo dedicato alle ragioni della disfatta, Papini biasima non solol’insufficienza di forze, ma va a monte e riconosce di non avere posseduto neppurela forza di volere “trovare e creare” le forze che gli mancavano205. E conclude di-cendo: “[...] non ho avuto sempre in me, in ogni momento, come asse della mia vita,come fuoco centrale della mia anima, il sogno ch’io dicevo e magnificavo a pa-role”206. Pare dunque opportuno inquadrare il profilo corriano nell’ambito del più
Follia e genialità: Sam Dunn è morto di Bruno Corra 131
200 Ibid. p. 208.201 Mario Verdone, Nota a Sam Dunn è morto, cit., p. 79.202 Bruno Corra, Antenati, in Con mani di vetro, cit., p. 13.203 13 gennaio 1917, Fondazione Primo Conti onlus, Fiesole, Fondo Pratella, Corrispondenza B.
Corra-F. Balilla Pratella.204 Ravenna, 18 febbraio, s.a.; Ravenna, 19 febbraio, s.a. ; 19 ottobre, s.a. ; 21 settembre, s.a., Fon-
dazione Primo Conti onlus, Fiesole, Fondo Settimelli, Corrispondenza B. Corra-E. Settimelli.205 Giovanni Papini, Un uomo finito, cit., p. 146.206 Ibid.

ampio schema di un’epoca culturale in grande fermento, che vede gli intellettuali tesinello sforzo convulso di assorbire e convogliare gli spunti offerti dalle direzioni piùdisparate. Sono questi anni di frenetica attività culturale in cui si fondano movi-menti, si dà vita a giornali, in un clima non sempre ricettivo ad accogliere le novità.Quanto più alte sono le aspettative, tanto maggiore è la disillusione, che assume sfu-mature intimiste nell’ambito del filone fiorentino del futurismo, meno propenso a fa-cili trionfalismi e caratterizzato dal rifugio nell’individuale.
Questo sentimento è altresì presente nelle lettere di Corra a Settimelli, in cui ilprimo lamenta l’indifferenza del pubblico o la sua tendenza a ragionare “all’in-grosso”207. In “Rivista” Mario Carli, rispondendo all’accusa di ricorrere ad articolisensazionali per attirare l’attenzione del pubblico, ricorda la bassa tiratura de “IlCentauro”. Per Carli, ciò riflette l’indifferenza del pubblico e la sua incapacità di ap-prezzare la “rivista d’intenzioni e di modi aristocraticissima, satura di poesia e di ge-nialità, annunziante senza fanfarate il puro mattino di nuove forme d’arte...”208.
La lettura delle due prefazioni scritte da Corra per il suo Sam Dunn è morto (perl’edizione del 1917 e per quella del 1928) conferma queste ipotesi ed aggiunge altriparticolari. Nella prima prefazione, parlando dell’importanza tecnica del romanzo,Corra afferma che essa “aggiunge molto ai molti valori di contenuto profusi in que-sta opera interessante e profonda”209. Tuttavia, nella prefazione all’edizione del1928, i toni cambiano e l’opera viene da lui definita “un racconto inconsueto, ilquale si propone solo (bando alle tendenze, alle scoperte e alle rivelazioni!) d’in-teressare un pubblico ristretto di amatori del bizzarro”210. E al sottotitolo appostodall’autore all’edizione del ’17 (“Romanzo Sintetico Futurista”), fa seguito quelloapposto all’edizione del ’28 (“Racconto insolito”), quasi a volerne sminuire l’im-portanza e l’affiliazione. Per Verdone, questo gesto è probabilmente legato al-l’amarezza di un Corra che, alla delusione per la fredda accoglienza della criticarestia a riconoscere il valore del romanzo, unisce quella arrecata dall’esito del-l’avanguardia italiana, rientrata nei ranghi del “rappel à l’ordre”211. E dunque, inquesta prospettiva, Verdone si chiede: “Forse la sconfitta di Sam Dunn realizza unaparabola segreta della ‘deviazione’ del futurismo storico?”212.
Nella sua recensione al romanzo, Amendola conferma: “Pochissimi sono stati ca-paci di andare più dentro e di capire l’importanza dell’opera di Bruno Corra”, no-tando che dal pubblico l’opera è stata per lo più vista come “un libro piacente,allegro, curioso”213. Alla luce di queste considerazioni, l’analisi di Rossana Verdonepare legittima e indica che il romanzo recava già in nuce i segni di un disagio giunto,negli anni successivi, a piena maturazione.
132 Capitolo quinto
207 S.l. e s.d., Fondazione Primo Conti onlus, Fiesole, Fondo Settimelli, Corrispondenza B. Corra-E. Settimelli.
208 Mario Carli, Il pubblico che ci corrompe, in “Rivista”, a. I, n. 14-15, Firenze, 13 luglio 1913, p. 5.209 Bruno Corra, Prefazione a Sam Dunn è morto, 1917, cit., p. 12. 210 Bruno Corra, Prefazione a Sam Dunn è morto, 1928, cit., p. 9.211 Mario Verdone, Nota a Sam Dunn è morto, cit., p. 76.212 Ibid., p. 79.213 Magamal, Sam Dunn è morto, cit.

Tuttavia, accanto a questa linea interpretativa se ne profila un’altra. Quest’ul-tima indaga le forze agenti e collega l’esito della rivoluzione alla maniera in cui essevengono dirette. Partendo dalle prose poetiche, si osservi il nesso tra le considera-zioni di Corra nella prosa Avventure e quelle della voce narrante in Sam Dunn èmorto. Nel primo caso, riflettendo su quanto andava esperendo, Corra aveva parlatodi “squilibri di forze nell’oscuro substrato invisibile in cui si regge la vita visi-bile”214. Sotto l’influsso di queste forze onnipotenti, egli avrebbe potuto scatenareun cataclisma disastroso per se stesso, per gli altri e per il mondo. Tutto questo – so-steneva Corra – era possibile, e lo spiegava in questi termini:
Un’energia elettrica, non intelligentemente diretta, può produrre una catastrofe. Così leenergie ignote che si agitano nella materia e negli esseri, intorno a noi ed in noi stessi.Vivendo molto stranamente, agendo molto ed in maniera sempre nuova, sempre diversa,poteva ben darsi che io provocassi una scarica violenta, apparentemente illogica215.
A questo proposito va notato che Amendola, nella sua recensione al romanzo,parlando di psiche cosmica dimostrata da Corra e identificando in essa la disposi-zione psichica dell’uomo futurista, aveva affermato: “L’uomo cosmico (= l’uomo fu-turista) sta già al di sopra delle leggi terrestri; egli non è più statico. Dinamico,sempre elettrico, egli acquista come Sam Dunn una diretta influenza sul Cosmos, loplasma, produce catastrofe [...]”216.
Se si accosta il segmento di Avventure a quello del romanzo, dove si legge: “Lavita di Dunn si è svolta in questo substrato incosciente, dinamitico, inesplorato sulquale è stratificata la realtà materiale”217, è chiaro che esiste continuità nel percorsodell’autore e che la rivoluzione prodotta in Sam Dunn è morto ha le sue radici in que-sto substrato ancora inesplorato ma dinamitico, in grado di generare delle scarichepotenti ma dai risultati imprevedibili. Come sostiene Gian Battista Nazzaro, la ri-voluzione di Sam Dunn e il gesto volgare che uccide il tentativo di Dunn, appar-tengono allo stesso nucleo di forze ma costituiscono due diversi possibili sbocchi218.L’energia che Dunn incanala ai fini della sua rivoluzione lirica e quella emanatadalla Peppona costituirebbero dunque due forze uguali e contrarie, ma la seconda,non intelligentemente incanalata, andrebbe a scatenare un esito imprevedibile e di-sastroso. Per Nazzaro, “in gioco sono soltanto delle alternative, delle mere possibi-lità in base alle quali i risultati mutano pur rimanendo intatta la forza energetica ditutte le correlazioni che reggono una pura visione del mondo. Il mutamento riguardasolo la periferia, non già il nucleo genetico [...]”219.
Ai fini della nostra analisi, è essenziale evidenziare che, indipendentemente dalrisultato conseguito, il fulcro del racconto è tutto racchiuso nelle possibilità rivelategrazie al percorso di Dunn. Nel capitolo conclusivo si legge:
Follia e genialità: Sam Dunn è morto di Bruno Corra 133
214 Bruno Corra, Avventure, cit., pp. 107-108.215 Ibid.216 Magamal, Sam Dunn è morto, cit.217 Bruno Corra, Sam Dunn è morto, cit., p. 30.218 Gian Battista Nazzaro, Nel mondo di “Sam Dunn”, cit., p. 118.219 Ibid.

Dato lo stadio di evoluzione a cui siamo giunti non sarà possibile evitare che la compa-gine della nostra vita venga, a breve scadenza, sgretolata, fluidificata e liricizzata da unainvasione di energie fantastiche. Questa che io faccio è una facile profezia. La rivoluzionefantastica di Sam Dunn non è stata che un’avvisaglia. Noi viviamo sopra una polverieradi fantasia che non tarderà a scoppiare 220.
La figura dell’artista esploratore, in grado di rivelare l’esistenza di un substratodinamitico della realtà, ancora inavvertito alla comune percezione, si ritrova in varimanifesti, come già illustrato nel secondo capitolo. Si ricorda che i pittori futuristisi erano riproposti di “rendere l’invisibile che si agita e vive al di là degli spes-sori”221. La psiche viene sollecitata dalle energie della civiltà moderna e, a sua volta,agisce sulla realtà proiettando su di essa la sua carica esploratrice. Ginna si era sof-fermato sul ruolo dell’artista-preveggente in Pittura dell’avvenire, affermando:“L’artista è uno scopritore che si serve di una sensibilità raffinata per forare il veloche copre la natura. Ed esso è molte volte un profeta”222. Questi riferimenti confe-riscono credibilità al personaggio creato da Corra, e dimostrano come tra il percorsodi Dunn e quello del poeta individuato negli scritti teorici esista congruenza e unitàdi intenti. Il romanzo si profila dunque come esempio di poetica e ha carattere pro-grammatico.
134 Capitolo quinto
220 Bruno Corra, Sam Dunn è morto, cit., p. 87.221 Prefazione al Catalogo delle Esposizioni, cit., p. 62.222 Arnaldo Ginna, Pittura dell’avvenire, cit., p. 196.

VI.
DALLA VISIONE ALLA RAPPRESENTAZIONE: IL BARBARO DI MARIO CARLI
E poi immergersi nel caos totale delle strade: clacson,pompieri, ambulanze, pullman […]. I caratteristici tom-bini delle strade che in continuazione cacciano fumo(vapore), che ti fanno credere che sotto ci sia qualcheforma di vita pronta ad esplodere.
Da una mail del mio amico Gianluca Stefanelli, di Matino (Le), travolto da New York. 2011
Nel corso dei precedenti capitoli si è visto come l’artista sia un esploratore, il cuicompito è quello di scoprire e rendere il moto universale, attraverso le varie espres-sioni artistiche. Come osserva Luca Somigli, in base al modello “energetico” delfuturismo, “l’opera d’arte è prima di tutto una attività, il luogo in cui si rivela la di-namicità della materia, incluso l’essere umano cui non viene concesso alcuno sta-tuto privilegiato”1. Esiste una costituzione occulta dell’universo, così comedell’individuo, ancora inesplorata, un corpo invisibile ma vitale sottostante quellovisibile, che l’artista si propone di sondare e rappresentare.
Proseguendo nello studio, sono stati presi in esame due stati che, grazie alle loropeculiarità, corrispondono a tale esplorazione: la dimensione onirica e la follia. Nelsogno l’essere è in grado di cogliere le relazioni fluide che sono proprie della vitadella materia. La follia, d’altra parte, consente di scoprire nessi inusitati tra le cose,secondo principi altri rispetto a quelli della logica comune, soggetta alla coscienzavigile. Il sognatore e il folle sono messi in condizione di scoprire sogni e follie dellamateria: libere associazioni, quella che in Sam Dunn è morto era stata definita comeuna “vasta logica fantasiosa”2.
Come evidenziato nel quarto capitolo, Freud aveva tracciato un parallelo tra ilsogno e l’atto creativo, individuando in entrambi una continuazione e un sostitutodel gioco infantile. Come il bambino costruisce un mondo di fantasia partendo daglioggetti reali a cui dà un nuovo assetto per mezzo dell’immaginazione, così la crea-zione del poeta prende vita nel momento in cui si rimettono in moto i meccanismiche caratterizzano l’attività fantastica3.
Sull’analogia dell’arte con il gioco infantile era intervenuto anche Rudolf Stei-ner in occasione di una conferenza tenuta nel 1888 a Vienna. Citando FriedrichSchiller, Steiner identifica nell’impulso al gioco lo stesso impulso che è alla base del-
1 Luca Somigli, “Imbottigliature” di Primo Conti: Un romanzo futurista?, cit., p. 347.2 Bruno Corra, Sam Dunn è morto, cit., p. 75.3 Sigmund Freud, Il poeta e la fantasia, cit.

l’arte4. Come nel gioco si interviene sulle cose della realtà per metterle in una con-nessione che non ubbidisce alle leggi della logica comune, così l’arte, vista come “li-bero gioco dell’uomo a un livello superiore”, introduce un nuovo ordine nelle cose5.
Pertanto, sia la dimensione onirica che quella creativa comportano la riattivazionedi quegli stessi processi che animano l’universo infantile. Eppure, a differenza delsogno, l’atto creativo converte le fantasie in un prodotto sociale, comunicativo. Lad-dove un folle o un sognatore vive questo stato in una dimensione privata, l’artistamira a dare visibilità alla sua scoperta. Così avviene per i futuristi fiorentini. L’arti-sta non è compreso nella sua visione in modo esaustivo, ma aspira a rappresentare ciòche vede, come emerge da articoli e scritti teorici.
Nell’articolo di apertura de “Il Centauro”, Corra annuncia, in riferimento alla“produzione originale” a cui il giornale darà ampio spazio: “stamperemo romanzi, no-velle, poemetti, fantasie”6. Pari intento si ritrova nella produzione letteraria annun-ciata da Bruno Corra. Nell’articolo su Chantecler, l’opera teatrale di EdmondRostand, Corra annuncia la sua futura produzione dicendo: “Questo io farò: immet-terò in ogni pagina l’essenza di una mia visione [...]”7. La fantasia viene vista comeun prodotto cui dare caratteri e imprimere a beneficio del pubblico. Nel momento incui esiste il palcoscenico di un teatro o la tribuna di un giornale, esiste parimenti unpubblico a cui il messaggio è rivolto. Nel Manifesto del teatro futurista sintetico Ma-rinetti, Corra e Settimelli si propongono di “Porre sulla scena tutte le scoperte che lanostra genialità va facendo nel subcosciente, nelle forze mal definite, nell’astrazionepura, nel cerebralismo puro, nella fantasia pura, nel record e nella fisico-follia”8. Lescoperte a cui giunge l’artista con il suo ingegno vanno dunque rappresentate.
Passando a Pittura dell’avvenire, dello stesso anno, Ginna riprende il discorsosul rapporto tra visione e rappresentazione, affermando: “Dal primo giorno in cuicominciai a vedere, come dicono i teosofi e gli occultisti, volli disegnare dipingere efermare sulla carta e sulla tela queste visioni”9. Da un lato si pone la visione, dall’altrola volontà di fissare l’oggetto della visione attraverso la forma artistica, conferendo-gli pertanto visibilità. Verso la conclusione, Ginna vede giunto il momento in cui “ipoeti della parola del colore e della musica possono evocare nella realtà più reale levisioni che fin’ora furono sogno”10.
Questo processo di trasposizione richiede grande impegno da parte dell’artista.Nello stesso manifesto sulla pittura, parlando dei pittori moderni per i quali l’artenon è copia della natura, Ginna rivela: “Trovare in mano ad un tratto tutta la propriaanima galoppante sfrenatamente nei sogni e doverla tradurre coi sottili mezzi mec-canici [...]”11. Lo sforzo richiesto da questo processo viene reiterato da Remo Chiti
136 Capitolo sesto
4 Rudolf Steiner, Goethe, padre di una nuova estetica, cit., p. 23.5 Ibid.6 Bruno Ginanni Corradini, Il liberismo, in “Il Centauro”, cit.7 Bruno Corra, Chantecler, in “Il Centauro”, a. I, n. 6, Firenze, 8 Dicembre, 1912.8 F.T. Marinetti – Emilio Settimelli – Bruno Corra, Manifesto del teatro futurista sintetico, cit., p. 180.9 Arnaldo Ginna, Pittura dell’avvenire, cit., p. 201.10 Ibid., p. 202.11 Ibid., p. 199.

il quale, ammirando Michelangelo, lo definisce un “fenomenale artista, di una stra-ordinaria raffinatezza, che impasta i suoi sogni con una sinfonia di fatica insosteni-bile, [...] che inchioda in macigni durissimi i suoi cieli e tutta l’irragiungibilemollezza delle sue danze nervose”12. L’atto creativo coincide con il proposito di fis-sare la visione in forma tangibile e concreta. Da un lato la “mollezza” dei sogni conla loro evanescenza, dall’altro la durezza rappresentata dalla pietra che “inchioda”,attribuendo pertanto stabilità e durata.
Da dove proviene il bisogno di tradurre i dati invisibili in visibili? Quale la spintache induce l’artista ad articolare la sua visione e trasporla in espressione artistica?E ancora: come avviene questo passaggio? A tal fine verrà esaminato il racconto diMario Carli13 Il Barbaro (Storia enfatica di uno spirito), pubblicato a puntate nel pe-riodico “Il Centauro”14. Lo scritto consente di seguire il percorso del protagonistadalla fase percettiva alla resa poetica. In parallelo, verranno esaminati estratti daaltre prose poetiche e stralci degli scritti sull’arte che vanno a convalidare l’esegesidel racconto di Carli e dimostrano come scritti teorici e creativi si affianchino nel-l’illustrare il percorso che conduce all’opera d’arte, così come viene concepito daiprotagonisti del movimento.
Nell’introduzione al racconto Mario Carli tiene a precisare che esso non è ri-conducibile ad alcun genere letterario (men che mai il romanzo “oggi troppo arre-trato”), in quanto si tratta di una “composizione libera e caotica” che “non tollera diessere ascritta a nessun genere”. Egli lo definisce “una concezione”, da intenderecome “una scorreria dell’immaginazione”15.
Come viene spiegato nella prima parte, dal titolo “Una porta si apre”, Il Barbaroha per protagonista il giovane Elio Morra, che fino a 13 anni “aveva fatto il bifolco,come tutta la sua gente”, fino a quando un prete, riconoscendogli del potenziale, loaveva fatto studiare, intravedendo in lui il futuro religioso. Elio si era dedicato aquesto obiettivo fino al momento in cui il suo cuore di ventenne aveva avvertito chela sua vita si era limitata ad essere “assimilazione”. A questo punto, la forza accu-mulatasi in lui in quel periodo di inerzia comincia ad agitarsi ed “il barbaro” iniziaad avvertire “il frastuono di vite pullulanti” che da mille parti lo attraggono e lo ca-tapultano in un getto ininterrotto di suoni ed immagini. Elio avverte qualcosa dinuovo e di strano attorno:
[...] un razzare di idee fulminee in ogni cammino del cielo, un imporsi e un contrapporsi
Dalla visione alla rappresentazione: Il Barbaro di Mario Carli 137
12 Remo Chiti, Misteri Michelangioleschi, in “Il Centauro”, cit., p. 1.13 Carli pubblica nel 1909 le novelle Le seduzioni, nel 1915 il romanzo Retroscena. Nel 1918, per
le edizioni de “L’Italia Futurista”, pubblica Le notti filtrate.14 La prima puntata esce nell’anno I n. 1, 3 novembre 1912. Nel n. 5 dell’anno II (9 febbraio, 1913,
p. 4) , alla fine della puntata n. X, che è anche l’ultima pubblicata sul periodico, la redazione spiega cheIl Barbaro è stato acquistato da un editore e uscirà presto in volume. Nella “Collezione di saggi critici”vol. II, cit., si annuncia l’uscita de Il Barbaro in volume, ma detta pubblicazione non risulta essere av-venuta. Come riporta Claudia Salaris, esso fu letto e apprezzato dallo scrittore francese Romain Rol-land, che era all’epoca in contatto epistolare con Carli. Claudia Salaris, Letteratura come artificio,introduzione a Mario Carli, La mia divinità, Montepulciano (SI), Editori del Grifo, 1991, p. 128.
15 Mario Carli, Il Barbaro, I “Una porta si apre”, in “Il Centauro”, a. I, n. 1, Firenze, 3 novembre1912, p. 3.

di trionfali fiammate negli ingegni e nei cuori, un precipitare incalzante di follie e un al-ternarsi prodigioso d’ombre e di luci [...]. La sua fantasia aveva finalmente concepita unavita più vasta. Nello spirito di Elio Morra s’era aperta una porta: la luce del mondo visgorgava rumorosa e travolgente, e slargava con un impeto e un rombo di rivolta quellepareti taciturne e melanconiche16.
L’immagine qui evocata rimanda a suoni ed immagini-chiave del futurismo. Giàa partire da Fondazione e Manifesto del Futurismo17 vengono evocate immagini dipotenza e di movimento irruente, di scorrimento, di trasformazione sotto l’impetodella velocità, di accozzo dei contrari in una nuova sintesi. Si accavallano rumori eluci in un gioco ad intermittenza che lascia il lettore elettrizzato e in preda all’in-quietudine, sbalzato dalla sella delle consuetudini. Il rombo del motore, l’elica tur-binante dell’areoplano evocato nel Manifesto tecnico della letteratura futurista18,che inaugura un nuovo modo di percepire la realtà in fermento, si ritrova nelle im-magini della realtà così come si presenta al “barbaro” stupefatto. La reazione di Elioa questo tumulto viene descritta come “un urlo, che era una sfida alla vita”19.
Il concitamento della realtà così come viene percepita dalla psiche futurista edespressa come un “urlo” è ricorrente nella produzione di Mario Carli. Evocando im-magini di strepito e fragore, veicolando un’emissione violenta e scomposta, l’urlo bensi presta a simbolizzare l’irruenza attribuita alla materia. Nella lirica di Carli intitolata,per l’appunto, Un urlo! (1916) viene evocato un universo in cui tutto è possibile. Que-sto scritto riflette un percorso di ricerca che va a sfondare i limiti del quotidiano, de-molendo la prevedibilità dei suoi schemi. Nell’esprimere la sua visione di una realtàduttile, ricca di “sfumature” e “arabeschi”, Carli confessa: “vorrei che di ogni cosa lasuperficie cedesse un poco, ci fosse un piccolo dolce affondamento sotto la spinta deimiei occhi febbrolosi [...]”. A questo desiderio si oppone la sofferenza di sentirsi “sci-volare su straniere durità ipocritamente compatte”20.
La lirica si accende in un crescendo di immagini che riflettono le vibrazioni emessedalla realtà. Il “guanciale saturo di risonanza” rimanda alle considerazioni già fattenel capitolo quattro sullo stato onirico visto come complice della scoperta. L’attivitàfantastica che corrisponde a quella dimensione consiste nel caos associativo di unarealtà ricca di rimbombi, vista nel suo potenziale gioco di rimandi. La prosa assumeun ritmo sempre più concitato, febbrile: è l’esaltazione della fantasia che si libera in“un urlo, un urlo liberatore” che coincide con la “potenza ritrovata”.
Tale immagine di potenza si ritrova in Elio Morra nel momento in cui si preparaad esplorare la realtà. Lasciandosi alle spalle quanto aveva costituito la sua vita fino aquel momento, Elio va “incontro alla vita [...] anelante di conquista”21. Come vienespiegato all’inizio del secondo capitolo (“Pensieri Azzurri”), Elio va in città dove tuttogli sembra più avvincente, sfolgorante, e persino la natura gli appare più seducente.
138 Capitolo sesto
16 Ibid.17 F.T. Marinetti, Fondazione e Manifesto del Futurismo, cit., pp. 7-14.18 F.T. Marinetti, Manifesto tecnico della letteratura futurista, cit.19 Mario Carli, Il Barbaro, I “Una porta si apre”, in “Il Centauro”, cit.20 Mario Carli, Un urlo!, cit., p. 68.21 Mario Carli, Il Barbaro, I “Una porta si apre”, in “Il Centauro”, cit.

Questo capitolo è denso di simbolismi propri della poetica futurista. Le prime righeaprono un ampio squarcio su un’immagine cara ai protagonisti del movimento:quella del primitivo. Come citato nel capitolo precedente, già nell’ambito del Ma-nifesto tecnico della pittura futurista (1910) i firmatari avevano dichiarato in chiu-sura: “Voi ci credete pazzi. Noi siamo invece i Primitivi di una nuova sensibilitàcompletamente trasformata”22. La figura del primitivo è reiterata nel racconto diCarli in questi termini:
E venne dunque in città. Ma sembrava che non lui vi fosse venuto, bensì che essa glifosse andata incontro per conquistarlo, sedotta dalla sua limpida bellezza di primitivo23.
La “sensibilità”, a cui è associata la figura del primitivo nel manifesto sulla pit-tura, si ritrova anche nel racconto di Carli, dove viene spiegato che Elio “si sentivacome nascere all’improvviso con chiaroveggenza e sensibilità”24. E ancora, verso lafine del capitolo, si legge: “La sua sensibilità era una regina che passava nel mondocorteggiata e adorata con ostinazione dall’anima universale: una regina di paesi bar-barici, dolce ma sana, bella ma lieta, graziosa ma forte”25. I suddetti riferimenti im-pongono di soffermarsi sulla figura del primitivo per esplorarne le caratteristiche ecapire su quali basi i futuristi fondino questa associazione.
Il principio del Novecento vede convergere molti studi condotti sulla mentalitàe la percezione primitiva nell’ambito dell’antropologia e delle scienze psichiche.L’analisi portata avanti in questo capitolo si colloca nell’ambito di una temperie cul-turale che influenza il futurismo e produce ulteriori sviluppi in teorie elaborate neglianni a seguire. La figura del primitivo chiaroveggente, dotato di una particolare sen-sibilità, caratterizzato da un modo verginale di sentire, emerge a più riprese neglistudi condotti in quel torno di tempo. Particolare enfasi è stata posta sulla manieraprimitiva di percepire la realtà e su questo aspetto ci soffermeremo, in quanto nelcorso dell’analisi emergeranno degli elementi rapportabili alla realtà di Elio Morra.
Come sostiene Charles Robert Aldrich, una fondamentale differenza tra le po-polazioni civilizzate e quelle primitive consiste nel diverso modo di rapportarsi allarealtà. A differenza della mente moderna, che rivolge l’attenzione soprattutto alpiano dell’oggettività, la mentalità primitiva si rapporta alla realtà in modo sogget-tivo. Nel primo caso si assiste ad un’operazione che vede distinguere gli oggettil’uno dall’altro a partire dall’osservazione “effettiva e reale”. Detti oggetti vengonopoi classificati concettualmente. I concetti stessi vengono quindi classificati, colfine di formare ulteriori concetti. Lungi dal rispecchiare una capacità superiore, que-sto processo implica piuttosto un diverso atteggiamento, un’attenzione superiore ri-volta alle cose materiali a scapito di quelle spirituali26. Nella mentalità primitiva, al
Dalla visione alla rappresentazione: Il Barbaro di Mario Carli 139
22 Manifesto tecnico della pittura futurista, cit., p. 26.23 Mario Carli, Il Barbaro, II “Pensieri azzurri”, in “Il Centauro”, a. I, n. 2, Firenze, 10 novembre
1912, p. 2.24 Ibid.25 Ibid., p. 3.26 Charles Robert Aldrich, Mente primitiva e civiltà moderna (prima edizione in inglese, 1931),
trad. Tullio Tentori, Torino, Einaudi, 1949, p. 51. Il lavoro di Aldrich prende le mosse da teorie avan-zate sul fronte della psicologia analitica e dell’antropologia nei principi del secolo.

contrario, le immagini di oggetti non vengono considerate per se stesse, ma in fun-zione del soggetto.
Secondo Aldrich, popoli primitivi e civilizzati non hanno diversi poteri di per-cezione sensoriale “se non rispetto a particolari oggetti sui quali abitualmente essidirigono il loro interesse”. Egli aggiunge che “Ciascuno percepisce meglio queglioggetti che sono per lui più importanti nella attività della sua vita e ai quali prestaattenzione di solito, che non gli oggetti che gli riescono insignificanti”27. Esiste unadisposizione ereditaria a “percepire determinati oggetti più comuni, a prestar loro at-tenzione, a riconoscerli, a scoprire in essi un significato e a riceverne una scossaemotiva”28. Oltre a questo fattore condiviso, esiste anche un elemento individuale,che rende la percezione sensoriale altamente soggettiva e legata al significato del-l’oggetto per l’individuo. Come osserva Aldrich, è vero che lo stimolo esterno è unincentivo alla percezione, ma “esso non ne determina la vividezza, la chiarezza, ilcontenuto o la natura, o i suoi effetti sul soggetto”29.
Sulla percezione dei primitivi era intervenuto l’autorevole antropologo franceseLucien Lévy-Bruhl, citato a più riprese da Aldrich. Nella sua opera Psiche e societàprimitive del 1910, Lévy-Bruhl indica come presso la civiltà occidentale a lui con-temporanea la rappresentazione sia per eccellenza un fenomeno intellettuale e co-gnitivo. Così non è presso le popolazioni primitive, in quanto la loro attivitàintellettuale non è abbastanza differenziata da considerare idee o immagini di oggettiper se stessi. Essi vengono percepiti nell’insieme delle valenze attribuitegli da pas-sioni ed emozioni o da essi evocate. Dal momento che l’attività mentale dell’uomocivilizzato è differenziata e analitica, questi ha difficoltà a rapportarsi a stati piùcomplessi, come quelli dei primitivi, in cui elementi emotivi o motori costituisconoparte integrante della rappresentazione e comportano una diversa attitudine ad os-servare gli oggetti rappresentati30.
Rapportando queste considerazioni alla realtà di Elio Morra, si spiega come, ar-rivato in città, la natura gli sembri animata e carica di “bizzarre espressioni nuove”31.Lo scintillio delle vetrine, l’oro delle uniformi delle guardie in piazza e la lucentezzadell’elmo sul loro capo, vengono menzionati come simbolo di una realtà che da ognilato gli si offre carica di richiami. Come spiega il narratore, “ciò avveniva perché eglidava involontariamente a tutte le cose il proprio carattere, vibrante di forza e di de-siderio”32.
Tuttavia, poche righe dopo, troviamo un’affermazione che punta in direzione diun più complesso rapporto tra soggetto ed oggetto. Descrivendo l’amore di Elio perquesta nuova vita, il narratore spiega che egli “si sentiva come nascere all’improv-viso con chiaroveggenza e sensibilità”33. Si sa che la chiaroveggenza è la capacità
140 Capitolo sesto
27 Ibid., p. 79.28 Ibid., p. 86.29 Ibid., p. 89. 30 Lucien Lévy-Bruhl, Psiche e società primitive (prima edizione in francese, 1910), trad. e introd.
Salvatore Lener, Roma, Newton Compton, 1970, p. 60. 31 Mario Carli, Il Barbaro, II “Pensieri azzurri”, in “Il Centauro”, cit., p. 2.32 Ibid.33 Ibid.

di vedere, grazie a delle facoltà particolari, ciò che altri non vedono. In Elio Morra,detta facoltà viene spiegata in questi termini:
Egli si sentiva fasciato d’azzurro: provava l’impressione di avvoltolarsi in un azzurro chegli si stendesse attorno soffice, cortese, blandissimo, senza fine, e si lasciava scivolare inquell’ascesa dolce e facile verso l’intelligenza dei sensi. Era un mondo ardente clamo-roso procace che gli si esprimeva da ogni parte, con mille voci e con mille impeti, chie-dendo di essere ascoltato e compreso [...]34.
L’azzurro, che si ritrova altresì nella denominazione del gruppo (“pattuglia az-zurra”), rimanda all’esplorazione negli spazi metafisici, col fine di cogliere una di-mensione della realtà non immediatamente percepibile. La sensibilità di cui è dotatoElio gli consente di lasciarsi avviluppare da questa dimensione associata all’azzurroed essere elevato “verso l’intelligenza dei sensi”. Si tratta di un livello cognitivograzie al quale avvertire le pulsioni dell’universo, penetrare attraverso la superficiedelle cose e ascoltare “le mille voci” e “i mille impeti” emanati da esse.
Tra le fondamentali caratteristiche della mentalità primitiva va individuata la na-tura mistica della stessa, per cui, come spiega Lévy-Bruhl, essa è rivolta alla perce-zione di forze ed influenze ignorate dai sensi comuni e tuttavia reali35. Ciò è dovutoal diverso orientamento della percezione, non rivolta all’aspetto oggettivo delle cose,ma alle loro qualità mistiche, ai loro poteri occulti. Le proprietà mistiche attribuitedal primitivo alla realtà annullano la distinzione che l’uomo civilizzato pone tra es-seri viventi ed esseri inanimati36.
Secondo l’antropologo francese, ciò che rende la percezione primitiva molto di-versa da quella dell’uomo civilizzato – dove uno degli elementi comprovanti la va-lidità oggettiva della percezione è che l’essere o fenomeno percepito appaia a tuttiin determinate condizioni – è la manifestazione di esseri o cose a certe persone conesclusione di altre37. Se certe caratteristiche di un oggetto vengono percepite solo dauna persona, la ragione sarebbe da individuare nella natura di queste qualità che sirivelano solo a colui dotato di una facoltà particolare o partecipe di un’entità supe-riore38. Lévy-Bruhl rileva quindi come l’esperienza, sulla quale si basa il criterio diciò che è o meno ammissibile come reale per la società occidentale del tempo, nonabbia valore per il primitivo e, d’altra parte, dal momento che tale esperienza ha peroggetto quanto è stabile, visibile, tangibile nella realtà fisica, ne risulta che i poteriocculti non vengono percepiti39.
Queste considerazioni sembrano attestare l’esistenza di una dimensione della re-altà che, seppure occulta, è presente ed accessibile al “barbaro” dotato di una fa-coltà cognitiva particolare, ottenuta grazie ad un alto grado di sensibilità. Tuttavia,
Dalla visione alla rappresentazione: Il Barbaro di Mario Carli 141
34 Ibid.35 Lucien Lévy-Bruhl, Psiche e società primitive, cit., p. 62.36 Ibid., p. 64.37 Ibid., p. 87.38 Ibid., pp. 88-90.39 Ibid., p. 90.

il raffronto tra i vari estratti induce a chiedersi se le forze ed influenze emanate dal-l’oggetto siano manifestazione di un lato occulto effettivamente presente, accessi-bile grazie ad una facoltà percettiva, o se non si tratti piuttosto di una proiezionesoggettiva. In tal caso, il soggetto attribuirebbe all’oggetto delle valenze di carattereindividuale. In altre parole, le “mille voci” e “i mille impeti” con i quali si esprimeil mondo al cospetto del “barbaro”, “chiedendo di essere ascoltato e compreso”40,sono voci ed impeti oggettivi, o echi di quell’urlo emesso dal “barbaro”, urlo che “imonti raccolsero” e “trasmisero lontano” quando Elio scese “incontro alla vita [...],anelante di conquista”41? La parte che segue andrà a chiarire questo punto.
La sezione centrale di questo capitolo è una celebrazione della forza avvertita dal“barbaro”, congiunta ad un’immensa sensazione di gioia, arrivata “al momento dellarivelazione e della rivolta”42. Si tratta della rivolta alla vita condotta fino a quel mo-mento e alla rivelazione di una realtà che gli si offre “rumorosa e travolgente”43.Elio non sa ancora dove dirigere tale forza, e tuttavia essa è così incoercibile daaspettare “il momento di sfrenarsi e irrompere nel mondo”, per andare a produrre unesito incerto, positivo o negativo, per “costruire o per devastare”44. Queste alterna-tive entrambe possibili e opposte, generate da una stessa forza, dalla stessa fonte, ri-chiamano le figure di Parigi e Portorosa in Sam Dunn è morto.
Sebbene l’energia accumulata e poi incanalata da Sam Dunn sia acquisita graziea pratiche miranti a sviluppare la facoltà veggente, attraverso cui rivelare “una lo-gica fantasiosa”, mentre “il barbaro” è naturalmente dotato di chiaroveggenza in virtùdi una predisposizione percettiva ereditaria, in entrambi i casi si assiste alla dinamicache vede soggetto ed oggetto interagire per produrre dei risultati. Infatti, nel mo-mento in cui Elio Morra avverte questa forza, inizia a “rilevare i movimenti e i rumoripiù profondi della propria anima, e ad associarvi quelli del mondo circostante”. Met-tendo a confronto questi due cuori pulsanti, “trovò da una parte un enorme cumulodi energia greggia da disciplinare, dall’altra un’armonia di organismi perfetti da sog-giogare. Il mondo poteva divenire sua preda solo se egli avesse voluto”45.
Come già rilevato nel capitolo precedente, in Sam Dunn è morto si assiste aduno scambio di energie, per cui l’accelerazione prodotta dalla vita moderna si in-treccia con una simile irruenza del mondo interiore. Le energie della multiforme re-altà esterna vengono intercettate da Sam Dunn e vanno ad alimentare un nucleo dienergia che egli, a sua volta, riverserà nella realtà esterna scatenando la rivoluzioneparigina. Anche nel caso del “barbaro” esistono due centri di energia: da un lato lepulsioni della propria anima, dall’altro quelle della realtà circostante. Esse si inter-secano, ma non si tratta di un’equa compartecipazione.
È vero che lo stimolo esterno provoca una forte spinta e dà impulso alla realtàdel “barbaro”. In città le cose sono animate da “bizzarre espressioni nuove che le so-
142 Capitolo sesto
40 Mario Carli, Il Barbaro, II “Pensieri azzurri”, in “Il Centauro”, cit., p. 3.41 Mario Carli, Il Barbaro, I “Una porta si apre”, in “Il Centauro”, cit.42 Mario Carli, Il Barbaro, II “Pensieri azzurri”, in “Il Centauro”, cit., p. 2.43 Mario Carli, Il Barbaro, I “Una porta si apre”, in “Il Centauro”, cit.44 Mario Carli, Il Barbaro, II “Pensieri azzurri”, in “Il Centauro”, cit., p. 2.45 Ibid.

litudini campestri non conoscevano”46. La capacità percettiva del “barbaro”, la suasensibilità, si vanno sviluppando a contatto con la città di cui egli sente il “richiamolontano, violento e inflessibile”47. Affermazioni quali: “egli amava la nuova vita, eanzi pensava di non aver mai vissuto prima d’ora, e si sentiva come nascere all’im-provviso con chiaroveggenza e sensibilità” e ancora: “Intanto la sua sensibilità si eravenuta destando”48 confermano questa tesi. Le energie emanate dalla realtà urbana,qui come in Sam Dunn è morto, agiscono come detonatore. Il ritmo della città, le suepulsioni scatenano una dinamica evidentemente non innescata a contatto con la re-altà campestre. “Il barbaro” ha la stessa potenzialità percettiva in un ambiente comenell’altro, eppure essa viene esaltata dal contatto con l’ambiente cittadino. Dunque,se da un lato le pulsioni sono riconducibili ad una fonte interiore, per cui egli attri-buisce a tutte le cose “il proprio carattere, vibrante di forza e di desiderio”, dall’altroè innegabile che la realtà esterna faccia scattare il meccanismo di transfer di energia.
D’altra parte, il riferimento al mondo circostante inteso come “organismi perfettida soggiogare” e possibile “preda” indica una correlazione inclinata dalla parte delsoggetto. Il fulcro principale e dominante è da individuare nell’energia venutasi con-centrando in Elio, energia ancora allo stato grezzo, in attesa di essere incanalata nelmondo circostante. Il capitolo successivo (“I venti e le idee”) riprende questo punto,aggiungendo ulteriori elementi alla discussione:
Egli era agitato convulsamente dall’impazienza di penetrare i mille segreti delle cose, edesigeva con prepotenza infrenabile che tutte queste cose vibrassero concordi con lui e siconfondessero con lui, sparendo nel vortice del suo pensiero, che s’imprimeva gigantescoe baldanzoso su ciò che afferrava come una preda49.
Ancora una volta, si fa riferimento ad un aspetto occulto della realtà, effettiva-mente presente, da “penetrare”. La realtà va scandagliata per trovare, tra le sue pie-ghe, l’intimo senso delle cose. Anche qui, si assiste all’intreccio tra realtà esterna emondo interiore, dove le due componenti non sono quasi più distinguibili l’una dal-l’altra. Eppure, in questo stralcio come nel precedente, il pensiero si eleva sovrano adimprimere la sua impronta. Si ritrova il termine “preda” già riscontrato nell’estrattoprecedente, ad indicare un rapporto di potere del “pensiero” sulle “cose”, dove il sog-getto imprime il suo marchio sull’oggetto.
Jung, che ha dedicato molti studi alla psicologia del primitivo già a partire dal1912 e sul cui lavoro Aldrich basa le sue considerazioni50, interviene sul rapporto trasoggetto e oggetto nel mondo del primitivo. Si tratta di un mondo miracoloso doveesseri e cose si muovono e vivono, dove anche gli oggetti inanimati sono dotati di vitae di un potere magico attraverso i quali essi partecipano in noi e noi in loro. Tuttavia– conclude Jung – prima o poi abbiamo dovuto renderci conto che “il loro potere era
Dalla visione alla rappresentazione: Il Barbaro di Mario Carli 143
46 Ibid.47 Ibid.48 Ibid.49 Mario Carli, Il Barbaro, III “I venti e le idee”, in “Il Centauro”, a. I, n. 3, 17 novembre 1912, p. 3.50 Si tratta di La libido: simboli e trasformazioni, contributo alla storia dell’evoluzione del pensiero,
cit. Si noti che Jung ha scritto la prefazione al lavoro di Aldrich Mente primitiva e civiltà moderna.

in realtà il nostro e che il loro significato era la nostra proiezione”51. Un riferimento al rapporto intercorrente tra psiche e realtà occulta, formulato in ter-
mini di incertezza, si coglie anche nel manifesto sulla pittura scritto da Arnaldo Ginna.Parlando della pittura come espressione di forme, Ginna afferma: “Con tutto questoIO NON POSSO DIRE se siano vibrazioni astrali o mentali; ED IO NON SO se que-ste forme, viventi una vita mille volte più intensa della nostra, vengano create dalla miapsiche o se esse stesse vengano a me quando io apro la finestra della mia anima”52.
Se andiamo ad esaminare la produzione di altri esponenti del gruppo, esistonoulteriori riferimenti a questo tipo di itinerario che rimanda da sé alle cose. L’essereproietta il suo stato d’animo sull’oggetto e così facendo lo carica di vibrazioni epulsioni che a loro volta rimbalzano su di lui in un eco che gli schiude l’infinito. InAvventure Bruno Corra parla di “oggetti vertiginosi che sembran fabbricati con pezzidi abissi” e, più avanti, osserva che “in certe ore l’infinito invade la materia”53. InSam Dunn è morto il narratore, amico di Dunn, racconta degli elogi rivolti da que-st’ultimo ai capelli della sua cameriera ogni qualvolta si recava in visita. Lui stessoassisteva a questa scena riferendo quanto segue: “Una volta l’ho sentito io dirle cheegli avrebbe voluto adorare per tutta la vita quei suoi capelli allegorici (?), che rap-presentavano uno dei più ammirevoli aneliti di un organismo materiale a dissolversiin un fascio di energie musicali […]”54. Il reale viene percepito e filtrato attraversola sensibilità dell’artista che restituisce alla natura, attraverso reti associative createdalla sua psiche, immagini arricchite di sovrasensi. Come ribadisce Primo Conti: “Illimite di un oggetto non è rappresentato dal suo profilo materiale, e non lo rappre-senta. Egli è la meta dove le suggestioni e le influenze sensibili di questo oggetto loconducono a evolversi nello spirito di chi osserva”55.
Riportando queste considerazioni all’esperienza di Elio Morra, ci si chiede comevenga visto dal “barbaro” questo gioco di forze ed influenze emanate dall’oggetto.La risposta è da individuare più avanti, nel capitolo 5 (“Il canto delle parole”), dovesi fa riferimento alla “simpatia” che inizia a manifestarsi nel suo mondo, già a par-tire dall’osservazione dell’umanità. Si legge che “egli non prova disgusto se nonper ciò che è comune e limitato: l’enorme, il mostruoso, l’illogico gli appartengono.Tutto ciò che ha una vita irregolare gli sembra degno di memoria”56.
Già da questo passaggio inizia a profilarsi l’immagine di una disposizione per-cettiva volta a cogliere aspetti inediti della realtà. La sua attenzione sorvola su quantosi presenta come ordinario e circoscritto. Il suo interesse verso “l’illogico” rimanda
144 Capitolo sesto
51 “Sooner or later we had to understand that their potency was really ours and that their significancewas our projection”. C.G. Jung, Psychological Commentary on “The Tibetan Book of the Great Libera-tion”, 1939, in Collected works of C.G. Jung , vol. 11. Questa citazione da Psychology and Religion:West and East, translated by R.F.C. Hull, London, Routledge & Kegan Paul, 1958, p. 476. Trad. dellasottoscritta.
52 Arnaldo Ginna, Pittura dell’avvenire, cit., p. 201. 53 Bruno Corra, Avventure, cit.54 Bruno Corra, Sam Dunn è morto, cit., p. 26.55 Primo Conti, Imbottigliature, in Imbottigliature, cit., p. 218.56 Mario Carli, Il Barbaro, V “Il canto delle parole”, in “Il Centauro”, a. I, n. 5, Firenze 1 dicem-
bre 1912, p. 2.

a quanto esiste di insolito e irregolare nella realtà e nei rapporti tra i suoi elementi.Ciò emerge chiaramente nelle righe successive:
Le sue impressioni sono per ora accordi di linee e movimenti, dei quali, per una selezionecontinua, gli rimangono impressi solo certi tratti caratteristici, certe anomalie grottesche,certe curiose rispondenze fra cosa e cosa, mai da nessuno scoperte.Ed è più fantasioso che sensibile57.
Questo riferimento alla percezione di “curiose rispondenze tra cosa e cosa, maida nessuno scoperte”, è un concetto reiterato nei documenti teorici. Proprio nell’ar-ticolo di apertura della stessa rivista in cui compare Il Barbaro, Corra individua nellascoperta di nuovi nessi la genesi del processo artistico. Egli sostiene infatti che “fareun’opera d’arte vuol dire scoprire dei rapporti nuovi”58. Del resto, nel corso dei ca-pitoli precedenti si è visto ampiamente come il concetto di arte, intesa come scopertadi nuove relazioni tra gli elementi della realtà, sia espresso in tutta una serie di ma-nifesti e scritti teorici, fino a culminare in Pesi misure e prezzi del genio artistico del1914, dove l’arte viene vista come prodotto dell’energia usata nello scoprire rapportitra elementi prima considerati distanti ed estranei gli uni dagli altri59.
Nel momento in cui la sua sensibilità si va “destando”, “il barbaro” si ricorda di“un’epoca lontanissima dell’infanzia”, allorché, in una particolare situazione di sof-ferenza, aveva avvertito delle sensazioni molto forti prodotte dall’effetto di luci esuoni. Ora come allora “quella sensibilità di fanciullo si faceva trovare intatta e riccacome una miniera lasciata in disparte”60. Quest’espressione è molto vicina a quellausata da Primo Conti e citata nel quarto capitolo, dove è già stato esplorato il recu-pero dell’infanzia nel processo fantastico. Si ricorderà che Conti, riscoprendo gli“stupori di bambino”, parla di una realtà che riemerge “fresca come un fiore sottola stoppa”61. Si tratta di una dimensione vissuta e accantonata, ora di nuovo pro-rompente nella vita adulta grazie alla riattivazione della dimensione fantastica.Quando il narratore riferisce che Elio “era più fantasioso che sensibile”, si riferisceal momento che segue la sensibilità. Elio si sente “come nascere all’improvviso conchiaroveggenza e sensibilità” e, grazie all’acquisizione di questa facoltà, si immettein una realtà fantastica che gli consente di percepire il dinamismo della materia.
Nel quarto capitolo l’indagine ha messo in evidenza come alla stagione dell’in-fanzia corrisponda la disposizione a percepire la vitalità della materia. Come dimo-strato da Corra in Leggenda62, essa coincide con una condizione dello spirito in cuiil pensiero, non ancora impostato in base ai parametri dell’utilità e libero di lasciarsiguidare dall’intuizione, è naturalmente portato a cogliere nessi insoliti tra le cose.Corra aveva definito tali nessi “nuovi rapporti logici, più elastici e misteriosi”, per-
Dalla visione alla rappresentazione: Il Barbaro di Mario Carli 145
57 Ibid.58 Bruno Ginanni Corradini, Il liberismo, in “Il Centauro”, cit.59 Bruno Corradini – Emilio Settimelli, Pesi, misure e prezzi del genio artistico, cit.60 Mario Carli, Il Barbaro II “Pensieri azzurri”, in “Il Centauro”, cit., p. 2.61 Primo Conti, Coscienze, cit.62 Bruno Ginanni Corradini, Leggenda, in “Il Centauro”, cit.

cepiti da un’anima ancora “monda di esperienza”63. L’universo infantile è visto dun-que come una stagione in cui l’essere, non ancora condizionato dall’esperienza conla quale filtrare quanto avvertito per ricomporlo entro lo schema del reale-razionale,avverte la fluidità della materia intesa come rapporto analogico tra i suoi elementi. I“rapporti”, le “rispondenze”, la “simpatia” avvertita da Elio, altro non sono che que-ste relazioni.
Nell’ambito degli studi sulla mentalità primitiva di quegli anni, ampie riflessionisono dedicate all’equivalenza tra universo infantile e mentalità primitiva, in relazionealla concatenazione delle idee. Jung imposta infatti un discorso a cui attingerà Al-drich, in polemica con Lévy-Bruhl, apportando un notevole contributo nell’ambitodelle discussioni al confine tra psicologia e antropologia.
La questione prende spunto da una riflessione di Levy-Bruhl, che si chiede comemai la mentalità primitiva attesti una tale indifferenza, si potrebbe quasi dire avver-sione, per le operazioni discorsive del pensiero, per il ragionamento e la riflessione,quando ai nostri occhi questa è un’occupazione naturale e quasi costante della mente.Puntualizzando che ciò non sarebbe indice di incapacità o inettitudine, quanto di unadiversa disposizione dell’attività mentale64. Tuttavia, riprendendo l’asserzione diLévy-Bruhl, Aldrich contesta che il ragionamento sia l’occupazione naturale e quasicontinua della mente umana. Pur convenendo che la capacità di ragionare sia comunead ogni mente equilibrata, come facoltà latente o attiva, essa raggiunge un pieno svi-luppo “assai tardi nella vita”. In realtà il ragionamento “è acquisizione estremamenteartificiale. Insegnare a un fanciullo a ragionare con esattezza e costanza è un compitoquanto mai laborioso [...]. E anche se l’uomo e la donna possono imparare a ragio-nare, questa rimane la forma d’attività psichica che più stanca”65.
Su questa linea di pensiero era intervenuto Jung, citato da Aldrich a supporto delsuo discorso. Jung aveva distinto due forme di pensiero: da un lato “il pensare rego-lato o logico” e dall’altro il “pensare non regolato” o, riprendendo le parole di Wil-liam James, “meramente associativo”66. Il primo tipo di pensiero appartieneall’ambito del reale e comporta un processo di imitazione che consiste nel ricalcarela successione di cose oggettivamente reali. In questo modo, le immagini create nellamente si succedono nella stessa sequenza causale degli eventi situati al di fuori diessa. I pensieri vengono pertanto costretti entro un tracciato definito mirante ad unoscopo utile. Per questo motivo esso viene altresì definito “pensiero ad attenzione re-golata”67. Esso è il prodotto dell’adattamento all’ambiente e ha come fine la comu-nicazione, è rivolto dunque al rapporto con gli altri e da esso concepito. Lo sforzorichiesto da questa operazione giustifica il fatto che esso venga applicato solo per unperiodo limitato68. Da quanto esposto è evidente che, per Jung, lo sviluppo del pen-
146 Capitolo sesto
63 Ibid.64 Lucien Lévy-Bruhl, La mentalità primitiva (prima edizione in francese, 1922), trad. Carlo Ci-
gnetti, Torino, Einaudi, 1966, p. 16.65 Charles Robert Aldrich, Mente primitiva, cit., pp. 97-98.66 C.G. Jung, La libido: simboli e trasformazioni, cit., p. 16.67 Ibid., p. 11.68 Ibid.

sare regolato, le cui espressioni più notevoli sono rappresentate da scienza e tec-nica69, ha comportato un duro esercizio da parte dell’individuo, non naturalmentepredisposto in questo senso.
L’altra forma di pensiero “non regolato o ‘puramente associativo’”, non vede ilpensiero disposto lungo un percorso definito, ma lo lascia “fluttuare, sprofondare eriemergere secondo il proprio peso”70. A differenza del pensiero regolato, non èspossante e allontana dalla realtà per condurre in un mondo di fantasia. In questa re-altà, il pensiero sotto forma di parola cessa, immagini e sensazioni si affollano, ub-bidendo non già alla realtà così com’è, ma come si vorrebbe che fosse71. Lacessazione del pensare regolato (visto come “l’esatto adattamento psicologico almondo reale”72) che scatta in seguito ad un calo dell’attenzione o ad un momentodi stanchezza, coincide con il ritorno alla fantasia. Come spiega Jung, in questomodo prende il sopravvento una più individuale concatenazione di idee. Se si veri-fica un ulteriore calo dell’attenzione, si perde per gradi la coscienza del presente ela fantasia invade interamente il campo73. La materia prima di questi pensieri che siallontanano dalla realtà è costituita dal passato con le sue infinite immagini mne-moniche74. Come già rilevato nel capitolo sul sogno e il suo rapporto con l’universoinfantile, alla base di questa forma di pensiero associativo, che per Jung equivale a“sognare o fantasticare” vi sono le reminiscenze75.
Volgendo lo sguardo alla mentalità primitiva Jung osserva che, mentre l’indivi-duo moderno volge la propria attenzione alla realtà materiale, i popoli antichi eranocontrassegnati da un modo di pensare più vicino al fantastico, alieno dall’approcciopreciso e concreto della scienza moderna. E infatti lo spirito antico non crea scienza,ma mitologia76. Siamo in presenza di un universo non interessato ad afferrare le di-namiche del mondo reale nel modo più esatto ed oggettivo possibile, ma alimentatoda una fonte interna, costituita da fantasie soggettive77. A questo punto Jung com-pie un passaggio significativo, evidenziando come questo stato mentale coincidacon lo stadio infantile78. Come il bambino, il primitivo prende le proprie fantasie perrealtà obiettive. Queste affinità hanno portato Jung ad evidenziare come passato in-dividuale e quello dell’umanità vengano così a coincidere. La primitività equivar-rebbe ad un’infanzia razziale79.
Anche il sogno condivide queste caratteristiche, nel senso che esso non è inte-ressato ai rapporti reali tra le cose e combina gli elementi più eterogenei, cosicché“al posto della realtà viene messo un mondo di impossibilità”80. Viene dunque trac-
Dalla visione alla rappresentazione: Il Barbaro di Mario Carli 147
69 Ibid., p. 18.70 Ibid., p. 16.71 Ibid.72 Ibid., p. 24.73 Ibid.74 Ibid.75 Ibid., pp. 17-18.76 Ibid., p. 19.77 Ibid., p. 20.78 Ibid.79 Ibid., p. 22.80 Ibid., p. 20.

ciato un parallelo tra universo fantastico e mitologico dell’antichità, sogno e universoinfantile. La condizione di pensiero nella vita psichica del bambino, così come nelladimensione onirica della vita adulta, non sarebbe altro che un riecheggiare delmondo antico81. La dinamica che sottende allo stato di sogno equivale, per Jung, adun recupero di caratteristiche riscontrabili nelle popolazioni depositarie di un’anticacultura e al recupero di un retaggio comune all’umanità.
Come ricorda Jung82, già Nietzsche era intervenuto sulla relazione che passa trastato di sogno e pensiero delle popolazioni antiche. Come spiega il filosofo, nelsogno l’individuo ragiona nello stesso modo in cui ragionava nello stato di veglia mi-gliaia di anni orsono. Durante il giorno la mente è obbligata ad ubbidire ai dettamidi un pensiero che opera secondo un rapporto di causa ed effetto, così sviluppatosiper venire incontro alle esigenze di una forma di civiltà più avanzata, mentre il sognoriporta l’essere a stadi passati dell’umanità, ricollegandolo così ad un patrimonioaccantonato83.
Nel racconto di Carli, una forma di “pensiero vergine e audace” contraddistin-gue il modo in cui “il barbaro” si rapporta alla realtà circostante. La verginità con-siste nella maniera candida e originale di osservare le cose, scevra dall’usura dovutaalle convenzioni. Come osservato, questa disposizione è comune alla realtà del pri-mitivo come a quella del bambino che si affaccia alla scoperta del mondo. A questastessa immagine ricorre Emilio Settimelli quando, nell’illustrare la sua teoria sullaconoscenza umana come “produttrice di scoperte”, fa riferimento al “più verginestato di vita” che caratterizza “l’uomo primitivo”. A questa figura egli riconduce ladisposizione a farsi sorprendere dalla percezione di nuovi “accozzi”:
Volendo definire la conoscenza umana e volendo poi valutarla, sono disceso fino alle ul-time fonti della vita, ho provato a vivere con le sensazioni e l’ingenuità dell’uomo pri-mitivo, riponendomi nel più vergine stato di vita. Eccomi nato or ora. Ho i sensi el’intelletto, questo e quelli, semplici e nuovi, vivo ora direttamente i primi istanti dellavita!84.
La semplicità e la purezza associate alla nascita comportano un novello approc-cio alla realtà, caratterizzato dalla sorpresa. Come egli spiega, in questo “tentativo”sono state “molteplici le sorprese date dai miei sensi ormai abituati alla pronta ri-sposta della mente”, dove con ciò egli intende il processo mentale dell’individuomoderno rivolto al fine utile85.
Ne Il Barbaro il pensiero “vergine e audace” è favorito da un particolare angolodi osservazione. Infatti, al piacere di immergersi nelle cose indugiando nelle vie,segue l’ebrezza di esplorarle dall’alto dove “il barbaro” “avrebbe forse visto molte
148 Capitolo sesto
81 Ibid., p. 22.82 Ibid.83 Friedrich Nietzsche, Umano, troppo umano, vol. I (prima edizione in tedesco, 1878), trad. Sos-
sio Giametta, Milano, Adelphi, 2008, pp. 22-24. 84 Emilio Settimelli, Scienza crociana e scienza (pardon!) mia, in “Rivista”, cit., p. 1.85 Ibid.

più cose che nel passato”86. L’osservatorio privilegiato è rappresentato dalle quat-tro finestre della sua soffitta, dove ognuna dà su un lato dell’orizzonte consentendocosì di “contemplarne tutti gli aspetti”87. Come scopre Elio, “lassù si agitavano iventi e le idee”88. Si legge:
I suoi sogni si arrampicavano sempre più ebbri nel cielo, aggrappandosi prima alle torripiù alte, poi cavalcando le rondini e le allodole, appoggiandosi alle nuvole, slanciandosiinfine a corsa pazza verso l’infinito, fino a concepire l’irreale. Se lo sguardo e il pensiero tornavano in basso, egli si sentiva preso dal ribrezzo: non riu-sciva a immaginare la passione incastrata fra le mura fredde e rigide, e un giorno pensòdi convincere gli uomini ad abbandonare le loro strade per salire a vivere sui tetti, dandosfogo lassù, nel modo più selvaggio ed eroico, a tutti i loro istinti89.
La percezione dell’irreale inteso dal “barbaro” come una dimensione altra di re-altà è resa possibile a condizione di distaccarsi dalla quotidianità ed elevarsi ad unlivello superiore, dove dare libero corso alla fantasia ed esplorare con audacia. Silegge che egli prova “l’urto delle cose piccole e basse”90, dove con questo si intendela prevedibilità di schemi rivolti all’utile e all’immediato. Questo punto è ripresoda Settimelli, il quale osserva che “Il Centauro” è rivolto solo “alla persona elevatache attraverso il tramestio ritmico e noioso della vita quotidiana senta il bisogno dicontemplare qualcosa di estraneo, qualcosa di vergine, qualcosa di inesplorato”91.
L’analisi de Il Barbaro va ora ad aprire uno spaccato sulla trasposizione della vi-sione in rappresentazione in quanto, per Elio Morra, l’esplorazione non è fine a sestessa, ma è seguita dal proposito di “foggiare quest’idea in qualcosa meno imma-teriale del pensiero”92. Come si è evidenziato nella parte introduttiva di questo ca-pitolo, dai vari scritti teorici del nucleo fiorentino emerge il proposito dirappresentare l’oggetto della visione attraverso l’arte. Nel racconto di Carli la vi-cenda del protagonista è coerente con il percorso evidenziato nei documenti teorici.Il percorso del “barbaro” passa infatti dall’ “idea” all’ “immagine”93. Egli è preso daldesiderio di “vedere, innanzi a sè, a grandi tratti, la plastica delle idee”94. Il pro-cesso viene descritto in questi termini:
[...] tutte le mille vibrazioni del mondo, rapidamente associate, fuse nel modo più strava-gante e suggestivo, svolgono nel suo cervello copiose figurazioni ideali, atteggiate, scac-ciate e sostituite, fin che abbian trovato la loro forma più intensa e più comprensiva95.
Dalla visione alla rappresentazione: Il Barbaro di Mario Carli 149
86 Mario Carli, Il Barbaro III “I venti e le idee”, in “Il Centauro”, cit.87 Ibid.88 Ibid.89 Ibid.90 Mario Carli, Il Barbaro, IV “Quasi un’allegoria”, in “Il Centauro”, a. I, n. 4, Firenze, 24 no-
vembre 1912, p. 1.91 Emilio Settimelli, “L’inutilità” del “Centauro”, in “Il Centauro”, cit.92 Mario Carli, Il Barbaro, V “Il canto delle parole”, in “Il Centauro”, cit., p. 2.93 Ibid.94 Ibid.95 Ibid.

Preso dall’urgenza di trovare un “mezzo di espressione” a queste figurazioni, Eliosi rivolge al marmo, che tra tutti i mezzi gli appare come il più “materiato”96. Da dovenasce questo impulso a dare all’idea forma materiale? Un’indicazione si trova piùavanti dove, in relazione alla difficoltà di trovare lo strumento idoneo ad esprimere ilsuo “sogno” e, quindi, di “adattare il pensiero alla materia”, si legge della preoccupa-zione del “barbaro” di non potere “svolgere le sue visioni davanti a tutta l’umanità”97.La visione va articolata ed espressa per essere usufruita in uno spazio pubblico.
In uno studio sui rapporti tra sogno, creatività e follia nella Francia del dician-novesimo secolo, Tony James individua la genesi comune di questi stati nell’affio-rare di immagini o parole che si sviluppano nella mente autonomamente. Nel casodi sogno e follia, a questo processo non si accompagna l’identificazione cosciente,mentre nel processo creativo occorre un ulteriore passaggio: è necessario dare alsogno carattere materiale98. Come puntualizza James, “per la letteratura ciò implicala presenza di parole effettivamente scritte o stampate sulla pagina”99. Questo pro-cesso implica l’intervento della coscienza da vegli e la presenza di “forme superioridell’attività umana” quali “la volontà, la ragione e il giudizio”100.
Nel delucidare quanto esposto, James spiega che, per quasi tutto il diciannovesimosecolo, il modello predominante vedeva veglia e sonno come due momenti antiteticie alternati. Il primo equivaleva alla presenza delle funzioni superiori, da ricondurrea coscienza, ragione, volontà, mentre il secondo era visto come separato da tali fun-zioni superiori. La linea di demarcazione tra le funzioni superiori e quelle inferioriandava principalmente individuata nella presenza o assenza della volontà. Alla sua as-senza corrispondevano le “attività automatiche”, come appunto il sogno. Lo stessofunzionamento automatico della mente era da riscontrare nel caso della follia101.
Effettivamente, se andiamo ad esaminare la posizione emergente nella Franciadella metà del diciannovesimo secolo, noteremo che lo psichiatra François Leuretdistingueva tra l’ispirazione attiva, concernente il genio, dall’ispirazione passiva, pro-pria dell’alienato. Mentre l’artista creativo gode di continuità del suo essere e unitàdella personalità, l’alienato mentale ne è privo e non agisce sotto il controllo della vo-lontà. In altre parole, nel secondo caso manca il controllo dell’ego cosciente102.
Sul finire del secolo decimonono l’eminente psichiatra francese Pierre Janet, fa-cendo un passo avanti rispetto ai suoi predecessori, spiega che anche tali attività au-tomatiche non sono puramente meccaniche, ma possiedono un livello di coscienza,da qui il termine “automatisme psychologique” adoperato da Janet103. Tuttavia, in
150 Capitolo sesto
96 Ibid.97 Ibid.98 Tony James, Dream, Creativity and Madness in Nineteenth-Century France, cit., p. 273. 99 “For the strong sense of creation to be present, a further stage is necessary: the dream must be
given material form. […] In the case of literature this means words actually written or printed on thepage”. Ibid., p. 274. Trad. della sottoscritta.
100 Ibid. James cita Pierre Janet in L’automatisme psychologique: essai de psychologie expérimen-tale sur les formes inférieures de l’activité humaine, Paris, Alcan, 1889.
101 Ibid., p. 272.102 François Leuret, Fragments psychologiques sur la folie, Paris, Crochard, 1834, pp. 268-269.103 Pierre Janet, L’automatisme psychologique: essai de psychologie expérimentale sure les formes
inférieures de l’activité humaine, cit., p. 463.

linea con i suoi predecessori, Janet nega che esso sia responsabile dell’atto creativo,il quale, a differenza di queste attività automatiche involontarie, richiede caratterevolontario104. Tra gli esempi di automatismo psicologico, Janet menziona l’istinto,il quale si trova in uno stadio intermedio: non è privo di coscienza, ma non possiedeneppure carattere intelligente e volontario. Citando Lemoine, egli spiega che l’istintosta tra il movimento della materia bruta e quello della volontà umana. Esso consi-ste in un’ “attività diretta da percezioni nettamente coscienti presso l’animale e co-stituenti la totalità del suo spirito, ma quasi sempre subcoscienti presso l’essereumano il cui spirito è colmo di fenomeni più elevati”105. Di contro, l’atto volonta-rio è preceduto dall’idea. L’atto volontario è da individuare nella stessa idea, nel fe-nomeno intellettuale propriamente detto. Perché ci siano degli atti superiori a quelliautomatici, è necessario che nell’intelligenza ci siano dei fenomeni di conoscenzasuperiori alle percezioni106. Le percezioni sono dei gruppi di immagini associate traloro. L’effetto volontario consente la sintesi, la sistematizzazione di quelle imma-gini107. I meccanismi di attività volontaria sono caratterizzati da unità e armonia.Mentre l’atto automatico non ha valore al di fuori dell’individuo, l’atto volontarioha carattere di universalità108.
Come ribadito da James, l’intelligenza creativa concerne lo stato di veglia,quando volontà e giudizio sono attivi. Non esiste creatività senza le “funzioni su-periori”109. Per lo studioso, colui che dà forma materiale al sogno attraverso l’attocreativo, colloca quest’ultimo in uno spazio intermedio tra sogno e realtà. Sebbeneconnessa al sogno nella sua genesi, la produzione artistica ha un’esistenza oggettiva.Essa è generata da sogno e stato di veglia assieme, tanto dall’automatismo quantodal giudizio, ed “esiste in uno spazio in cui sogno e stato di veglia coesistono”110.
Da quanto esposto finora, emerge che il processo creativo affonda le radici nelladimensione fantastica ma, a differenza di quella, necessita delle funzioni superioriproprie della coscienza da vegli, quali la volontà e il giudizio, grazie alle quali arti-colare la visione. Vedremo ora come il discorso si rapporta alla concezione futuri-sta, espressa sia attraverso il racconto di Carli che negli scritti teorici. Questospaccato teorico è stato infatti sollecitato dalla volontà di Morra di trasporre l’og-getto della visione in rappresentazione. La sua aspirazione a “svolgere le sue vi-sioni davanti a tutta l’umanità”111, attraverso lo strumento più appropriato, rispondead una peculiarità dell’atto volontario stesso, che si pone come atto universale, ri-volto a tutti gli individui.
Dalla visione alla rappresentazione: Il Barbaro di Mario Carli 151
104 Ibid., pp. 472-473.105 “[...] l’instinct c’est l’activité dirigée par des perceptions nettement conscientes chez l’animal
et formant mème la totalité de son esprit, presque toujours subconscientes chez l’homme, dont l’espritest rempli par des phénomènes plus élevés”. Ibid., p. 463. Trad. della sottoscritta.
106 Ibid., p. 473.107 Ibid., p. 475.108 Ibid., p. 476.109 Tony James, Dream, Creativity and Madness in Nineteenth-Century France, cit., p. 273.110 “The work is a product born of dream and of waking life, of “automatism” and of judgement,
and it exists in a place where dreaming and waking are found together”. Ibid., p. 275. Trad. della sot-toscritta.
111 Mario Carli, Il Barbaro, V “Il canto delle parole”, in “Il Centauro”, cit., p. 2.

Questo concetto trova conferma nel già citato articolo di Emilio Settimelli incui, a sostegno dell’universalità del prodotto artistico, vengono chiamati in causa isuoi fruitori:
Capire vuol dire rifare per conto nostro i ragionamenti di un altro: ragionare. Se dunquel’opera d’arte non fosse opera del ragionamento, come la si potrebbe capire? Se le opered’arte non fossero un fatto intellettivo, sarebbero come il discorso di un pazzo che nonsi comprende. [...] L’impressione è un riflesso dell’arte, non è l’arte stessa. C’è o non c’èa seconda dell’individuo. Il ragionamento c’è e c’è sempre per tutti gli individui112.
Mentre il sogno è rivolto al mondo interiore, l’atto creativo è rivolto alla realtàesterna. Mentre il primo non svolge una funzione comunicativa, il secondo si ri-volge ad un pubblico e si avvale di un veicolo condiviso dagli altri: il linguaggio del-l’io cosciente. Il ragionamento alla base dell’idea, a cui tutti possono risalire inquanto esso “c’è e c’è sempre per tutti gli individui”113 e la rappresentazione di que-sta attraverso un mezzo comune, garantiscono la fruibilità del prodotto artistico.Come affermano anche i Ginanni Corradini in Arte dell’avvenire. Paradosso: “Espri-mere un’idea vuol dire: esser tale da far vedere a tutti la stessa idea”114.
In questo scritto teorico, dedicato al ruolo dell’arte e alle dinamiche che sotten-dono la creazione artistica, la rappresentazione dell’ “idea” è vista come il fulcro delprocesso creativo115. Così anche in Pittura dell’avvenire, dove la tecnica adoperatanelle varie forme artistiche è vista come “un’idea da esprimere”. Nell’estratto, par-zialmente citato all’inizio di questo capitolo, si legge infatti:
Trovar in mano ad un tratto tutta la propria anima galoppante sfrenatamente nei sogni edoverla tradurre coi sottili mezzi meccanici provocò in quegli artisti geniali una serie diritorcimenti dolorosi in mezzo a vittorie a delusioni a disfatte. Allora per istinto tutte lefacoltà tutti i mezzi e tutte le audacie furono diretti verso lo studio della tecnica. E la tec-nica divenne essa stessa un’idea da esprimere; ed ogni tecnica divenne una scuola me-todo e un nuovo ideale116.
Il processo creativo viene quindi visto come un’operazione sistematica che ri-chiede l’impiego di tutti i mezzi e di tutte le facoltà a disposizione dell’artista versoun preciso obiettivo: lo sviluppo di una tecnica atta a “tradurre” i sogni, idonea a“esprimere” le “idee” emerse all’impazzata nel corso dell’esperienza onirica.
A questo punto occorre chiarire cosa si intenda per “idea” e come si formi. InArte dell’avvenire. Paradosso gli autori non si limitano ad indicare nell’arte la rap-presentazione di un’ “idea” (o “pensiero”, dove i due termini sono usati interscam-biabilmente), ma illustrano lo sviluppo della stessa a partire dalla fase percettiva.Riflettendo sulla reazione provocata da un paesaggio, essi affermano:
152 Capitolo sesto
112 Emilio Settimelli, Scienza crociana e scienza (pardon) mia, in “Rivista”, cit., p. 2. 113 Ibid.114 Arnaldo e Bruno Corradini, Arte dell’avvenire. Paradosso, cit., p. 127.115 Ibid., p. 128.116 Arnaldo Ginna, Pittura dell’avvenire, cit., p. 199.

Può darsi ed anzi avviene di frequente, che qualcuno davanti a quel paesaggio non sifermi a considerare i colori ma, pensando o alla frescura che si godrebbe sotto quegli al-beri, o alla felicità di possedere una bella villa in quel luogo, o altro, associ il paesaggioai suoi pensieri e attribuisca a quello ciò che è di questi117.
La natura fornisce dunque gli elementi principali. Questi, a contatto con i senti-menti dell’artista, generano delle rispondenze che l’artista andrà a rappresentare ser-vendosi degli stessi elementi offerti dalla realtà visiva. L’opera d’arte è il prodottodell’anima data dal poeta alle cose che sono attorno a lui. Come spiega Corra, questadinamica vede la “scomposizione della realtà visiva nei suoi ultimi elementi di forma,di linea e di colore e riaccozzo di questi elementi in nuovi rapporti reciproci”118. Nesegue una “combinazione irreale di elementi tolti dalla realtà”119. Più avanti Corraparlerà di “ricostruzione fantastica della realtà disciolta nelle sue molecole plastichecromatiche e lineari”120.
In base alla teoria teosofica, che Ginna cita nell’ambito di alcuni appunti sulla pit-tura, esiste un percorso che parte dalla percezione per arrivare al pensiero. Attraversoi sensi l’essere percepisce la realtà che lo circonda, e questa genera delle impressioni.Come osserva Rudolf Steiner, camminando per un prato fiorito si osservano i coloriattraverso la vista. Ma l’individuo non si limita ad osservare, egli gode del paesaggioe accosta il dato ad una vicenda sua propria. Per mezzo dei sentimenti, costui collegai fiori alla sua esistenza121. I sensi consentono dunque la percezione, con la quale l’es-sere si pone in relazione temporanea con le cose, ma attraverso l’anima egli conservaqueste impressioni. Esse vengono trasformate dall’anima in sensazioni, custodite nellamemoria quali rappresentazioni e consegnate infine allo spirito perché questi confe-risca loro durata122. Come spiega Steiner, alle sensazioni si uniscono “i sentimenti dipiacere e dispiacere, gli impulsi, gli istinti, le passioni”123. Come le sensazioni, essihanno carattere di vita personale, ma intorno a questi “l’uomo forma pensieri”124, coni quali egli si eleva oltre la sua vita personale e abbraccia l’ordine dell’universo.
Se andiamo a vedere il manifesto sull’arte dei Ginanni Corradini, si legge chel’opera d’arte è il frutto di ciò che viene definita “passione” data alle cose. In esso siafferma: “Ecco definita l’opera d’arte: passioni in tali reciproci rapporti da formareun sistema”125. La missione dell’artista consiste nel dare “creature di passione”,un’opera cioè che si imponga con una forza sua propria, generata dai sentimenti del-l’artista126. Corra e Ginna identificano dunque, nella “passione, il sentimento”, il ca-
Dalla visione alla rappresentazione: Il Barbaro di Mario Carli 153
117 Arnaldo e Bruno Corradini, Arte dell’avvenire. Paradosso, cit., p. 128. 118 Bruno Corra, Prefazione a Arnaldo Ginna, Pittura dell’avvenire, 1915, in Mario Verdone (a cura
di) Manifesti futuristi e scritti teorici, Ravenna, Longo, 1984, p. 185.119 Ibid.120 Ibid., p. 186.121 Rudolf Steiner, Teosofia (prima edizione in tedesco, 1904), trad. Ida Levi Bachi, Milano, Edi-
trice Antroposofica, 1990, p. 21.122 Ibid., p. 64.123 Ibid., p. 33.124 Ibid., p. 34.125 Arnaldo e Bruno Corradini, Arte dell’avvenire. Paradosso, cit., p. 129. 126 Ibid., p. 130.

posaldo del prodotto artistico, “la base, l’origine certa e unica dell’opera d’arte”127. Ma occorre capire cosa intendano i firmatari del manifesto per “passione” e “sen-
timento”. Come viene spiegato in nota, questi termini stanno a designare “tutto ciòche costituisce la nostra vita psichica da trasognamenti vaghi da cui germina il pen-siero, al pensiero stesso: il pensiero è l’ultimo stadio della passione”128. Dunque, seè vero che essi assumono ampio significato che va ad includere anche il “pensiero”,non sarebbe corretto accorpare il tutto in un unico momento. La passione è alla basedell’opera d’arte, ma essa rappresenta uno stadio. Il risultato finale è il prodotto diun grado più elevato: il “pensiero”. Avviene quindi che “Il pensiero si genera dallapassione; la passione produce il pensiero, il quale è opera d’arte”129. A questo pro-posito, si osservi l’affermazione di Mario Carli in Tesi di un’arte nuova, sulla ne-cessità di “studiare le impressioni dei sensi; seguire il loro sviluppo nel cervello,dominare la corsa del pensiero e rappresentare tutto ciò”130.
Nello scritto teorico i Ginanni Corradini portano il discorso oltre, arrivando adefinire il “pensiero”. Come viene spiegato: “Ufficio dell’arte è di esprimere il pen-siero, cioè una relazione scoperta tra cose o tra persone”131. Come già proclamatoda Settimelli “Il pensiero è scoperta” e “il valore del pensiero sarà tanto maggiorequanto maggiore sarà la scoperta”132. “Noi intendiamo la parola pensiero nel sensodi scoperta: quindi l’arte è pensiero”, sanciva Corra133.
Tornando alla dinamica del percorso di Elio Morra, noteremo che egli viene de-scritto come “splendido accozzo di volontà e d’ingenuità, di istinti primitivi e diprofonde vedute: selvaggio cosciente, che sul limitare di una nuova vita s’era cre-duto simile a un dio [...]”134. L’ “accozzo” di istinto e volontà richiama l’immaginedel centauro: “l’essere che è insieme uomo e bestia, che raffigura materialmentel’unione dell’intelligenza con la passionalità”135. Il fiuto e la forza associati al suostato primitivo acuiscono la potenza immaginativa, la sua percezione di una realtàrappresentata come “sinfonia enorme e tumultuosa di voci barbariche”136, viste nelloro potere di impatto creato da urti repentini e associazioni folgoranti. Il “fiuto”, ri-vendicato dal movimento nel manifesto La scienza futurista, rappresenta una fa-coltà atta a sondare la realtà per scoprirne una dimensione celata, caotica, infermento137. Tuttavia, nel momento in cui Elio ambisce a rappresentare la sua vi-sione, a “esprimere questo eterno, questo impalpabile e illimitato spirito delle
154 Capitolo sesto
127 Ibid., p. 128. 128 Ibid., p. 129.129 Ibid.130 Mario Carli, Tesi di un’arte nuova, in “La Difesa dell’Arte”, cit., p. 3.131 Arnaldo e Bruno Corradini, Arte dell’avvenire. Paradosso, cit., p. 151.132 Emilio Settimelli, Il nuovo sistema di critica, in “La Difesa dell’Arte”, cit.133 Bruno Ginanni Corradini, Il liberismo, in “Il Centauro”, cit.134 Mario Carli, Il Barbaro, VII “Un modo di non morire”, in “Il Centauro”, a. I, n. 8, Firenze, 22
dicembre 1912, p. 2.135 Bruno Ginanni Corradini, Il liberismo, in “Il Centauro”, cit.136 Mario Carli, Il Barbaro, V “Il canto delle parole”, in “Il Centauro”, cit., p. 2.137 La scienza futurista, cit., pp. 206-207.

cose”138, egli è impegnato in un atto cosciente, intellettivo e volontario. Come pre-cisa il narratore, egli “deve solo trovarne il modo, deve trovare la veste ai Pensieriche sono in lui”139. All’immateriale sarà data una veste, all’impalpabile una formaesteriore che possa esprimerlo. L’espressione implica articolazione, e quindi, lamessa a punto di una tecnica atta a convertire la visione in un sistema di segni. Lostesso Carli, nell’ambito di un intervento ispirato da Edgar Allan Poe, osserva chequesti “ha dato un metodo alle nostre fantasticherie, ci ha fatto sembrare possibilel’esecuzione di ogni più raffinata follia”140.
Il concetto viene elaborato da Arnaldo Ginna, che vede “gli artisti geniali” to-talmente dediti ad un’operazione sistematica finalizzata all’elaborazione di una “tec-nica” atta a “tradurre” quanto emerso nel corso dell’esperienza onirica141. Comeribadisce in una lettera inedita a Francesco Balilla Pratella, il pensiero va incanalatoin espressioni: pensiero-musicale, pensiero-pittorico, pensiero-filosofico e cosìvia142. In Arte dell’avvenire. Paradosso, Corra e Ginna illustrano il rapporto tra sen-timenti e forme di espressione spiegando: “Tale è la condizione dell’Artista: senti-menti dentro; colori, o forme, o linee, o suoni, o parole fuori, relazione tra quelli equesti”143. Ne consegue che esiste un parallelismo tra tutte le arti e la scelta di unmezzo di espressione piuttosto che un altro dipende dalle tendenze e condizioni delsingolo144. Dunque “L’essenza delle arti è una; vari sono i mezzi d’espressione”145.
La parte successiva de Il Barbaro traccia il percorso compiuto da Morra nel-l’atto di articolare la sua visione. I vari mezzi di espressione vengono passati al va-glio con il fine di trovare quello più consono a rappresentare il pensiero. Morra sirivolge alle forme, ai colori, ai movimenti, ai suoni, non ritenendo queste forme suf-ficientemente equivalenti146 al suo pensiero, in grado di esprimerlo compiutamente.In ultimo, scopre la potenzialità delle parole:
[...] le parole sorgono, vibrano, stillano, come uscite da un lavacro, creando ciascuna ilsuo piccolo mondo, appoggiandosi ai pensieri che rappresentano. [...] Elio ascolta ineb-briato quella germinazione di piccole voci che chiedono di essere associate e commiste.Più tardi metterà le sue mani sapienti tra quella folla di frammenti dispersi, e ne usciràl’opera d’arte: ma intanto si compiace di sentirli pullulare disordinatamente innanzi aisuoi sensi [...]. Ma la vita è pure in questo disordine, in questo miscuglio. Ogni voce sifa sentire volta a volta sulle altre, e nell’attimo della sua vittoria essa vive147.
Dalla visione alla rappresentazione: Il Barbaro di Mario Carli 155
138 Mario Carli, Il Barbaro, V “Il canto delle parole”, in “Il Centauro”, cit., p. 2.139 Ibid.140 Mario Carli, Il mio Poe, in “Il Centauro”, cit.141 Arnaldo Ginna, Pittura dell’avvenire, cit., p. 199.142 S.l. e s.d., Fondazione Primo Conti onlus, Fiesole, Fondo Pratella, Corrispondenza A. Ginna-F.
Balilla Pratella.143 Arnaldo e Bruno Corradini, Arte dell’avvenire. Paradosso, cit., p. 129.144 Ibid., pp. 132, 129.145 Ibid., p. 129.146 Il concetto di “equivalenza” è introdotto in Pittura dell’avvenire, dove si parla della pittura come
“un insieme di tinte e di linee equivalente” ad uno stato d’animo. Cit., p. 198.147 Mario Carli, Il Barbaro, V “Il canto delle parole”, in “Il Centauro”, cit., p. 2.

Nel manifesto sull’arte la letteratura viene descritta come “arte delle parole” e illetterato viene visto come colui che “esprime passioni per parole”148. Viene poi spie-gato in nota che “l’accozzo di parole” può non avere senso ma costituire “musica diimmagini”, se poi invece esse vanno a rappresentare un’idea si hanno le forme d’artesuperiori149. Per “il barbaro” la parola assurge al ruolo di “veste ai Pensieri che sonoin lui”150. Le parole, viste nelle loro potenzialità associative, rappresentano lo stru-mento più idoneo a captare le relazioni tra gli elementi di una realtà pullulante ecaotica, relazioni quindi fugaci e in continua evoluzione. L’opera d’arte è vista comerisultato di un sapiente intervento volto a dare struttura a questa germinazione:
Quegli atomi di musica innumerevoli e soleggiati, ansiosi di accozzi e di costruzioni, on-deggianti nei ritmi più disperati, sotto soffi precoci di chimera, avevano il presentimentodella poesia.Si, aveva capito alla fine: le parole benedette in cui la musica la forma e il colore avevanopreso posto, le parole munifiche che gli si erano offerte come una folla di anime, esse,esse sole avrebbero vestito i suoi fantasmi, esse sole, immateriali e carnose, eteree e vo-luttuose, piccole e immense, voli di aquile e squittii di passerotti, melodia e armonia,persona e universo, libellula e divinità, colte a piene mani dal barbaro immaginoso, avreb-bero costruito il suo mondo di poesia.Ed Elio era poeta151.
In un contributo allo studio sui primitivi, l’antropologo Edward Burnett Tylorosservava come il poeta a lui contemporaneo abbia molti elementi in comune con lementi delle tribù primitive nello stadio mitologico del pensiero152. L’immaginazioneche permea le popolazioni antiche e primitive sopravvive nella persona comune cosìcome nel poeta, ma mentre nel primo caso essa si trova allo stato grezzo, presso ilpoeta assume la forma di un più conscio prodotto artistico finemente elaborato. Se-condo Tylor, per capire la mentalità primitiva occorrerebbe porsi nella condizione diascoltare la poesia e lasciarsi così trasportare in un’atmosfera immaginativa153. Daqueste considerazioni prende spunto l’intervento successivo di Aldrich il quale, ci-tando Tylor, ribadisce che la sensibilità poetica veicola l’approccio alla realtà rap-presentata dal selvaggio: la sua maniera di percepire la realtà, il modo inusuale dicollegare le idee, l’intensità delle emozioni154. Il nesso stabilito tra sensibilità primi-tiva e sensibilità poetica attribuisce significato alla predilezione del “barbaro imma-ginoso” per la poesia quale strumento atto ad esprimere le sue visioni e svolgerledavanti a tutta l’umanità. D’altro canto, Mario Carli era scrittore e poeta e quindi ènaturale che al suo personaggio affidi lo strumento espressivo da lui prescelto.
156 Capitolo sesto
148 Arnaldo e Bruno Corradini, Arte dell’avvenire. Paradosso, cit., p. 150.149 Ibid.150 Mario Carli, Il Barbaro, V “Il canto delle parole”, in “Il Centauro”, cit., p. 2.151 Mario Carli, Il Barbaro, V “Il canto delle parole”, in “Il Centauro”, cit., p. 3.152 Edward Burnett Tylor, Alle origini della cultura (prima edizione in inglese, 1871), trad. Giovanni
Battista Bronzini, vol. III, Roma, Edizioni dell’Ateneo, 1988, pp. 53-54.153 Ibid., p. 42.154 Charles Robert Aldrich, Mente primitiva e civiltà moderna, cit., pp. 74-75.

La dinamica individuata da Tylor, per cui il poeta consentirebbe alla persona co-mune di ristabilire un contatto con la realtà immaginativa che gli appartiene da tempiprimordiali viene altresì indicata da Henri Bergson ed espressa nell’ambito dellasua concezione filosofica. Bergson individua nell’arte la funzione di penetrare piùa fondo nella realtà. Per il filosofo francese la facoltà di vedere più in profondità èesercitata dall’artista grazie al suo distacco dalla realtà vista in relazione alla suafunzione pratica e materiale. Si tratta di un distacco che si manifesta “in un modovergineo di vedere, di ascoltare e di pensare”155. L’oggetto della rappresentazione èil prodotto del rapporto di simpatia e intuito stabilito dall’artista con l’oggetto. At-traverso forme e colori, traspare così la vita interiore delle cose. Per Bergson, “l’artenon ha altro obiettivo che di scartare i simboli praticamente utili, le generalità con-venzionalmente e socialmente accettate, infine tutto ciò che ci nasconde la realtàper metterci di fronte alla realtà stessa”156. Il poeta viene definito da Bergson un“rivelatore”, in grado di mostrare cose che altrimenti non colpirebbero l’attenzionee tuttavia familiari in qualche modo157. Secondo il filosofo, nell’individuo esiste giàun’indistinta percezione della visione espressa dall’artista, scalzata dalla percezionelegata all’utilità158.
In base alle teorie esposte in questo capitolo, l’arte è un mezzo grazie al qualericonoscere le nostre stesse pulsioni. Essa rimanda ad una facoltà già posseduta, inseguito accantonata, imposta nuovamente all’attenzione nella dimensione fantasticae riconquistata grazie “ai poeti della parola, del colore e della musica”. Come af-ferma Ginna nello scritto sulla pittura: “È giunto il momento in cui i poeti della pa-rola, del colore e della musica possono evocare nella realtà più reale le visioni chefin’ora furono sogno”159.
In riferimento alla capacità percettiva rivendicata dal futurismo Maurizio Calvesicita il Manifesto tecnico della pittura futurista nel quale i firmatari parlano di “po-tenza visiva che può dare risultati analoghi a quelli dei raggi X”160. Commentandoquesto punto, lo studioso afferma: “Si tratta senza dubbio di un’allusione alla facoltàdi vedere al di là dei limiti fisici della materia, propria dei soggetti ‘sensibili’ ai qualii futuristi si paragonano come, e per la stessa ragione, ai folli e ai primitivi”161. Peril secondo futurismo fiorentino, la percezione resa possibile in determinate condi-zioni consente di auscultare il palpito della materia. Si tratta di un percorso svoltoall’insegna del pensiero e caratterizzato dall’articolazione, grazie alla quale sancirea questo statuto universale.
Dalla visione alla rappresentazione: Il Barbaro di Mario Carli 157
155 Henri Bergson, Il carattere comico, cit., p. 100.156 Ibid., p. 102.157 Henri Bergson, La percezione del mutamento, cit., p. 126.158 Ibid., p. 127.159 Arnaldo Ginna, Pittura dell’avvenire, cit., p. 202.160 Manifesto tecnico della pittura futurista, cit., p. 24. 161 “C’est une allusion sans équivoque à la faculté de voir au-delà des limites physiques de la ma-
tière, propre aux sujets ‘sensitifs’ auxquels les futuristes se comparaient, comme, et pur la même rai-son, aux fous et aux primitifs”. Maurizio Calvesi, L’écriture médiumnique comme source del’automatisme futuriste et surréaliste,cit., p. 47. Trad. della sottoscritta.


In conclusione
Nel giugno del 1917, recensendo su “L’Italia Futurista” la raccolta di liriche diMaria Ginanni Montagne trasparenti, Emilio Settimelli commenta retrospettivamentela produzione letteraria del gruppo spiegando di avere provato a “dare alla luce l’operapuramente cerebrale”. Definisce ancora quest’impresa come un “immenso tentativodi oggettivarsi, di cavare dal cervello un poema come un oggetto d’argento da unastuccio di velluto, con egual pulitezza [...]”1. Passa quindi ad elogiare il volumedella Ginanni quale opera che riesce a raggiungere l’obiettivo da loro tutti perseguitopiù volte.
Nel quadro degli studi critici rivolti al futurismo, questo lavoro ha dedicato un’am-pia analisi interamente a questo nucleo, ricostruendone l’evoluzione ideologica sulpercorso che conduce alla realizzazione dell’opera cerebrale. Ha individuato le di-namiche di questo processo, ha messo in rilievo l’originalità della concezione ela-borata dal gruppo e il contributo apportato nel quadro complessivo del futurismo.
Collocando la poetica del movimento nel contesto del filone milanese e di quellofiorentino precedente, questo studio ha dimostrato in che modo il secondo futurismofiorentino rappresenta un momento di assimilazione e convergenza. La direttiva tec-nologico-modernista dell’anima milanese e quella onirico-spirituale di quella fio-rentina vengono ricongiunte proprio sotto l’emblema della macchina, in una duplicevalenza. Essa simbolizza il dinamismo che anima la realtà, introducendo una nuovadimensione di irruenza nel mondo interiore. D’altro canto, il positivismo rappresen-tato dalla macchina trasferisce l’oggettività delle scienze positive nell’esplorazionedella dimensione occulta, che avviene all’insegna del ragionamento. Questa teoriadella creatività è in effetti una teoria della scoperta da parte del “genio”, incalzato epotenziato dalle complesse energie che vanno affacciandosi alla conoscenza neiprincipi del Novecento. È una concezione che vede la genialità impegnata ad au-scultare le pulsioni della realtà profonda e a rappresentarla nel prodotto artistico, ilquale riflette il carattere cerebrale della scoperta.
Nel 1909 nasceva il futurismo, dicevamo nell’introduzione. Un movimento po-liedrico che, a qualche anno dalla sua esplosione, avrebbe fecondato l’attività di un
1 Emilio Settimelli, Primo bilancio di “Montagne trasparenti” di Maria Ginanni, in “L’Italia Fu-turista”, cit.

secondo nucleo fiorentino, già molto operativo a partire dal 1912. Tra qualche annoricorre il centenario della fondazione de “L’Italia Futurista”, che si spera polarizzil’attenzione della critica e del pubblico verso l’originale contributo di questo nu-cleo e la sua eredità. Pensando a questa ricorrenza, si auspica che le fonti primariesia teoriche che creative possano diventare più facilmente fruibili. Sarebbe utile ri-mettere in circolazione le testate che precedono “L’Italia Futurista” attraverso ri-stampe integrali, come già avvenuto per “L’Italia Futurista” e, laddove possibile,archivi digitali, di facile accesso. Iniziative editoriali tese a riportare alla luce testicreativi difficilmente reperibili contribuirebbero alla loro circolazione e a dare aqueste opere la giusta collocazione nel quadro della produzione delle avanguardieeuropee del primo Novecento. Ampio campo di studio è tuttora costituito dalle pro-duzioni di autori meno conosciuti ma non meno singolari, per rendere giustizia al-l’eterogeneità dei contributi e delle influenze presenti nel fitto tessuto di questomovimento. Restano notevoli potenzialità di ricerca che, corroborate da una piùvasta circolazione delle fonti primarie, dallo scrutinio dei tanti materiali ancora ine-diti e dal contributo di studi specifici rivolti al movimento, si auspica troveranno lagiusta estrinsecazione in lavori futuri.
160 In conclusione

Bibliografia
OPERE DEI FUTURISTI
A.B.C. (Arnaldo e Bruno Corradini), Metodo, Ravenna, Tipo-lito Ravegnana, 1910, ora inMario Verdone (a cura di), Manifesti futuristi e scritti teorici di Arnaldo Ginna e BrunoCorra, Ravenna, Longo, 1984, pp. 49-79.
Balla, Depero, Ricostruzione futurista dell’universo, Milano, 11 marzo 1915, ora in LucianoDe Maria (a cura di), Marinetti e i futuristi, Milano, Garzanti, 1994, pp. 172-176.
Boccioni, Carrà, Russolo, Balla, Severini, Prefazione al Catalogo delle Esposizioni di Parigi,Londra, Berlino, Bruxelles, Monaco, Amburgo, Vienna ecc., febbraio 1912, ora in Lu-ciano De Maria (a cura di), Marinetti e i futuristi, Milano, Garzanti, 1994, pp. 59-66.
Boccioni, Carrà, Russolo, Balla, Severini, Manifesto tecnico della pittura futurista, 11 aprile1910, ora in Luciano De Maria (a cura di), Marinetti e i futuristi, Milano, Garzanti, 1994,pp. 23-26.
Boccioni, Carrà, Russolo, Balla, Severini, Manifesto dei pittori futuristi, 11 febbraio 1910,ora in Luciano De Maria (a cura di), Marinetti e i futuristi, Milano, Garzanti, 1994, pp.20-23.
Bragaglia, Anton Giulio, Fotodinamismo futurista, 1911, Torino, Einaudi, 1970.Carli, Mario, Notti filtrate, Edizioni de “L’Italia Futurista”, Firenze, 1918, ora in Luciano
Caruso (a cura di), Dossier futurista 1910-1919, Firenze, S.P.E.S., 1995.Carli, Mario, Scoperte da 10 lire l’una, in “L’Italia Futurista”, a. II, n. 2, Firenze, 25 febbraio
1917, p. 2.Carli, Mario, Allucinazioni, 1916, in La mia divinità, Roma, Berlutti, 1923, p. 68.Carli, Mario, Un urlo, 1916, in La mia divinità, Roma, Berlutti, 1923, p. 69.Carli, Mario, Il pubblico che ci corrompe, in “Rivista”, a. I, n. 14-15, Firenze, 13 luglio 1913,
p. 5.Carli, Mario, Il mio Poe, in “Il Centauro”, a. I, n. 9, Firenze, 29 dicembre 1912, p. 1.Carli, Mario, Il Barbaro, I “Una porta si apre”, in “Il Centauro”, a. I, n. 1, Firenze, 3 no-
vembre 1912, p. 3.Carli, Mario, Il Barbaro, II “Pensieri azzurri”, in “Il Centauro”, a. I, n. 2, Firenze, 10 no-
vembre 1912, pp. 2-3.Carli, Mario, Il Barbaro, III “I venti e le idee”, in “Il Centauro”, a. I, n. 3, Firenze, 17 no-
vembre 1912, p. 3.Carli, Mario, Il Barbaro, IV “Quasi un’allegoria”, in “Il Centauro”, a. I, n. 4, Firenze, 24
novembre 1912, pp. 1-2.Carli, Mario, Il Barbaro, V “Il canto delle parole”, in “Il Centauro”, a. I, n. 5, Firenze, 1 di-
cembre 1912, pp. 2-3.Carli, Mario, Il Barbaro, VII “Un modo di non morire”, in “Il Centauro”, a. I, n. 8, Firenze,
22 dicembre 1912, p. 2.Carli, Mario, C’era una volta il pensiero, in “La Difesa dell’Arte”, a. II, n. 36-37, Firenze,
2 ottobre 1910, p. 2.Carli, Mario, Tesi di un’arte nuova, in “La Difesa dell’Arte”, a. II, n. 22-23, Firenze, 19-26
giugno 1910, pp. 3-4.Chiti, Remo, Misteri Michelangioleschi (indagini intuitive), in “Il Centauro”, a. I, n. 2, Fi-
renze, 10 novembre 1912, pp. 1-2.Conti, Primo, La gola del merlo (memorie provocate da Gabriel Cacho Millet), Firenze, San-
soni, 1983.

162 Bibliografia
Conti, Primo, Imbottigliature, in Imbottigliature, Firenze, Edizioni de “L”Italia Futurista”,1917, ora in Alessandro Masi (a cura di), Zig zag, il romanzo futurista, Milano, il Sag-giatore, 1995, pp. 217-222.
Conti, Primo, Coscienze, in Imbottigliature, Firenze, Edizioni de “L’Italia Futurista”, 1917,ora in Alessandro Masi (a cura di), Zig zag, il romanzo futurista, Milano, il Saggiatore,1995, pp. 188-189.
Conti, Primo, Pagine sentimentali, in Imbottigliature, Firenze, Edizioni de “L’Italia Futuri-sta”, 1917, ora in Alessandro Masi (a cura di), Zig zag, il romanzo futurista, Milano, ilSaggiatore, 1995, pp. 197-207.
Corra, Bruno, Prefazione a Sam Dunn è morto (Racconto insolito), Milano, Alpes, 1928, pp.7-10.
Corra, Bruno, O rinnovarsi o morire (sviluppate la vostra personalità), Milano, Facchi, 1919.Corra, Bruno, Per l’arte nuova della nuova Italia, Milano, Studio Editoriale Lombardo, 1918.Corra, Bruno, Il primato artistico italiano, in “L’Italia Futurista”, a. II, n. 1, Firenze, 10 feb-
braio 1917, p. 1. Corra, Bruno, Prefazione a Arnaldo Ginna, Pittura dell’avvenire, 1915, poi in “L’Italia Fu-
turista”, a. II, n. 21, Firenze, 8 luglio 1917, ora in Mario Verdone (a cura di), Manifestifuturisti e scritti teorici di Arnaldo Ginna e Bruno Corra, Ravenna, Longo, 1984, pp.183-186.
Corra, Bruno, Prefazione a Sam Dunn è morto (Romanzo Sintetico Futurista), Milano, Stu-dio Editoriale Lombardo, 1917.
Corra, Bruno, Sam Dunn è morto (Romanzo Futurista), Edizioni Futuriste di “Poesia”, Mi-lano, 1917.
Corra, Bruno, Per l’onnipotenza, s.d., in Con mani di vetro, Milano, Studio Editoriale Lom-bardo, 1916, poi in Madrigali e grotteschi, Milano, Facchi, 1919, pp. 93-96.
Corra, Bruno, Antenati, agosto 1914, in Con mani di vetro, Milano, Studio Editoriale Lom-bardo, 1916, poi in Madrigali e grotteschi, Milano, Facchi, 1919, pp. 11-14.
Corra, Bruno, Spiraglio, Torino, dicembre 1913, in Con mani di vetro, Milano, Studio Edi-toriale Lombardo, 1916, poi in Madrigali e grotteschi, Milano, Facchi, 1919, pp. 85-86.
Corra, Bruno, Avventure, Parigi, 4 novembre 1912, in Con mani di vetro, Milano, StudioEditoriale Lombardo, 1916, poi in Madrigali e grotteschi, Milano, Facchi, 1919, pp. 105-110.
Corra, Bruno, Accordi Medianici, Londra, luglio 1912, in Con mani di vetro, Milano, Stu-dio Editoriale Lombardo, 1916, poi in Madrigali e grotteschi, Milano, Facchi, 1919, pp.101-103.
Corra, Bruno, Strauss il funambulo, in “Il Centauro”, a. II, n. 1, Firenze, 12 gennaio 1913,p. 4.
Corra, Bruno, Chantecler, in “Il Centauro”, a. I, n. 6, Firenze, 8 dicembre, 1912, p. 2.Corra, B. – Ginanni, A. – Chiti, R. – Settimelli, E. – Carli, M. – Mara, O. – Nannetti, N., La
scienza futurista, in “L’Italia Futurista”, a. I, n. 2, Firenze, 15 giugno 1916, ora in MarioVerdone (a cura di), Manifesti futuristi e scritti teorici di Arnaldo Ginna e Bruno Corra,Ravenna, Longo, 1984, pp. 205-209.
Corradini Bruno – Settimelli Emilio, Pesi, misure e prezzi del genio artistico. Manifesto fu-turista, Milano, 1914, ora in Mario Verdone (a cura di), Manifesti futuristi e scritti teo-rici di Arnaldo Ginna e Bruno Corra, Ravenna, Longo, 1984, pp. 167-173.
Corradini, Bruno, Il liberismo, in “Collezione di saggi critici”, vol. II, Bologna, Beltrami,1912, pp. 141-174.
Corradini, Arnaldo e Bruno, Arte dell’avvenire. Paradosso (edizione ampliata), Bologna,Beltrami, 1911, ora in Mario Verdone (a cura di), Manifesti futuristi e scritti teorici di Ar-naldo Ginna e Bruno Corra, Ravenna, Longo, 1984, pp. 127-153.

Bibliografia 163
G. Corradini, Bruno, Commenti al capolavoro di F.T. Marinetti, in “Rivista”, a. I, n. 7, Fi-renze, 18 maggio 1913, p. 2.
G. Corradini, Bruno, Il Futurismo spiegato e discusso (La lussuria futurista; e anche: tuttici vogliono bene), in “Rivista”, a. I, n. 2, Firenze, 13 aprile 1913, p. 1.
G. Corradini, Bruno, Il Futurismo spiegato e discusso (Il passatismo del Futurismo), in “Ri-vista”, a. I, n. 2, Firenze, 13 aprile 1913, p. 2.
Ginanni Corradini, Bruno, La coltura umana, in “Rivista” a. I, n. 1, Firenze, 6 aprile 1913,pp. 2-3.
Ginanni Corradini, Bruno, Due parole franche a Sem Benelli, in “Il Centauro”, a. II, n. 5, Fi-renze, 9 febbraio 1913, p. 3.
Ginanni Corradini, Bruno, Carducci e Baudelaire sono imitatori (contro l’originalità), in “IlCentauro”, a. II, n. 4, Firenze, 2 febbraio 1913, p. 4.
Ginanni Corradini, Bruno, Replica a Hopkins, in “Il Centauro”, a. I n. 9, Firenze, dicembre1912, p. 2.
Ginanni Corradini, Bruno, Leggenda, in “Il Centauro”, a. I, n. 8, Firenze, 22 dicembre 1912,p. 1.
Ginanni Corradini, Bruno, Chantecler, in “Il Centauro”, a. I, n. 6, Firenze, 8 dicembre 1912,pp. 1-2.
Ginanni Corradini, Bruno, Il liberismo, in “Il Centauro”, a. I, n. 1, Firenze, 3 novembre 1912,p. 1.
Ginna, Arnaldo, L’uomo futuro, 1933, con prefazione di F.T. Marinetti, ora in Mario Ver-done (a cura di), Manifesti futuristi e scritti teorici di Arnaldo Ginna e Bruno Corra, Ra-venna, Longo, 1984, pp. 219-239.
Ginna, Arnaldo, Attimi occulti (racconto psicanalitico), 1929, ora in Mario Verdone, Il mi-sterioso Ginna, in “Il Caffè”, n. 1, febbraio 1968, pp. 56-58.
Ginna, Arnaldo, A proposito di “Arte dell’avvenire” (e altre pagine di taccuini 1913-1967),in Mario Verdone (a cura di), Manifesti futuristi e scritti teorici di Arnaldo Ginna e BrunoCorra, Ravenna, Longo, 1984, pp. 257-268.
Ginna, Arnaldo, Il coraggio nelle ricerche di occultismo, in “L’Italia Futurista”, a. II, n. 12,Firenze, 6 maggio 1917, p. 2.
Ginna, Arnaldo, Pittura dell’avvenire, 1915, poi a puntate in “L’Italia Futurista” dal n. 16, 3giugno 1917 al n. 20, 1 luglio 1917, ora in Mario Verdone (a cura di), Manifesti futuristie scritti teorici di Arnaldo Ginna e Bruno Corra, Ravenna, Longo, 1984, pp. 183-203.
Ginanni, Maria, Fra due dita, in “L’Italia Futurista”, a. II, n. 37, Firenze, 15 gennaio 1918,p. 2.
Ginanni, Maria, Montagne trasparenti, Edizioni de “L’Italia Futurista”, Firenze, 1917.Ginanni, Maria, Come una danza, in “L’Italia Futurista”, a. II, n. 4, Firenze, 11 marzo 1917,
p. 2.Ginanni, Maria, Trasparenze. I ponti delle cose, in “L’Italia Futurista”, a. I, n. 11, Firenze, 1
dicembre 1916, p. 2.Ginanni, Maria, Frammenti di novelle colorate, in “L’Italia Futurista”, a. I, n. 2, Firenze, 15
giugno 1916, p. 2.Ginanni, Maria, Frammento di novella colorata, in “L’Italia Futurista”, a. I, n. 1, Firenze, 1
giugno 1916, p. 2.Ginanni, Maria, Le lucciole, in “L’Italia Futurista”, a. I, n. 9, Firenze, 1 novembre 1916, p.
2.Magamal, Sam Dunn è morto, in “L’Italia Futurista”, a. II, n. 28, Firenze, 9 settembre 1917,
p. 3. Marinetti, F.T. – Settimelli E. – Corra B., Manifesto del teatro futurista sintetico, Milano,
1915, ora in Mario Verdone (a cura di), Manifesti futuristi e scritti teorici di Arnaldo

164 Bibliografia
Ginna e Bruno Corra, Ravenna, Longo, 1984, pp. 175-181.Marinetti, F.T., Contro il matrimonio, in Democrazia futurista, 1919, ora in F.T. Marinetti,
Teoria e invenzione futurista, a cura di Luciano De Maria, Milano, Mondadori, 1968, pp.368-371.
Marinetti, F.T., L’introduzione del pugno nella lotta artistica, in “L’Italia Futurista”, a. II, n.9, Firenze, 15 aprile 1917, p. 2.
Marinetti, F.T., Il teatro di varietà, 1913, ora in F.T. Marinetti, Teoria e invenzione futurista,a cura di Luciano De Maria, Milano, Mondadori, 1968, pp. 80-91.
Marinetti, F.T., Distruzione della sintassi- Immaginazione senza fili- Parole in libertà, 11maggio 1913, ora in F.T. Marinetti, Teoria e invenzione futurista, a cura di Luciano DeMaria, Milano, Mondadori, 1968, pp. 65-80.
Marinetti, F.T., Manifesto tecnico della letteratura futurista, 11 maggio 1912, ora in F.T.Marinetti, Teoria e invenzione futurista, a cura di Luciano De Maria, Milano, Mondadori,1968, pp. 46-54.
Marinetti, F.T., Risposte alle obiezioni, supplemento al Manifesto tecnico della letteratura fu-turista, 11 agosto 1912, ora in F.T. Marinetti, Teoria e invenzione futurista, a cura di Lu-ciano De Maria, Milano, Mondadori, 1968, pp. 55-59.
Marinetti, F.T., L’uomo moltiplicato e il regno della macchina, 1910, ora in F.T. Marinetti,Teoria e invenzione futurista, a cura di Luciano De Maria, Milano, Mondadori, 1968, pp.297-301.
Marinetti, F.T., Fondazione e Manifesto del Futurismo, pubblicato sul “Figaro” il 20 feb-braio 1909, ora in F.T. Marinetti, Teoria e invenzione futurista, a cura di Luciano DeMaria, Milano, Mondadori, 1968, pp. 7-14.
Papini, Giovanni, Futurismo e Marinettismo, in “Lacerba”, a. III, n. 7, Firenze, 1915, ora inLuciano De Maria (a cura di), Marinetti e i futuristi, Milano, Garzanti, 1994, pp. 285-288.
Papini, Giovanni, Un uomo finito 1913, ora Firenze, Ponte delle Grazie, 1994.Papini, Giovanni, Alleati e nemici. L’evoluzione creatrice. H. Bergson, L’évolution créatrice,
Paris, F. Alcan, 1907, in “Leonardo: rivista d’idee”, a. V, serie 3, Firenze, agosto 1907,pp. 305-307.
Papini, Giovanni, Franche spiegazioni, in “Leonardo: rivista d’idee”, a. V, serie 3, Firenze,aprile-giugno 1907, p. 130.
“La redazione”, Il nostro programma, in “Rivista”, a. I n. 1, Firenze, 6 aprile 1913, pp. 1-2.Settimelli, Emilio, Primo bilancio di “Montagne trasparenti” di Maria Ginanni, in “L’Ita-
lia Futurista”, a. II, n. 19, Firenze, 24 giugno 1917, p.1.Settimelli, Emilio, Maria Ginanni, prima grande scrittrice italiana, in “L’Italia Futurista”,
a. II, n. 3, Firenze, 4 marzo 1917, p. 1. Settimelli, Emilio, Presentazione a Maria Ginanni, Montagne trasparenti, Firenze, Edizioni
de “L’Italia Futurista”, 1917, pp. 5-17.Settimelli, Emilio, L’Italia Futurista, in “L’Italia Futurista”, a. I, n. 1, Firenze, 1 giugno
1916, p. 1.Settimelli, Emilio, Scienza crociana e scienza (pardon!) mia, in “Rivista”, a. I, n. 18-19, Fi-
renze, 10 agosto 1913, pp. 1-3.Settimelli, Emilio, Superare D’Annunzio e Croce, in “Rivista”, a. I, n. 16-17, Firenze, 27 lu-
glio 1913, pp. 1-2. Settimelli, Emilio, Superare d’Annunzio e Croce, in “Il Centauro” a. II, n. 4, Firenze, 2 feb-
braio 1913, pp. 1-2.Settimelli, Emilio, L’inutilità del “Centauro”, in “Il Centauro”, a. II, n. 3, Firenze, 26 gen-
naio 1913, p. 1.Settimelli, Emilio, A proposito di futurismo, in “Il Centauro”, a. II, n. 1, Firenze, 12 gennaio
1913, p. 1.

Bibliografia 165
Settimelli, Emilio, La critica di Benedetto Croce, in “Collezione di saggi critici”, vol. II, Bo-logna, Beltrami, 1912, pp. 5-101.
Settimelli, Emilio, La seconda parte del nuovo sistema di critica, in “La Difesa dell’Arte”,a. II, n. 22-23, Firenze, 19-26 giugno 1910, pp.1-2.
Settimelli, Emilio, La bestia umana, in “La Difesa dell’Arte”, a. II, n. 17, Firenze, 15 mag-gio 1910, p. 2.
Settimelli, Emilio, Il nuovo sistema di critica, in “La Difesa dell’Arte”, a. I, n. 2, Firenze, 11novembre 1909, p. 1.
Soffici, Ardengo, Arthur Rimbaud, 1911, ora in Opere, vol. I, Vallecchi, Roma, 1959.Valeria, Irma, Occultismo e arte nuova, in “L’Italia Futurista”, a. II, n. 17, Firenze, 10 giu-
gno 1917, p. 2.Valeria, Irma, Mendicanti d’azzurro, in Morbidezze in agguato, Edizioni de “L’Italia Futu-
rista”, Firenze, 1917, pp. 6-8.
OPERE SUL FUTURISMO
Apolloni, Ignazio e Arrigo, Nino (a cura di), Futurismo come attualità e divenire, “Rivistadi Studi Italiani”, a. XXVII, n. 1, giugno 2009.
Arrigo, Nino, Futurismo come attualità e divenire, in “Rivista di Studi Italiani”, a. XXVII,n. 1, giugno 2009, pp. 1-4.
Bagatti, Fabrizio, Rapporti tra futurismo marinettiano e futurismo fiorentino, in Fabrizio Ba-gatti, Gloria Manghetti, Silvia Porto (a cura di), Futurismo a Firenze 1910-1920, Firenze,Sansoni, 1984, pp. 33-38.
Bagatti, Fabrizio – Manghetti, Gloria – Porto, Silvia (a cura di), Futurismo a Firenze 1910-1920, Catalogo della mostra (Firenze, 18 febbraio-8 aprile 1984), Firenze, Sansoni, 1984.
Bandini, Bruno, Il futurismo in Romagna, in Anna Maria Nalini (a cura di), Futurismo inEmilia Romagna, Modena, Artioli, 1990, pp. 65-66.
Bandini, Mirella, Elementi protosurrealisti nei testi di Mario Carli, Bruno Corra e Maria Gi-nanni in “L’Italia Futurista”, in Luciano Caruso (a cura di), Il “fronte interno” de “l’Ita-lia Futurista”, Firenze, S.P.E.S., 1992, pp. 15-18.
Bentivoglio, Mirella, La poetica futurista di Irma Valeria, in “Il Cristallo: Rassegna di variaumanità”, a. 41, n. 3, dicembre 1999, pp. 92-98.
Berghaus, Günter (edited by), Futurism and the Technological Imagination, Amsterdam-New York, NY, Rodopi, 2009.
Bertoni, Alberto, Elementi innovatori del futurismo emiliano-romagnolo: le “periferie” diRavenna e di Ferrara, in Anna Maria Nalini (a cura di), Futurismo in Emilia Romagna,Modena, Artioli, 1990, pp. 83-90.
Bigongiari, Piero, Il terzo futurismo fiorentino, presentazione a Maria Carla Papini (a curadi), L’Italia Futurista (1916-1918), Roma, Edizioni dell’Ateneo e Bizzarri, 1977, pp. 9-21.
Boatto, A., Conti, P., De Maria, L., Prampolini, G., Ramat, S., Scheiwiller, V., Verdone, M.,Vivaldi, C., “Tavola rotonda” su Primo Conti e la Pattuglia azzurra, in “Antologia Vieus-seux”, a. X, n. 39-40, luglio-dicembre 1975, pp. 7-54.
Calvesi, Maurizio, L’écriture médiumnique comme source de l’automatisme futuriste et sur-réaliste, in “Europe”, n. 551, mars 1975, pp. 44-48.
Carmosino, Daniela, “Dalla coscienza intellettiva a quella veggente”: tardo simbolismo opre-surrealismo?, in Micol Forti, Lucia Collarile, Mariastella Margozzi (a cura di), Ar-monie e disarmonie degli stati d’animo- Ginna Futurista, Roma, Gangemi, 2009, pp.69-77.

166 Bibliografia
Carrà, Massimo, Convergenze e difficoltà fra Milano e Firenze, in Fabrizio Bagatti, GloriaManghetti, Silvia Porto (a cura di), Futurismo a Firenze 1910-1920, Firenze, Sansoni,1984, pp. 9-16.
Caruso, Luciano (a cura di), Dossier futurista 1910-1919, Firenze, S.P.E.S., 1995. Caruso, Luciano (a cura di), “L’Italia Futurista 1916-1918”, Firenze, S.P.E.S, 1992.Caruso, Luciano (a cura di), Il “fronte interno” de “L’Italia Futurista” (Firenze 1916-1918),
Firenze, S.P.E.S., 1992.Celant, Germano, Futurismo esoterico, in “Il Verri”, n. 33-34, 1970, pp. 108-117.Cigliana, Simona, Futurismo esoterico. Contributi per una storia dell’irrazionalismo ita-
liano tra Otto e Novecento (prima edizione, 1996), Napoli, Liguori, 2002.Cioni, Anna Maria, Teoria e pratica della scrittura esoterica nel futurismo, in “Critica let-
teraria”, a. III, n. 9, 1975, pp. 684-687.Crispolti, Enrico (a cura di), Il futurismo in Romagna, Rimini, Maggioli, 1986.De Maria, Luciano, La nascita dell’avanguardia. Saggi sul futurismo italiano, Venezia, Mar-
silio, 1986.De Maria, Luciano, dibattito seguito all’intervento di Sergio Zoppi, L’avanguardia europea
e il futurismo a Firenze, in Gloria Manghetti (a cura di), Futurismo a Firenze 1910-1920,Verona, Bi & Gi editori, 1984, pp. 39-41.
De Maria, Luciano (a cura di), F.T. Marinetti, Teoria e invenzione futurista, Milano, Mon-dadori, 1968.
De Maria, Luciano (a cura di), Marinetti e i futuristi, Milano, Garzanti, 1994.De Paz, Alfredo, Dada, surrealismo e dintorni, Bologna, Clueb, 1979.De Vincenti, Gloria, Genio e ambiente nel Secondo Futurismo Fiorentino: “Sam Dunn è
morto” di Bruno Corra, in “The Italianist”, vol. 33 n. 1, February 2013, pp. 120-137.De Vincenti, Gloria, From Childhood experience to ars poetica: forming substitutes, in
“Forum Italicum”, vol. 46, n. 1, Spring 2012, pp. 38-52.De Vincenti, Gloria, Il “pensiero peregrino” nel Secondo Futurismo Fiorentino: quando la
macchina investe lo spirito, in “Rivista di Studi Italiani”, a. XXVII, n. 1, giugno 2009,pp. 93-106.
Dondi, Laura, Dal “secondo futurismo fiorentino”del periodo eroico al “secondo futuri-smo”, in Luciano De Maria (a cura di), Marinetti e i futuristi, Milano, Garzanti, 1994, pp.XLIII-LIV.
Drudi Gambillo, Maria e Fiori,Teresa (a cura di), Archivi del Futurismo, vol. II, Roma, DeLuca Editore, 1962.
Forti, Micol – Collarile, Lucia – Margozzi, Mariastella (a cura di), Armonie e disarmoniedegli stati d’animo- Ginna Futurista, Catalogo della mostra (Roma, 12 marzo-10 mag-gio 2009, Firenze, 23 giugno-20 settembre 2009), Roma, Gangemi, 2009.
Gazzola, Giuseppe (edited by), Futurismo: impact and legacy, Stony Brook, NY, ForumItalicum Publishing, Filibrary Series n. 31, 2011.
Gherarducci, Isabella, Il futurismo italiano: materiali e testimonianze critiche, Roma, Edi-tori Riuniti, 1976.
Giannone, Antonio Lucio, “L’Italia futurista” e la poetica del “frammento”, in Luciano Ca-ruso (a cura di), Il “fronte interno” de “L’Italia Futurista”, Firenze, S.P.E.S., 1992, pp.25-28.
Gioanola, Elio, Bruno Corra, in G. Mariani e M. Petrucciani, Letteratura italiana contem-poranea, vol. II, Roma, Lucarini, 1980, pp. 787-792.
Grana, Gianni, Dal futurismo al surrealismo in Novecento, le avanguardie letterarie, vol.II, Milano, Marzorati, 1986, pp. 499-511.
Grana, Gianni, Il surreal-futurismo fiorentino, in Novecento, le avanguardie letterarie, vol.II, Milano, Marzorati, 1986, pp. 555-565.

Bibliografia 167
Guglielminetti, Marziano, Bruno Corra, avanguardia e successo, in “Il lettore di provincia”,a.18, n. 69, settembre 1987, pp. 11-16.
Lambiase, Sergio – Nazzaro, G. Battista, Marinetti e i futuristi, Milano, Garzanti, 1978.Lista, Giovanni, I caratteri specifici del futurismo emiliano-romagnolo e le loro ripercus-
sioni nel campo dello spettacolo, in Anna Maria Nalini (a cura di), Futurismo in EmiliaRomagna, Modena, Artioli, 1990, pp. 95-99.
Lora -Totino, Arrigo, Lo sperimentalismo de “L’Italia Futurista”, in Luciano Caruso (a curadi), Il “fronte interno” de “L’Italia Futurista”, Firenze, S.P.E.S., 1992, pp. 44-47.
Luisetti, Federico and Somigli, Luca (edited by), A Century of Futurism: 1909-2009, “An-nali d’Italianistica”, vol. 27, 2009.
Luti, Giorgio, L’avanguardia francese e il futurismo fiorentino, in “Revue des Ètudes Ita-liennes”, vol. 43, n. 3-4, luglio-dicembre 1997, pp. 133-142.
Manghetti, Gloria (a cura di), Firenze Futurista 1909-1920, Atti del convegno di studi (Fi-renze, 15-16 maggio 2009), Firenze, Edizioni Polistampa, 2010.
Manghetti, Gloria (a cura di), Marinetti e il Futurismo a Firenze, Catalogo della mostra (Fi-renze, 19 dicembre 1994-21 gennaio 1995), Roma, De Luca, 1994.
Manghetti, Gloria (a cura di), Futurismo a Firenze 1910-1920, Atti del convegno (Firenze,1-3 marzo 1984), Verona, Bi & Gi editori, 1984.
Martini, Stelio M., Le “novità” de “L’Italia futurista”, in Luciano Caruso (a cura di), Il“fronte interno” de “L’Italia Futurista” (Firenze 1916-1918), Firenze, S.P.E.S., 1992, pp.53-56.
Masi, Alessandro (a cura di), Zig zag, il romanzo futurista, Milano, il Saggiatore, 1995.Nalini Anna Maria (a cura di), Futurismo in Emilia Romagna, Modena, Artioli, 1990.Nalini Setti, Anna Maria, Appunti per una lettura sistematica del futurismo in Emilia-Ro-
magna, in Anna Maria Nalini (a cura di), Futurismo in Emilia Romagna, Modena, Artioli,1990, pp. 7-10.
Nazzaro, Gian Battista, Nel mondo di “Sam Dunn”, in “Es”, n. 2, ottobre-gennaio 1975, pp.88-126.
Notte, R. Esoterismo, in Ezio Godoli (a cura di), Dizionario del Futurismo, Firenze, Vallec-chi, 2001, pp. 412-416.
Papini, Maria Carla, Tra futurismo, surrealismo e oltre: il gruppo dell’“Italia Futurista”, inLuciano Caruso (a cura di), Il “fronte interno” de “l’Italia Futurista”, Firenze, S.P.E.S.,1992, pp. 62-65.
Papini, Maria Carla (a cura di), L’Italia Futurista (1916-1918), Roma, Edizioni dell’Ateneoe Bizzarri, 1977.
Piscopo Ugo, Significato e funzione del gruppo nel futurismo, in Questioni ed aspetti del fu-turismo: con un’appendice di testi del futurismo a Napoli, Napoli, Libreria Editrice Fer-raro, 1976.
Porto, Silvia, Esperienze del futurismo fiorentino nel settore delle arti visive, in Fabrizio Ba-gatti, Gloria Manghetti, Silvia Porto (a cura di), Futurismo a Firenze 1910-1920, Firenze,Sansoni, 1984, pp. 39-48.
Ramat, Silvio, Nota a Maria Carla Papini (a cura di), L’Italia Futurista (1916-1918), Roma,Edizioni dell’Ateneo e Bizzarri, 1977, pp. 25-28.
Romani, Bruno, Dal simbolismo al futurismo, Firenze, Sandron, 1969, p. 116.Saccone, Antonio, Primordi dell’Italia Futurista: Corra, Settimelli e la “misurazione” del-
l’opera d’arte, in Luciano Caruso (a cura di), Il “fronte interno” de “L’Italia Futuri-sta”, Firenze, S.P.E.S., 1992, pp. 79-83.
Salaris, Claudia, Letteratura come artificio, introduzione a Mario Carli, La mia divinità,Montepulciano, Editori del Grifo, 1991, pp. 125-133.
Salaris, Claudia, Storia del futurismo, Roma, Editori Riuniti, 1985.

168 Bibliografia
Salaris, Claudia, Le futuriste: donne e letteratura d’avanguardia d’Italia (1909-1944), Mi-lano, Edizioni delle donne, 1982.
Scaligero M. e Sprovieri G., Arnaldo Ginna (un pioniere dell’astrattismo), Roma, StudioTipografico B.S., 1961.
Scrivo, Luigi, Sintesi del Futurismo: Storia e documenti, Roma, Bulzoni, 1968.Sica, Paola, Maria Ginanni: futurist woman and visual writer, in “Italica”, vol. 79, n. 3, Au-
tumn 2002, pp. 339-352.Somigli, Luca, “Imbottigliature” di Primo Conti: Un romanzo futurista?, in “Forum Itali-
cum”, vol. 33, n. 2, Fall 1999, pp. 337-351.Vanden Berghe, Dirk, “L’Italia Futurista” e il Secondo Futurismo Fiorentino, in “Il Ponte”,
vol. 44, n. 6, novembre-dicembre 1988, pp. 165-177.Verdone, Mario, Il futurismo fiorentino. Documenti per l’avanguardia, in Luciano Caruso (a
cura di), Il “fronte interno” de “L’Italia Futurista”, Firenze, S.P.E.S., 1992, pp. 84-88.Verdone, Mario, Diario parafuturista, Roma, Lucarini, 1990.Verdone, Mario, Ginna e Corra, in “Il lettore di provincia”, a. 18, n. 69, settembre 1987, pp.
69-80.Verdone, Mario, Arnaldo Ginna tra astrazione e futurismo, Ravenna, Edizioni Essegi, 1985.Verdone, Mario, Arnaldo Ginna, in Fabrizio Bagatti, Gloria Manghetti, Silvia Porto (a cura
di), Futurismo a Firenze 1910-1920, Firenze, Sansoni, 1984, pp. 17-20.Verdone, Mario (a cura di), Manifesti futuristi e scritti teorici di Arnaldo Ginna e Bruno
Corra, Ravenna, Longo, 1984.Verdone, Mario, Introduzione a Manifesti futuristi e scritti teorici di Arnaldo Ginna e Bruno
Corra, Ravenna, Longo, 1984, pp. 7-37. Verdone, Mario, Prosa e critica futurista, Milano, Feltrinelli, 1973.Verdone, Mario, Nota a Sam Dunn è morto, a cura di Mario Verdone, Torino, Einaudi, 1970,
pp. 73-80. Verdone, Mario, Il “misterioso Ginna”, in “Il Caffè”, n. 1, febbraio 1968, pp. 56-58.Verdone, Mario, Cinema e letteratura del futurismo, Roma, “Bianco e Nero”, a. XXVIII, n.
10-11-12, ottobre-novembre-dicembre 1967.Verdone, Rossana Schiavina, Bruno Corra tra futurismo e surrealismo, estratto da “Teatro
Contemporaneo”, a. III, n. 5, ottobre 1983-gennaio 1984, Roma, Lucarini, pp. 201-208.Viazzi, Glauco, I poeti del futurismo 1909-1944, Milano, Longanesi, 1978.Zanotto, Sandro, Motivi irrazionali ed esoterici nel futurismo toscano, in Gloria Manghetti
(a cura di), Futurismo a Firenze 1910-1920, Verona, Bi & Gi editori, 1984, pp. 111-118.Zoppi, Sergio, L’avanguardia europea e il futurismo a Firenze, in Gloria Manghetti (a cura
di), Futurismo a Firenze 1910-1920, Verona, Bi & Gi editori, 1984, pp. 23-37.
ALTRE OPERE
Agamben, Giorgio, Infanzia e storia, Torino, Einaudi, 1978.Aldrich, Charles Robert, Mente primitiva e società moderna (prima edizione in inglese,
1931), trad. Tullio Tentori, Torino, Einaudi, 1949.Artioli, Umberto, La scena e la dynamis (immaginario e struttura nelle sintesi futuriste),
Bologna, Patron, 1975.Assagioli, Roberto, Le idee di S. Freud sulla sessualità, in “La Voce”, a. II, Firenze, 9 e 10
febbraio 1910, pp. 262-263.Assagioli, Roberto, Il nuovo pensiero americano, in “Leonardo: rivista d’idee”, a.V, serie 3,
Firenze, aprile-giugno 1907, pp. 201-212.Bachelard, Gaston, La poetica della rêverie (prima edizione in francese 1960), trad. Gio-

Bibliografia 169
vanna Silvestri Stevan, Bari, Dedalo, 1972.Bandini, Mirella, La vertigine del moderno: percorsi surrealisti, Roma, Officina, 1986.Bergson, Henri, La percezione del mutamento (due conferenze tenute all’università di Ox-
ford il 26 e il 27 maggio 1911), in Pensiero e movimento, trad. Francesca Sforza, Milano,Bompiani, 2000, pp. 121-148.
Bergson, Henri, L’evoluzione creatrice (prima edizione in francese, 1907), trad. Fabio Poli-dori, Milano, Cortina, 2002.
Bergson, Henri, Introduzione alla metafisica (“Revue de métaphysique et de morale”, jan-vier 1903), in Pensiero e movimento, trad. Francesca Sforza, Milano, Bompiani, 2000, pp.149-189.
Bergson, Henri, Il sogno (“Bulletin de l’Institut Général Psychologique”, mai 1901), inL’energia spirituale, trad. Giuseppe Bianco, Milano, Cortina, 2008, pp. 65-82.
Bergson, Henri, Il carattere comico (“Revue de Paris”, 1er février, 1er mars 1899), in Il riso:saggio sul significato del comico, pref. Beniamino Placido, Bari, Laterza, 1982, pp. 87-128.
Blavatsky, Elena Petrovna, Introduzione alla teosofia (prima edizione in inglese, 1889), trad.G.B. Penne, Torino, Fratelli Bocca, 1911.
Breton, André, Manifesti del Surrealismo (prima edizione in francese, 1924), trad. LilianaMagrini, Torino, Einaudi, 1987.
Capuana, Luigi, Mondo occulto, Napoli, Pierro, 1896, ora in L.C., Mondo occulto, a cura diSimona Cigliana, Catania, Edizioni del Prisma, 1995, pp. 163-211.
Capuana, Luigi, Lettera aperta a Luigi Pirandello: a proposito di un fantasma. Credenti emiscredenti dello spiritismo, in “Gazzetta del Popolo”, Torino, 2 gennaio 1906, ora inL.C., Mondo occulto, a cura di Simona Cigliana, Catania, Edizioni del Prisma, 1995, pp.239-242.
Capuana, Luigi, Spiritismo?, Catania, Giannotta, 1884, ora in L.C., Mondo occulto, a curadi Simona Cigliana, Catania, Edizioni del Prisma, 1995, pp. 55-162.
Carotenuto, Aldo, Introduzione a C.G. Jung, Inconscio, occultismo e magia, Roma, NewtonCompton Italiana, 1971, pp. 8-31.
Carrouges, Michel, La dynamique de l’occultation, in Occulte-Occultation, études et docu-ments réunis par Henri Behar, “Cahiers du centre de recherches sur le Surréalisme”, Mé-lusine n. II, Lausanne, L’Âge d’Homme, 1981, pp. 39-52.
Cigliana, Simona, Introduzione a Luigi Capuana, Mondo occulto, a cura di Simona Cigliana,Catania, Edizioni del Prisma, 1995, pp. 9-53.
Conner, Tom, Introduction, Tom Conner (edited by) Dreams in French Literature: The Per-sistent Voice, Amsterdam-Atlanta, Rodopi, 1995, pp. 9-25.
David, Michel, La psicanalisi nella cultura italiana, Torino, Boringhieri, 1966.Ferdinand, Louis – Maury, Alfred, Le sommeil et les rêves, Paris, Didier, 1861. Freud, Sigmund, Il poeta e la fantasia (prima edizione in tedesco, 1907), ora in Saggi sul-
l’arte, la letteratura e il linguaggio, trad. Cesare L. Musatti, vol. I, Torino, Boringhieri,1969, pp. 47-59.
Freud, Sigmund, L’interpretazione dei sogni (prima edizione in tedesco, 1900), trad. Anto-nella Ravazzolo, Roma, Newton Compton, 1988.
Giacanelli, Ferruccio, Il medico, l’alienista, in Delia Frigessi, Ferruccio Giacanelli, LuisaMangoni (a cura di), Cesare Lombroso, Delitto, genio, follia: scritti scelti, Torino, Bol-lati Boringhieri, 1995, pp. 5-43.
Gunn, John Alexander, Bergson and his philosophy, New York, E.P. Dutton and Companypublishers, 1920.
James, Tony, Dream, Creativity, and Madness in Nineteenth-Century France, Oxford, Claren-don Press, 1995.

170 Bibliografia
James, William, Le energie degli uomini, in “Leonardo: rivista d’idee”, a. V, serie 3, febbraio1907, pp. 1-25.
James, William, Great men, great thoughts and the environment, in “Atlantic Monthly”, vol.46, n. 276, October 1880, pp. 441-459.
Janet, Pierre, L’automatisme psychologique: essai de psychologie expérimentale sur lesformes inférieures de l’activité humaine, Paris, Alcan, 1889.
Jung, Carl Gustav, Psychological Commentary on “The Tibetan Book of the Great Libera-tion”, in Psychology and Religion: West and East (prima edizione in inglese, 1954), trans-lated by R.F.C. Hull, London, Routledge & Kegan Paul, 1958, pp. 475-493.
Jung, Carl Gustav, Inconscio (prima edizione in tedesco, 1918), in Inconscio, occultismo emagia, trad. Celso Balducci, Roma, Newton Compton, 1971, pp. 187-215.
Jung, Carl Gustav, La libido: simboli e trasformazioni, contributi alla storia dell’evoluzionedel pensiero (prima edizione in tedesco, 1912), trad. Girolamo Mancuso, Roma, NewtonCompton, 1975.
Laurent, Emile, La poésie décadente devant la science psychiatrique, Paris, Maloine, 1897.Leuret, François, Fragments psychologiques sur la folie, Paris, Crochard, 1834.Lévy-Bruhl, Lucien, Psiche e società primitive (prima edizione in francese, 1910), trad. e in-
trod. Salvatore Lener, Roma, Newton Compton, 1970.Lévy-Bruhl, Lucien, La mentalità primitiva (prima edizione in francese, 1922), trad. Carlo
Cignetti, Torino, Einaudi, 1966.Lombroso, Cesare, L’incosciente nel genio, in “Rivista d’Italia”, aprile 1901, fascicolo 4,
pp. 644-655.Lombroso, Cesare, L’uomo di genio in rapporto alla psichiatria, alla storia e all’estetica
(prima edizione Genio e follia, 1864), Torino, Bocca, 1888.Luziani, Luciano, Benedetto Croce-Ohimé-scienziato, in “Rivista”, a. I, n. 2, Firenze, 13
aprile 1913, pp. 4-5.Luziani, Luciano, Cesare Lombroso, in “La Difesa dell’Arte”, a. I, n. 2, Firenze, 11 novem-
bre 1909, p. 3. Missiroli, Mario, L’ultima gaffe di G. Lombroso, in “Leonardo: rivista d’idee”, a. V, serie 3,
Firenze, agosto 1907, pp. 301-304.Musatti, Cesare L., Prefazione a Michel David, La psicanalisi nella cultura italiana, Torino,
Boringhieri, 1966, pp. VII-IX.Nerval, Gerard de, Aurélia (prima edizione in francese, 1855), Le figlie del fuoco, La Pan-
dora, Aurelia, trad. Renata Debenedetti, Milano, Garzanti, 1983, pp. 203-259. Nietzsche, Friedrich, Genealogia della morale (prima edizione in tedesco, 1887), trad. Fer-
ruccio Masini, Milano, Adelphi, 2006.Nietzsche, Friedrich, Umano, troppo umano (prima edizione in tedesco, 1878), trad. Sossio
Giametta, vol. I, Milano, Adelphi, 2008. Paliyenko, Adrianna, Margins of Madness and Creativity: Nineteenth-Century French Psy-
chiatric and Literary Discourses on Dream, in Tom Conner (edited by), Dreams in FrenchLiterature: the Persistent Voice, Amsterdam-Atlanta, Rodopi, 1995, pp. 173-198.
Prezzolini, Giuseppe, Leggenda e psicologia dello scienziato, in “Rivista di psicologia ap-plicata alla pedagogia ed alla psicopatologia”, Bologna, Stabilimento Poligrafico Emi-liano, marzo-aprile 1907, p. 93.
Reghini, Arturo (a cura di), Georgica Animi (La Raja Yoga), traduzione di una conferenza diSwami Vivekananda, tenuta a New York nell’inverno 1895-1896, in “Leonardo: rivistad’idee”, a. VI, serie 3, Firenze, aprile 1906, pp. 184-186.
Sass, Louis A., Madness and Modernism: Insanity in the Light of Modern Art, Literature, andThought, Cambridge, Massachusetts, Harvard University Press, 1994.
Simonton, Dean Keith, Origins of Genius, New York-Oxford, Oxford University Press, 1999.

Bibliografia 171
Sinnett, Alfred Percy, The Occult World, London, Trubner & Co, 1881.Steiner, Rudolf, La vita onirica, conferenza tenuta a Penmaenmawr, North Wales, il 22 ago-
sto 1923, in Conoscenza iniziatica, tredici conferenze tenute a Penmaenmawr dal 19 al31 agosto 1923, trad. E. de Renzis, Milano, Editrice Antroposofica, 1985, pp. 64-78.
Steiner, Rudolf, Il movimento occulto nel secolo diciannovesimo e il mondo della cultura, tre-dici conferenze tenute a Dornach dal 10 ottobre al 7 novembre 1915, trad. Adele Crippa,Milano, Editrice Antroposofica, 1993.
Steiner, Rudolf, Il mondo dei sensi e il mondo dello spirito, sei conferenze tenute ad Han-nover dal 27 dicembre 1911 al primo gennaio 1912, trad. Lina Schwarz, Milano, EditriceAntroposofica, 1970.
Steiner, Rudolf, Arte e conoscenza dell’arte, fondamenti di una nuova estetica, una rela-zione, quattro articoli dal 1890 al 1898 e otto conferenze tenute fra il 1909 e il 1921,trad. Iberto Bavastro, Milano, Editrice Antroposofica, 1998.
Steiner, Rudolf, La scienza occulta nelle sue linee generali (prima edizione in tedesco, 1910),trad. E. De Renzis e E. Battaglini, Milano, Editrice Antroposofica, 2005.
Steiner, Rudolf, Teosofia (prima edizione in tedesco, 1904), trad. Ida Levi Bachi, Milano, Edi-trice Antroposofica, 1990.
Steiner, Rudolf, L’iniziazione: come si conseguono conoscenze dei mondi superiori? (primaedizione in tedesco, 1904), trad. Emmelina De Renzis, Milano, Editrice Antroposofica,1977.
Steiner, Rudolf, Goethe, padre di una nuova estetica, conferenza tenuta a Vienna il 9 no-vembre 1888, in Arte e conoscenza dell’arte, fondamenti di una nuova estetica, trad. Ib-erto Bavastro, Milano, Editrice Antroposofica, 1998, pp. 11-32.
Steiner, Rudolf, Art as Spiritual Activity, selected lectures on visual arts from 1888 to 1923,with an introduction by Michael Howard, Hudson, New York, Anthroposophic Press,1998.
Steptoe, Andrew (edited by), Genius and the Mind, Oxford University Press, 1998.Szasz, Thomas, The Myth of Mental Illness, in James Fadiman and Donald Kewman (edited
by), Exploring Madness: Experience, Theory and Research, Monterey, California,Brooks/Cole Publishing Company, 1973, pp. 87-96.
Tylor, Edward Burnett, Alle origini della cultura (prima edizione in inglese, 1871), trad. Gio-vanni Battista Bronzini, vol. III, Roma, Edizioni dell’Ateneo, 1988, pp. 53-54.
Valli, Donato, Vita e morte del “ frammento” in Italia, Lecce, Milella, 1980.Wendel, Georg, Teoria sul genio e follia: Georg Wendel contro C. Lombroso, trad. R. Ba-
zardjian, Padova, Fratelli Drucker editori, 1911.


Indice dei nomi
Agamben, Giorgio, 24 e n, 93 e nAldrich, Charles Robert, 139 e n, 140, 143
e n, 146 e n, 156 e nAmendola Kühn, Eva, 20, 36n, 108, 118,
121, 132, 133Apollinaire, Guillaume, 31, 44Apolloni, Ignazio, 14nArchipenko, Alexander, 31, 34Aristotele, 113Arrigo, Nino, 14 e nAssagioli, Roberto, 18 e n, 121 e n
Bachelard, Gaston, 91 e nBagatti, Fabrizio, 13 e n, 37n, 38nBalducci, Celso, 76nBalla, Giacomo,12n, 30, 33, 38, 49n, 50 en, 53, 105n, 106n, 124nBandini, Mirella, 13 e nBaroncini, Luigi, 18Battaglini, Enzo, 75nBaudelaire, Charles, 11, 28, 38, 41, 93,
113Bavastro, Iberto, 57nBazardjian, Raphaël, 114nBeethoven, Ludwig van, 113Bergson, Henri, 19, 23, 68, 69 e n, 70 e n,
80 e n, 83, 84 e n, 156n, 157 e nBesant, Annie, 58Bianco, Giuseppe, 84nBigongiari, Piero, 46nBlavatsky, Helena Petrovna, 57 e n, 58Boccioni, Umberto, 27, 30, 34, 38, 49n,
50n, 99, 106nBois, Joseph, 28Bragaglia, Anton Giulio, 50, 51n, 126nBreton, André, 11, 102 e n
Bronzini, Giovanni Battista, 156nButti, Enrico Annibale, 54Buzzi, Paolo, 34, 38, 50, 126n
Calvesi, Maurizio, 14n, 25 e n, 77 e n, 157e n
Cangiullo, Francesco, 38Capuana, Luigi, 54n, 56 e n, 57 e n, 60, 61
e nCarbonaro, Marj, 36nCarli, Mario, 12, 13n, 16, 22n, 23, 25 e n,
33, 34, 37 e n, 46, 72 e n, 79 e n, 81 e n,93 e n, 96 e n, 102, 115 e n, 116 e n, 118,125, 132 e n, 137 e n, 138 e n, 139 e n,140n, 142n, 143n, 144n, 145n, 148, 149e n, 151 e n, 154 e n, 155 e n, 156 e n
Carmosino, Daniela, 17nCarrà, Carlo, 27, 30, 34, 49n, 50n, 106nCarrà, Massimo, 30, 31n, 44 e nCaruso, Luciano, 12 e n, 13n, 15n, 36n,
41n, 93n, 103nCelant, Germano, 13n, 51n, 53 e nChiti, Remo, 22n, 33, 34, 37, 50, 70 e n, 81
e n, 136, 137nCigliana, Simona, 13 e n, 51 e n, 52n, 54
e n, 56n, 57 e n, 105 e nCignetti, Carlo, 146nCioni, Anna Maria, 13n, 126 e nCollarile, Lucia, 14 e n, 17 e n, 18Conner, Tom, 82 e n, 113nConti, Primo, 8, 9, 14n, 23, 33 e n, 34 e n,
35, 39n, 40n, 43 e n, 44n, 45, 49, 50,55n, 73n, 79 e n, 83, 88 e n, 91, 93,109n, 117 e n, 125, 131n, 132n, 144 e n,145 e n, 155n
Corra, Bruno, 7, 12 e n, 14 e n, 15, 16, 17

174 Indice dei nomi
e n, 19 e n, 20 e n, 21 e n, 22 e n, 23 e n,24 e n, 25, 33 e n, 34n, 35, 37n, 39 e n,40 e n, 41 n, 42 e n, 43, 44 e n, 45, 46,48 e n, 55 e n, 56n, 59 e n, 61 e n, 63n,64 e n, 65 e n, 66 e n, 67 e n, 70 e n, 71e n, 72 e n, 73 e n, 75 e n, 77 e n, 79 e n,80 e n, 81 e n, 83, 86 e n, 87 e n, 88, 89e n, 90, 91 e n, 92, 93, 97, 99, 100n, 102e n, 103n, 104 e n, 105 e n, 107 e n, 108e n, 109 e n, 110, 111n, 112n, 114, 116e n, 117 e n, 118 e n, 119 e n, 120 e n,121, 122 e n, 123 e n, 125 e n, 126, 127e n, 129 e n, 130 e n, 131 e n, 132 e n,133 e n, 134 e n, 135n, 136 e n, 144 e n,145 e n, 152 e n, 153 e n, 154 e n, 155 en, 156n
Corradini Bruno, vedi Corra, BrunoCrippa, Adele, 53nCriscuoli, 63 e nCrisi Ginanni, Maria, vedi Ginanni, MariaCroce, Benedetto, 42 e n, 65, 66, 104
D’Annunzio, Gabriele, 42David, Michel, 18 e n, 19 e n, 76 e nDebenedetti, Renata, 82nDe Maria, Luciano, 11 e n, 27n, 28n, 29 e
n, 31n, 43 e n, 44n, 45 e n, 48, 49n, 50n,82n, 106n
de Nerval, Gérard, 82 e n, 101 e n, 102Depero, Fortunato, 50 e n, 105n, 124nDe Renzis, Emmelina, 58n, 75nDini, Fanny, 36nDondi, Laura, 82 e nDrudi Gambillo, Maria, 68n
Fadiman, James, 111nFayol, Henri, 60Ferdinand, Louis, 100nFiori, Teresa, 68nFlammarion, Camille, 51Fort, Paul, 31Forti, Micol, 14 e n, 17nFranchi, Raffaello, 21, 32, 50Freud, Sigmund, 18 e n, 19, 51, 83 e n, 84
e n, 89 e n, 90 e n, 91 e n, 93n, 101 e n,102, 103n, 135 e n
Frigessi, Delia, 52n
Gazzola, Giuseppe, 14nGiacanelli, Ferruccio, 51, 52nGiametta, Sossio, 148nGinanni, Maria, 8, 13, 23, 33, 35, 36n, 83,
85, 86n, 87 e n, 89, 93, 94n, 95n, 96n,97, 105 e n, 116 e n, 117, 125, 159 e n
Ginanni Corradini, Arnaldo, vedi Ginna,Arnaldo
Ginanni Corradini, Bruno, vedi Corra,Bruno
Ginna, Arnaldo, 12 e n, 14 e n, 17 e n, 19e n, 20 e n, 23 e n, 25, 33 e n, 34 e n, 35,37 e n, 46, 58 e n, 59 e n, 60, 62 e n, 67e n, 71, 74 e n, 75 e n, 81 e n, 85, 93 e n,99, 106 e n, 107 e n, 116, 117 e n, 125,127n, 134 e n, 136 e n, 144 e n, 152n,153 e n, 155 e n, 157 e n
Gioanola, Elio, 107 e n, 122 e n, 129 e nGiuliani, Fulvia, 36nGodoli, Ezio, 50nGoethe, Johann Wolfgang von, 57Grana, Gianni, 14n, 18 e n
Hildebrandt, Friedrich Wilhelm, 89Hull, R.F.C., 144n
Jacob, Max, 31Jacobbi, Ruggero, 46 e nJames, Tony, 100 e n, 150 e n, 151 e nJames, William, 114 e n, 122 e n, 146Janet, Pierre, 150 e n, 151Jarry, Alfred, 11Jung, Carl Gustav, 19, 23, 51, 76 e n, 84 e
n. 91 e n, 143 e n, 144n, 146 e n, 147,148
Kandinsky, Wassily, 34Kewman, Donald, 111nKlimt, Gustav, 37Kubin, Alfred, 37
Laforgue, Jules, 31Lambiase, Sergio, 19n, 45 e n, 49n, 99nLaurent, Emile, 104 e nLautréamont, 31Leadbeater, Charles Webster, 58Lener, Salvatore, 140nLeuret, François, 150 e n

Indice dei nomi 175
Levi, Elifas, 58Levi Bachi, Ida, 153nLévy-Bruhl, Lucien, 140 e n, 141 e n, 146
e nLista, Giovanni, 125 e nLombroso, Cesare, 52 e n, 53, 54 e n, 77,
113 e n, 114 e nLora-Totino, Arrigo, 41 e n, 42 e nLucini, Gian Pietro, 29 e n, 33, 44Lucrezio, 65Luisetti, Federico, 14nLuti, Giorgio, 31 e nLuziani, Luciano, 66 e n, 104 e n, 113, e n
Magamal, vedi Amendola Kühn, EvaMagrini, Liliana, 102nMallarmé, Stéphane, 28, 31, 45, 50, 113Mancuso, Girolamo, 84nManghetti, Gloria, 9, 13 e n, 14nMangoni, Luisa, 52nMara, Oscar, 22n, 116Margozzi, Mariastella, 14 e n, 17nMariani, Gaetano, 107nMarinetti, Filippo Tommaso, 13 e n, 15,
19n, 21, 27, 28, 29 e n, 30 e n, 31 e n, 32,33, 34, 36 e n, 38, 39, 40 e n, 41 e n, 42e n, 43, 44 e n, 45 e n, 49 e n, 50 e n, 54e n, 70 e n, 72, 73 e n, 77 e n, 96 e n, 99e n, 105 e n, 108 e n, 116, 117, 126 e n,127n, 136 e n, 138n
Marpillero, Emma, 36nMartini, Stelio Maria, 36n, 42 e nMarzorati, Angelo, 53Masi, Alessandro, 79nMasini, Ferruccio, 101nMasselon, René, 18nMaury, Alfred, 19, 84, 100 e n, 103Mesmer, Franz, 51Meunier, Paul, 18nMichelangelo, 81, 137Missiroli, Mario, 113 e nModena, Gustavo, 18Moreau de Tours, Jacques, 113Morselli, Enrico, 18, 52Mozart, Wolfgang Amadeus, 113Musatti, Cesare L., 76 e n, 83n
Nalini Setti, Anna Maria, 13n, 46 e n, 125n
Nannetti, Neri, 22nNathan, Ernesto, 53Nazzaro, Gian Battista, 19n, 45n, 49n,
99n, 126 e n, 133 e nNerval, vedi de Nerval, GérardNewton, Isaac, 113Nietzsche, Friedrich Wilhelm, 101 e n,
148 e nNotte, Emilio, 99 e nNotte, Riccardo, 50 e n, 54n
Paladino, Eusapia, 52 e nPalazzeschi, Aldo, 27, 31, 34, 46Paliyenko, Adrianna M., 113 e nPapini, Giovanni, 8, 25, 27, 30, 31 e n, 34,
46, 52 e n, 53, 58, 68 e n, 119 e n, 120 en, 121 e n, 129, 131 e n
Papini, Maria Carla, 11, 12n, 13n, 42 e n,46 e n, 47 e n
Papus (Gérard Encausse), 58Pascal, Blaise, 113Penne, Giovanni Battista, 57nPetrucciani, Mario, 107nPicasso, Pablo, 31Pirandello, Luigi, 56, 57nPiubellini, Enrica, 36nPlacido, Beniamino, 80nPoe, Edgar Allan, 38, 41, 71, 81 e n, 113,
155 e nPolidori, Fabio, 69nPorto, Silvia, 13 e n, 46 e nPrampolini, Enrico, 68Pratella, Francesco Balilla, 33, 38, 99, 131
e n, 155 e nPrezzolini, Giuseppe, 52, 58, 60 e n, 119n
Radestock, Paul, 101, 103Rank, Otto, 18 e nRavazzolo, Antonella, 83nReghini, Arturo, 121, 122nRimbaud, Arthur, 28, 41, 45, 95 e nRobert, Enif, 36nRolland, Romain, 137nRomani, Bruno, 28 e n, 31 e n, 32n, 54n,
76 e nRosà, Rosa, 33, 36 e n, 107nRostand, Edmond, 136Rousseau, Jean-Jacques, 113

176 Indice dei nomi
Russolo, Luigi, 27, 30, 34, 38, 49n, 50n,106n
Saccone, Antonio, 103 e nSaint-Pol-Roux, 11Salaris, Claudia, 12 e n, 30n, 36 e n, 82 e
n, 137nSanminiatelli, Bino, 68Sass, Louis A., 100 e n, 101 e nScattolini, Virgilio, 34, 63n, 65Schiaparelli, Giovanni, 51Schiavina Verdone, Rossana, 129 e n, 130
e n, 132Schiller, Friedrich, 135Schopenhauer, Arthur, 113Schuré, Edouard, 54, 58Schwarz, Lina, 86nSeneca, 113Settimelli, Emilio, 7, 8, 12, 15 e n, 16, 17,
22 e n, 24n, 32 e n, 33 e n, 34 e n, 35 en, 36 e n, 37 e n, 38 e n, 39n, 40 e n, 41e n, 42 e n, 43 e n, 44n, 47 e n, 55 e n,59, 63 e n, 64 e n, 65 e n, 66 e n, 72 e n,73 e n, 75n, 77 e n, 79 e n, 80 e n, 82, 94e n, 96 e n, 100n, 102 e n, 103n, 104 e n,105 e n, 108 e n, 109n, 112n, 116n, 117e n, 119, 121, 123 e n, 127n, 131 e n,132 e n, 136 e n, 145n, 148 e n, 149 e n,152 e n, 154 e n, 159 e n
Severini, Gino, 30, 49n, 50n, 106nSforza, Francesca, 69n, 80nSilvestri Stevan, Giovanna, 91nSimonton, Dean Keith, 113 e n, 115 e nSinnett, Alfred Percy, 57 e nSoffici, Ardengo, 8, 27, 30, 31, 34, 45, 46
e n, 95 e n, 96, 129Somigli, Luca, 14n, 91 e n, 135 e n
Soupault, Philippe, 11Steiner, Rudolf, 11, 17 e n, 18, 53 e n, 57
e n, 58 e n, 74, 75 e n, 84 e n, 85 e n, 86e n, 118, 119n, 135, 136n, 153 e n
Strauss, Johann, 75 e nStrümpell, Ludwig, 89Szasz, Thomas, 111n
Tavolato, Italo, 27Tentori, Tullio, 139nTromelin, 59, 60Tylor Burnett, Edward, 156 e n
Valeria, Irma, 13, 20 e n, 23, 33, 36n, 37 en, 59 e n, 83, 90 e n, 95 e n
Valli, Donato, 80 e nVanden Berghe, Dirk, 45 e n, 47 e n, 48 e nVenna, Lucio, 99nVerdone, Mario, 11 e n, 12 e n, 13, 15 e n,
19 e n, 20 e n, 22n, 24, 33 e n, 34 e n, 35e n, 36 e n, 37 e n, 41n, 43 e n, 47 e n,48, 50, 55n, 58 e n, 74 e n, 75 e n, 81n,82 e n, 93 n, 96 e n, 107n, 108 e n, 111e n, 129 e n, 130 e n, 131 e n, 132 e n,153n
Verlaine, Paul, 28, 113Vivekananda, Swami, 122nVolkelt, Johannes, 89von Haynau, Edith, vedi Rosà, Rosa
Wallace, Alfred Russell, 60Wendel, Georg, 114 e n
Zanotto, Sandro, 13n, 46 e n, 82 e n, 126e n
Zoppi, Sergio, 31 e n, 43n, 44 e n

Indice
Ringraziamenti p. 5
Prefazionedi Gloria Manghetti » 7
Introduzione » 11
1. Il secondo futurismo fiorentino: genesi, protagonisti e peculiarità » 27
2. La “pattuglia azzurra”: in esplorazione » 49
3. Tra istinto e ragionamento: strumenti esplorativi » 63
4. La dimensione onirica » 79
5. Follia e genialità: Sam Dunn è morto di Bruno Corra » 99
6. Dalla visione alla rappresentazione: Il Barbaro di Mario Carli » 135
In conclusione » 159
Bibliografia » 161Opere dei Futuristi » 161Opere sul Futurismo » 165Altre Opere » 168
Indice dei nomi » 173


Finito di stamparenel mese di giugno 2013
per A. Longo Editore in Ravennada Digital Print Segrate