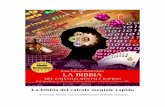Il libro - 3.droppdf.com3.droppdf.com/files/xGigQ/bestie-da-vittoria.pdf · Un libro denuncia che...
Transcript of Il libro - 3.droppdf.com3.droppdf.com/files/xGigQ/bestie-da-vittoria.pdf · Un libro denuncia che...
Il libro
La gente non si rende conto che cos’è correre una tappa di 250 chilometri dopo
venti giorni che sei in sella a una bici, la neve l’acqua il freddo il caldo la febbre la
dissenteria il dolore la fatica. Quando sai che domani devi correre la stessa
distanza e anche il giorno dopo e il giorno dopo ancora, tutto quello che puoi
ingerire lo ingerisci. Non siamo eroi, siamo dei pazzi scatenati, dei coglioni. Gente
che sta in dialisi, che si è bruciata le palle, che è morta per ispessimento della
parete cardiaca. Per un ciclista l’importante è vincere, non pensi mai che ti ritiri,
che ti possono beccare, che ti puoi ammalare, che puoi farti male. Esiste solo la
vittoria.
Quando i direttori sportivi dicono: «Non so niente», mentono. L’ambiente non ti
obbliga a doparti, ti sollecita perché tutti hanno interesse che tu vinca, la squadra
e gli sponsor hanno bisogno del campione, il campione crea un indotto che dà da
mangiare a un sacco di famiglie.
Ogni ciclista sa che tutti si dopano eppure nessuno parla. La verità è che nessuno
di noi pensa di sbagliare, facciamo tutto quello che un ciclista professionista deve
fare. La verità è che tutti si dopano e che tutti lo rifarebbero, la verità per la
società civile è inaccettabile. Come si fa a dire la verità e a essere credibile?
Bisognerebbe accettare l’inaccettabile.
Questa è l’altra faccia del ciclismo, il racconto di quel mondo parallelo fatto di
ipocrisia, interessi e giochi di potere che sta dietro ai colori, ai tifosi lungo le
strade, ai carrozzoni festanti delle grandi gare. Un sistema cannibale di cui tutti
sono a conoscenza, ma di cui nessuno parla, perché tutti hanno troppo da
difendere. Un libro denuncia che chi fa parte del sistema non potrebbe scrivere.
Solo uno che non ha più nulla da perdere, come Di Luca, radiato a vita per doping,
poteva farlo.
L’autore
Danilo Di Luca, ciclista professionista dal 1999 al 2013. In carriera ha vinto 54
gare, tra queste Giro di Lombardia, Amstel Gold Race, Freccia Vallone, Liegi-
Bastogne-Liegi e Giro d’Italia. È stato radiato per doping nel 2013. Oggi è
costruttore di bici a marchio Kyklos.
Alessandra Carati è editor, ghostwriter e formatrice.
Danilo Di Luca
Bestie da vittoria
con Alessandra Carati
BESTIE DA VITTORIA
«Noi siamo quel che facciamo. Le intenzioni, specialmente se buone, e i rimorsi,
specialmente se giusti, ognuno, dentro di sé, può giocarseli come vuole, fino alla
disintegrazione, alla follia. Ma un fatto è un fatto: non ha contraddizioni, non ha
ambiguità, non contiene il diverso e il contrario.»
LEONARDO SCIASCIA, Candido, ovvero un sogno fatto in Sicilia
A Carlo
27 maggio 2013
Sono sdraiato sul letto e guardo il soffitto del bilocale dove vivo dopo la fine del
mio matrimonio. La casa sembra ancora incartata nella plastica, nel frigo ci sono
solo un paio di bottiglie d’acqua.
Osservo i miei piedi, sono nudi, magri, con la pianta stretta e affusolata. Sono
piedi buoni per spingere sui pedali, per imprimere una potenza di 450 watt e far
arrivare la bici su per le salite più dure.
Questo so fare nella vita, correre in bici.
Fuori dalla finestra il Gran Sasso si mostra in tutta la sua bellezza. Spesso mi
chiedono perché non ho lasciato l’Abruzzo per correre in una squadra del Nord.
Non hanno mai visto il Gran Sasso a maggio, non sono mai arrivati in cima a Passo
Lanciano quando scavalli la montagna e il mare è solo una striscia blu che ti lasci
alle spalle e le nuvole sono così vicine che puoi arrivare a toccarle.
Due giorni fa stavo per correre le ultime tre tappe del Giro, poi la comunicazione
della positività ai controlli antidoping. Non ho bisogno di aspettare sentenze
ufficiali, so che la mia carriera è finita.
Non rimpiango niente, ho interpretato il mestiere come fanno tutti gli atleti
agonisti. Il ciclismo di oggi non è più lo sport che ho amato.
Sono stanco della solitudine della menzogna di nascondermi, non di andare in
bici.
Nella vita la bici mi ha dato tutto, è l’unica cosa che mi ha dato tutto.
Un mese fa, domenica 28 aprile, ho partecipato al giro di Toscana. Sono arrivato
sesto, non male per uno che corre la sua seconda gara stagionale.
Mi sono cambiato sul pullman della squadra, ho salutato i compagni, il personale,
i direttori sportivi e ci siamo dati appuntamento il giovedì successivo a Napoli, per
la partenza del Giro d’Italia.
Sono partito da Arezzo verso le cinque del pomeriggio.Guidavo tranquillo,
l’Appenino sfilava imponente oltre il finestrino. Mi sentivo solido come le
montagne.
In auto passavo in rassegna mentalmente il programma per gli allenamenti
successivi, studiavo le tappe che avrei potuto vincere, pensavo a come continuare
a “curarmi”.
La “cura” è la sostanza, dopante e non: vitamine, aminoacidi, integratori,
proteine, disintossicanti, EPO, cortisone, ormoni di vario tipo, corticosteroidi,
testosterone.
Verso le nove di sera sono arrivato a Pescara, avevo fame e sono andato
direttamente al ristorante. Mi sono fermato a chiacchierare con un amico, un
ciclista amatore, abbiamo parlato del percorso del Giro, mi ha chiesto se ero in
forma.
«Sì» ho risposto a dispetto dell’età, dei casini con la squadra, dei miei guai
economici, dell’entusiasmo che era venuto meno. Mi sentivo bene, volevo correre
e volevo ancora vincere.
Verso le undici sono rientrato a casa, ho sistemato la valigia e ho continuato la
cura di EPO che avevo cominciato venti giorni prima. Ho preparato siringa da
insulina, alcol, cotone, laccio emostatico e ho preso la fiala dal frigo. Le fiale sono
da 4.000, 10.000, 20.000 o 40.000 unità. Ho aspirato 500 unità, una microdose,
poi ho rimesso la fiala in frigo. Quindici anni fa, prima dei controlli sull’ematocrito,
qualcuno arrivava a farsi anche 4.000 unità al giorno. Una follia.
Mi sono disinfettato l’incavo del braccio sinistro con l’alcol, ho stretto bene il
laccio per far saltar fuori la vena, ho premuto lo stantuffo e ho fatto uscire aria
dalla siringa, ho poggiato l’ago sull’ombra scura della vena, con decisione ho
bucato la pelle. Mi sono iniettato il liquido e l’ho guardato scomparire dentro il
braccio. Ho fatto tutto con delicatezza, stavo mescolando l’EPO al mio sangue che
scorreva. Ho cercato di tenere la mano ferma per evitare un fuori vena, se muovi
l’ago puoi bucare la vena dall’altro lato e la sostanza finisce sottocute. È
importante che l’iniezione sia endovenosa e non sottocutanea perché in vena
l’emivita del farmaco – cioè la sua concentrazione nel sangue e quindi la sua
rintracciabilità – è di poche ore, mentre sottocute il tempo si allunga.
I ciclisti sono degli eccellenti infermieri, dopo anni di esperienza sul proprio corpo
sono perfettamente in grado di distinguere tra una puntura sottocute e una in
vena, e sanno praticarle entrambe. Per loro bucarsi è molto semplice e poco
rischioso.
Conosco tempi e quantità: per 500 unità di EPO in vena i tempi di rintracciabilità
sono dalle 3 alle 6 ore, più aumenta la quantità più aumentano le ore di emivita
del prodotto nel sangue e nelle urine.
Con 500 unità ero tranquillo, anche fossero venuti la mattina dopo sarei risultato
pulito.
Non avevo mai rischiato in passato e tantomeno quella volta: avevo l’EPO di
ultima generazione, la quantità giusta, la mano leggera e precisa.
Ho aspettato di vedere il serbatoio della siringa vuoto e poi ho sfilato dolcemente
l’ago dal braccio, il tutto è durato al massimo venti secondi. Ho chiuso tutto in un
sacchetto e ho gettato il sacchetto nella pattumiera. Mi sono infilato a letto,
stanco.
La gara era il mio unico pensiero, volevo dimostrare che non ero finito, che a 37
anni avevo ancora qualche carta da giocarmi.
Mi sono addormentato carico per i giorni che mi aspettavano.
Alle sette e mezza è suonato il citofono. Ho aperto gli occhi, appena mi sono reso
conto di dov’ero ho pensato a un controllo a sorpresa. “Ok,” mi sono detto “sono
a posto, ora rispondo e mentre salgono vado a pisciare”, nell’urina avrebbero
potuto esserci ancora tracce e quindi la possibilità di risultare positivo. Ho fatto
tutte queste considerazioni in meno di cinque secondi, automatismi dettati
dall’allenamento a nascondersi.
Ho risposto al citofono con naturalezza, dall’altra parte ha gracchiato una voce
maschile: «UCI, controllo fuori competizione».
«Salite.»
Da regolamento puoi rimandare indietro due controlli, al terzo rifiuto sei
automaticamente squalificato. Non avevo ancora usato nessuno dei due jolly,
potevo mandarli via e non sarebbe successo niente, ma ero tranquillo, i miei
calcoli erano arrotondati per eccesso di qualche ora, 23 + 6 fanno le cinque del
mattino.
Mentre salivano sono andato in bagno e ho pisciato.
Li ho fatti accomodare in soggiorno. Uno dei due ha aperto la borsa, c’erano
siringhe, provette sterili, contenitori per le urine, guanti in lattice. Le stesse cose
che avrebbero potuto trovare nella mia cassetta del pronto soccorso. Erano
cordiali e distanti.
«È un controllo sangue e urina.»
Lo sapevo già, quando vengono a casa è sempre sangue e urina. Continuavo a
ripetermi che dovevo stare tranquillo, anche se una leggera scossa mi
attraversava il corpo. Speravo che non se ne accorgessero.
«Possiamo iniziare col sangue? Non mi scappa.»
«Certo.»
Ha risposto quello più alto. Non si era tolto il soprabito, sedeva sul divano ancora
tutto vestito. Mi è sembrato che, nel parlare, un piccolo sorriso gli avesse
increspato la bocca. Ho aperto e chiuso gli occhi, forse la tensione mi faceva brutti
scherzi. Viviamo come animali sempre sul punto di essere braccati. Quasi vorrei
che mi beccassero, ho pensato e un senso di liberazione mi ha afferrato il corpo. È
subito svanito quando ho pensato al dopo.
Il più basso dei due mi ha fatto sedere e mi ha prelevato il sangue, gli ho dato il
braccio destro, sul sinistro mi facevo l’EPO.
Mi è venuto da sorridere, sapevo che lui sapeva, entrambi sapevano. Eppure il
circo aveva bisogno dei suoi pagliacci.
«Adesso sentirai un piccolo pizzicotto» ha detto e mi ha infilato l’ago in modo
maldestro, ho capito subito che mi sarebbe venuto un livido. Ha riempito una
provetta col sangue rosso, denso. Poi mi ha massaggiato l’incavo del braccio con
del cotone imbevuto di disinfettante: «Sono appena rientrato da un congedo, ho
perso un po’ la mano».
Mi ha fatto un buco grande come una casa.
Sono andato verso il frigo: «Devo bere, non mi scappa».
«Resta a vista.»
È stato il più alto a parlare, i suoi occhi non tradivano nessuna espressione, erano
immobili, vuoti. Lui era il poliziotto cattivo, l’altro quello buono.
Ci ho messo mezz’ora a farmi scappare la pipì. Il tempo si era fermato, il desiderio
che se ne andassero cresceva sempre di più ed era arrivato a riempire tutto il
soggiorno. Chissà se sentivano il peso della mia ostilità.
Verso le otto e mezza finalmente sono riuscito a fare i 100 cc richiesti. Ho firmato
le carte e abbiamo chiuso l’esame con tutte le procedure regolari.
Se ne sono andati poco prima delle nove. Ho guardato il divano vuoto, ho aperto
le finestre, fatto circolare l’aria.
Mi sono vestito, sono andato al bar e ho fatto colazione.Mi sono incontrato con i
colleghi per una sgambata di un paio d’ore.
Tutto regolare, tutto come da programma.
Il 24 maggio 2013, mentre sono in gara, mi comunicano la positività. Lascio il Giro,
lascio il ciclismo, lascio lo sport.
Scopro che hanno modificato il metodo d’indagine, hanno trovato il sistema di
rilevare la presenza di EPO nel sangue fino a 24 ore dopo l’assunzione. I miei
calcoli non sono serviti a niente.
Sono il primo a cui è stato riservato l’onore del nuovo ritrovato, ora la voce si
spargerà e tutti gli altri si regoleranno.
Mi dico che se avessi avuto il medico giusto l’avrei saputo in anticipo.
Se avessi avuto la squadra giusta sarei stato protetto.
Avrei potuto non aprire al controllo, certo.
Non avrei mai potuto non doparmi.
Il doping migliora la prestazione di una percentuale che sta tra il 5 e il 7% e può
arrivare al 10-12% quando sei in un picco di forma.
Se non mi fossi dopato non avrei mai vinto.
Il 5 dicembre 2013 sono radiato a vita dal Tribunale di giustizia sportiva del CONI,
un primato nella storia del ciclismo italiano.
Non mi pento di niente.
Ho mentito ho tradito ho fatto quello che dovevo fare per arrivare primo, ma non
è il punto, il punto è che non ho fatto la profilassi al sistema.
1
Ho gli occhi incollati al televisore.
Dalla finestra che dà sul cortile entra un raggio di sole, illumina le foto appese alla
parete, sono ciclisti che si arrampicano sulla strada, gesti atletici e fatica.
Fuori, appoggiata al muro di cinta, la biciclettina con cui ho disputato le mie prime
otto gare, tutte vinte.
Sullo schermo scivolano le immagini del 67° Giro d’Italia, 1984.
Il divano è piccolo, la cucina a vista, qualche oggetto di poco valore e i mobili fatti
da mio padre, falegname. Alla mano destra gli mancano tre dita, una per ogni
figlio.
Seduti nell’aria calda e ferma, uno accanto all’altra, siamo soli, mia madre e io,
ipnotizzati dall’impresa che si sta per compiere davanti ai nostri occhi: l’ultima
tappa, la cronometro di Verona se la giocano Moser e Fignon. Fignon parte con un
vantaggio di un minuto e ventuno secondi, ma Moser è una fucilata.
Sento la coscia di mia madre incollata alla mia, siamo immobili, quando
compaiono i risultati dei tempi parziali lei non riesce a controllare qualche fremito
involontario, Moser è in netto vantaggio. Infila l’ingresso dell’arena ed esplode il
finimondo. Fignon deve ancora arrivare ma tutti hanno già capito che Moser si è
preso tappa e giro. In un attimo siamo in piedi e gridiamo, gridiamo forte, con i
pugni chiusi alzati verso il cielo.
Dopo scoppierà il putiferio, scriveranno che Moser ha rubato la vittoria, che
l’elicottero della RAI ha frenato il francese e sospinto l’italiano, che le ruote
lenticolari l’hanno avvantaggiato, che per lui hanno annullato all’ultimo minuto la
scalata dello Stelvio.
Ho otto anni e sono così lontano dall’immaginare trucchi, veleni, guerre intestine.
Per me la bici è tagliare l’aria con la faccia, è vedere la linea dell’arrivo scorrere
sotto la ruota.
Moser imbraccia il trofeo e mia mamma scoppia a piangere. La guardo da sotto,
non ho mai visto piangere un adulto, soprattutto uno dei miei genitori. Le afferro
la gonna e tiro forte: «Ma’, stai a piangere per Moser? Allora mo’ che vado io al
Giro e lo vinco tu che fai? Svieni qui?».
Abbassa gli occhi, mi prende il viso tra le mani e ride, poi si asciuga la faccia con il
grembiule, non immagina che da quel giorno avrei inseguito il Giro, avrei fatto di
tutto per tagliare il traguardo ed entrare nell’albo d’oro.
Quando sei un ciclista professionista passi 330 giorni all’anno in sella a una
bicicletta, tra gare e allenamenti. Ogni giorno consumi tra le 5.000 e le 7.000
chilocalorie – il consumo medio di una persona normale è tra le 2.000 e le 2.500.
Per capire la fatica di un ciclista gli devi guardare le mani, sono scarnificate, sotto
la pelle in filigrana puoi intuire nervi e tendini. Tutto il suo corpo è così, asciugato
nella ricerca del rapporto più spinto tra peso e potenza.
Vincere poi è un’altra questione, una combinazione di fattori: meticolosità,
carattere, senso tattico, classe, determinazione, fantasia. Destino.
Oggi peso 69 chili per 170 centimetri, quando ho vinto il Giro d’Italia ne pesavo
61.
Oggi sto anche venti giorni filati senza salire su una bicicletta.
2
Nel ’95 passo da juniores a dilettante. Ho 19 anni e corro con gente di ogni età,
anche ex professionisti. Si fanno di tutto.
Quelli che battevo con facilità mi sfrecciano accanto, sono dei bolidi. “Come cazzo
è possibile?” continuo a ripetermi mentre li vedo sfilare uno a uno con le facce di
chi sta facendo l’uscita della domenica. Io fatico come un dannato, sudo, entro in
lattosi1 e i battiti mi salgono a centottanta. Non mollo, anche quando mi staccano
e capisco che non ne ho più.
Sono stato un bambino prodigio e la mia mente si è abituata a sentire la vittoria
come qualcosa che sta sempre a portata di mano.
A tre anni mi metto in sella a una bicicletta e, dopo aver osservato bene mio
fratello Aldo che ne ha tredici, provo a fare il surplace. Il surplace è quando stai
fermo in equilibrio sulla bici senza appoggiare i piedi a terra. È come tenere ferma
l’auto in salita giocando con frizione e acceleratore.
Mi riesce facile come respirare. Aldo non ci crede.
Da piccolo sono indiavolato e faccio di tutto: gioco a calcio, corro a piedi, nuoto,
scio, vado con lo skateboard, e tutto mi riesce bene. Le cose cambiano quando a
otto anni mi regalano la prima bici da corsa.
Me la compra mio padre, è usata e me la rivernicia tutta: «Di che colore la vuoi?».
«D’oro.»
Mi guarda.
«La voglio d’oro.»
Mi accarezza la testa e mi sorride, è saldo come una quercia.
Quando me la restituisce tutta scintillante, vado sotto la salita che c’è dietro casa,
mi alzo sui pedali e parto. Muovo la bici a destra e a sinistra in modo che
controbilanci il mio peso, il corpo sa già come fare, sa tutto. In poche mosse
raggiungo una perfetta sincronia, io e lei siamo tutt’uno.
Mi sono detto: “Questo è il mio sport”.
Continuo a fare il resto ma la bici è la mia cosa speciale.
Da quel momento non ci sono state più feste di compleanno, comunioni, sabati
pomeriggio con gli amici, niente di niente, solo la bici.
Da piccolo ero timidissimo, avevo paura di parlare con le persone. La presenza
degli altri mi faceva sudare, non mi sentivo adeguato, provavo il disagio di non
essere mai al posto giusto. La bici mi ha dato coraggio, mi ha dato una carta
d’identità con cui presentarmi al mondo. Lo sforzo la fatica l’ostinazione non
erano niente, alle gare ero qualcuno.
Mia madre ripete sempre che la distruggeva vedermi correre, arrivavo sul
traguardo che non riuscivo a parlare, ero stremato, dovevano tirarmi giù a
braccia. Quando facevo le discese e lei mi guardava dalla tv di casa, se ne andava
in corridoio dalla paura.
Per capire cosa significa andare in discesa, basta prendere una bici e provare a
venire giù a 40, 50 chilometri all’ora senza toccare i freni. Già così si ha una buona
sensazione di quello che può succedere. Ecco, noi scendiamo a 60, 70, 80
chilometri con punte di 100, la strada ti viene incontro in un modo violentissimo.
Una cosa da perdere la vita.
Per non farsi male c’è bisogno di una lucidità estrema, c’è bisogno di essere affilati
e precisi come una lama, freddi. E non puoi avere paura.
In discesa andavo come un pazzo, era l’unico modo di correre che conoscevo,
l’unico che mi avrebbe permesso di vincere.
Scalpito per gareggiare, la bici è una fissazione, una malattia.
Mio nonno è stato un ciclista amatoriale, abbiamo la casa tappezzata di sue foto
con il numero sulla schiena e lo sguardo saettante. Vorrebbe che almeno uno di
noi tre seguisse le sue orme. Massimo, mio fratello di mezzo, non ne vuole sapere
e si mette a fare il maratoneta, mentre Aldo lo accontenta.
Sono piccolo, in mezzo alla folla assiepata lungo l’arrivo gli adulti spingono e si
spintonano, mio nonno mi solleva e mi mette in spalla così da permettermi di
vedere i corridori che tagliano il traguardo. Arriva il primo, esausto, il viso
smangiato dallo sforzo, appena sfreccia sulla linea dell’arrivo stacca le mani dal
manubrio e le alza al cielo, i suoi occhi in un secondo si fanno vivi e grandi, tutta
l’energia rimasta si concentra in un urlo bestiale che scarica a terra la tensione, il
desiderio, l’adrenalina. In un lampo so cosa voglio, più di ogni cosa al mondo
voglio essere al suo posto, il mio corpo coperto di brividi e rabbia agonistica.
A qualche decina di metri lo segue il gruppetto dei fuggitivi, Aldo non c’è, lo cerco
con lo sguardo, non lo trovo. Spingo gli occhi più in là, fino in fondo al rettilineo
che precede l’arrivo, eccolo, sono in due, sedicesimo e diciassettesimo posto. Ora
sprinta con quell’altro, penso, e invece lui che fa? Resta dietro, lascia che l’altro
faccia la volata e gli si mette a ruota. Arriva diciassettesimo.
Nonno mi posa a terra, mi prende per mano e ci facciamo largo per raggiungere
Aldo, lo vedo, scende dalla bici e dà una pacca sulla spalla all’avversario che l’ha
battuto. Lascio la mano di mio nonno e mi scaravento contro di lui, tiro un calcio
alla ruota: «Manco la volata fai! Cosa corri a fare?».
Sono arrabbiatissimo, non per il diciassettesimo posto, sono furioso perché non ci
ha nemmeno provato, perché ha mollato prima di provarci. Aldo è senza fiato per
la fatica, mi guarda con gli occhi sgranati e non capisce, so che non capisce.
«Ma che vuoi? Non sai di che parli, perché non ci provi tu?»
«L’anno prossimo mi metto a correre e ti faccio vedere io come si fa.»
A otto anni disputo la mia prima gara a Picciano, provincia di Pescara. Mi allena
Mario Di Nicola, l’uomo che mi ha messo in bici e mi ha insegnato come starci.
Il circuito è tutto in paese, due giri su strada. Fa parte delle gare nazionali. Anche
se è il mio esordio, non corro in G1, corro direttamente in G2, con i ragazzi più
grandi.
Sono emozionatissimo, il cuore mi batte forte.
Mario mi accompagna a fare il controllo rapporti della bici e poi alla partenza, lì
mi lascia da solo: «Mo’ quando danno il via, tu parti e vai come sai fare, come fai
sempre in allenamento». Ha il potere di farmi sentire che posso sconfiggere
qualsiasi drago.
Scatta il segnale, sono così agitato che non riesco a infilare il piede nel
fermapunte, non parto. Gli altri sono andati tutti.
Su un circuito del genere che dura massimo 3 chilometri, se parti per ultimo hai
già perso. Un altro bambino avrebbe pianto, avrebbe buttato la bici a terra e si
sarebbe ritirato, ma io non ci penso nemmeno, non voglio perdere.
Mi fiondo a testa bassa e pedalo come un matto, ci metto tutta la forza che ho,
tutta la volontà, l’ostinazione dei miei otto anni. Li rimonto uno a uno. A 500
metri dall’arrivo, a metà dell’ultimo giro supero quello che sta in testa e lo stacco.
Non ci credo nemmeno io. Taglio il traguardo. All’arrivo mi aspetta Mario. Alla
fine di una gara non si spendeva mai in complimenti, faceva solo delle grandi
cazziate quando perdevi. Invece questa volta mi viene incontro, mi prende dalla
bici e mi solleva in aria, mi fa festa davanti a tutti i compagni, anche quelli più
grandi. Sono così felice che mi tremano le gambe, a stento riesco a trattenere la
pipì. Ancora adesso ricordo il calore e l’intensità di quel momento. Mia madre
tiene la coppa sul ripiano più alto del soggiorno, 29 aprile 1984, Picciano.
È Mario a insegnarmi tutto sulla bici: stare a ruota, fare le volate, stare in gruppo.
Già vede i miei possibili difetti e cerca di correggerli alla radice. Mi urla sempre
perché in discesa e in pianura non tengo le mani sulla parte inferiore del
manubrio: «Dani’, mani basse sulla bici! Quante volte te lo devo dire?». Ha
ragione, si ha più controllo, più stabilità e si è anche più aerodinamici.
Imparo a impennare. Lo faccio talmente bene che Aldo prima di ogni gara mi fa
interi servizi fotografici: faccio qualche metro su una ruota sola senza mani,
impenno quasi da fermo e resto in equilibrio per una manciata di secondi.
Sono dotato e sono anche vanitoso, esibizionista. Mario se ne accorge e comincia
a chiamarmi “il polletto Valle Spluga”. Deve tenere a bada il mio carattere e non è
semplice, perché vinco facile e spesso. Ogni volta trova qualcosa da
rimproverarmi ed è la salvezza per me, dà una misura al mio ego strabordante.
Mi bastona sempre sulla tattica, che negli anni diventa il mio punto di forza: «Ecco
che arriva il polletto Valle Spluga! Eh bravo il pollo, sei partito troppo presto a fare
la volata».
Oppure: «Sei partito troppo tardi a fare la volata».
Oppure: «Dovevi staccarlo prima sullo strappetto».
«Dovevi anticiparlo in curva.»
«Dovevi metterti a ruota e poi anticiparlo.»
Mi martella per nove anni, dagli otto ai sedici, e mi regala gli insegnamenti più
preziosi.
Dopo Picciano disputo altre diciannove gare nazionali – venti è il numero massimo
a cui si può partecipare –, ne vinco diciassette e nelle restanti due mi piazzo
secondo.
Mia madre mi ha raccontato che, quando passeggiava prima delle gare, c’era
sempre qualche bambino che vedendomi si metteva a piangere: «Non voglio più
correre, ci sta pure Di Luca oggi». Piangevano perché sapevano che vincevo.
Sembravo un angelo, piccolino con i boccoli lucidi e biondi, ma avevo dentro una
cosa che mi mangiava, una smania che era più forte di ogni vergogna, di ogni
timidezza, di ogni paura. Era un bruciore micidiale, che si spegneva solo quando
tagliavo il traguardo.
A una gara capita che c’è un ragazzino bravo, un certo Simone. In giro ho sentito
parlare di lui ma non ci ho mai corso. Ha la mia stessa età, due gambette sode e
scattanti e mi passa di quindici centimetri.
Sono seduto sul bagagliaio aperto dell’auto, mia madre mi sta aiutando a vestirmi,
pantaloncini e maglietta da corsa, calze, scarpette.
«Dani’, hai visto che oggi ci sta pure Simone?»
Punta al centro delle mie paure e va a segno. Mi sono sempre chiesto da chi ho
ereditato una certa durezza, un senso di sfida nei confronti della vita e la testa
coriacea. Oggi so che è stata lei, mia madre ha sempre voluto che vincessi quanto
l’ho voluto io.
«Che me n’importa a me.»
Mi libero dalla sua presa e finisco d’infilarmi da solo la maglietta. Volto lo sguardo
dall’altra parte, per orgoglio, perché non voglio che mi legga un’incertezza negli
occhi, perché non voglio deluderla e non voglio ammettere di aver paura, perché
ho il dubbio che lei possa pensare che non sono il più forte. La paura, il dubbio
sono le uniche cose che si possono mettere tra un corridore e il traguardo.
Perdo, arrivo secondo dietro Simone.
A fine gara, mentre mia madre mi spoglia, non muovo un dito per aiutarla, sono
incazzato nero.
«Dani’, ma che c’hai? Alza il piede che così non ti riesco a togliere la scarpa.»
Sferro un calcio di protesta e le sfioro il viso. Mi guarda nello stesso modo in cui
guardo gli avversari in gara, cosa che mi ha fatto guadagnare il soprannome di
killer.
«Non ti do uno schiaffo solo perché c’è gente intorno.»
«È colpa tua se ho perso».
«Ah sì? Questa è bella, e perché?»
«Tu mi hai detto di Simone, tu mi hai fatto venire la paura.»
Ho bisogno di convincermi che quel sentimento oscuro e pericoloso non nasce in
me, non me lo porto dentro come qualcosa che può esplodere all’improvviso. Ho
bisogno che qualcuno se lo carichi sulle spalle.
L’istinto di mia madre non fallisce, la costruzione di un campione nasce
prestissimo in famiglia, dalla smisurata fiducia che un genitore è in grado di far
crescere in un figlio.
«C’hai ragione, me ne dovevo stare zitta.»
Ecco, ora tutto è tornato in ordine. La sera, prima di andare a dormire, mi
accoccolo vicino a lei per sentire il suo corpo caldo premere contro il mio,
un’infusione di coraggio.
Quando gareggi le domeniche sono interamente dedicate alle corse, si preparano
cibo vestiti e bici, si carica l’auto, si parte per fare i chilometri che separano dalle
gare, che possono essere provinciali regionali o interregionali.
Quando inizio a competere, la mia famiglia si spacca: mio padre segue Aldo, che
poi smetterà nei dilettanti, e mia madre segue me. Per diversi anni, forse i più
importanti nella formazione del carattere agonistico, mia madre è un mentore,
senza saperlo. Sento che ha un’incrollabile fede nella mia forza fisica e mentale,
ha la capacità di sopportare stress e fatica senza darlo a vedere, una
determinazione emotiva fuori dal comune.
Senza intenzione e per contatto queste sue qualità, indispensabili per un atleta
professionista, scivolano dentro di me e formano il senso di un controllo totale
sulle situazioni.
Alle gare ascolto le conversazioni che ha con le altre madri: «Ma che cosa dai da
mangiare a tuo figlio?».
«Niente, le penne in bianco alla mattina.»
«Eh sì, e com’è che vince sempre?»
«È lui, questo bambino è proprio forte.»
In me cresce un senso di straordinarietà, mi sento un superbambino invincibile.
Mia madre ha la capacità di passare sopra alle ansie, di normalizzarle e toglie loro
la possibilità di interferire con la mia prestazione. Quando Mario viene a
prendermi a casa prima delle gare e lei vede che sono spesso in bagno per
l’adrenalina o per l’agitazione, non dice nulla, non mi chiede se va tutto bene, se
ho paura, perché me ne sto al bagno. Fa come se l’ansia non esistesse e così
imparo a lasciarla a casa, a non portarmela alle corse.
Quando divento più grande, continua a rafforzarmi nel conflitto, mi si
contrappone in tutto, soprattutto sulla scuola: decide che mi devo per forza
diplomare. Frequento le superiori perché mi obbliga ma mi rompo le palle, il mio
unico pensiero è la bici. Secondo me campioni ci si nasce, tutto viene facile, poi ci
vogliono dedizione ed esperienza certo, ma solo quando sei sulla tua strada ti
senti a posto con il mondo.
Comincio a diventare insofferente, scalpito per avere la mia indipendenza: «Tanto
anche se non sono promosso, sono campione».
«Finché sei in casa mia fai quello che ti dico io, non m’interessa se sei campione.»
Uscivo in bici tutti i pomeriggi fino alle sei e non aprivo un libro.
«Ricordati che se non prendi il diploma non corri.»
Nella nostra guerra privata facevo piccole prove di resistenza, mi tempravo nel
tenere testa al mio talento e alla sua cocciutaggine.
A scuola la professoressa di storia dell’arte mi metteva sempre 2, 3, 4 perché non
studiavo. Un giorno mi ha umiliato davanti a tutti: «Ma che ci vai a fare in
bicicletta? Pensa a studiare che con la bici non combini niente!».
Dentro di me ho detto: “Te lo faccio vedere io cosa combino con la bici”.
Quindici anni dopo, quando ho vinto il Giro, ci siamo rincontrati e mi ha fatto un
sacco di complimenti, ho sorriso e li ho accettati anche se ricordavo molto bene
quando mi aveva messo in ridicolo davanti a tutti.
La mia famiglia è semplice, mio padre fa il falegname da quando aveva nove anni,
conosce l’italiano poco e male. È un uomo taciturno, di una smisurata gentilezza,
un lavoratore instancabile. Tutto quello che c’è in casa è il suo sudore, in famiglia
ci siamo sempre sudati tutto.
Il mio talento è un vulcano, un’esplosione tale da non crederci. A quattro anni
avevo una grinta e una determinazione che potevano cambiare il mio destino. E in
questo scarto di traiettoria ho trascinato tutta la famiglia, ero il bambino d’oro, il
minore, il più coccolato, il più dotato.
Diventa evidente quando gareggio nella categoria allievi, ancora di più negli
juniores. Ho diciotto anni, corro con quelli più grandi di me e vinco tanto. Vinco
tre internazionali per tre domeniche di fila, dove siamo in duecento, i migliori da
tutta Italia.
Sono uno della Polisportiva di Spoltore, non ho una società alle spalle, non mi
conosce nessuno, mi presento alle gare in mezzo a campioncini blasonati del Nord
Italia che hanno già dimostrato di saper vincere. Parto in totale svantaggio e allora
faccio l’unica cosa che so fare, corro da arrogante, mi metto in vista appena
posso, attacco sempre anche quando so che tutto è perduto. Sono scatenato.
A Montemagno, vicino ad Asti, mi permetto di strappare la vittoria a Valentino
China, giovane promessa del ciclismo italiano. Lo faccio di forza, di rabbia, di
disperazione, con una bici senza pretese mi metto a picchiare sui pedali a un
chilometro e mezzo dall’arrivo in salita. Nessuno pensava che ce l’avrei fatta, che
avrei dato un distacco così grande da essere imprendibile.
A fine gara una televisione locale va a cercare China e lo intervista, gli passo
accanto in bici e mi fermo, voglio essere inquadrato, comparire, ho una gran
voglia di mostrarmi. Valentino è ancora incredulo ma sfoggia una disinvoltura
notevole nel parlare e attribuisce il suo secondo posto a una sua défaillance non
alla mia forza. L’operatore si ferma su di me, ho ancora la bici tra le gambe, il
giornalista è costretto a rivolgermi qualche domanda. Quando mi presenta sbaglia
il cognome e poi prosegue riassumendo in modo impreciso l’andamento degli
ultimi chilometri di gara. Io rispondo, puntualizzo, sottolineo che questa è la mia
terza vittoria consecutiva. Insomma in un minuto e mezzo riesco a risultare il più
antipatico della terra. Non ho nessun equipaggiamento adeguato per relazionarmi
con i media, nessuna furbizia.
Davanti alla telecamera non sono nessuno, sono uno con un marcato accento del
Sud che si presenta a correre in una squadra sfigata e si mette il gel sui capelli2.
Quando sono entrato nell’ambiente, il divario tra Nord e Sud Italia era abissale. So
che oggi nel mondo globalizzato può sembrare ridicolo che la provenienza conti,
ma il ciclismo è un piccolo ecosistema e le relazioni che sei in grado di coltivare
fanno la differenza. Il ciclismo è un fatto lombardo, veneto, friulano, emiliano,
toscano. I lombardi sono uomini di carattere e personalità che hanno vinto grandi
giri, i toscani sono scalatori, i veneti gregari, cioè più in sottordine che in
comando. La geografia conta, e molto. Le squadre, gli sponsor, i corridori nascono
al nord e se non ci nascono ci si trasferiscono. Nibali è siciliano, si è formato in una
squadra toscana e ora vive a Lugano. Lo stesso Figueras, il mio grande antagonista
nei dilettanti, è napoletano ma correva in una squadra lombarda. Essere defilato
geograficamente significa essere tagliato fuori dalle relazioni che ti permettono di
costruirti una visibilità, un’immagine, gli amici giusti.
Tutto questo non lo sapevo, vincere era così facile che non mi ha mai sfiorato
l’idea di dover sacrificare la mia vita per poter continuare a farlo. In Abruzzo stavo
bene, i miei affetti erano lì, le strade su per il Gran Sasso e la Majella, Carlo
Santuccione il mio medico curante.
A Pescara ero adorato come un reuccio.
Ho pensato che essere un campione bastasse e mi sbagliavo, se potessi tornare
indietro mi trasferirei in Svizzera.
1. L’eccesso di acido lattico intossica i muscoli, porta a una richiesta sempre
maggiore di ossigeno alle fibre e a un successivo rallentamento della contrazione
muscolare, fino a giungere al crampo. Provoca uno stato di estrema fatica e
sofferenza fisica.
2. Il filmato della vittoria e dell’intervista in coda è presente in rete
https://www.youtube.com/watch?v=MewmPzDNxZ0
3
Comincio a farmi qualcosa a ventuno anni, al terzo anno da dilettante, tardi
rispetto agli altri. Prima Santuccione non vuole.
«Carlo, com’è? Non vinco più.»
«Aspetta, stai tranquillo.»
«Sì, ma faccio una fatica del diavolo.»
«Non ti preoccupare.»
«Quelli mi passano.»
«Devi pazientare.»
Mi spiega che se comincio troppo presto mi brucio perché il fisico non è pronto,
non è maturo. Prima devo mettere a punto il motore, farlo girare liscio altrimenti
poi, quando metto la benzina a cento ottani, scoppio subito. Carlo non mi avrebbe
mai fatto fare una cosa pericolosa, ha sempre vigilato sulla mia vita come un
padre.
Tra noi è stato amore a prima vista. Mia madre mi ha portato da lui quando avevo
otto anni. Aveva fama di essere un medico sportivo competente e scrupoloso,
aveva in cura moltissimi atleti della zona e non solo. Mi ha sottoposto a diversi
test, qualche esame, prove sotto sforzo. Poi mi ha fatto sedere sul lettino e mi ha
parlato a lungo, non come si parla a un bambino, come si parla a un grande atleta:
«Tu sei molto bravo».
Lo guardavo e sentivo qualcosa di intenso che ci legava.
«Sei molto forte.»
Una fiducia totale, incondizionata.
«C’è bisogno di lavorare parecchio, sei pronto?»
«Sì.»
Risposi in modo semplice e senza nessuna esitazione, non avevo scelta, il mio
destino era quell’uomo in camice bianco.
I primi anni mi ha lasciato libero di vivere la bici e le corse come un gioco poi,
quando ho iniziato a farmi il fisico da ciclista, mi dava delle vere e proprie tabelle
di allenamento. Per esempio il giovedì dovevo fare la distanza, cioè correre più
chilometri degli altri giorni. La distanza è fondamentale perché arriva a
trasformare il tuo fisico fino a fargli correre i 200-250 chilometri della gara.
Il venerdì mattina andavo da lui per la visita, mi toccava le gambe: «Perché ne hai
fatti 150 se ti ho detto che ne dovevi fare 180?».
Capiva quanti chilometri avevo fatto solo toccandomi le gambe e non succedeva
una volta, succedeva sempre.
Io sbiancavo: «Abbiamo visto che faceva brutto tempo e siamo tornati indietro».
E lui s’incazzava: «Non me ne frega niente, tu devi fare i chilometri che sono scritti
sul programma, non uno di più non uno di meno».
Mi ha costruito come atleta e come uomo, mi diceva come allenarmi, cosa
mangiare, come dormire, come comportarmi con le persone che avevo intorno.
Credeva in me e io vincevo.
Si era fatto un’idea precisa su dove potessi arrivare e su come farlo: «Non hai il
fisico pronto, non puoi vincere il Giro a 22-23 anni sennò scoppi, finisci. Dobbiamo
fare un programma per cui arrivi a vincere il Giro a 29-30 anni. Il primo anno fai
una settimana e ti ritiri, il secondo fai dieci giorni, vinci la tappa e torni a casa, il
terzo fai due settimane e ti ritiri e poi pensiamo alla vittoria. Ci devi arrivare per
gradi, lascia al corpo il tempo di maturare».
Non mi avrebbe mai fatto rischiare, dovevo arrivare fisicamente preparato
altrimenti mi sarei consumato per lo sforzo e addio carriera. Mi diceva che tra i 30
e i 34 anni sarebbe stato il momento per raccogliere, Giro e Tour sarebbero stati
miei.
Mi parlava anche dei farmaci, come non farlo? Eravamo alla fine degli anni ’90, il
decennio in cui lo sport professionistico ha conosciuto l’impiego più sconsiderato
e folle e suicida del doping. Il decennio dell’EPO, fino a una certa soglia tollerato e
prescritto.
Carlo ha una visione profondamente umana della sua professione, per lui gestire
un atleta significa capirlo e rispettarlo. Ognuno di noi è strutturato in un modo
diverso, se prendi una persona e vedi che ha i polpacci grossi e i quadricipiti
piccoli significa che biomeccanicamente fa un lavoro diverso da chi ha i
quadricipiti grossi e i polpacci piccoli, uno cammina sulle punte l’altro cammina
sui talloni. Per il primo andranno bene dei lavori che non funzionano per il
secondo.
L’atleta è un essere umano, va capito studiato nutrito allenato, gli devi dire come
mangiare, a qualcuno il cappuccino fa andare forte a un altro fa andare piano, a
uno lo spaghetto fa male per un altro è benzina, gli devi dire se dormire di più o di
meno, come lavorare.
Interpretare un atleta, leggerlo è la cosa più difficile. Soltanto uno stupido può
pensare che basti l’EPO per diventare un campione. Chi è un atleta? Come si
muove? Come dorme? Come recupera? Come digerisce? Ha problemi in famiglia?
Come sta con la mamma? Come sta con la fidanzata? Come sta economicamente?
Un atleta può diventare grande se il suo medico, il suo preparatore lo mettono al
top delle condizioni per agire. E ci vogliono disponibilità, affetto, competenza.
Carlo si alzava alle due di notte e pensava alla fisiologia, ai dosaggi e poi verificava
con me sul campo, vedeva se sotto sforzo producevo più o meno cortisolo, se
andavo in deficit di qualcosa e mi cambiava alimentazione, tabelle, programma di
gare. Mi seguiva sul Passo Lanciano in auto e si segnava tutto: tempi parziali e
intermedi, frequenza di pedalate, rapporto con cui affrontavo la salita, frequenza
cardiaca, lattato alla partenza e alla fine. Migliaia di atleti monitorati, trent’anni di
test documentati.
È semplicistico e superficiale riportare tutto alla farmacia. È questo che le persone
fuori dall’ambiente faticano a capire. L’asino bombato è sempre un asino, il
purosangue è sempre un purosangue. Pantani dopato e tutti gli altri dopati,
Pantani li massacra. Pantani senza niente e tutti senza niente, Pantani li massacra.
Ci sono sport dove non puoi improvvisare: ciclismo, sci di fondo, maratona. Se
non ti alleni, se non hai un’alimentazione corretta, se non vai a dormire presto,
non bevi, non fumi, se non sei perfetto, se come diciamo noi non “fai la vita”, non
hai i risultati. E questa regola vale anche per chi è dotato di un talento speciale. Il
talento non si esaurisce nelle doti fisiche, l’atleta fisicamente dotato ma senza
testa non arriva a grandi risultati, è un corridore normale.
Con le gambe collegate al cervello ci nasci, chi è scollegato non ce la fa, puoi
migliorare ma non ti elevi.
Quello che ti fa vincere è l’allineamento mente corpo.
Forte personalità, forte convinzione, forte autostima.
Avevo bisogno di sentirmi dire che ero il migliore e Carlo lo sapeva e lo faceva, me
lo diceva in continuazione: «Sei meraviglioso, sei il più bravo, sei un campione». A
volte mi faceva sdraiare sul lettino e mi toccava le gambe: «Sei forte, ma stavolta
non vinci».
Aveva quest’abitudine di toccarti le gambe e pronosticare la vittoria.
Nell’ambiente noi corridori abruzzesi lo avevamo soprannominato “il Mago”:
«Che ti ha detto il Mago? Ti ha toccato le gambe?».
«Sì, stavolta niente, butta male.»
Ci beccava sempre. Ovviamente non era magia, ma intuito fisiologico formidabile.
Non stava scritto su nessun libro di testo, era qualcosa a cui era arrivato
attraverso la pratica e l’osservazione, lui lo chiamava “il segno di Santuccione”. Un
giorno me l’aveva spiegato, se prendi un atleta lo stendi sul lettino e gli fai fare
una contrazione muscolare mentre gli senti il polso, nel 90% dei casi non c’è
nessuna variazione della frequenza cardiaca. In qualcuno, invece, per un attimo il
battito scompare, si ferma e riparte. In quell’attimo le fibre muscolari si
contraggono in perfetta sincronia e il flusso arterioso si blocca. Il muscolo
funziona come una spugna: si imbeve di acqua, si strizza, si rilassa. A volte la
spugna si strizza all’unisono, significa che le fibre sono talmente in sintonia che il
muscolo riesce a spremersi completamente e lì il battito s’interrompe. È come con
il tiro alla fune tra due gruppi, da una parte persone deboli e dall’altra persone
forti. Se il gruppo dei deboli tira perfettamente in sincrono e tra i forti c’è chi tira
mezzo secondo prima o mezzo secondo dopo, vincono i deboli.
Questa cosa succede a pochi atleti e quando accade, la qualità della prestazione
può essere stellare. È una dote superiore, un regalo che ti fa la natura.
Carlo ti metteva sul lettino, ti palpava il ventre, ti vedeva le spalle, ti toccava le
gambe. Ti teneva venti minuti e poi ti diceva: «Non vai un cazzo».
Oppure: «Vai forte».
Oppure: «Stai migliorando».
«Hai fatto troppa palestra e hai le gambe intossicate.»
«Ti stai allenando bene.»
«Ti stai allenando male.»
Ti visitava e prevedeva l’imminente futuro agonistico.
Al terzo anno da dilettante mi prendono nel Caneva, una squadra di Pordenone.
Lascio casa e mi trasferisco in Friuli. Inizio la preparazione, sto sempre in ritiro,
faccio tutto per bene, anche se il posto proprio non mi piace. Vivo in un albergo
mezzo vuoto e non lego con nessuno, dopo gli allenamenti me ne sto sempre per
conto mio. In più il tempo fa schifo, grigio e piovoso cinque giorni su sette. Mi
sento Jack Nicholson in Shining, sento che come lui potrei impazzire.
Quando sto in Abruzzo, siamo un bel gruppo, 14-15 corridori. Usciamo insieme la
mattina, parliamo e la fatica passa. In Friuli mi sento depresso, il luogo, la gente,
tutto mi sembra ostile.
Scendo a casa per disputare una corsa minore, con l’intenzione di fermarmi un
paio di settimane per poi affrontare le gare più importanti. Vado da Carlo.
«Carlo allora?»
«Allora cosa? Stenditi sul lettino.»
Mi ausculta, mi guarda l’interno degli occhi, mi pesa, mi misura la massa grassa
con il plicometro. Poi passa al “segno di Santuccione” e mi tocca le gambe: «Stai
benissimo. Sei uno splendore».
Lo guardo con aria interrogativa, in attesa.
«Ora si vede se sei davvero un corridore o se vai a lavorare.»
«Quindi?»
«Si comincia.»
Le persone normali pensano che l’atleta professionista, a un certo punto della
carriera, si trovi a un bivio e decida se fare o meno uso di sostanze. Le cose non
stanno affatto così, non c’è un confine netto che separa il prima e il dopo. Il vero
spartiacque è quando scegli di diventare un corridore, quando capisci che andare
in bici è il tuo lavoro. A quel punto l’unico obiettivo è puntare alla vittoria, che tu
sia un gregario o un campione. Quando il ciclismo è il tuo mestiere, non pensi alla
posta in gioco, tutti i confini si spostano ed entri in un ambiente dove le regole e il
sistema di valori sono ribaltati rispetto a quelli del mondo reale.
A dicembre i direttori sportivi fanno il calendario, decidono chi è il capitano, chi
lavora per lui, chi corre e in quali gare.
«Questa settimana bisogna andare, devi essere pronto. Preparati.»
Quando ti dicono “preparati” ti stanno dicendo “dopati”. È un invito a fare quello
che devi fare per ottenere i risultati, altrimenti non ti fanno correre e ti rovinano,
perché non hai ritmo non hai fondo non hai niente. Alla prima gara fai 150
chilometri e ti ritiri, non reggi lo sforzo fisicamente. Se invece fai tutto quello che
devi ti danno la possibilità di emergere per metterti in mostra agli occhi di un’altra
squadra che l’anno successivo potrebbe offrirti di più.
I ciclisti non sono un bene societario come i calciatori, non hanno un cartellino
che si può vendere o comprare. Hanno un contratto d’ingaggio, possono scegliere
quando andarsene e possono essere lasciati a casa con la stessa facilità. Quando
un ciclista viene trovato positivo è immediatamente scaricato dalla società che
non è tenuta a corrispondergli il resto dello stipendio, anzi si rivale su di lui per
danno d’immagine, arrivando a chiedergli fino a 100.000 euro di risarcimento.
In questo sistema gli sponsor hanno bisogno di risultati per far fruttare gli
investimenti, i direttori sportivi hanno bisogno di risultati per tenersi gli sponsor e
i corridori hanno bisogno di risultati per strappare un contratto.
Il ciclista passa da dilettante a professionista per 35.000 euro l’anno, fa le cose
come vanno fatte, vince tre, quattro corse importanti e l’anno dopo arriva a
300.000, fino ai 4-5 milioni dei corridori al top. Certo non tutti i somari diventano
cavalli, devi avere qualcosa di molto buono di tuo.
Quando mancano venti giorni alla gara il DS ti chiede: «Come stai?».
«Così così.»
«Mettiti a posto.»
Significa che devi stare a posto coi valori del sangue. Nel momento in cui ti
beccano non sa più niente nessuno. Ti hanno trovato positivo, sei una testa di
cazzo, un figlio di puttana, hai rovinato la squadra, ti cacciano ti licenziano ti
chiedono i danni.
Quando i direttori sportivi dicono: «Non so niente», mentono. Sono corridori
cresciuti con la cultura dell’aiutino, della farmacia e l’hanno tramandata, traggono
un profitto dallo stato delle cose perché così la squadra vince e loro guadagnano
prestigio, premi, soldi.
L’ambiente non ti obbliga, ti sollecita perché tutti hanno interesse che tu vinca,
che si crei il personaggio con la sua risonanza mediatica, ma se non hai equilibrio
sei morto perché quando ti trovano positivo (e succede a tutti prima o poi) sei
solo, hai fatto tutto di tua iniziativa.
Andare in bici per 6 ore di fila, fare 260 chilometri a 40 di media con sole pioggia
vento è disumano, lo sforzo mangia tutto, non hai un filo di grasso, non hai
niente, tutte le tue riserve sono consumate. La ricerca di qualcosa che ti allevi il
dolore è costante: «Non hai qualcosa che mi toglie la fatica?».
«Non hai qualcosa che mi fa andare ancora più forte? Che mi dà più resistenza?
Più velocità?»
«Non hai niente di buono?»
In questo gorgo infernale può succedere che siano i medici delle squadre a dirti:
«Prendi questo1».
E anche quando nessuno fa pressione o invita, si cerca la farmacia in autonomia
totale e senza nessun tipo di controllo, ci si muove come dei cani sciolti, dei
grandissimi “fai da te” e l’ambiente è pieno di medici compiacenti.
Il ciclista è predisposto a fare una fatica enorme e ha anche la mentalità vincente.
Vinci qualche corsa importante e sali di gradino, aumentano guadagni,
responsabilità, ritorno mediatico. Entri in una bolla che è gratificante, vai per
strada e ti riconoscono, in un negozio in un ristorante all’aeroporto, ti fanno lo
sconto quando compri un’auto. Quando sei in cima alle scale sei propenso a fare
tutto quello che serve per non scendere, non hai paura di niente.
E allora se leggi sul bugiardino di un farmaco: «Sfondamento della retina,
glaucoma, diabete, trombosi, ictus, porosità e fragilità ossea» e ti viene la paura e
ti chiedi: “Ma che cazzo vado a prendere ’sta roba?” te la fai passare e ingerisci
tutto quello che puoi ingerire, perché è l’unico modo per fare il tuo mestiere al
meglio.
L’assunzione di sostanze illegali porta con sé la menzogna: mentiamo alla famiglia,
alle mogli, ai giornalisti, ai massaggiatori, ai meccanici, perfino ai nostri colleghi.
Ogni ciclista sa che tutti si dopano eppure nessuno parla e qualcuno sostiene pure
pubblicamente di andare “a pane e acqua”.
Fine dell'estratto Kindle.
Ti è piaciuto?
Scarica la versione completa di questo libri