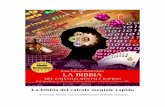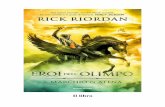Il libro - 3.droppdf.com3.droppdf.com/files/5xtUZ/eroi-dell-olimpo-4-la-casa-di-ade.pdfdovranno...
Transcript of Il libro - 3.droppdf.com3.droppdf.com/files/5xtUZ/eroi-dell-olimpo-4-la-casa-di-ade.pdfdovranno...
Annabeth e Percy sono precipitati in un baratro profondissimo, tanto da ritrovarsi
nelle viscere del Tartaro.
I semidei non hanno un istante da perdere: Jason, Leo, Piper, Frank, Hazel e Nico
dovranno trovare al più presto la Casa di Ade e sigillare le Porte della Morte,
imprigionando le creature infernali che premono per oltrepassarle. Solo così
potranno liberare i due eroi e impedire il ritorno di Gea, la dea della terra, che
vuole distruggere il mondo con le sue armate di giganti. Senza trascurare un
piccolo dettaglio: dovranno essere dalla parte giusta, quando le porte saranno
chiuse, altrimenti non potranno più uscirne! La posta in gioco è più alta che mai in
questa nuova avventura, in cui i semidei si misureranno con i mostri spaventosi che
dimorano lungo le sponde ribollenti del Flegetonte e negli abissi infuocati del
Tartaro.
L’autore
Autore di successo per ragazzi e adulti,
Rick Riordan è stato premiato con i riconoscimenti più importanti del genere
mystery. Dopo aver insegnato inglese per quindici anni, ora si dedica a tempo
pieno alla scrittura e vive a Boston con la moglie e i due figli.
Le saghe ―Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo‖, ―Eroi dell’Olimpo‖ e ―The Kane
Chronicles‖ sono un successo mondiale e in Italia hanno venduto più di un milione
di copie.
Rick Riordan
Eroi dell’Olimpo
La casa di Ade
Traduzione di Loredana Baldinucci e Laura Melosi
Ai miei meravigliosi lettori:
mi dispiace per l’ultimo finale in sospeso.
Be’, no, in realtà non mi dispiace: AHAHAHAH.
Però, sul serio: vi voglio bene ragazzi.
I
HAZEL
Durante il terzo attacco, Hazel per poco non inghiottì un masso. Stava scrutando
nella nebbia, chiedendosi perché dovesse essere così difficile attraversare una
stupida catena montuosa, quando gli allarmi della nave scattarono.
— Tutto a babordo! — urlò Nico dall’albero di trinchetto dell’imbarcazione
volante.
Leo strattonò il timone, e l’Argo II virò a sinistra. I remi aerei sferzavano le nuvole
come file di coltelli.
Hazel commise l’errore di guardare oltre il parapetto. Una sagoma scura e sferica
le si precipitò incontro. Pensò: ―Perché la luna ci sta venendo addosso?‖ poi strillò
e si gettò sul ponte. Una roccia enorme passò così vicina alla sua testa da scostarle
i capelli dal viso.
CRACK!
L’albero di trinchetto crollò: la vela, il pennone e Nico si schiantarono sul ponte. Il
masso, più o meno delle dimensioni di una jeep, si allontanò turbinando nella
nebbia come se avesse cose più importanti da fare altrove.
— Nico! — Hazel corse dal fratello mentre Leo raddrizzava la nave.
— Sto bene — brontolò il figlio di Ade, scalciando per liberarsi le gambe dalle
pieghe della vela.
Lei lo aiutò a rialzarsi, e insieme barcollarono fino a prua. Stavolta Hazel sbirciò
giù con più prudenza. Le nuvole si divisero il tempo sufficiente per svelare la cima:
una roccia nera e aguzza come la punta di un giavellotto, che dalle pendici verde
muschio si slanciava verso l’alto. In piedi sulla vetta c’era un dio della montagna,
uno dei numina montanum, come li aveva chiamati Jason; in greco, ourea.
Creature odiose, comunque le si chiamasse.
Come gli altri numina che avevano già affrontato, questo indossava una semplice
tunica bianca sulla pelle ruvida e scura come basalto. Era alto sei metri e molto
muscoloso, con una fluente barba bianca, i capelli incolti e uno sguardo folle negli
occhi, da eremita pazzo. Ululò qualcosa che Hazel non capì, ma che di certo non
era un benvenuto. A mani nude, staccò un altro moncone di roccia dalla montagna
e iniziò a plasmarlo in una sfera.
La scena scomparve nella nebbia, ma quando il dio della montagna ululò di nuovo,
altri numina risposero in lontananza, con voci che riecheggiavano nella vallata.
— Stupide divinità rocciose! — urlò Leo dal timone. — È la terza volta che devo
rimpiazzare quell’albero! Pensate che crescano nelle foreste?
Nico aggrottò la fronte. — Be’, gli alberi sono di legno, perciò…
— Non è questo il punto! — Leo afferrò uno dei comandi, quello ricavato dal
joystick di una Nintendo Wii, e lo ruotò a cerchio.
A pochi metri di distanza, una botola si spalancò sul ponte, lasciando uscire un
cannone di bronzo celeste. Hazel ebbe appena il tempo di coprirsi le orecchie
prima che la carica partisse, spargendo una decina di sfere di metallo seguite da
scie di fuoco verde. A mezz’aria, le sfere liberarono lame simili a pale di elicottero
e si allontanarono roteando nella nebbia.
Poco dopo, una serie di esplosioni rimbombò fra le montagne, seguita dal ruggito
indignato dei numina montanum.
— Ah! — gridò Leo.
Purtroppo, intuì Hazel ripensando ai due ultimi scontri, la nuovissima arma di Leo
era riuscita solo a farli arrabbiare.
Un altro masso fischiò nell’aria, a poca distanza dal fianco destro della nave.
— Portaci fuori di qui! — urlò Nico.
Leo borbottò qualche commento poco lusinghiero nei confronti dei numina, ma si
rimise al timone. I motori ronzarono. Il sartiame magico si tese, e la nave virò a
sinistra. L’Argo II prese velocità e si ritirò verso nord-ovest, come aveva fatto nel
corso degli ultimi due giorni.
Hazel non si rilassò finché non furono lontani dalle montagne. La nebbia si
disperse. Sotto di loro, la luce del mattino illuminava le campagne italiane: dolci
colline verdi e campi dorati non molto diversi da quelli della California
settentrionale. Per un attimo le sembrò quasi di tornare al Campo Giove.
Quel pensiero le gravò sul petto. Il Campo Giove era stato la sua casa solo per
nove mesi, da quando Nico l’aveva riportata indietro dagli Inferi. Ma ne sentiva la
mancanza più di New Orleans, la città dove era nata, e decisamente più
dell’Alaska, dove era morta nel lontano 1942.
Le mancava la branda nella caserma della Quinta Coorte. Le mancavano i pasti in
mensa, con gli spiriti del vento che facevano volare i piatti, e i legionari che
scherzavano sui giochi di guerra. Avrebbe tanto voluto passeggiare per le vie di
Nuova Roma, mano nella mano con Frank, e sentirsi per una volta solo una
ragazza come tante, con un ragazzo vero, dolce e premuroso. Soprattutto, avrebbe
tanto voluto sentirsi al sicuro. Era stanca di avere paura e di essere preoccupata
tutto il tempo.
Rimase sul cassero di poppa, mentre Nico si toglieva le schegge dell’albero dalle
braccia e Leo pigiava i pulsanti della console di comando.
— Be’, è stato uno schifo totale — commentò Leo. — Che dici, devo svegliare gli
altri?
Hazel fu tentata di rispondere di sì, ma i restanti membri dell’equipaggio avevano
fatto il turno di notte e si erano più che meritati il riposo. Difendere la nave era
sfiancante. Era come se ogni tanto un mostro della mitologia romana si svegliasse
e decidesse che l’Argo II era un bocconcino imperdibile.
Poche settimane prima, Hazel non avrebbe mai creduto che si potesse dormire
durante l’attacco di uno dei numina, ma in quel momento era certa che i suoi amici
sottocoperta stessero russando della grossa. Ogni volta che lei aveva la possibilità
di dormire, entrava praticamente in coma. — Hanno bisogno di riposare — disse.
— Dovremo trovare un’altra strada da soli.
— Mmm… — Con la fronte aggrottata, Leo scrutò il monitor. La maglietta a
brandelli e i jeans macchiati d’olio gli donavano un’aria da reduce di un incontro di
wrestling con una locomotiva. Da quando Percy e Annabeth erano precipitati nel
Tartaro, aveva lavorato quasi senza sosta. Si comportava con più rabbia e ancora
più smania del solito.
Hazel era preoccupata per lui, ma in parte era anche sollevata dal cambiamento.
Ogni volta che Leo sorrideva e scherzava, somigliava troppo a Sammy, il suo bis-
bisnonno… nonché primo ragazzo di Hazel, nel 1942.
―Accidenti‖ si disse la figlia di Plutone. ―Perché la mia vita dev’essere così
complicata?‖
— Un’altra strada — borbottò Leo. — Tu ne vedi una?
Sul monitor brillava una mappa dell’Italia, con gli Appennini che attraversavano lo
stivale e il puntino verde dell’Argo II che lampeggiava sul versante occidentale
della catena montuosa, a poche centinaia di chilometri da Roma. Il percorso
avrebbe dovuto essere semplice. Dovevano arrivare in un luogo chiamato Epiro, in
Grecia, e trovare un vecchio tempio chiamato ―Casa di Ade‖ (o di Plutone, volendo
usare il nome romano; o anche: del Padre Assente Peggiore del Mondo, come
preferiva Hazel).
Per raggiungere l’Epiro, non dovevano fare altro che puntare dritti verso est,
superando gli Appennini e il Mare Adriatico. Ma le cose non erano andate così.
Ogni volta che tentavano di attraversare la spina dorsale d’Italia, gli dei della
montagna li attaccavano.
Negli ultimi due giorni avevano costeggiato gli Appennini risalendo verso nord,
nella speranza di trovare un passo sicuro, ma senza risultati. I numina montanum
erano figli di Gea, la dea che Hazel detestava di più al mondo. E questo li rendeva
dei nemici molto determinati. L’Argo II non era in grado di volare abbastanza in
alto per evitare i loro attacchi; nonostante tutte le sue difese, non sarebbe riuscita a
portarli dall’altra parte senza prima ridursi a pezzettini.
— È colpa nostra — disse Hazel. — Mia e di Nico. I numina percepiscono la
nostra presenza. — Lanciò un’occhiata al fratellastro.
Da quando lo avevano salvato dai giganti, Nico aveva iniziato a recuperare le
forze, ma era ancora magrissimo. Il suo fisico scheletrico ballava dentro i jeans e la
maglietta. I capelli lunghi e neri incorniciavano due occhi infossati. La carnagione
olivastra aveva assunto un pallore verdognolo e malaticcio, simile al colore della
linfa degli alberi.
Secondo i calcoli umani, aveva solo quattordici anni, uno soltanto più di Hazel, ma
questo non significava granché. Come Hazel, Nico Di Angelo era un semidio
proveniente da un’altra epoca. Irradiava una sorta di energia antica, una
malinconia che nasceva dalla consapevolezza di non appartenere al mondo
moderno.
Hazel non lo conosceva da molto, ma capiva e condivideva la sua tristezza. I figli
di Ade – o Plutone, che dir si voglia – avevano raramente una vita felice. E, a
giudicare da quello che Nico le aveva raccontato la sera prima, la loro sfida più
grande doveva ancora arrivare, e li attendeva nella Casa di Ade: una sfida che lui
l’aveva implorata di non rivelare agli altri.
Nico strinse forte l’elsa della propria spada di ferro dello Stige. — Gli spiriti della
Terra non amano i figli degli Inferi, è vero. Gli stiamo sullo stomaco, letteralmente.
Ma credo che i numina avvertirebbero comunque la nostra presenza. Abbiamo
l’Athena Parthenos a bordo. Praticamente un faro magico.
Hazel rabbrividì, pensando all’enorme statua che occupava quasi tutta la stiva.
Recuperarla da quella caverna sotto la città di Roma era costato loro un prezzo
altissimo; solo che ora non avevano idea di come servirsene. Per il momento,
l’unica cosa che sembrava in grado di fare era segnalare la loro presenza a un
numero ancora maggiore di mostri.
Leo fece scorrere il dito lungo la mappa dell’Italia. — Allora, attraversare le
montagne è fuori discussione. Il problema è che sono parecchio lunghe, sia verso
nord sia verso sud.
— Potremmo passare via mare — suggerì Hazel. — Costeggiando la punta
meridionale dell’Italia.
— Ci vuole troppo — commentò Nico. — E poi, non abbiamo… — Gli si incrinò
la voce. — Lo sai… il nostro esperto marino, Percy.
Il nome rimase sospeso nell’aria come una tempesta imminente.
Percy Jackson, figlio di Poseidone… probabilmente il semidio che Hazel
ammirava di più in assoluto. Le aveva salvato la vita molte volte durante la
missione in Alaska; ma quando lui aveva avuto bisogno di lei, a Roma, Hazel lo
aveva deluso. Era rimasta a guardare, impotente, mentre Percy e Annabeth
precipitavano nel baratro.
Hazel trasse un respiro profondo. Percy e Annabeth erano ancora vivi, in cuor suo
ne era certa. Poteva ancora aiutarli, se fosse riuscita ad arrivare alla Casa di Ade, se
fosse sopravvissuta alla sfida da cui Nico l’aveva messa in guardia… — Che ne
dite di continuare verso nord? — chiese. — Deve esserci un passo da qualche
parte, un’interruzione nella catena montuosa.
Leo armeggiò con la bronzea sfera di Archimede che aveva installato sulla console,
il suo giocattolo più nuovo e pericoloso. Ogni volta che Hazel vi posava lo
sguardo, le si seccava la gola. Temeva che Leo inserisse la combinazione sbagliata
e li scaraventasse per sbaglio tutti fuoribordo, o facesse esplodere la nave, o
trasformasse l’Argo II in un tostapane gigante.
Ma furono più fortunati. Dalla superficie della sfera sbucò un piccolo proiettore e
sopra la console prese vita un’immagine tridimensionale degli Appennini.
— Non lo so. — Leo esaminò l’ologramma. — Non vedo nessun passo adatto, a
nord. Ma l’idea mi piace di più che tornare verso sud. Ho chiuso con Roma.
Nessuno trovò nulla da ribattere. Roma non era stata una bella esperienza.
— Qualunque cosa decidiamo di fare, dobbiamo sbrigarci — intervenne Nico. —
Ogni giorno che Annabeth e Percy trascorrono nel Tartaro…
Non ci fu bisogno che terminasse. Dovevano sperare che i loro amici riuscissero a
sopravvivere abbastanza a lungo da trovare le Porte della Morte. Poi, sempre che
l’Argo II fosse riuscita ad arrivare alla Casa di Ade, forse loro avrebbero potuto
aprire le porte dall’altro lato, salvare Percy e Annabeth e sigillare l’ingresso,
impedendo una volta per tutte alle forze di Gea di continuare a reincarnarsi nel
mondo mortale.
Sì… niente poteva andare storto in quel piano.
Nico scrutò con il volto corrucciato le campagne italiane che scorrevano sotto di
loro. — Forse dovremmo proprio svegliare gli altri. Questa decisione riguarda tutti.
— No — replicò Hazel. — Possiamo trovare una soluzione.
Non avrebbe saputo spiegare perché ne fosse così convinta ma, da quando avevano
lasciato Roma, l’equipaggio aveva iniziato a perdere coesione. Avevano appena
cominciato a lavorare come una squadra, che bam… i due membri più importanti
erano precipitati nel Tartaro. Percy era la spina dorsale del gruppo, aveva
trasmesso loro la sicurezza necessaria per attraversare l’Atlantico e il
Mediterraneo. Quanto ad Annabeth, di fatto era stata a capo della missione. Aveva
recuperato l’Athena Parthenos tutta da sola. Era la più intelligente dei sette, quella
che aveva sempre le risposte.
Se avessero svegliato il resto dell’equipaggio ogni volta che c’era un problema,
avrebbero ricominciato a discutere, a sentirsi sempre più disperati, si disse Hazel.
Invece voleva che Percy e Annabeth fossero orgogliosi di lei. Doveva prendere
l’iniziativa. Non poteva credere che il suo unico ruolo in quell’impresa fosse quello
da cui Nico l’aveva messa in guardia: rimuovere l’ostacolo che li aspettava nella
Casa di Ade. Scacciò quel pensiero.
— Dobbiamo pensare in modo creativo — disse. — Deve esserci un’altra strada
per attraversare queste montagne… oppure un modo per nasconderci dai numina.
Nico sospirò. — Se fossi stato da solo, avrei potuto viaggiare nelle tenebre. Ma
non funzionerà per un’intera nave. E, a dire il vero, non so nemmeno se ho più la
forza di trasportare me stesso.
— Potrei escogitare una forma di camuffamento — propose Leo. — Per esempio,
uno schermo di fumo che ci nasconda fra le nuvole. — Ma neppure lui sembrava
molto entusiasta di quell’idea.
Hazel scrutò il paesaggio rurale che scorreva sotto la nave e pensò a quello che
c’era ancora più sotto: il regno di suo padre, il signore degli Inferi. Aveva
incontrato Plutone solo una volta, e all’epoca non si era neanche resa conto della
sua identità. Di certo non si era mai aspettata aiuti da lui, né durante la propria
prima vita, né in tutto il tempo trascorso come spirito negli Inferi, e nemmeno da
quando Nico l’aveva riportata nel mondo dei vivi.
Il servitore di suo padre, Thanatos, il dio della morte, aveva suggerito che Plutone,
ignorandola, in realtà le stesse facendo un favore. Dopotutto, non avrebbe dovuto
essere viva. Se Plutone si fosse accorto di lei, forse avrebbe dovuto ricondurla nella
terra dei morti.
Ciò significava che fare appello a Plutone sarebbe stata una pessima idea. Però…
―Ti prego, papà‖ si ritrovò a supplicare. ―Devo trovare una strada per arrivare al
tuo tempio in Grecia, la Casa di Ade. Se sei laggiù, mostrami che cosa devo fare.‖
Ai margini dell’orizzonte, un guizzo di movimento attirò lo sguardo della ragazza:
qualcosa di piccolo e beige che correva sui campi a una velocità impossibile,
lasciandosi alle spalle una scia di vapore, come un aeroplano.
Hazel non riusciva a crederci. Non osava quasi sperarlo, ma doveva per forza
essere… — Arion!
— Cosa? — domandò Nico.
Leo liberò un grido di gioia quando vide avvicinarsi la nuvola di polvere. — È il
suo cavallo, bello! Questa parte della storia te la sei persa. Non lo vedevamo dal
Kansas!
Hazel rise, per la prima volta da giorni. Era così bello rivedere il suo vecchio
amico.
A circa un chilometro di distanza, a nord, la macchiolina beige scavalcò una
collina e si fermò sulla cima. Da lontano non si distingueva bene, ma quando il
cavallo si impennò e nitrì, il suono raggiunse anche l’Argo II.
Hazel non aveva dubbi: era Arion. — Dobbiamo andare da lui. È qui per aiutarci.
— Okay. — Leo si grattò la testa. — Ma… ehm… avevamo deciso di non atterrare
più, ricordi? Per quella faccenda di Gea che vuole distruggerci…
— Allora avviciniamoci, e poi userò la scala. — Il cuore di Hazel martellava forte.
— Credo che Arion voglia dirmi qualcosa.
II
HAZEL
Hazel non si era mai sentita così felice. Be’, tranne forse la notte del banchetto
della vittoria al Campo Giove, quando aveva baciato Frank per la prima volta…
ma ci andava vicino.
Non appena a terra, corse da Arion e gli gettò le braccia al collo. — Mi sei
mancato! — Premette il viso sul fianco caldo del cavallo, che profumava di
salsedine e mele. — Dove sei stato?
Arion nitrì piano.
Hazel rimpianse di non saper parlare il cavallese come Percy, ma colse lo stesso il
senso generale del messaggio. Arion sembrava impaziente, come a dire: ―Non è il
momento per i sentimentalismi, ragazzina. Andiamo!‖
— Vuoi che venga con te?
L’animale ciondolò la testa, pestando gli zoccoli. Nei suoi occhi bruni luccicò
un’espressione d’urgenza.
Hazel non riusciva ancora a credere che fosse davvero lì. Il cavallo magico era in
grado di correre su ogni genere di superficie, perfino sul mare; ma lei aveva temuto
che non li avrebbe seguiti nelle antiche terre. Il Mediterraneo era troppo pericoloso
per i semidei e i loro alleati.
Non sarebbe venuto, se lei non si fosse trovata in serie difficoltà. E sembrava
agitato… Qualunque cosa riuscisse a intimorire quel cavallo temerario avrebbe
dovuto terrorizzarla.
Invece era sollevata. Era così stanca del mal di mare e del mal d’aria. A bordo
dell’Argo II si sentiva una zavorra. Era felice di trovarsi di nuovo a terra, anche se
era il territorio di Gea. Era pronta a cavalcare.
— Hazel! — chiamò Nico, dalla nave. — Che succede?
— Va tutto bene! — Hazel si accovacciò ed evocò una pepita d’oro. Stava
diventando più brava a controllare il suo potere: non capitava quasi più che le
pietre preziose le spuntassero intorno per sbaglio, ed estrarre l’oro dal terreno era
facile. Diede la pepita ad Arion… era il suo spuntino preferito. Poi rivolse un
sorriso verso l’alto a Leo e Nico, che la osservavano da trecento metri di altezza, in
cima alla scaletta. — Arion vuole portarmi da qualche parte.
I ragazzi si scambiarono uno sguardo nervoso.
— Ehm… — Leo indicò verso nord. — Per favore, dimmi che non vuole portarti
là…
Hazel era così concentrata su Arion, che non aveva notato la perturbazione. A un
chilometro di distanza, sulla cresta della collina successiva, una tempesta si era
addensata sopra delle rovine di pietra, forse i resti di un tempio o di una fortezza
romana. Un tornado di nubi serpeggiava verso la collina, sinuoso come un dito
nero d’inchiostro.
Hazel avvertì un sapore di sangue in bocca. Guardò Arion. — Vuoi andare là?
Il cavallo nitrì, come a dire: ―Ovvio! Dove, sennò?‖
Be’… Hazel aveva chiesto aiuto. Era questa la risposta di suo padre?
Sperava di sì, solo che percepiva qualcosa di diverso da Plutone all’opera in quella
tempesta… qualcosa di oscuro, potente e non necessariamente bendisposto.
Tuttavia era la sua occasione per aiutare gli amici, per dare una direzione, anziché
limitarsi a seguire.
Strinse meglio la cintura della lunga spada d’oro imperiale e salì in groppa ad
Arion. — Me la caverò! — gridò ai due ragazzi. — Voi aspettatemi qui.
— Aspettarti? Per quanto? — chiese Nico. — E se non torni?
— Non ti preoccupare, tornerò — promise Hazel, augurandosi che fosse vero.
Spronò Arion, e si lanciarono nella campagna, puntando dritti verso il tornado in
arrivo.
III
HAZEL
La tempesta inghiottiva la collina in un imbuto roteante di vapore nero.
Arion vi si tuffò dentro.
Hazel si ritrovò sulla cima, ma le sembrò di essere entrata in un’altra dimensione.
Il mondo aveva perso il suo colore. Le pareti del tornado racchiudevano la collina
in una torbida oscurità. Il cielo grigio ribolliva. Le rovine romane sembravano
quasi luccicare, tanto erano sbiancate. Perfino il manto color miele di Arion si era
tinto di cenere.
Nell’occhio del ciclone, l’aria era immobile. Hazel si sentiva formicolare la pelle,
come se l’avesse appena strofinata con l’alcol. Di fronte a lei, un arco ricoperto di
muschio conduceva in un luogo chiuso.
La figlia di Plutone non riusciva a vedere molto nella penombra, ma avvertì una
presenza. Si sentiva come un ferro vicino a un’enorme calamita. La forza di
attrazione era irresistibile, la trascinava avanti.
Ma lei esitò. Trattenne per le redini Arion, che pestò impaziente sul terreno,
facendolo crepitare. Ovunque posasse gli zoccoli, erba, terriccio e sassi
diventavano bianchi di brina. Hazel ripensò al ghiacciaio di Hubbard in Alaska,
all’inquietante sensazione della superficie che si incrinava. Ricordò il pavimento di
quell’orribile caverna di Roma che si sgretolava, facendo piombare Percy e
Annabeth dritti nel Tartaro.
Alla fine decise di proseguire, con la speranza che il terreno non le si dissolvesse
sotto i piedi. — E va bene, andiamo, bello. — La sua voce risuonò soffocata, come
se stesse parlando con un cuscino davanti alla bocca.
Arion oltrepassò al trotto l’arco, e si ritrovarono in un cortile quadrato racchiuso da
muri in rovina, grande quanto un campo da tennis. Al centro delle pareti c’erano
altri tre archi, rivolti a nord, a est e a ovest. In mezzo al cortile si incrociavano due
sentieri lastricati. Una foschia aleggiava nell’aria, brandelli bianchi e sottili che si
attorcigliavano e ondulavano come se fossero vivi.
Non era una foschia qualunque, comprese Hazel. Era la Foschia.
Per tutta la vita aveva sentito parlare della Foschia, il velo soprannaturale che
oscurava il mondo dei miti alla vista dei mortali. Poteva ingannare gli umani e
perfino i semidei, inducendoli a vedere i mostri come innocui animali e gli dei
come persone comuni.
Lei non aveva mai pensato che fosse del vapore vero e proprio, ma le venne la
pelle d’oca mentre la osservava avvolgersi intorno alle zampe di Arion e fluttuare
fra le macerie degli archi di quel cortile abbandonato. E capì: quella materia bianca
era magia allo stato puro.
In lontananza, un cane ululò.
Arion di solito non aveva paura di niente, ma arretrò, sbuffando nervoso.
— Va tutto bene. — Hazel lo accarezzò sul collo. — Lo affronteremo insieme.
Adesso smonto, okay? — Scivolò giù dalla groppa di Arion, che subito si voltò e
corse via. — Arion, aspe…
Ma il cavallo era già scomparso da dove era venuto. E tanti saluti all’idea di
affrontare insieme la situazione.
Un altro ululato squarciò l’aria, stavolta più vicino.
Hazel avanzò verso il centro del cortile. — C’è nessuno? — chiamò.
La Foschia le si incollò addosso.
— Ciao — disse una voce.
La figura pallida di una donna comparve nell’arco settentrionale. No, un attimo…
era nell’arco orientale. No, in quello occidentale. Tre immagini fumose della stessa
donna si mossero all’unisono verso il centro delle rovine. La figura era sfocata,
fatta di Foschia, e due pennacchi di vapore più piccoli la seguivano, sfrecciando ai
suoi piedi come animaletti. Bestie da compagnia, forse?
La donna raggiunse il centro del cortile, e le tre figure si fusero in una sola,
solidificandosi in una giovane dalla veste scura, senza maniche. Non poteva avere
più di vent’anni, ma Hazel sapeva che era un’impressione irrilevante. I capelli
dorati erano raccolti in una coda alta, alla maniera greca. L’abito era così fluido e
setoso che sembrava riversarsi giù dalle sue spalle come inchiostro.
— Hazel Levesque — esordì la donna. Era bellissima, ma di un pallore mortale.
Una volta, a New Orleans, Hazel era stata costretta ad andare alla veglia funebre di
una sua compagna di scuola. Ricordava il corpo senza vita della ragazzina nella
bara aperta. Le avevano truccato il viso per farla apparire graziosa, come se
dormisse, e Hazel l’aveva trovato terrificante.
La sconosciuta le ricordava la compagna defunta, con l’unica differenza che aveva
gli occhi aperti e completamente neri. Quando inclinò la testa, sembrò frangersi di
nuovo in tre persone diverse. Le immagini sfocate si confondevano e
sovrapponevano, come la fotografia di qualcuno che si muove troppo in fretta per
restare impresso sulla pellicola.
— Chi sei? — Le dita di Hazel si mossero verso l’elsa della spada. — Cioè…
quale dea sei?
Di questo almeno era certa. Quella donna irradiava potere. Tutto intorno a loro – la
Foschia, la tempesta monocromatica, il bagliore irreale delle rovine – era
provocato dalla sua presenza.
— Ah… — La donna annuì. — Permettimi di fare un po’ di luce. Sollevò le mani.
E a un tratto stringeva due torce di canne intrecciate, che brillavano fioche.
La Foschia arretrò ai margini del cortile. Ai piedi calzati di sandali della donna, i
due animali di fumo assunsero una forma solida. Uno era un labrador retriever
nero. L’altro sembrava un lungo ratto grigio e peloso, con una mascherina bianca
sul muso. Una puzzola, forse?
La donna sorrise serenamente. — Io sono Ecate, la dea della magia. Abbiamo
molto di cui parlare, se vuoi sopravvivere a questa notte.
IV
HAZEL
Hazel avrebbe voluto scappare, ma i suoi piedi erano incollati al terreno smaltato
di bianco.
Ai lati dell’incrocio, due portatorce di ferro scuro eruppero dalla terra come steli di
una pianta. Ecate vi fissò le torce, poi camminò intorno a Hazel in un cerchio lento,
osservandola come se fossero compagne di una strana danza irreale.
Il cane nero e la donnola la seguirono.
— Sei come tua madre — disse Ecate.
Hazel si sentì un nodo in gola. — La conoscevi?
— Certo. Marie era una chiromante. Si occupava di incantesimi e maledizioni e
gris-gris. Io sono la dea della magia.
Quegli occhi nerissimi sembravano attirare Hazel, come se cercassero di estrarre la
sua anima. Durante la sua prima vita a New Orleans, era stata tormentata dai
ragazzi della scuola per via di sua madre. Dicevano che Marie Levesque era una
strega. Le suore mormoravano che commerciasse con il diavolo.
―Se le suore avevano paura di mia madre, cos’avrebbero pensato di questa dea?‖ si
chiese Hazel.
— Molti mi temono — disse Ecate, come leggendole nel pensiero. — Ma la magia
non è né buona né cattiva. È uno strumento, come un coltello. Un coltello è
cattivo? Solo se lo è chi lo impugna.
— Mia… mia madre… — balbettò Hazel. — Lei non credeva alla magia. Non ci
credeva davvero. Faceva finta, per i soldi.
La donnola squittì e scoprì i denti. Poi produsse una specie di verso stridulo dal
sedere. In altre circostanze, una donnola con problemi intestinali sarebbe stata
divertente, ma Hazel non rise. Gli occhi rossi del mustelide la guardavano
minacciosi, come piccoli tizzoni ardenti.
— Buona, Gale — disse Ecate. Rivolse a Hazel una scrollata di spalle, come per
scusarsi. — A Gale non piace sentir parlare di miscredenti e imbroglioni. Un
tempo anche lei era una maga.
— Questa puzzola era una maga?
— È una donnola, a dire il vero — specificò Ecate. — Ma sì, Gale un tempo era
una sgradevole maga umana. Aveva un terribile problema di igiene personale, per
non parlare dei… ehm… problemi digestivi. — Ecate si sventolò una mano davanti
al naso. — Dava una pessima fama ai miei seguaci.
— Ah, ecco. — Hazel si sforzò di non guardare la donnola. Non aveva nessuna
voglia di approfondire i disturbi intestinali della bestiola.
— A ogni modo, l’ho trasformata in una donnola — continuò la dea. — Anche se
spesso si comporta da puzzola.
Hazel deglutì. Guardò il cane nero, che strofinava affettuosamente il muso sulla
mano della dea. — E il labrador…?
— Oh, lei è Ecuba, ex regina di Troia — spiegò Ecate, come se fosse ovvio.
Il cane sbuffò.
— Hai ragione, Ecuba — ammise la dea. — Non abbiamo tempo per le
presentazioni. Il punto è, Hazel Levesque, che per quanto tua madre si sia convinta
del contrario, possedeva il dono della magia vera. Alla fine se n’è resa conto.
Quando ha cercato un incantesimo per invocare Plutone, l’ho aiutata io a trovarlo.
— Tu…?
— Sì. — Ecate continuava a camminare intorno a Hazel. — Avevo visto del
potenziale in lei. E ora ne vedo ancora di più in te.
Hazel si sentiva girare la testa. Ricordava la confessione della madre poco prima di
morire: come aveva evocato Plutone, come il dio si era innamorato di lei e come
poi lei, Hazel, era nata con una maledizione per colpa dell’avidità di Marie
Levesque. Hazel era in grado di richiamare in superficie pietre, metalli e beni
preziosi dalle viscere della Terra, ma chiunque ne faceva uso finiva col patire
molte disgrazie, fino alla morte.
Ora quella dea stava dicendo che era stata lei a rendere tutto questo possibile.
— Mia madre ha sofferto a causa della magia. Per tutta la vita io…
— Tutta la tua vita non sarebbe neanche esistita senza di me — replicò Ecate, in
tono piatto. — Non ho tempo per la tua rabbia. E non ce l’hai nemmeno tu. Senza
il mio aiuto, morirai.
Il cane nero ringhiò. La donnola fece scattare i denti in un morso e liberò il proprio
fetore.
Hazel si sentì come se i polmoni le si riempissero di sabbia. — Che genere di
aiuto? — chiese.
Ecate sollevò le mani pallide. Nei tre archi da cui era venuta – nord, est e ovest – la
Foschia cominciò a roteare. Un turbinio di immagini in bianco e nero comparve a
intermittenza, come in quei vecchi film muti che davano ancora al cinema quando
Hazel era piccola.
Nell’arco occidentale, semidei greci e romani combattevano gli uni contro gli altri
sul fianco di una collina, all’ombra di un grande pino. L’erba era cosparsa di feriti
e moribondi. Hazel vide se stessa in sella ad Arion: cavalcava in mezzo al caos e
gridava, cercando di fermare quella violenza.
Nell’arco orientale, scorse l’Argo II precipitare dal cielo sopra gli Appennini. Il
sartiame era in fiamme. Un masso si abbatté sul cassero, un altro penetrò nello
scafo. La nave scoppiò come una zucca marcia, e il motore esplose.
Le immagini dell’arco settentrionale erano perfino più sconfortanti. Hazel vide
Leo, svenuto – o morto – precipitare fra le nuvole. Vide Frank, barcollante e solo,
avanzare lungo una galleria buia, con le braccia strette intorno al corpo, la
maglietta zuppa di sangue. E infine vide se stessa in un’immensa caverna piena di
fili di luce, simili a una ragnatela luminosa. Faticava ad avanzare, mentre Percy e
Annabeth, in lontananza, giacevano scomposti e immobili ai piedi di due porte di
metallo nero e argento.
— Scelte — spiegò Ecate. — Ti trovi a un incrocio, Hazel Levesque. E io sono la
dea degli incroci.
La terra tremò. Hazel abbassò lo sguardo e vide luccicare monete d’argento ai suoi
piedi… migliaia di antichi denarii romani stavano spuntando in superficie, come se
l’intera collina ribollisse. Le visioni appena scorte l’avevano sconvolta a tal punto
da farle evocare ogni singolo pezzetto d’argento presente nelle campagne
circostanti.
— Qui il passato è molto vicino alla superficie — disse la dea. — Nei tempi
antichi, due grandi strade romane si incontravano in questo luogo. Qui si
scambiavano notizie, si gestivano commerci. Gli amici si ritrovavano e i nemici si
scontravano. Interi eserciti sceglievano una direzione. Gli incroci sono sempre
teatro di decisioni.
— Come… come Giano. — Hazel ripensò al tempio di Giano sulla Collina dei
Templi, al Campo Giove. I semidei andavano là quando dovevano prendere una
decisione importante. Lanciavano una moneta, testa o croce, e speravano che il dio
bifronte li guidasse nella giusta direzione. Hazel aveva sempre detestato quel
posto. Non aveva mai capito perché i suoi amici desiderassero tanto che un dio
scegliesse al posto loro. Dopo tutto quello che aveva passato, ormai si fidava della
saggezza degli dei quanto delle slot machine di New Orleans.
La dea della magia emise un sibilo disgustato. — Giano e le sue soglie. Vorrebbe
farti credere che tutte le scelte siano fra bianco e nero, sì e no, dentro o fuori. In
realtà, non è così semplice. Ogni volta che si giunge a un incrocio, ci sono sempre
almeno tre direzioni possibili… quattro, se si conta quella da cui si è venuti. Ecco,
tu ti trovi a questo genere di incrocio, Hazel.
La figlia di Plutone guardò di nuovo le visioni all’interno di ciascun arco: una
guerra fra semidei, la distruzione dell’Argo II, la rovina totale per se stessa e per i
suoi amici. — Sono tutte pessime scelte.
— Tutte le scelte comportano dei rischi — la corresse la dea. — Ma qual è il tuo
obiettivo? La tua strada?
— La mia strada? — Hazel fece un gesto vago verso i tre archi. — Nessuna di
queste.
Il cane Ecuba ringhiò. La donnola Gale zampettò rapida intorno ai piedi della dea,
continuando a far scattare le mascelle e ad ammorbare l’aria.
— Potresti tornare indietro — suggerì Ecate. — Ripercorrere i tuoi passi fino a
Roma… ma le forze di Gea se lo aspettano. Nessuno di voi sopravvivrebbe.
— Allora… cosa mi stai dicendo?
Ecate si avvicinò a una torcia. Raccolse una manciata di fiamme e le plasmò,
finché nella sua mano non comparve una piccola mappa dell’Italia in rilievo. —
Potreste andare a ovest. — Ecate allontanò il dito dalla mappa infuocata. —
Tornate in America con il vostro trofeo, l’Athena Parthenos. Laggiù, i vostri
compagni greci e romani sono sull’orlo di una guerra. Partite subito, e forse
salverete loro la vita.
— Forse — ripeté Hazel. — Ma Gea si ridesterà in Grecia, ed è lì che si stanno
radunando i giganti.
— È vero. Gea ha scelto il 1° agosto, la festa di Spes, dea della speranza, per la
propria ascesa al potere. Ridestandosi nel Giorno della Speranza, intende
distruggere la speranza per sempre. Ma, ammesso che riusciate a giungere in
Grecia in tempo, sareste in grado di fermarla? Non lo so. — Ecate fece scorrere il
dito lungo le cime degli Appennini infuocati. — Potreste andare a est, oltre le
montagne, ma Gea farà qualunque cosa per impedirvi di attraversare l’Italia. Vi ha
sollevato contro i suoi dei delle montagne.
— L’abbiamo notato — commentò Hazel.
— Qualsiasi tentativo di attraversare gli Appennini comporterebbe la distruzione
della vostra nave. Ironia della sorte, questa potrebbe essere la scelta più sicura per
il vostro equipaggio. Vedo che tutti voi sopravvivreste all’esplosione. È possibile,
anche se improbabile, che raggiungereste comunque l’Epiro per chiudere le Porte
della Morte. Forse trovereste Gea e impedireste il suo ritorno. Ma a quel punto
entrambi i vostri campi sarebbero distrutti. Non avreste più una casa a cui tornare.
— Ecate sorrise. — Ma è più probabile che la distruzione della nave vi lascerebbe
sulle montagne. Sarebbe la fine della vostra eroica impresa, però risparmierebbe a
te e ai tuoi amici le molte sofferenze dei giorni a venire. La guerra contro i giganti
sarebbe vinta o persa senza di voi.
―Vinta o persa senza di noi.‖ Una piccola, colpevole parte di Hazel trovava
quell’ipotesi invitante. Era da tanto tempo che desiderava essere una ragazza
qualunque. Non voleva altro dolore per sé e i suoi amici. Ne avevano già passate
troppe.
Guardò oltre le spalle della dea, nell’arco centrale. Vide Percy e Annabeth a terra,
indifesi, di fronte alle porte nere e argento. Una gigantesca sagoma scura,
vagamente umanoide, troneggiava sopra di loro, con il piede alzato come per
schiacciare Percy.
— E loro? — chiese Hazel, con voce roca. — Percy e Annabeth?
Ecate fece spallucce. — Ovest, est o sud che sia… moriranno.
— No! — esclamò Hazel.
— Allora ti resta soltanto una via, anche se è la più pericolosa. — Il dito di Ecate
attraversò gli Appennini in miniatura, lasciando una scia di luce bianca nelle
fiamme rosse. — C’è un passo segreto qui a nord, un luogo che è sotto il mio
dominio, e che Annibale attraversò quando marciò contro Roma. — La dea tracciò
un ampio anello, su in alto, verso le Alpi, poi a est, verso il mare, infine lungo la
costa occidentale della Grecia. — Una volta attraversato il passo, viaggerete verso
Bologna, a nord, e poi verso Venezia. Da qui, solcherete l’Adriatico diretti alla
vostra meta: l’Epiro, in Grecia.
Hazel non era un granché in geografia. Non aveva idea di come fosse il Mare
Adriatico. Non aveva mai sentito parlare di Bologna, e tutto ciò che sapeva di
Venezia erano certe storie vaghe di gondole e canali. Una cosa però era evidente.
— Sembra del tutto fuori strada.
— Ecco perché Gea non si aspetta che scegliate questa rotta — replicò Ecate. —
Posso coprire per un po’ la vostra avanzata, ma il successo del viaggio dipende da
te, Hazel Levesque. Devi imparare a usare la Foschia.
— Io? — Hazel sentì il cuore rotolare giù dal petto. — Usare la Foschia? Come?
Ecate spense la mappa dell’Italia e rivolse un gesto della mano a Ecuba. La
Foschia si raccolse intorno al labrador finché non fu completamente avvolto da un
bozzolo bianco. Poi la nebbia scomparve con un nitido puf! e al posto del cane
apparve un burbero gattino nero dagli occhi d’oro.
— Miao.
— Io sono la dea della Foschia — spiegò Ecate. — Ho il compito di conservare il
velo che separa il mondo degli dei dal mondo dei mortali. I miei figli imparano a
usare la Foschia a loro vantaggio, a creare illusioni o a influenzare le menti dei
mortali. Anche altri semidei possono riuscirci. E devi farlo anche tu, Hazel, se vuoi
aiutare i tuoi amici.
— Ma… — Hazel guardò il gattino. Sapeva che in realtà era Ecuba, il labrador
nero, ma non riusciva a convincersene fino in fondo. Il gatto era così reale. — Non
credo di farcela.
— Tua madre aveva talento — ribatté Ecate. — E tu ne hai più di lei. Come figlia
di Plutone tornata dal regno dei morti, comprendi il velo che separa i due mondi
meglio di moltissimi altri. Tu puoi controllare la Foschia. In caso contrario… be’,
tuo fratello Nico ti ha già messo in guardia. Gli spiriti hanno bisbigliato al suo
orecchio. Gli hanno predetto il tuo futuro. Quando raggiungerai la Casa di Ade,
incontrerai una formidabile nemica, che non si può distruggere con la forza o con
la spada. Solo tu potrai sconfiggerla, e ti occorrerà la magia per farlo.
Hazel sentì le gambe molli. Ricordava l’espressione cupa di Nico, le sue dita
impresse nel suo braccio. ―Non puoi dirlo agli altri. Non ancora. Il loro coraggio è
già al limite.‖
— Chi? — domandò con voce lugubre. — Chi è questa nemica?
— Non pronuncerò il suo nome — disse Ecate. — La metterebbe in allerta prima
che tu sia pronta ad affrontarla. Andate a nord, Hazel. E, durante il viaggio,
esercitati a evocare la Foschia. Arrivati a Bologna, cercate i due nani. Vi
condurranno a un tesoro che forse vi aiuterà a sopravvivere nella Casa di Ade.
— Non capisco.
— Miao — si lamentò il gattino.
— Sì, sì, Ecuba. — La dea fece di nuovo scattare la mano, e il gatto scomparve. Il
labrador nero tornò al suo posto. — Lo capirai, Hazel — promise la dea. — Di
tanto in tanto, manderò Gale a controllare i tuoi progressi.
La donnola soffiò, con gli occhi rossi e luccicanti pieni di cattiveria.
— Magnifico — disse Hazel.
— Dovrai essere pronta prima di raggiungere l’Epiro — continuò la dea. — Se ce
la farai, forse ci incontreremo di nuovo… per la battaglia finale.
―Una battaglia finale‖ pensò Hazel. ―Oh, che gioia.‖
Chissà se avrebbe potuto impedire che le rivelazioni viste nella Foschia
diventassero realtà: Leo che precipitava giù dal cielo; Frank che avanzava
barcollando nel buio, solo e gravemente ferito; Percy e Annabeth alla mercé di un
gigante di tenebre…
Hazel detestava gli enigmi degli dei e le loro oscure indicazioni. E cominciava a
odiare anche gli incroci. — Perché mi stai aiutando? — chiese. — Al Campo
Giove dicevano che ti eri schierata dalla parte dei Titani, nell’ultima guerra.
Gli occhi scuri di Ecate scintillarono. — Questo perché sono figlia di Perseo e
Asteria, faccio parte dei Titani. Molto tempo prima che gli dei dell’Olimpo
salissero al potere, io governavo la Foschia. Nonostante questo, nella prima Guerra
dei Titani, millenni fa, mi schierai dalla parte di Zeus contro Crono. Non potevo
non vedere la crudeltà di Crono. Speravo che Zeus si dimostrasse un sovrano
migliore. — Ecate fece una risata amara. — Quando Persefone fu rapita da tuo
padre, fui io a guidare sua madre Demetra nelle tenebre con le mie torce e ad
aiutarla nella ricerca. E quando i giganti si ribellarono la prima volta, mi schierai di
nuovo con gli dei. Combattei contro il mio arcinemico Clizio, creato da Gea per
assorbire e sconfiggere la mia magia.
— Clizio. — Hazel non aveva mai sentito quel nome. Ma si sentiva il corpo
pesante soltanto a pronunciarlo. Lanciò un’occhiata alle immagini nella porta
settentrionale, all’enorme sagoma scura che si stagliava sopra Percy e Annabeth.
— È lui la minaccia nella Casa di Ade?
— Oh, lui ti aspetta lì… — Ecate annuì. — Ma prima dovrai sconfiggere la maga.
E se non ci riesci… — Schioccò le dita, e tutti gli archi precipitarono nel buio. La
Foschia si dissolse, le immagini svanirono. — Tutti dobbiamo affrontare delle
scelte — continuò la dea. — Quando Crono è insorto la seconda volta, ho
commesso un errore. L’ho sostenuto. Ero stanca di essere ignorata dalle cosiddette
divinità maggiori. Nonostante i miei anni di fedele servizio, non si fidavano di me,
mi rifiutavano un seggio nel Consiglio…
La donnola squittì con rabbia.
— Ora non ha più importanza. — La dea sospirò. — Ho rifatto pace con l’Olimpo.
E adesso che gli dei sono così prostrati – presi come sono nel conflitto tra le loro
due personalità, quella greca e quella romana – io li aiuterò. In Grecia così come a
Roma, io sono sempre rimasta Ecate. Ti assisterò contro i giganti, se mi
dimostrerai il tuo valore. Perciò adesso a te la scelta, Hazel Levesque. Ti fiderai di
me… o mi eviterai, come hanno fatto troppo spesso gli dei dell’Olimpo?
Hazel si sentiva il cuore pulsare nelle orecchie. Poteva fidarsi di quella dea oscura,
colpevole di aver dato a sua madre la magia che aveva distrutto la sua vita? No,
non poteva. Non le piaceva molto neanche il cane nero, né tantomeno quella
donnola puzzolente.
Ma sapeva anche di non poter permettere che Percy e Annabeth morissero.
— Andremo a nord — decise. — Prenderemo il tuo passo segreto attraverso le
montagne.
Ecate annuì, con una lievissima ombra di soddisfazione sul viso. — Hai scelto
bene, anche se la strada non sarà facile. Molti mostri insorgeranno contro di voi.
Perfino alcuni dei miei servitori si sono schierati con Gea, sperando di distruggere
il vostro mondo mortale. — La dea riprese le due torce. — Preparati, figlia di
Plutone. Se avrai successo contro la maga, ci incontreremo di nuovo.
— Ce la farò — promise Hazel. — E comunque… non sto scegliendo una delle tue
strade. Mi sto costruendo la mia.
Ecate inarcò le sopracciglia. La donnola ebbe un fremito di rabbia, mentre il cane
ringhiò.
— Troveremo il modo di fermare Gea — continuò Hazel. — Salveremo i nostri
amici dal Tartaro. Manterremo l’equipaggio unito e la nave intatta, e impediremo
al Campo Giove e al Campo Mezzosangue di farsi la guerra. Vinceremo su tutti i
fronti.
La tempesta tuonò. Le pareti nere del ciclone rotearono ancora più forte.
— Interessante — commentò la dea, come se Hazel fosse il risultato inedito di un
esperimento scientifico. — Uno spettacolo di magia cui varrebbe la pena assistere.
All’improvviso un’ondata di tenebre oscurò ogni cosa.
Quando Hazel tornò a vedere, la tempesta, la dea e i suoi servi erano scomparsi. Si
trovava al centro delle rovine in cima alla collina, immersa nella luce del mattino,
con la sola compagnia di Arion, che si muoveva impaziente accanto a lei, nitrendo
piano.
— Hai ragione — disse al cavallo. — Andiamocene di qui.
— Cos’è successo? — domandò subito Leo quando la vide salire a bordo.
Hazel si sentiva ancora tremare le mani per il colloquio con la dea. Lanciò
un’occhiata oltre il parapetto e vide la polvere della scia di Arion che si allungava
sulle colline. Aveva sperato che restasse, ma non poteva biasimarlo se voleva
andarsene il prima possibile.
Le campagne scintillavano di rugiada, sotto il sole del mattino. Sulla collina, le
rovine si ergevano bianche e mute, senza più tracce di antiche strade, dee o
donnole con problemi intestinali.
— Hazel? — la chiamò Nico.
La ragazza sentì le ginocchia cedere. Nico e Leo l’afferrarono per le braccia e
l’accompagnarono ai gradini di coperta a prua. Lei provò un po’ di imbarazzo per
quel mancamento da donzella in pericolo, ma era rimasta senza forze. Il ricordo
delle scene che aveva visto brillare all’incrocio la riempiva di terrore.
— Ho incontrato Ecate — riuscì a dire.
Non raccontò tutto. Ricordava le parole di Nico: «Il loro coraggio è già al limite.»
Ma riferì del passo segreto a nord, fra le montagne, e della deviazione che Ecate
aveva descritto e che poteva portarli nell’Epiro.
Quando ebbe finito, Nico le prese la mano. I suoi occhi erano pieni di
preoccupazione. — Hai incontrato Ecate a un incrocio. Molti semidei non
sopravvivono a una cosa simile. E quelli che ci riescono poi non sono più gli stessi.
Sei sicura di sta…?
— Sto bene — concluse Hazel. Ma sapeva di mentire. Ricordava la forza e la
rabbia con cui aveva dichiarato a Ecate che aveva fatto da sola la propria scelta e
che loro avrebbero vinto su tutti i fronti. Ma adesso le sembravano solo vanterie. Il
coraggio l’aveva abbandonata.
— E se Ecate ci stesse ingannando? — chiese Leo. — Questa nuova rotta potrebbe
essere una trappola.
Hazel scosse la testa. — Se fosse una trappola, credo che Ecate l’avrebbe dipinta
come un’impresa facile, per indurci in tentazione. E, credimi, non l’ha fatto.
Leo tirò fuori una calcolatrice dalla cintura degli attrezzi e digitò un po’ di numeri.
— Sono… più o meno cinquecento chilometri fuori rotta, per arrivare a Venezia.
Poi dobbiamo tornare indietro lungo l’Adriatico. E cos’è questa storia dei nani di…
di dove hai detto che sono?
— Di Bologna — rispose Hazel. — Ma perché dobbiamo andare a cercarli… be’,
non ne ho idea. Per via di non so quale tesoro che ci aiuterà nell’impresa.
Leo scrollò la testa. — Adoro i tesori, ma…
— È l’opzione migliore che abbiamo. — Nico aiutò la sorella ad alzarsi. —
Dobbiamo recuperare il tempo perso, andare il più veloce possibile. La vita di
Percy e Annabeth forse dipende da questo.
— Vuoi andare più veloce? — Leo sogghignò. — Mi piace! — Corse alla console
e si mise a smanettare con i pulsanti.
Nico prese la sorella a braccetto e la guidò fuori portata d’orecchi. — Che altro ti
ha detto Ecate? Ti ha parlato di…?
— Non ce la faccio — tagliò corto Hazel. Le scene che aveva visto all’incrocio
l’avevano quasi sopraffatta: Percy e Annabeth inermi ai piedi di quelle porte di
metallo, il gigante di tenebre che li minacciava, lei stessa intrappolata in un
labirinto di luce, incapace di aiutarli.
«Dovrai sconfiggere la maga» aveva detto Ecate. «E se non ci riesci…»
―È la fine‖ pensò Hazel. ―Tutte le porte si chiuderanno. Sarà persa ogni speranza.‖
Nico l’aveva messa in guardia. Aveva comunicato con i morti, che gli avevano
bisbigliato cenni del loro futuro. Due figli degli Inferi sarebbero entrati nella Casa
di Ade. Avrebbero fronteggiato un nemico impossibile. Solo uno di loro sarebbe
giunto alle Porte della Morte.
Hazel non riusciva a guardare il fratello negli occhi. — Te lo dico dopo —
promise, cercando di non far tremare la voce. — Ora è meglio riposare finché si
può. Stanotte attraverseremo gli Appennini.
V
ANNABETH
Nove giorni.
Mentre precipitava, Annabeth ripensò a Esiodo, l’antico poeta greco secondo il
quale si impiegavano nove giorni per cadere dalla terra al Tartaro. Sperò che
Esiodo si sbagliasse.
Aveva perso la cognizione del tempo. Da quanto stavano cadendo, lei e Percy?
Ore? Un giorno? Sembrava un’eternità. Si tenevano per mano da quando erano
crollati nel baratro. Percy l’attirò a sé e, stretti l’uno all’altra, continuarono a
precipitare nell’oscurità più assoluta.
Il vento fischiava nelle orecchie di Annabeth. L’aria era sempre più calda e umida,
come se stessero piombando a picco nella gola di un drago gigantesco. Si era
appena rotta una caviglia e la sentiva pulsare, anche se non avrebbe saputo dire se
era ancora avvolta nella ragnatela.
Maledetta Aracne. L’avevano intrappolata nella sua stessa tela, investita con
un’auto e spinta nel Tartaro, ma nonostante tutto la donna ragno aveva ottenuto la
sua vendetta. In qualche modo uno dei suoi fili di seta aveva intrappolato la gamba
di Annabeth e l’aveva trascinata oltre l’orlo del precipizio, con Percy al seguito.
La figlia di Atena non riusciva a immaginare che Aracne fosse ancora viva, da
qualche parte nelle tenebre sottostanti. Non aveva nessuna voglia di incontrarla di
nuovo, una volta raggiunto il fondo. Volendo essere ottimisti, e ammesso che ci
fosse un fondo, lei e Percy si sarebbero spiaccicati nell’impatto, perciò i ragni
giganti erano l’ultimo dei loro problemi.
Si strinse forte a Percy e cercò di non singhiozzare. Non si era aspettata una vita
facile. Moltissimi semidei morivano giovani per mano di mostri orrendi, era così
fin dall’antichità. Non per niente i Greci avevano inventato la tragedia. Sapevano
che i grandi eroi non facevano mai una bella fine.
Però era un’ingiustizia. Ne aveva passate di tutti i colori per recuperare la statua di
Atena, e proprio quando c’era riuscita, quando le cose sembravano mettersi meglio
e aveva ritrovato Percy, erano precipitati dritti verso la morte.
Nemmeno gli dei potevano concepire un fato così avverso.
Ma Gea non era come gli altri dei. La Madre Terra era più antica, più malvagia, più
assetata di sangue. Annabeth immaginava di sentire la sua risata mentre
piombavano nell’abisso.
Premette le labbra sull’orecchio di Percy. — Ti amo.
Non era sicura che lui potesse sentirla ma, se dovevano morire, voleva che quelle
fossero le ultime parole che avrebbe pronunciato.
Cercò disperatamente di escogitare un piano per salvarsi. Era una figlia di Atena.
Aveva dimostrato il proprio valore nelle gallerie sotterranee di Roma, vincendo
una lunga serie di sfide grazie all’intelligenza. Ma non riusciva a pensare a un solo
modo per invertire o rallentare la caduta.
Nessuno di loro due aveva il potere di volare, al contrario di Jason, che era in
grado di controllare il vento, e di Frank, che poteva trasformarsi in un animale
alato. Se avessero toccato il fondo alla velocità terminale… be’, non ci voleva un
genio per capire che sarebbe stato un atterraggio terminale.
Stava prendendo in seria considerazione la possibilità di fabbricare un paracadute
con le magliette, tanto era disperata, quando intorno a loro qualcosa cambiò. Si
rese conto di riuscire a vedere i capelli di Percy mentre lo abbracciava. L’oscurità
assunse una sfumatura rossastra. Il fischio che aveva nelle orecchie si trasformò in
qualcosa di più simile a un boato. L’aria si fece bollente, quasi intollerabile, intrisa
di un odore di uova marce.
All’improvviso il canale entro cui stavano precipitando si allargò in una caverna
immensa. Qualche centinaia di metri sotto di loro, Annabeth intravide il fondo. Per
un attimo, fu troppo sbigottita per riuscire a pensare in modo sensato. Quella
caverna avrebbe potuto accogliere senza problemi l’intera isola di Manhattan, e lei
non riusciva neanche a scorgerla in tutta la sua ampiezza. Il paesaggio – almeno da
quanto riusciva a vedere – era costituito da pianure di pietra brulla e nera,
inframmezzate qua e là da rilievi puntuti e voragini infuocate. Sulla sinistra, il
terreno era interrotto da una serie di scogliere, simili a colossali gradini che
sprofondavano ancora di più nell’abisso.
Il tanfo di zolfo annebbiava i pensieri, ma Annabeth si concentrò sull’area
direttamente sotto di loro e scorse un nastro di liquido nero e scintillante: un fiume.
— Percy! — gli gridò nell’orecchio. — Acqua! — Gesticolò come una pazza.
Era difficile interpretare il volto di Percy nella luce rossa e fioca. Sembrava
terrorizzato e sotto shock, ma lo vide annuire come se avesse capito.
Percy era in grado di controllare l’acqua, sempre che di acqua si trattasse. Forse
poteva riuscire in qualche modo ad attutire la caduta. Naturalmente, Annabeth
aveva sentito storie terribili sui fiumi degli Inferi: potevano cancellarti la memoria,
o ridurti il corpo e l’anima in cenere. Ma decise di non pensarci. Era la loro unica
occasione.
Il fiume era sempre più vicino. All’ultimo secondo Percy lanciò un urlo di sfida.
L’acqua esplose in un geyser gigantesco e li inghiottì.
VI
ANNABETH
L’impatto non la uccise, ma per poco non ci riuscì il freddo. L’acqua gelida le
prosciugò l’aria dai polmoni.
Annabeth si irrigidì e perse la presa su Percy. Cominciò ad affondare. Degli strani
gemiti le riempirono le orecchie: milioni di voci strazianti, come se il fiume fosse
fatto di tristezza distillata. Le voci erano peggiori del freddo. La appesantivano, le
intorpidivano la mente.
―Che senso ha lottare?‖ le dicevano. ―Tanto sei morta. Non te ne andrai mai di
qui.‖
Avrebbe potuto toccare il fondo, annegare e lasciare che il fiume si portasse via il
suo corpo. Sarebbe stato più facile. Bastava chiudere gli occhi e…
Percy l’afferrò per una mano e la scosse, riportandola alla realtà. Lei non riusciva a
vederlo nell’acqua torbida, ma d’un tratto non voleva più morire. Insieme, si
slanciarono verso l’alto ed emersero in superficie.
Annabeth spalancò la bocca e i polmoni, grata di respirare, sebbene l’aria fosse
sulfurea. Vide che l’acqua roteava intorno a loro, e si rese conto che Percy stava
creando un vortice per tenerli a galla.
Pur non riuscendo a distinguere nulla del paesaggio circostante, sapeva che quello
era un fiume. E i fiumi hanno sempre due rive. — Terra — gracchiò. —
Spostiamoci di lato.
Percy sembrava quasi morto dallo sfinimento. Di solito l’acqua lo rinvigoriva, ma
quell’acqua no. Controllarla aveva prosciugato tutte le sue forze.
Il vortice cominciò a dissolversi. Annabeth si allacciò con un braccio alla vita di
Percy e cercò di nuotare sfidando la corrente. Il fiume lavorava contro di lei:
migliaia di voci gementi le bisbigliavano alle orecchie, si insinuavano nella sua
testa.
―La vita è disperazione‖ dicevano. ―Tutto è vano, e alla fine muori.‖
— Vano — mormorò Percy. Batteva i denti dal freddo. Smise di nuotare e
cominciò ad affondare.
— Percy! — strillò la figlia di Atena. — Il fiume ti sta confondendo la mente. È il
Cocito, il Fiume del Lamento. È fatto di infelicità pura!
— Infelicità — concordò Percy.
— Combattila!
Annabeth scalciò e lottò con tutte le sue forze, sforzandosi di tenere entrambi a
galla. Un altro scherzetto cosmico a tutto vantaggio delle risate di Gea: la figlia di
Atena che muore cercando di impedire al suo ragazzo, il figlio di Poseidone, di
affogare.
―Scordatelo, vecchia strega‖ pensò. Abbracciò Percy più forte e lo baciò. —
Parlami di Nuova Roma — ordinò. — Quali erano i tuoi progetti per noi?
— Nuova Roma… per noi…
— Sì, Testa d’Alghe. Hai detto che lì potremmo avere un futuro. Racconta!
Annabeth non aveva mai desiderato lasciare il Campo Mezzosangue. Era l’unica
vera casa che avesse mai conosciuto. Ma giorni prima, sull’Argo II, Percy le aveva
detto che aveva immaginato per loro un futuro insieme, fra i semidei romani. Nella
città di Nuova Roma, i veterani della legione potevano sistemarsi in tutta sicurezza,
andare all’università, sposarsi, perfino avere figli.
— Architettura — mormorò Percy. Il suo sguardo cominciò a snebbiarsi. — Penso
che ti piacerebbero le case, i parchi. C’è una strada piena di fontane bellissime.
Annabeth cominciò a fare progressi contro la corrente. Le sembrava di avere sacchi
di sabbia bagnata al posto delle braccia e delle gambe, ma finalmente Percy la
stava aiutando. La linea scura della costa era ormai vicina. — L’università —
ansimò. — Potremmo andarci insieme?
— Sì — confermò lui, in un tono un po’ più saldo.
— Tu che cosa studieresti?
— Non lo so — ammise Percy.
— Scienze marine — suggerì lei. — Oceanografia?
— Surf?
Annabeth rise, e il suono sprigionò un’onda d’urto nell’acqua. I lamenti si
ridussero a un rumore di sottofondo. Chissà se qualcuno aveva mai riso nel Tartaro
prima di allora. Una pura e semplice risata di gusto. Annabeth ne dubitava.
Usò gli ultimi residui di forza per raggiungere l’argine e affondò i piedi nella
sabbia. Lei e Percy si trascinarono a riva e, scossi dai brividi e dai singulti,
crollarono sulla spiaggia scura.
Annabeth avrebbe tanto voluto accoccolarsi accanto a Percy e dormire. Voleva
chiudere gli occhi, sperare che tutto fosse soltanto un brutto sogno e risvegliarsi a
bordo dell’Argo II, al sicuro insieme ai suoi amici. Be’… al sicuro nei limiti di
quanto era concesso a una semidea.
Invece no. Erano davvero nel Tartaro. Ai loro piedi, il fiume Cocito scorreva in un
boato, una marea di sventura liquida. L’aria sulfurea bruciava i polmoni e
pizzicava la pelle. Quando si guardò le braccia, Annabeth vide che erano già rosse
di orticaria. Cercò di mettersi a sedere, e una fitta di dolore le tolse il fiato.
La spiaggia non era fatta di sabbia. Erano seduti su una distesa di schegge di vetro
acuminate, alcune delle quali le si erano conficcate nel palmo delle mani.
L’aria era acida. L’acqua era infelicità pura. Il terreno, un vetro rotto. Tutto in quel
posto era concepito per procurare dolore e uccidere.
Annabeth trasse un respiro tremante e si chiese se le voci nel Cocito non avessero
ragione. Forse lottare per la sopravvivenza era inutile. Sarebbero morti nel giro di
un’ora.
Accanto a lei, Percy tossì. — Questo posto puzza quanto il mio ex patrigno.
Annabeth riuscì a rispondere con un sorriso. Non aveva mai conosciuto Gabe il
Puzzone, ma ne aveva sentito molto parlare. Percy stava cercando di tirarla un po’
su, e lei lo amava per questo.
Se fosse caduta nel Tartaro da sola, pensò, avrebbe avuto il destino segnato. Dopo
tutto quello che aveva passato a Roma per trovare l’Athena Parthenos, aveva
raggiunto il limite. Non avrebbe fatto altro che raggomitolarsi su se stessa fino a
diventare un altro fantasma, sciogliendosi nel Cocito.
Ma non era sola. Aveva Percy. E questo significava che non poteva arrendersi.
Annabeth si costrinse a fare il punto della situazione. Il piede era ancora chiuso
nell’ingessatura di fortuna fatta di legno e plastica per imballaggi con le bollicine,
in un groviglio di ragnatele. Ma, quando lo liberò e lo mosse, sentì che non faceva
male. L’ambrosia che aveva mangiato nelle gallerie sotterranee di Roma le aveva
finalmente aggiustato le ossa.
Il suo zaino era sparito, perso durante la caduta, o forse portato via dalla corrente.
Odiava l’idea di aver smarrito il computer di Dedalo, con tutti i suoi programmi e i
suoi dati fantastici, ma c’erano problemi peggiori. Anche il pugnale di bronzo
celeste non c’era più, ed era la sua arma personale da quando aveva sette anni.
Quando se ne accorse fu davvero un brutto colpo, ma non era il momento di
pensarci. Rimandò i rimpianti a dopo. Che altro avevano?
Niente cibo, niente acqua… in pratica, niente viveri.
Che inizio promettente!
Lanciò un’occhiata a Percy. Sembrava messo male. Aveva i capelli scuri
appiccicati sulla fronte, la maglietta a brandelli, le dita scorticate per lo sforzo di
aggrapparsi alla sporgenza prima della caduta. Ma soprattutto, tremava tutto e
aveva le labbra blu.
— Dobbiamo muoverci, se non vogliamo rischiare l’ipotermia — disse Annabeth.
— Riesci ad alzarti?
Lui annuì, e si rimisero entrambi in piedi a fatica.
Annabeth gli cinse la vita con un braccio, anche se non avrebbe saputo dire chi
sosteneva chi. Perlustrò i dintorni con lo sguardo. In alto, non vide tracce della
galleria da cui erano precipitati. Non riusciva nemmeno a scorgere il soffitto della
caverna: c’erano solo nuvole color sangue che fluttuavano nella foschia grigia. Era
come guardare attraverso un fine miscuglio di cemento e succo di pomodoro.
La spiaggia di vetro nero si stendeva per una cinquantina di metri nell’entroterra,
per poi interrompersi bruscamente sul margine di una scogliera. Da quella
posizione Annabeth non riusciva a vedere cosa ci fosse sotto, ma il margine
scintillava di luce rossa, come illuminato da grandi fuochi. Un ricordo lontano si
affacciò nei suoi pensieri, qualcosa che riguardava il Tartaro e il fuoco.
Però, prima che lei potesse pensarci troppo, Percy trasse un respiro forte. —
Guarda. — Indicò a valle.
A una trentina di metri di distanza c’era una Fiat 500 rossa dall’aria familiare, con
il muso conficcato nella sabbia. Era tale e quale all’auto che aveva investito
Aracne spedendola dritta nel Tartaro.
Annabeth sperò che fosse uno sbaglio, ma quante Fiat 500 potevano esserci nel
Tartaro? Avrebbe preferito non avvicinarsi, però doveva controllare. Strinse forte
la mano di Percy e raggiunsero insieme il rottame. Uno dei copertoni dell’auto si
era staccato e galleggiava in un gorgo d’acqua putrida del Cocito. I finestrini erano
rotti; le schegge di vetro più chiaro erano sparse come zucchero a velo sulla
spiaggia scura. Sotto il tettuccio fracassato c’erano i brandelli luccicanti di un
gigantesco bozzolo di seta: la trappola che con l’inganno Annabeth aveva fatto
tessere ad Aracne. Impossibile sbagliarsi: era vuoto. Impronte trasversali
tracciavano sulla sabbia una pista diretta a valle… come se qualcosa di pesante,
munito di varie zampe, si fosse allontanato nell’oscurità.
— È viva. — Annabeth era così inorridita, così sconvolta da quell’ennesima
ingiustizia, che dovette reprimere l’impulso di vomitare.
— Siamo nel Tartaro — osservò Percy. — In pratica, è il cortile di casa dei mostri.
Forse quaggiù non possono essere uccisi. — Poi le rivolse uno sguardo
imbarazzato, come se si fosse reso conto di non essere molto utile per risollevare il
morale della squadra. — O forse ha una brutta ferita, e si è allontanata per andare a
morire da qualche parte.
— Ecco, preferisco questa ipotesi — concordò la figlia di Atena. Notò che Percy
aveva ancora i brividi. Neanche lei aveva molto caldo, nonostante l’aria bollente e
appiccicosa. Le ferite che le schegge di vetro le avevano procurato alle mani
stavano ancora sanguinando, cosa anomala per lei, che di solito guariva in fretta.
Faceva sempre più fatica a respirare. — Questo posto ci sta uccidendo — disse. —
Letteralmente, intendo. A meno che…
Tartaro. Fuoco. Il ricordo lontano si fece lucido.
Annabeth scrutò verso l’entroterra, in direzione della scogliera illuminata dalle
fiamme. Era un’idea assolutamente folle. Ma forse era la loro unica possibilità.
— A meno che? — la incalzò Percy. — Hai un piano geniale, vero?
— Ho un piano — mormorò Annabeth. — Non so quanto sia geniale. Dobbiamo
trovare il Fiume di Fuoco.
VII
ANNABETH
Quando si sporsero, Annabeth fu certa di avere firmato la loro condanna a morte.
La scogliera si affacciava su uno strapiombo di oltre venti metri, sul fondo del
quale si estendeva una versione da incubo del Grand Canyon: un fiume di fuoco si
apriva la strada in un crepaccio frastagliato di ossidiana. Il bagliore rosso della
corrente gettava ombre spaventose lungo le pareti di roccia.
Perfino in cima al canyon il calore era intenso. Il gelo del fiume Cocito non le
aveva ancora abbandonato le ossa, ma ora Annabeth si sentiva il volto ustionato.
Ogni respiro richiedeva uno sforzo, come se avesse il petto pieno di polistirolo. Le
ferite sui palmi sembravano sanguinare di più anziché di meno. Il piede, fino a
poco prima quasi guarito, era di nuovo dolorante, tanto da farle rimpiangere
l’ingessatura di fortuna. Trasaliva a ogni passo.
Ammesso di riuscire a scendere fino alla sponda del fiume di fuoco, cosa di cui
dubitava, il suo piano era una follia pura e semplice.
— Ehm… — Percy esaminò la scogliera. Indicò una minuscola fenditura che
percorreva diagonalmente tutta la parete, da cima a fondo. — Possiamo provare
con quella sporgenza. Forse così riusciamo a scendere.
Non disse che erano pazzi da legare. Riuscì perfino a sembrare speranzoso.
Annabeth gliene fu grata, ma ebbe lo stesso paura di condurlo a una morte certa.
Naturalmente, restando lì sarebbero morti comunque. Avevano già le braccia piene
di bolle a causa dell’esposizione all’aria del Tartaro. L’ambiente intero, lì, era sano
quanto il nocciolo di un reattore nucleare.
Percy partì per primo. La sporgenza era appena sufficiente per appoggiarvi gli
alluci, costringendoli ad aggrapparsi con le mani a qualsiasi fessura nella roccia.
Ogni volta che faceva pressione sul piede ferito, Annabeth avrebbe voluto gridare.
Si era strappata le maniche della maglietta e le aveva avvolte intorno ai palmi
insanguinati, ma aveva ancora le dita deboli e scivolose.
Pochi passi più sotto, Percy sbuffò aggrappandosi a un’altra crepa. — Allora, come
si chiama questo fiume di fuoco?
— Flegetonte — rispose Annabeth. — Dovresti concentrarti nella discesa.
— Flegetonte? — Percy si calò ancora un poco lungo la sporgenza. Erano più o
meno a un terzo del tragitto, a un’altezza tale da rimetterci la pelle in caso di
caduta. — Che vuol dire? Il ―flagello dei tonti‖?
— Non farmi ridere, ti prego.
— Sto solo cercando di prenderla alla leggera.
— Grazie — brontolò lei, rischiando quasi di perdere l’appiglio con il piede ferito.
— Precipiterò verso la morte con il sorriso sulle labbra.
Continuarono a scendere, un passo alla volta. Annabeth si sentiva bruciare gli
occhi per il sudore. Le tremavano le mani. Ma, con suo grande stupore, alla fine si
ritrovarono sani e salvi ai piedi della scogliera.
Inciampò prima di toccare il fondo, e Percy la prese al volo. Annabeth si allarmò
quando avvertì il calore febbricitante della sua pelle: Percy aveva delle bolle rosse
sul viso, come se avesse il vaiolo.
Quanto a lei, non ci vedeva bene. Si sentiva la gola in fiamme e lo stomaco stretto
in una morsa.
―Dobbiamo sbrigarci‖ pensò. — Al fiume — ordinò, cercando di non lasciar
trasparire il panico nella voce. — Possiamo farcela.
Avanzarono incerti su lastre di vetro scivolose, girando intorno a massi enormi,
evitando stalagmiti che li avrebbero trafitti al primo passo falso. I vestiti a brandelli
fumavano per il calore del fiume, ma i due ragazzi continuarono a procedere finché
non crollarono in ginocchio sulla riva del Flegetonte.
— Dobbiamo bere — disse Annabeth.
Percy barcollò, con gli occhi socchiusi. Dovette contare fino a tre prima di parlare.
— Ehm… dobbiamo bere il fuoco?
— Il Flegetonte scorre dal regno di Ade fino al Tartaro. — Annabeth riusciva a
parlare a stento; aveva la gola chiusa per il calore e per l’aria acida. — Il fiume è
usato per punire i malvagi. Ma alcune leggende lo chiamano… il Fiume della
Guarigione.
— Alcune leggende?
Annabeth deglutì, sforzandosi di rimanere lucida. — Il Flegetonte conserva intatti i
malvagi per permettere loro di tollerare i tormenti dei Campi della Pena. Credo…
credo che sia l’equivalente infernale del nettare e dell’ambrosia.
Percy trasalì quando un refolo di scintille si levò dal fiume, ruotando intorno al suo
viso. — Ma è fuoco. Come…?
— Così. — Annabeth infilò le mani nel fiume.
Una cosa stupida? Sì, però era convinta di non avere scelta. Se avessero aspettato
ancora, sarebbero svenuti e poi morti. Era molto meglio provare qualcosa di
sciocco e augurarsi che funzionasse.
Al primo contatto, il fuoco non risultò doloroso. Sembrava freddo, il che
probabilmente significava che era così caldo da sovraccaricare i nervi. Prima che
potesse cambiare idea, Annabeth raccolse il liquido infuocato nelle mani a coppa e
se lo portò alla bocca.
Si aspettava un sapore di benzina. Ma era molto, molto peggio. Una volta, in un
ristorante di San Francisco, aveva commesso l’errore di assaggiare un peperoncino
piccante che servivano insieme a un piatto indiano. Un solo, insignificante morso,
ed era stato come se il sistema respiratorio fosse sul punto di implodere. Bere dal
Flegetonte fu come ingurgitare un frappè di peperoncini indiani. Ogni singola
cavità del corpo si riempì di fuoco liquido. Annabeth si sentiva come se avesse
immerso la lingua in una friggitrice. Con gli occhi che versavano lacrime bollenti e
ogni poro della pelle in fiamme, crollò a terra scossa da violenti conati di vomito.
— Annabeth! — Percy la prese per le braccia e riuscì a impedirle di rotolare dentro
il fiume, appena in tempo.
Poi le convulsioni cessarono. Con un respiro strozzato, la figlia di Atena riuscì a
mettersi a sedere. Era sfibrata, con lo stomaco sottosopra, ma il respiro successivo
fu più facile. Le bolle che aveva sulle braccia cominciarono a svanire. — Ha
funzionato — gracchiò. — Percy, devi bere.
— Io… — Il figlio di Poseidone rivoltò gli occhi e le crollò addosso.
Disperata, Annabeth giunse le mani a coppa e raccolse altro fuoco. Ignorando il
dolore, fece gocciolare un po’ del liquido fiammeggiante nella bocca di Percy, che
non reagì. Provò di nuovo, versandogli in gola tutto il liquido raccolto.
Stavolta Percy sputò e tossì. Annabeth lo sostenne mentre era scosso dai tremiti,
con il fuoco magico che gli scorreva in corpo.
Poi la febbre scomparve. Le bolle svanirono. Percy riuscì a sedersi e schioccò le
labbra. — Che schifo! — esclamò. — Saporito, ma disgustoso.
Annabeth rise debolmente. Era così sollevata che le girava la testa. — Sì, direi che
è una buona sintesi.
— Ci hai salvato la vita.
— Per ora. Il problema è che siamo ancora nel Tartaro.
Percy strizzò gli occhi. Si guardò intorno come se comprendesse soltanto in quel
momento la vera portata del luogo in cui si trovavano. — Per la divina Era. Non ho
mai pensato che… be’, in effetti non so che cosa mi aspettassi. Forse che il Tartaro
fosse uno spazio vuoto, una voragine senza fondo. Ma questo è un posto reale.
Annabeth ripensò al paesaggio che aveva scorto durante la caduta: una serie di
altipiani che sprofondavano man mano nelle tenebre. — Non lo abbiamo ancora
visto tutto. Questa potrebbe essere solo la prima piccolissima parte dell’abisso, i
gradini d’ingresso.
— Lo stuoino davanti alla porta — borbottò Percy.
Scrutarono entrambi le nuvole color sangue che turbinavano nella foschia grigia.
Non avrebbero mai avuto la forza necessaria per risalire la scogliera, neanche
volendo. Ormai avevano solo due possibilità: seguire la corrente o andare verso la
fonte, costeggiando le rive del fiume Flegetonte.
— Troveremo una via d’uscita — decise Percy. — Le Porte della Morte.
Annabeth rabbrividì. Ricordava cos’aveva detto Percy poco prima di precipitare
nel Tartaro. Aveva fatto promettere a Nico Di Angelo che avrebbe condotto l’Argo
II nell’Epiro, sul versante mortale delle Porte della Morte. «Ci vediamo là» aveva
detto.
L’idea sembrava perfino più folle che bere il fuoco. Come avrebbero fatto loro due
a vagare nel Tartaro fino a trovare le porte? Erano riusciti a stento a percorrere un
centinaio di metri senza morire.
— Dobbiamo farlo — disse Percy. — Non soltanto per noi. Per tutti quelli che
amiamo. Le Porte della Morte vanno chiuse da entrambi i lati, o i mostri
continueranno ad attraversarle. Le forze di Gea invaderebbero il mondo.
Annabeth sapeva che aveva ragione. Però… quando tentò di immaginare un piano
efficace, si sentì sopraffare dai problemi logistici. Non avevano idea di come
localizzare le porte. Non sapevano quanto tempo ci sarebbe voluto, né se nel
Tartaro il tempo scorresse alla stessa velocità. Come avrebbero fatto a
sincronizzare un incontro con gli altri? E Nico aveva parlato di una legione di
mostri più potenti di Gea a guardia delle porte, sul versante del Tartaro. Di certo lei
e Percy non erano in grado di lanciarsi in un attacco frontale.
Annabeth decise di tenere tutti quei dubbi per sé. Sapevano entrambi di avere
scarse probabilità di successo. E poi, dopo la nuotata nel fiume Cocito, lei ne aveva
abbastanza di gemiti e lamentele. Si ripromise di non lagnarsi mai più in vita sua.
— Bene. — Trasse un respiro profondo, grata almeno che i polmoni non le
facessero male. — Se restiamo vicini al fiume, sapremo come curarci. Se seguiamo
la corrente…
Accadde così in fretta, che Annabeth sarebbe morta se fosse stata da sola.
Gli occhi di Percy puntarono qualcosa alle sue spalle.
Annabeth si voltò nell’istante in cui una grossa sagoma scura le si lanciava contro:
una massa indistinta, ringhiante e mostruosa, con le zampe sottili coperte di spine e
gli occhi malvagi e luccicanti. Ebbe solo il tempo di pensare: ―Aracne.‖ Ma era
impietrita dall’orrore, i sensi soffocati dall’odore dolciastro e nauseabondo del
mostro.
Poi udì lo scatto familiare della penna a sfera di Percy che si trasformava in spada.
La lama vibrò sopra la sua testa disegnando un arco di luce bronzea. Un gemito
orrendo riecheggiò per tutto il canyon.
Annabeth rimase ferma lì, stupita, mentre una polvere gialla – i resti di Aracne – le
pioveva intorno come polline arboreo.
— Stai bene? — Percy perlustrò con lo sguardo le scogliere e i massi circostanti, in
allerta per eventuali altri mostri, ma non ne comparve nessuno. La polvere dorata
del ragno si depositò sulle rocce di ossidiana.
Annabeth fissava sbigottita il ragazzo. La lama in bronzo celeste di Vortice brillava
ancora di più nell’oscurità del Tartaro. Mentre solcava l’aria spessa e bollente,
produceva un sibilo di sfida, come un serpente pronto ad attaccare.
— Lei mi… mi avrebbe ucciso — balbettò la figlia di Atena.
Percy scalciò la polvere depositatasi sulle rocce con un’espressione cupa e
insoddisfatta in viso. — È morta troppo facilmente, considerata la tortura che ti ha
inflitto. Meritava di peggio.
Annabeth non poteva negarlo, ma la durezza nella voce di Percy la turbò. Non
aveva mai visto nessuno infuriarsi o diventare così vendicativo per lei. Si sentì
quasi felice che Aracne fosse morta in fretta. — Come hai fatto a muoverti tanto
velocemente?
— Dobbiamo guardarci le spalle a vicenda, no? — Percy si strinse nelle spalle. —
Allora, stavi dicendo… seguiamo la corrente?
Annabeth annuì, ancora un po’ stordita. La polvere gialla si dissolse sulla riva
rocciosa ed evaporò. Almeno adesso sapevano che i mostri nel Tartaro si potevano
uccidere … anche se non avevano idea di quanto a lungo Aracne sarebbe rimasta
morta. Di certo lei non aveva alcuna intenzione di fermarsi per scoprirlo. — Sì,
seguiamo la corrente. Se il fiume arriva dai livelli superiori degli Inferi, dovrebbe
addentrarsi sempre di più nelle profondità del Tartaro…
— Perciò il fiume conduce in territori più pericolosi — concluse Percy. — Ovvero
il luogo in cui probabilmente si trovano le Porte della Morte. Siamo fortunati!
VIII
ANNABETH
Annabeth si sentiva crollare dallo sfinimento. Continuò ad arrancare, vagamente
stordita, cercando di mettere insieme un piano. In quanto figlia di Atena, i piani
avrebbero dovuto essere la sua specialità, ma era difficile escogitare strategie con
lo stomaco che brontolava e la gola secca. L’acqua infuocata del Flegetonte
l’aveva guarita e rinforzata, ma non era servita a placare la fame o la sete. Lo scopo
del fiume non era quello di farti stare bene, intuì. Serviva solo a mantenerti in
piedi, per poter subire i dolori strazianti della pena.
Avevano percorso solo qualche centinaio di metri quando Annabeth udì delle voci
– voci femminili che litigavano – e scattò subito in allerta. Bisbigliò: — Percy, giù!
— Lo trascinò dietro un masso lì accanto, infilandosi così vicina alla riva che per
poco non si incendiò le scarpe.
Dalla parte opposta, su uno stretto sentiero tra il fiume e le scogliere, le voci
ringhiavano, sempre più forti e più vicine. Annabeth cercò di respirare con calma.
Le voci suonavano vagamente umane, ma questo non significava nulla. Dava per
scontato che qualsiasi cosa lì nel Tartaro fosse un nemico. Non sapeva come mai
non li avessero ancora individuati, considerato che i mostri erano in grado di
fiutare la presenza di semidei, soprattutto quando erano potenti come Percy, figlio
di Poseidone. Annabeth dubitava che nascondersi dietro un masso sarebbe servito a
molto appena quelli avessero percepito il loro odore.
Tuttavia, quando furono più vicini, il tono delle voci non cambiò. I loro passi
irregolari – grat, pum, grat, pum – non si fecero più veloci.
— Presto? — chiese una voce gracchiante, come se stesse facendo i gargarismi nel
Flegetonte.
— Oh, santi numi! — esclamò un’altra. Sembrava molto più giovane e molto più
umana, come una ragazza con gli amici al centro commerciale. Chissà perché,
suonava familiare. — Siete verameeeente noiose! Ve l’ho detto, ci vogliono, tipo,
tre giorni da qui.
Percy afferrò il polso di Annabeth. La guardò allarmato, come se anche lui avesse
riconosciuto la voce della ragazza del centro commerciale.
Ci fu un coro di brontolii e di ringhi. Le creature – forse mezza decina, intuì
Annabeth – si erano fermate proprio dall’altra parte del masso, eppure
continuavano a non dare segni di essersi accorte dell’odore di semidei. Annabeth si
chiese se il proprio odore non fosse cambiato nel Tartaro, o se le altre esalazioni
fossero così potenti da mascherare l’aura.
— Comincio a chiedermi se tu conosci davvero la strada, ragazzina — disse una
terza voce, roca e vecchia come la prima.
— Oh, chiudi quella boccaccia zannuta, Serefone — replicò la ragazza. —
Quand’è stata l’ultima volta che sei fuggita nel mondo mortale? Io ci sono stata un
paio di anni fa. Conosco la strada! E so cosa ci aspetta, lassù. Voi non ne avete
idea!
— La Madre Terra non ti ha eletta a nostro capo! — strepitò una quarta voce.
Altri sibili, tafferugli e gemiti ferali, come in una zuffa tra giganteschi gatti
randagi.
Alla fine, la creatura di nome Serefone strillò: — Basta!
Il tafferuglio si interruppe.
— Ti seguiremo, per ora. Ma se tu non ci condurrai bene, se scopriamo che ci hai
mentito sulla convocazione di Gea…
— Io non mento! — sbottò la ragazza. — Credetemi, ho ottime ragioni per unirmi
a questa battaglia. Ho dei nemici da divorare, e voi banchetterete con il sangue
degli eroi. Vi chiedo soltanto di lasciarmi un bocconcino speciale… un bocconcino
di nome Percy Jackson.
Annabeth soffocò un ringhio. Dimenticò la paura. Avrebbe voluto saltare fuori e
disintegrare i mostri con il proprio pugnale di bronzo celeste. Peccato che lo avesse
perso.
— Credetemi… Gea ci ha chiamate, e ce la spasseremo un mondo — continuò la
ragazza. — Prima che questa guerra sia finita, mortali e semidei tremeranno al
suono del mio nome… Kelli!
Annabeth per poco non si lasciò sfuggire un grido. Lanciò un’occhiata a Percy:
perfino nella luce rossa del Flegetonte era pallido come un lenzuolo. ―Empuse‖
sillabò muovendo solo le labbra. ―Vampire.‖
Percy annuì, cupo.
Annabeth ricordava bene Kelli. Due anni prima, durante la giornata di
orientamento di Percy nella nuova scuola, lui e Rachel Dare erano stati attaccati da
empuse travestite da cheerleader. Una di loro era Kelli. In seguito, la stessa empusa
li aveva attaccati nel laboratorio di Dedalo. Annabeth l’aveva pugnalata alle spalle,
spedendola… lì. Nel Tartaro.
Le creature se ne andarono strascicando i piedi, le voci si fecero sempre più
indistinte.
Annabeth si arrischiò a fare capolino oltre il masso. E quello che vide confermò i
suoi sospetti: cinque donne si allontanavano zoppicando sulle gambe male
assortite: la destra di bronzo e meccanica, la sinistra villosa e con il piede asinino.
Avevano i capelli di fuoco e la pelle d’avorio. Indossavano brandelli di tuniche
greche, tranne la prima, Kelli, che portava una camicetta bruciacchiata e un
gonnellino a pieghe… il completo da cheerleader.
Annabeth strinse i denti. Aveva affrontato un sacco di brutti mostri nel corso degli
anni, ma aveva un odio particolare per le empuse.
Oltre alle zanne e agli artigli micidiali, erano abilissime nel manipolare la Foschia.
Erano in grado di cambiare forma e di usare la lingua ammaliatrice, convincendo i
mortali ad abbassare la guardia. Gli uomini erano le loro vittime privilegiate. La
tattica preferita delle empuse era di farli innamorare, per poi berne il sangue e
divorarne le carni. Come primo appuntamento non erano decisamente il massimo.
Kelli aveva quasi ucciso Percy. E poi aveva manipolato il suo vecchio amico Luke,
spingendolo a commettere gesta sempre più malvagie nel nome di Crono.
Percy si alzò. — Stanno andando alle Porte della Morte — mormorò. — Sai che
cosa significa?
Annabeth avrebbe preferito non pensarci, ma purtroppo quella banda di orripilanti
femmine vampire era l’incontro più fortunato che avessero mai potuto fare nel
Tartaro.
— Sì — ammise. — Dobbiamo seguirle.
IX
LEO
Leo passò la nottata a combattere con un’Atena di dodici metri.
Da quando avevano portato la statua a bordo, aveva un’ossessione: doveva capire a
tutti i costi come funzionava. Era certo che avesse poteri grandissimi. Doveva
esserci un interruttore segreto o uno spingidisco o qualcosa del genere.
Avrebbe dovuto dormire, ma non ci riusciva. Aveva trascorso ore a strisciare sopra
la statua, che occupava quasi tutta la stiva. I piedi di Atena erano incastrati
nell’infermeria, perciò bisognava infilarsi fra i suoi ditoni d’avorio se serviva una
pillola. Il corpo occupava tutto il corridoio di babordo, la mano tesa si infilava
nella sala motori, porgendo la statua di Nike a grandezza naturale nel palmo, come
a dire: ―Tieni, prendi un po’ di vittoria!‖ Il volto sereno di Atena occupava gran
parte delle stalle dei pegasi a poppa, che per fortuna erano vuote. Se Leo fosse
stato un cavallo magico, non avrebbe voluto abitare in una stalla con una dea della
saggezza extralarge che ti fissa di continuo.
La statua era incastrata così stretta che Leo dovette arrampicarvisi sopra e
insinuarsi fra le varie parti del corpo per cercare eventuali leve e pulsanti. Di
nuovo, non trovò nulla.
Aveva fatto ricerche. Sapeva che la statua era ricavata da un telaio di legno cavo
coperto di avorio e oro, il che spiegava perché fosse così leggera. Era in ottima
forma, considerato che aveva più di duemila anni; era stata rubata ad Atene,
trasferita a Roma e custodita in gran segreto nella caverna di un ragno per secoli.
La magia l’aveva conservata, pensò il figlio di Efesto, oltre al fatto che era
un’opera di grande maestria artigianale.
Annabeth aveva detto… be’, Leo cercò di non pensare a lei. Soffriva ancora molto
per la caduta di Annabeth e Percy nel Tartaro. Era colpa sua, ne era convinto.
Avrebbe dovuto assicurarsi che tutti fossero tornati a bordo sani e salvi prima di
cominciare a prelevare la statua. Avrebbe dovuto rendersi conto che il pavimento
della caverna era instabile.
Tuttavia piangersi addosso non sarebbe servito a recuperare Percy e Annabeth.
Doveva concentrarsi sui problemi che poteva risolvere.
Annabeth aveva detto che la statua era la chiave per la sconfitta di Gea: poteva
sanare la frattura fra i semidei greci e romani. E Leo pensava che non fosse
soltanto una cosa simbolica. Forse gli occhi di Atena sparavano raggi laser, o il
serpente dietro lo scudo sputava veleno. O forse la statua di Nike prendeva vita e si
scatenava come un ninja.
Leo immaginava tutte le cose divertenti che la statua avrebbe fatto se fosse stato lui
a progettarla, ma più la esaminava, più la sua frustrazione aumentava. L’Athena
Parthenos irradiava magia, perfino lui riusciva a sentirlo. Ma non sembrava fare
altro, a parte incutere timore con la sua semplice presenza.
La nave si inclinò di lato, in una manovra diversiva. Leo resistette all’impulso di
correre al timone. Jason, Piper e Frank erano in servizio con Hazel in quel
momento. Erano in grado di gestire qualunque problema fosse in corso. E poi
Hazel aveva insistito per mettersi al timone e guidarli attraverso il passo segreto di
cui le aveva parlato la dea della magia.
Si augurò che la figlia di Plutone avesse ragione su quella lunga deviazione verso
nord. Lui non si fidava di Ecate. Non capiva come mai una dea così inquietante
all’improvviso avesse deciso di rendersi utile.
Naturalmente, non si fidava della magia in generale. Ecco perché aveva tutti quei
problemi con l’Athena Parthenos. Non c’erano parti meccaniche. Qualunque cosa
la statua facesse, funzionava solo in virtù della stregoneria pura… e non era il
genere di cose che Leo apprezzasse. Avrebbe preferito che ci fosse una logica,
come in una macchina.
Alla fine, esausto, non riuscì più a pensare. Si rannicchiò con una coperta in sala
motori e rimase ad ascoltare il ronzio rassicurante dei vari congegni. Buford, il
tavolino meccanico, se ne stava quieto in un angolo in modalità sleep, e russava
emettendo lievi sbuffi di vapore: shhh, pfft, shh, pfft.
A Leo piaceva la propria cabina, ma si sentiva più al sicuro lì, nel cuore della nave,
in una stanza piena di meccanismi che sapeva come controllare. E poi forse, se
avesse trascorso più tempo nelle vicinanze dell’Athena Parthenos, a poco a poco
avrebbe recepito i suoi segreti.
— Ce la vediamo fra me e te, ragazzona — mormorò tirandosi su la coperta fino al
mento. — Alla fine dovrai collaborare. — Chiuse gli occhi e si addormentò.
Purtroppo questo significava solo una cosa: sogni.
Il figlio di Efesto stava fuggendo a rotta di collo nella vecchia officina di sua
madre, dove lei era morta quando lui aveva otto anni. Non sapeva di preciso che
cosa lo stesse inseguendo, ma era sempre più vicino, ed era grosso, malvagio e
carico di odio.
Leo inciampava fra i bancali, rovesciava cassette degli attrezzi e incespicava sopra
i cavi. Intravide l’uscita e si lanciò in quella direzione, ma una sagoma gli si stagliò
di fronte: una donna avvolta in vesti fatte di terra turbinante, con il viso coperto da
un velo di polvere.
―Dove vai, piccolo eroe?‖ La voce di Gea sembrava venire da ogni direzione.
―Resta, e fai la conoscenza del mio figlio preferito.‖
Leo scartò a sinistra, ma la risata della dea della terra lo seguì.
―La notte in cui tua madre morì, ti misi in guardia. Ti dissi che le Parche non
volevano concedermi di ucciderti, allora. Ma ora hai scelto la tua strada. La tua
morte è vicina, Leo Valdez.‖
Il figlio di Efesto andò a sbattere contro un tavolo da lavoro, la vecchia postazione
della madre. La parete dietro il tavolo era tappezzata dei disegni che lui stesso
aveva fatto con le matite colorate. Singhiozzò per la disperazione e si voltò, ma la
cosa che lo inseguiva gli intralciava il cammino: un essere colossale avvolto
nell’ombra, la forma vagamente umanoide, la testa che sfiorava il soffitto alto sei
metri.
Le mani di Leo si incendiarono. Colpì il gigante con una raffica di fuoco, ma le
tenebre estinsero le fiamme. Cercò di pescare qualcosa dalla cintura degli attrezzi,
ma le tasche erano cucite. Tentò di parlare – di dire qualunque cosa pur di salvarsi
la vita – ma non riusciva a emettere un suono, come se qualcuno gli avesse rubato
l’aria dai polmoni.
Fine dell'estratto Kindle.
Ti è piaciuto?
Scarica la versione completa di questo libri