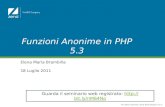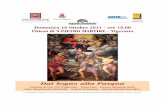Il «Copista del Digenis Akritas». Appunti su mani anonime salentine dei secoli XIII e XIV, in...
-
Upload
daniele-arnesano -
Category
Documents
-
view
108 -
download
4
description
Transcript of Il «Copista del Digenis Akritas». Appunti su mani anonime salentine dei secoli XIII e XIV, in...

BizantinisticaRivista di Studi Bizantini e Slavi
SERIE SECONDA
Anno VII - 2005
FONDAZIONE
CENTRO ITALIANO DI STUDI SULL’ALTO MEDIOEVOSPOLETO

DANIELE ARNESANO
Il « Copista del Digenis Akritas ».Appunti su mani anonime salentine
dei secoli XIII e XIV
L’intensa produzione libraria greca nel Salento medievale è testimoniatadai manoscritti giunti fino a noi in quantità considerevole 1. Il tentativo didelineare la storia grafica salentina incontra la sua maggiore difficoltà, oltreche nella varietà delle manifestazioni grafiche, nella quantità di testimonianzeda esaminare. L’indagine procede così nell’altalenante complementarietà tralo studio analitico dei manoscritti e l’imprenscindibile esigenza di ordinarli ingruppi omogenei 2. Nelle pagine seguenti propongo l’identificazione di alcu-ne mani, in forma di semplici “appunti” che dovrebbero contribuire a definiremeglio il panorama grafico. Si tratta, ad eccezione del copista Giorgio diAradeo 3, di mani anonime; soltanto per la prima, grazie al manoscritto piùimportante del quale essa è responsabile, ho formulato il nome convenzionaleche dà il titolo al presente lavoro. Tutte le mani esaminate rientrano nellatemperie storico-grafica definita da Victor Gardthausen “palaeographischeBarockzeit”, la quale incontrò una particolare fortuna nell’area salentina du-rante i secoli XIII e XIV 4.
1 Si veda O. MAZZOTTA, Monaci e libri greci nel Salento medievale, Novoli, 1989 (Scriptorium, 2), pp. 63-101 e D. ARNESANO, Il repertorio dei codici greci salentini di Oronzo Mazzotta. Aggiornamenti e integrazioni,in Tracce di storia. Studi in onore di monsignor Oronzo Mazzotta, a cura di M. SPEDICATO, Galatina, 2005, pp.27-82.
2 Talvolta è possibile attribuire due o più manoscritti alla stessa mano; tra i casi più recenti mi permetto dirinviare a D. ARNESANO, Il « Copista del Dioscoride ». Un anonimo salentino del secolo XIII, in Bollettino deiClassici, XXIV (2003), pp. 29-55.
3 Cfr. § 10.4 V. GARDTHAUSEN, Griechische Palaeographie, Leipzig, 1879, p. 197; A. JACOB, Les écritures de Terre
d’Otrante, in La paléographie grecque et byzantine (Paris, 21-25 octobre 1974), Paris, 1977 (Colloques inter-nationaux du Centre National de la Recherche Scientifique, 559), pp. 269-281: 273-276.

DANIELE ARNESANO136
1. Propongo di indicare come “Copista del Digenis Akritas” lo scriba ano-nimo responsabile del Crypt. Z. a. XLIV (Gr. 59) 5, autorevole testimone delfamoso poema epico, che ha giustamente stimolato una profonda riflessionenegli studiosi della letteratura bizantina, in particolare come opera “di frontie-ra” 6: ha osservato Guglielmo Cavallo che « la circolazione del Digenis Akri-tas in Terra d’Otranto non si può ritenere casuale, giacchè l’Italia meridiona-le, come l’Anatolia, terra d’origine del poema, fu zona bizantina di frontie-ra » 7. I ff. 1r-73r del codice criptense contengono la redazione più completadel Digenis Akritas (sigla G) 8, i ff. 73v-79v contengono la versione c delloSpaneas 9. Il manoscritto, in carta occidentale non filigranata, è stato vergatoda una sola mano 10, ma vanno registrati due interventi di una coeva manosalentina ai ff. 13v e 35v.
5 A. ROCCHI, Codices Cryptenses seu Abbatiae cryptae Ferratae in Tusculano digesti et illustrati cura etstudio D. A. Rocchi, hieromonachi basiliani bibliothecae custodis, Tusculani, 1883, pp. 469-470.
6 Per un’introduzione all’opera si veda P. ODORICO, Digenis Akritas. Poema anonimo bizantino, Firenze,1995, pp. XXI-LIII; più in particolare cfr. E. MALTESE, Un eroe di frontiera, ibid., pp. IX-XVII: X. Tra gli in-terventi più recenti si veda M. D. LAUXTERMANN, La poesia, in Lo Spazio Letterario del Medioevo, 3, Le culturecircostanti, I, La cultura bizantina, a cura di G. CAVALLO, Roma, 2004, pp. 301-343: 306-307 e C. CUPANE, Ilromanzo, ibid., pp. 407-453: 430-431, 449.
7 G. CAVALLO, Ai confini dell’impero. Appunti sulle culture di frontiera a Bisanzio, in corso di stampa ne-gli atti del terzo convegno europeo di studi medievali. Ringrazio Guglielmo Cavallo per aver messo gentilmen-te a mia disposizione il dattiloscritto.
8 E. JEFFREYS, Digenis Akritis. Edited and Translated, Cambridge, 1998 (Cambridge Medieval Classics, 7);C. JOUANNO, Digénis Akritas, le héros des frontières. Une épopée byzantine. Version de Grottaferrata, Tur-nhout, 1998; P. ODORICO, L’Akrite. L’épopée byzantine de Digénis Akritas, Toulouse, 2002; a queste edizioni ri-mando anche per l’ampia biliografia. Dal Crypt. Z. a. XLIV fu esemplato dal Rocchi l’odierno Crypt. Z. a.LXXII (Gr. 382): S. LUCÀ, Su origine e datazione del Crypt. B.b.VI (ff. 1-9). Appunti sulla collezione mano-scritta greca di Grottaferrata, in Tra Oriente e Occidente. Scritture e libri greci fra le regioni orientali di Bi-sanzio e l’Italia, a cura di L. PERRIA, Roma, 2003 (Testi e studi bizantino-neoellenici, 14), pp. 145-224: 211 n.296. La versione più antica del poema è quella contenuta nello Scorial. Y IV 22 (sigla E): F. RIZZO NERVO, Di-ghenís Akritis. Versione dell’Escorial, Soveria Mannelli, 1996 (Medioevo Romanzo e Orientale. Testi, 3).
9 G. DANEZIS, Spaneas. Vorlage, Quellen, Versionen, München, 1987 (Miscellanea Byzantina Monacensia,31), pp. 3, 163-170 (sigla G). Il codice criptense costituisce un ramo a se stante (appunto la versione c) dellacomplessa tradizione manoscritta, insieme al più recente Vat. gr. 1276 (ibid., sigla V): A. ACCONCIA LONGO - A.JACOB, Une anthologie salentine du XIVe siècle: le Vaticanus gr. 1276, in Rivista di Studi Bizantini e Neoelleni-ci, XVII-XIX (1980-1982), pp. 149-228: 212-213 nr. 25. I rapporti fra i due testimoni sono stati chiariti da G.SPADARO, Due redazioni inedite dello « Spaneas » (Vat. gr. 1276 e Cryptensis Z.a. XLIV), in XVI. Internationa-ler Byzantinistenkongress (Wien, 4.-9. Oktober 1981). Akten, II/3 (= Jahrbuch der Österreichischen Byzantini-stik, XXXII [1982]), pp. 277-288, tav. prima di p. 279 (f. 78r), cui si deve anche la corretta interpretazione diun’inscriptio che caratterizza i due manoscritti: in essa si sottolinea una vicinanza fra Comneni e Normanniche, letta in chiave politica filo-normanna, consente di collocarne l’origine proprio in area salentina ed ipotiz-zare che dell’importazione dello Spaneas sia stato responsabile Nettario di Casole (ibid., p. 282).
10 A. JACOB, scheda in Codici greci dell’Italia meridionale (Grottaferrata, Biblioteca del Monumento Nazio-nale, 31 marzo - 31 maggio 2000), a cura di P. CANART - S. LUCÀ, Roma, 2000, p. 132 nr. 60, con uno speci-men (f. 47v). Come ha notato lo studioso, nell’ultimo foglio (79v, rr. 7-22) una mano diversa (salentina e coe-va) ha vergato un frammento di oroscopo. Altri specimina in M. PETTA, Codici greci della Puglia trasferiti inbiblioteche italiane ed estere, in Bollettino della Badia Greca di Grottaferrata, XXVI (1972), pp. 85-129, tav.1 dopo p. 112 (f. 20v), tav. 2 prima di p. 113 (f. 59v).

IL « COPISTA DEL DIGENIS AKRITAS » 137
Al Copista del Digenis Akritas va attribuita anche la Schedografia Par. gr.2574 (Tav. I) 11. Numerosi manoscritti di contenuto schedografico furono pro-dotti nel Salento medievale, in gran parte ancora da studiare 12. In margine altesto del manoscritto parigino una mano più tarda ha annotato delle glosse inlingua romanza con alfabeto greco 13. Il medesimo copista è responsabile an-che dei ff. 50v-92v dell’Ambros. E 20 sup. 14. Si tratta di un codice membra-naceo, in parte palinsesto, vergato da quattro copisti; il primo (ff. 1-22v, 29r-50r) ed il secondo (ff. 23r-28v) hanno copiato la Liturgia di Giovanni Criso-stomo e la Liturgia dei Presantificati 15. Il Copista del Digenis Akritas ha tra-
11 H. OMONT, Inventaire sommaire des manucrits grecs de la Bibliothèque Nationale, Paris, 1886-1888 (ri-stampa Hildesheim-Zürich-New York, 2000), III, p. 7 (il catalogo di Omont è ora consultabile in rete: ht-tp://www.bnf.fr/pages/zNavigat/frame/catalogues—num.htm); il codice è palinsesto: ALFRED JACOB, Notes sur lesmanuscrits grecs palimpsestes de la Bibliothèque nationale, in Mélanges Julien Havet. Recueil de travaux d’é-rudition dédiés à la mémoire de Julien Havet (1853-1893), Paris, 1895, pp. 759-770: 767. Sulla schedografia siveda G. SCHIRÒ, La schedografia a Bisanzio nei secoli XI-XII e la scuola dei SS. XL Martiri, in Bollettino dellaBadia Greca di Grottaferrata, XIII (1949), pp. 11-29; R. BROWNING, Il codice Marciano Gr. XI.31 e la schedo-grafia bizantina, in Miscellanea Marciana di Studi Bessarionei, Padua, 1976 (Medioevo e Umanesimo, 24),pp. 21-34 (ristampato in Studies on Byzantine History, Literature and Education, London, 1977, nr. XVI).
12 Un’eccezione è il recente saggio di ’I. BASSHS, Tøn néwn filológwn palaísmata. ‘H sullogæ scedøn toûkådika Vaticanus Palatinus Gr. 92, in ’Ellhnikà, LII (2002), pp. 37-68. Il Par. gr. 2574 è stato attribuito al co-pista di una di queste schedografie, Nicola di Galatina, responsabile del Barb. gr. 102: H. GAMILLSCHEG, Zurhandschriftlichen Überlieferung byzantinischer Schulbücher, in Jahrbuch der Österreichischen Byzantinistik,XXVI (1977), pp. 211-230: 213-214; E. GAMILLSCHEG - D. HARLFINGER - H. HUNGER, Repertorium der griechi-schen Kopisten 800-1600, 2, Handschriften aus Bibliotheken Frankreichs und Nachträge zu den BibliothekenGrossbritanniens, Wien, 1989, nr. 446 = 3, Handschriften aus Bibliotheken Roms mit dem Vatikan, Wien,1997, nr. 526.
13 F. 45v (margine esterno): prosälutov / loû pailegrínou; f. 47r (margine esterno): o‘målax / lou bitzínou.Bibliografia sulle glosse dialettali salentine in D. ARNESANO, D. BALDI, Il palinsesto Laur. Plut. 57.36. Una notastorica sull’assedio di Gallipoli e nuove testimonianze dialettali italo-meridionali, in Rivista di Studi Bizantinie Neoellenici, XLI (2004), pp. 113-139: note alle pp. 130-131.
14 D. MARTINI, D. BASSI, Catalogus codicum graecorum Bibliothecae Ambrosianae, Milano, 1906 (ristampaHildesheim-New York, 1978), pp. 305-306. Ulteriore bibliografia presso http://www.ambrosiana.it. Come ilPar. gr. 2574, anche questi fogli sono stati attribuiti a Nicola di Galatina: A. JACOB, Les annales d’une famillesacerdotale grecque de Galatina dans l’Ambrosianus C 7 sup. et la peste en Terre d’Otrante à la fin du mo-yen âge, in Bollettino Storico di Terra d’Otranto, I (1991), pp. 23-51: 25. Mentre è indiscutibile l’identità dimano fra il manoscritto parigino e i ff. 50v-92v di quello ambrosiano, mi permetto di non condividere la loroattribuzione al copista di Galatina, che a mio avviso torna ad essere responsabile della sola schedografia barbe-riniana. Per la diversità fra le due mani (beninteso, assai simili, ma non identificabili) si veda la fine di questoparagrafo: si rilevano le differenze più significative fra la scrittura di Nicola di Galatina (citate in nota) e quel-la del nostro anonimo (descritta nel testo).
15 R. F. TAFT, A History of the Liturgy of St. John Chrysostom, IV, The Great Entrance, Roma, 1975(Orientalia Christiana Analecta, 200), in particolare pp. 170, 249 e n. 147, pp. 263, 295 e n. 43, pp. 301, 420(citato come Ambros. gr. 276); A. JACOB, Deux formules d’immixtion syro-palestiniennes et leur utilisationdans le rite byzantin de l’Italie méridionale, in Vetera Christianorum, XIII (1976), pp. 29-64: 39; ID., La lettrepatriarcale du Typicon de Casole et l’évêque Paul de Gallipoli, in Rivista di Studi Bizantini e Neoellenici,XXIV (1987), pp. 143-163: 162; R. F. TAFT, A History of the Liturgy of St. John Chrysostom, IV, The Dip-tychs, Roma, 1991 (Orientalia Christiana Analecta, 238), in particolare p. 139; ID., Byzantine Communion RitesII: Later Formulas and Rubrics in the Ritual of Clergy Communion, in Orientalia Christiana Periodica,LXVII (2001), pp. 275-352: 291 (Ambros. Gr. 276). Uno specimen della scrittura del primo copista in MAZZOT-TA, Monaci e libri greci cit., tav. XXIII (f. 50r).

DANIELE ARNESANO138
scritto la Liturgia di Basilio e le pericopi evangeliche del mattino 16; il quartocopista è responsabile delle epistole e delle pericopi evangeliche del tempocomune (ff. 93r-119v).
Nel codice fattizio della Biblioteca del Monumento Nazionale di Grotta-ferrata indicato con la moderna segnatura “Gr. 79” sono stati raccolti fram-menti di manoscritti eterogenei. Il f. 28, isolato e coincidente con l’antica se-gnatura A. d. XI, proviene da un codice palinsesto, contiene Salmi ed è statovergato dal Copista del Digenis Akritas 17.
Il Copista del Digenis Akritas esibisce una minuscola nel testo nitida eleggibile, nel commento barocca e aggrovigliata; essa rivela una mano espertae disinvolta, abituata ad un’intensa attività professionale. Come la maggiorparte delle scritture salentine, essa non presenta peculiarità esclusive, bensìun’impronta inconfondibile nella formulazione complessiva, nella concerta-zione di determinate opzioni grafiche. Si noti alpha maiuscolo con il corpocentrale ridotto ad un cerchietto o ad un piccolo triangolo 18, delta minuscolocon ansa protesa verso sinistra e spigolosa 19, la forma di zeta, lambda forma-to da due tratti quasi sempre dritti 20, sigma minuscolo con piccolo nucleo diforma circolare 21, tau alto con tratto orizzontale dritto e prolungato verso si-nistra 22, phi in due tempi inclinato a sinistra 23, infine psi a forma di crocecon boule all’inizio del tratto orizzontale 24.
2. Nel Par. gr. 2574 va registrato l’intervento di una seconda mano, che,collaborando con il Copista del Digenis Akritas, ha vergato i ff. 38r, 139v -140r (r. 12), 141r (rr. 16-21) (Tav. II). Essa è senza dubbio identificabile con
16 P. J. FEDWICK, Bibliotheca Basiliana Universalis. A study of the Manuscript Tradition, Translations andEditions of the Works of Basil of Caesarea, IV.2, Turnhout, 1999 (Corpus Christianorum), p. 753.
17 Esso è accuratamente descritto da LUCÀ, Su origine e datazione cit., pp. 172-173, tav. 15 (f. 28v); cfr. an-che E. CRISCI, I Palinsesti di Grottaferrata. Studio codicologico e paleografico, Napoli, 1990 (Pubblicazionidell’Università degli Studi di Cassino. Sezione di studi filologici, letterari, storici, artistici e geografici, 2), I,pp. 33 (descritto sotto la segnatura G. b. XXXVII), 137 (G. b. XXXVII b); si veda inoltre la descrizione dispo-nibile presso http://palin.iccu.sbn.it (sotto la segnatura Gr. 79).
18 Nicola di Galatina esibisce l’alpha “en fer de lance”: A. TURYN, Codices Graeci Vaticani saeculis XIII etXIV scripti annorumque notis instructi, Città del Vaticano, 1964, tav. 43 (f. 18r), r. 17.
19 Questa forma non è preferita né messa in evidenza da Nicola di Galatina.20 Nicola di Galatina tende ad arrotondare il secondo tratto e a prolungarlo vistosamente sotto la lettera se-
guente: ibid., rr. 1, 3, 6, 10, 13.21 Nicola di Galatina impiega un sigma di modulo maggiore e schiacciato: ibid., rr. 3, 4, 5.22 Il tau alto, più raro in Nicola di Galatina, non presenta questa caratteristica; il tratto orizzontale è nor-
malmente più corto e talvolta ondulato: ibid., rr. 9, 14 dal basso.23 Nicola di Galatina, che preferisce il phi “a chiave di violino” speculare e in legatura, esibisce un phi in
due tempi verticale o inclinato a destra: ibid., rr. 8, 9.24 Il tratto orizzontale è concavo e privo di boule in Nicola di Galatina: ibid., r. 2 dal basso.

IL « COPISTA DEL DIGENIS AKRITAS » 139
quella responsabile dei ff. 1r-212v dell’Etymologicum Gudianum Vindob.phil. gr. 158 25. I ff. 213r-237v, 239r-240v del codice viennese furono vergatidal Copista del Dioscoride e la mano anonima in questione si rivela preziosotrait d’union fra i due copisti, legandoli al medesimo periodo e alla stessaarea d’attività 26. Poiché nel manoscritto viennese la scrittura è minuta, piùcorsiva, eseguita più rapidamente e con uno strumento dalla punta più sottile,l’impression d’ensemble non suggerisce l’immediata identificazione; tuttaviaun’osservazione più accurata della grafia dei due manoscritti non lascia a mioavviso adito a dubbi. Tra le analogie si notino alpha maiuscolo con asta oriz-zontale anziché obliqua, la forma di beta maiuscolo, gamma alto “ad uncino”,la forma di csi, tau alto, phi in due tempi con il nucleo schiacciato, omegalegato all’accento acuto, le legature alpha-zeta ed epsilon-phi (con epsilon “agancio”), infine il compendio di kai.
3. Ad una stessa mano vanno attribuiti la Paracletica Veron. 134 27, l’ottoe-co, canonario e triodio Ambros. G 5 sup. (ff. 1r-111r, 113r-252r) 28 e i ff.356-365 dell’Ottob. gr. 1 (Tav. III) 29, menologio costituito da un nucleo ori-ginario del secolo XI-XII 30. Il codice ottoboniano circolò probabilmente in
25 H. HUNGER, Katalog der griechischen Handschriften der Österreichischen Nationalbibliothek, I, Wien, 1961,p. 261. Il codice è palinsesto ed è descritto anche presso http://palin.iccu.sbn.it. Sulla tradizione manoscritta dell’E-tymologicum Gudianum si veda ora E. SCIARRA, Note sul codice Vat. Barb. gr. 70 e sulla tradizione manoscritta del-l’Etymologicum Gudianum, in Selecta colligere, 2, a cura di R. M. PICCIONE, Alessandria, 2005, in corso di stampa(con uno specimen del codice di Vienna). Ringrazio Elisabetta Sciarra per aver messo gentilmente a mia disposizio-ne il dattiloscritto.
26 ARNESANO, Il « Copista del Dioscoride » cit., pp. 41-42, tav. IV (f. 227r).27 E. MIONI, Catalogo di manoscritti greci esistenti nelle biblioteche italiane, Roma, 1964 (Indici e Catalo-
ghi, XX), II, pp. 509-511. Il codice è palinsesto: M. FORMENTIN, I palinsesti greci della Biblioteca NazionaleMarciana e della Capitolare di Verona, in Díptuca, II (1980-1981), pp. 146-186: 185-186; uno dei tre codicesantiquiores è un autorevole testimone della Vita di S. Spiridione: P. VAN DEN VEN, La légende de S. Spyridonévêque de Trimithonte, Louvain, 1953 (Bibliothèque du Muséon, 33), pp. 57*-59*, 157* (sigla V), tav. 1 (f.31r); esso è vergato in un’antica minuscola a mio avviso assai vicina a scritture della “scuola niliana”; si con-fronti la grafia del Laur. 7.8, testimone delle Orazioni di Gregorio Nazianzeno prodotto in Calabria nel sec. X:scheda di M. C. VICARIO in Codici greci dell’Italia meridionale cit., pp. 49-51 nr. 9 (con uno specimen). Altrispecimina del manoscritto veronese in S. MARCHI, I Manoscritti della Biblioteca Capitolare di Verona. Catalo-go descrittivo redatto da don Antonio Spagnolo, Verona, 1996, p. 219 (f. 29r); A. PIAZZI, Biblioteca CapitolareVerona, Fiesole, 1994, p. 98 tav. XLVIII (29r), p. 99 tav. XLIX (f. 34v).
28 MARTINI, BASSI, Catalogus codicum graecorum cit., p. 448; bibliografia presso http://www.ambrosiana.it.29 E. FERON, F. BATTAGLINI, Codices manuscripti graeci Ottoboniani Bibliothecae Vaticanae, Romae, 1893,
pp. 3-6; bibliografia in P. CANART, V. PERI, Sussidi bibliografici per i manoscritti greci della Biblioteca Vatica-na, Città del Vaticano, 1970 (Studi e Testi, 261), p. 181; M. BUONOCORE, Bibliografia dei fondi manoscritti del-la Biblioteca Vaticana (1968-1980), Città del Vaticano, 1986, I (Studi e Testi, 318), p. 383; M. CERESA, Biblio-grafia dei fondi manoscritti della Biblioteca Vaticana (1981-1985), Città del Vaticano, 1991 (Studi e Testi,342), p. 142; ID., Bibliografia dei fondi manoscritti della Biblioteca Vaticana (1986-1990), Città del Vaticano,1998 (Studi e Testi, 379), p. 305. Rispetto agli studi precedenti, seguo la foliazione più recente (a matita, alcentro del recto di ogni foglio).
30 Questa parte antica del manoscritto fu vergata da due mani, per la seconda delle quali, in particolare,

DANIELE ARNESANO140
Basilicata o in Calabria, poiché una rozza mano del sec. XV appose, nel mar-gine inferiore del f. 362v, la seguente firma: † ’Egå a’delfòv ’Andréav tñvmonñv toû a’gíou ’Adrianoû kaì Natalíav 31. La scrittura dell’anonimo èmolto simile a quella del Copista del Digenis Akritas e se ne differenzia, al-dilà della minore disinvoltura e scioltezza del copista, per la forma di pochelettere: beta maiuscolo con l’occhiello di unione delle due pance molto incli-nato verso il basso (orizzontale invece nel Copista del Digenis Akritas), phiin due tempi inclinato a destra, psi con tratto orizzontale concavo.
4. Simile alla scrittura del Copista del Digenis Akritas è anche quella del-l’anonimo responsabile del meneo Ambros. D 62 sup. 32 e dei fogli di guardiadel canonario Ambros. D 65 sup. (ff. IV-2), acquistato a Soleto nel 1606 33. Ilnucleo originario di questo manoscritto, attribuibile al sec. XI, è a mio avvisodi origine calabrese e presenta analogie con le scritture della “scuola nilia-na” 34. Come il copista di cui si è detto al paragrafo precedente, l’anonimo in
Santo Lucà ha rilevato forti analogie con la scrittura di uno dei collaboratori del copista Luca cqamalóv, re-sponsabile del Vat. gr. 2025, che lo studioso ha localizzato in area lucana (pur non escludendo quella salenti-na): S. LUCÀ, I copisti Luca cqamalòv e Paolo tapeinòv, in Archivio Storico per la Calabria e la Lucania,LXVIII (2001), pp. 149-173: 156. Come notato già dallo studioso, salentini sono anche i ff. 1-2 e i ff. 366-368, del sec. XIII.
31 LUCÀ, I copisti Luca cqamalóv cit., p. 157 e n. 24.32 MARTINI, BASSI, Catalogus codicum graecorum cit., pp. 270-271. Precisamente i ff. 3r-168v. Si tratta di
un palinsesto realizzato raschiando un manoscritto di contenuto giuridico: C. FERRINI, Notizie su alcuni mano-scritti importanti per la storia del diritto greco-romano, in Byzantinische Zeitschrift, VI (1897), pp. 155-157:155; cfr. anche http://palin.iccu.sbn.it. I fogli di guardia (ff. I, 169) provengono dall’antico codice dal quale fu-rono ricavati anche quelli dell’Ambros. Q 57 sup. (ff. 221-223), sticherario vergato dal Copista del Dioscoride(ARNESANO, Il « Copista del Dioscoride » cit., pp. 42-43), e quelli del Ambros. G 36 sup. (ff. I-II, 189-190).Quest’ultimo è un salterio, acquistato a Galatone nel 1606, vergato in un artificioso “stile di Reggio”, assai si-mile a quello in cui è vergato il codex unicus delle Lettere di Aristeneto, Vindob. phil. gr. 310, in margine alquale Palagano d’Otranto, allievo di Nettario di Casole, vergò un epigramma: A. JACOB, Une épigramme de Pa-laganus d’Otrante dans l’Aristénète de Vienne et le problème de l’Odyssée de Heidelberg, in Rivista di StudiBizantini e Neoellenici, XXV (1988), pp. 185-203: 186-189 e tav. I (f. 32r). Bibliografia sui tre manoscrittiambrosiani e sui fogli di guardia presso http://www.ambrosiana.it.
33 MARTINI, BASSI, Catalogus codicum graecorum cit., pp. 272-273; bibliografia presso http://www.ambrosia-na.it. Precisamente i ff. IV-2; il f. IV (palinsesto, descritto presso http://palin.iccu.sbn.it) è senza riscontro; i ff.1-2 costituiscono un bifoglio. I ff. 3-55, 69, 92, 116, 149, 153, 171-172, 177-207 sono di restauro, vergati daun copista salentino del sec. XV-XVI; la mano presenta forti analogie con la scrittura di Roberto Maiorano diMelpignano, che nel 1496 ultimò il codice aristotelico Vindob. phil. gr. 2 e nell’anno 1500 parte del libro d’o-re Neap. II A 35: di quest’ultimo si veda la scheda di A. JACOB in Codici greci dell’Italia meridionale cit., p.151 nr. 74, con uno specimen; altri specimina in Mazzotta, Monaci e libri greci cit., tavv. XXIX-XXXI.
34 Un termine di confronto si trova ad esempio nel Vat. gr. 1506, ultimato nel 1024 da Atanasio: S. LUCÀ,Scritture e libri della « scuola niliana », in Scritture, libri e testi nelle aree provinciali di Bisanzio. Atti del se-minario di Erice (18-25 settembre 1988), a cura di G. CAVALLO, G. DE GREGORIO - M. MANIACI, Spoleto, 1991(Biblioteca del « Centro per il collegamento degli studi medievali e umanistici nell’Università di Perugia », 5),pp. 319-387: 349 e tav. 13b (f. 66r); GAMILLSCHEG, HARLFINGER, HUNGER, Repertorium der griechischen Kopisten800-1600, 3, Handschriften aus Bibliotheken Roms mit dem Vatikan cit., nr. 8.

IL « COPISTA DEL DIGENIS AKRITAS » 141
questione non presenta lo stesso livello di competenza grafica del Copista delDigenis Akritas; il risultato complessivo è modesto ed anzi proprio nel ductusincerto e talvolta quasi stentato risiede la diversità rispetto a quest’ultimo. Ledifferenze sostanziali si riducono infatti al solo beta maiuscolo, con la panciasuperiore sporgente e spigolosa rispetto a quella inferiore.
5. Per la realizzazione dell’Ambros. G 5 sup., l’anonimo di cui si è dettoal paragrafo 3 ricevette l’aiuto di un collaboratore, intervenuto ai ff. 111v-112v, 252v-262v e nel margine inferiore del f. 86r. La sua mano va senz’al-tro identificata con quella che ha vergato i ff. 113r-163v dell’Ambros. E 18sup., contenente la Historia ecclesiastica attribuita a Basilio, alla quale sonointercalati altri testi di carattere liturgico, tra i quali ampi estratti della Pro-theoria di Nicola d’Andida e la versificazione attribuita erroneamente a Psel-lo (Tav. IV) 35. I ff. 1r-112r dell’Ambros. E 18 sup. sono vergati in una mi-nuscola calabrese del sec. XII 36, mentre salentina e attribuibile al sec. XIII-XIV è la mano che è intervenuta ai ff. Ir, IVv, 112v. All’anonimo dei duecodici ambrosiani va attribuito anche il f. 107r del Barb. gr. 354, testimonedelle Pandette di Antioco in carta occidentale non filigranata 37, al quale fu-rono accorpati alcuni fogli vergati nel 1479 da Nicola Schinzari di Galati-na 38. Infine, all’anonimo copista va attribuito il foglio di guardia, provenienteda un libro liturgico membranaceo di mm 200 × 148, posto alla fine di unacinquecentina conservata presso la Biblioteca della Curia Vescovile di Nardò(Tav. V) 39. La scrittura si distingue per la notevole abilità e scioltezza delcopista, che fonde esecuzione rapida e risultato nitido. L’effetto complessivo
35 MARTINI, BASSI, Catalogus codicum graecorum cit., pp. 304-305; A. JACOB, Un opuscule didactique otran-tais sur la Liturgie eucharistique. L’adaptation en vers, faussement attribuée à Psellos, de la Protheoria de Ni-colas d’Andida, in Rivista di Studi Bizantini e Neoellenici, XIV-XVI (1977-1979), pp. 161-178: 164-167, 176.Ulteriore bibliografia presso http://www.ambrosiana.it.
36 S. LUCÀ, L’apporto dell’Italia meridionale alla costituzione del fondo greco dell’Ambrosiana, in Nuovericerche sui manoscritti greci dell’Ambrosiana. Atti del Convegno (Milano, 5-6 giugno 2003), a cura di C. M.MAZZUCCHI - C. PASINI, Milano, 2004, pp. 191-242: 224 nr. 1.
37 Bibliografia sul manoscritto in CANART - PERI, Sussidi bibliografici cit., p. 146; BUONOCORE, Bibliografiadei fondi manoscritti cit., I, p. 104; CERESA, Bibliografia dei fondi manoscritti della Biblioteca Vaticana (1981-1985) cit., p. 27; ID., Bibliografia dei fondi manoscritti della Biblioteca Vaticana (1986-1990) cit., p. 245.
38 JACOB, Les annales d’une famille cit., pp. 29-31, 43-45, tav. III (f. 119r).39 Ringrazio don Francesco Danieli, responsabile dell’archivio storico vescovile di Nardò, per avermi gen-
tilmente segnalato questo foglio di guardia. La cinquecentina, contenente Persio, è protetta all’inizio da un fo-glio di guardia proveniente da un libro liturgico latino a due colonne del sec. XIII-XIV ed è coperta da unapergamena ricavata da un atto notarile latino. Il volume, privo di segnatura, fa parte di un folto gruppo di librisottratti anni fa alla biblioteca, recentemente ritrovati e restituiti. Il fatto che il foglio vergato dal nostro anoni-mo si conservi a Nardò appare indizio troppo debole per ipotizzare un’attività di copia dello scriba nella citta-dina salentina.

DANIELE ARNESANO142
è di una pagina barocca ma non confusa, propria di una mano che nella suaspontaneità tradisce la probabile consuetudine con la scrittura dei documenti.Si osservano un forte contrasto modulare, un notevole prolungamento delleaste, legature vistose, sovrapposizioni e seminclusioni, svolazzi ed arabeschinei margini destro e inferiore della pagina. Si noti tra l’altro la forma di betamaiuscolo, ny maiuscolo, la forma di csi, le legature alpha-sigma e doppio-gamma, il compendio di kai.
6. All’opera di una stessa mano vanno attribuiti il Vat. Pii II gr. 15, notocome Etymologicum Reginense e come palinsesto dei Basilici 40, e il palinse-sto Neap. ex. Vindob. gr. 15, contenente l’Alessandra di Licofrone 41. A que-sto anonimo copista va attribuito anche il f. 75 (isolato) dell’Ambros. G 53sup. 42, codice della prima metà del sec. XIV sul quale si tornerà più avan-ti 43. La scrittura è una minuscola informale, corsiva, leggermente inclinata adestra, poco appariscente rispetto ad altre manifestazioni della minuscola ba-rocca otrantina. Tra le analogie si noti alpha “en fer de lance”, la forma dibeta maiuscolo, my maiuscolo e my minuscolo molto corsivi, tau alto contratto orizzontale corto e ondulato e ispessimento alla base del tratto verticale,phi in due tempi con il corpo centrale di forma quasi triangolare, le legatureepsilon-pi, sigma-iota e tau-iota.
7. Il manoscritto Vallic. C 7 è un codice membranaceo contenente il com-mento di Teofilatto di Bulgaria ai Vangeli ed è databile all’anno 1292 circa 44.
40 H. STEVENSON, Codices manuscripti graeci Reginae Svecorum et Pii PP. II Bibliothecae Vaticanae, Ro-mae, 1888, pp. 141-142. Sul testo della strato superiore si veda SCIARRA, Note sul codice Vat. Barb. gr. 70 cit.e tav. 9; sul testo dello strato inferiore si veda V. CAPOCCI, Il Card. Giovanni Mercati e il testo inedito deiframmenti del libro 59 dei Basilici da lui preparato per l’edizione (Cod. Vatic. fondo di Pio II gr. 15), in Ren-diconti dell’Istituto Lombardo. Classe di Lettere e Scienze Morali e Storiche, CVI (1972), pp. 495-517, tav. ap. 504 (f. 79r) e G. CAVALLO, La circolazione di testi giuridici in lingua greca nel Mezzogiorno medievale, inScuole, diritto e società nel Mezzogiorno medievale d’Italia, a cura di M. BELLOMO, II, Catania, 1987 (Studi eRicerche dei « Quaderni Catanesi », 8), pp. 87-136, tav. a p. 121 (f. 20r). Ulteriore bibliografia: CANART, PERI,Sussidi bibliografici cit., p. 299; Buonocore, Bibliografia dei fondi manoscritti cit., I, p. 583; CERESA, Biblio-grafia dei fondi manoscritti della Biblioteca Vaticana (1981-1985) cit., p. 237; ID., Bibliografia dei fondi ma-noscritti della Biblioteca Vaticana (1986-1990) cit., p. 360.
41 E. MIONI, Catalogus codicum graecorum Bibliothecae Nationalis Neapolitanae, I.1, Roma, 1992 (Indici ecataloghi, n.s., VIII), pp. 24-25; http://palin.iccu.sbn.it, con specimina e bibliografia.
42 MARTINI, BASSI, Catalogus codicum graecorum cit., pp. 473-474; bibliografia presso www.ambrosiana.it.43 Cfr. § 15.44 E. MARTINI, Catalogo di manoscritti greci esistenti nelle biblioteche italiane, Milano, 1893-1902; ristam-
pa Roma, 1967 (Indici e Cataloghi, XIX), II, pp. 54-56; K. ALAND, Kurzgefasste Liste der Griechischen Han-dschriften des Neuen Testaments, Berlin-New York, 1994 (Arbeiten zur Neuetestamentlichen Textforschung,1), p. 275 nr. l 933; A. JACOB, Une mention d’Ugento dans la Chronique de Skylitzès, in Revue des étudesbyzantines, XXXV (1977), pp. 229-235: 233-234; PH. HOFFMANN, La décoration du Parisinus graecus 2572,

IL « COPISTA DEL DIGENIS AKRITAS » 143
La mano principale (Tav. VI) 45 è la stessa che ha vergato il Par. gr. 1304, codicein carta italiana non filigranata 46. Quest’ultimo contiene, tra l’altro, parte deiTria syntagmata di Nettario di Casole 47, parte del resoconto della discussionesul Purgatorio avvenuta a Casole fra il metropolita di Corfù Giorgio Bardanesed il francescano Bartolomeo 48 e, dello stesso Bardanes, una lettera ai sacer-doti di Nardò su argomenti liturgici 49. La scrittura è un’esperta baroccaotrantina della fine del secolo XIII, nella quale si noteranno alpha maiuscolocon il corpo di forma triangolare o “a bandierina”, la forma di beta maiusco-lo, gamma minuscolo sbilanciato verso sinistra quando la lettera lega con lasuccessiva (talvolta con occhiello), delta minuscolo con un’ampia ansa pro-lungata verso sinistra, tau con il tratto orizzontale assai prolungato sotto il ri-go verso sinistra e terminante con una boucle quando la lettera è in legatura(ad. es. in meta-), la legatura epsilon-pi con l’occhiello spostato verso sini-stra, il compendio di -òn a forma di “=” inclinato.
8. L’Ambros. L 116 sup. è un codice di carta non filigranata, contenenteIliade e vergato da un unico copista 50. Alla sua mano va attribuito il Par.Coisl. 190, codice misto di pergamena palinsesta e carta non filigranata, testi-mone del Commento ai Salmi di Niceta di Eraclea 51. Il Par. gr. 2773 è un
schédographie otrantaise de la fin du XIIIe siècle (a. 1295-1296), in Mélanges de l’École Française de Rome.Moyen Age-Temps Modernes, 96 (1984), pp. 617-645: 628.
45 La seconda mano ha vergato i ff. 10r-52r: uno specimen in G. CAVALLO, La produzione libraria italo-gre-ca, in Lo spazio letterario del Medioevo, 1, Il Medioevo latino, I, La produzione del testo, I, a cura di G. CA-VALLO - C. LEONARDI - E. MENESTÒ, Roma, 1992, tav. 27 (f. 35r).
46 OMONT, Inventaire sommaire cit., I, p. 294; M.-TH. LE LEANNEC-BAVAVEAS, Les papiers non filigranés mé-diévaux dans les manuscrits grecs de la Bibliothèque Nationale de France, in Scriptorium, LIII (1999), pp.275-324: 309, 313. Le dimensioni dei due manoscritti differiscono notevolmente (Vallic. C 7, mm 320 × 230;Par. gr. 1304, mm 210 × 150), ma non a caso; il manoscritto vallicelliano ha infatti dimensioni identiche ad al-tri due testimoni di grande formato del commento di Teofilatto ai Vangeli, il Vat. gr. 1221 e l’Ambros. A 178sup. (che tuttavia presentano un’impaginazione a due colonne); sull’ambrosiano cfr. LUCÀ, L’apporto dell’Italiameridionale cit., pp. 205-206.
47 J. M. HOECK - R. J. LOENERTZ, Nikolaos von Otranto Abt von Casole. Beiträge zur Geschichte der Ost.westichen Beziehungen unter Innocenz III und Friedrich, Ettal, 1965 (Studia Patristica et Byzantina, 11), p. 99nr. 4 (sigla R), p. 103 (stemma).
48 M. RONCAGLIA, Georges Bardanès métropolite de Corfou et Barthélemy de l’Ordre Franciscain, Roma,1953 (Studi e testi francescani, 4), pp. 9, 37, 55 (sigla P), tav. 4 (ff. 4r, 4v).
49 HOECK - LOENERTZ, Nikolaos von Otranto cit., pp. 148, 207-209 nr. 17 (sigla P).50 MARTINI - BASSI, Catalogus codicum graecorum cit., pp. 603-604; G. CAVALLO, Lo specchio omerico, in
Mélanges de l’École Française de Rome. Moyen Age-Temps Modernes, CI (1989), pp. 609-627: 621, tav. 17;E. SCIARRA, La tradizione degli scholia iliadici in Terra d’Otranto, Roma, 2005 (Supplemento a Bollettino deiClassici, 23), pp. 14-20, tav. 1.
51 OMONT, Inventaire sommaire cit., III, p. 150; R. DEVREESSE, Catalogue des manuscrits grecs, II, Le fondsCoslin, Paris, 1945, p. 164; FEDWICK, Bibliotheca Basiliana Universalis cit., p. 939 sigla k5611; J. DORIVAL, Leschaînes exégétiques grecques sur les Psaumes, 3, Leuven, 1992 (Spicilegium Sacrum Lovaniense. Études etdocuments, 45), pp. 505-508 nr. 23, pp. 516, 541, 542, 547, 548; J. IRIGOIN, Les cahiers des manuscrits grecs,

DANIELE ARNESANO144
codice palinsesto, contenente le Opere e i giorni di Esiodo 52 ed un epigram-ma schedografico per due allievi di Taranto 53; esso è dovuto a tre copistiprincipali: il primo, identificabile con il nostro anonimo, è responsabile deltesto di Esiodo 54, agli altri due si deve il commento 55, disposto a pericopialternate ai versi 56. La scrittura dell’anonimo è una minuscola barocca leg-germente inclinata a destra, sciolta e corsiva, soprattutto nelle parti di com-mento. Si noti la forma di alpha e di beta maiuscoli, theta schiacciato contratto orizzontale leggermente ondulato, my maiuscolo, la forma di csi, tau al-to con tratto orizzontale corto e ondulato, phi quasi sempre in due tempi,omega aperto legato con l’accento, la legatura epsilon-pi, la legatura epsilon-
in Recherches de codicologie comparée. La composition du codex au Moyen Âge, en Orient et en Occident.Communications présentées à la table ronde tenue à l’École normale supérieure les 5 et 6 décembre 1990, éd.par PH. HOFFMANN, Paris, 1998, pp. 1-19: 12; LE LÉANNEC-BAVAVÉAS, Les papiers non filigranés cit., pp. 318-320. Si noti che il supporto, le dimensioni e la mise en page sono identiche a quelle di un codice di contenutoanalogo, il Vindob. Suppl. gr. 37, contenente le Orazioni di Gregorio di Nazianzo con il commento di Nicetadi Eraclea e ultimato nel 1265 da Nicola di Gallipoli: D. ARNESANO - E. SCIARRA, L’attività del copista Nicoladi Gallipoli e la tradizione manoscritta dell’Iliade in Terra d’Otranto, in Segno e Testo, I (2003), pp. 257-307:258-261.
52 OMONT, Inventaire sommaire cit., III, p. 38; T. DE MARINIS, La biblioteca napoletana dei re d’Aragona, I,Verona, 1969, p. 80; JACOB, Notes sur les manuscrits grecs palimpsestes cit., p. 769; F. SOLMSEN, Hesiodi Theo-gonia Opera et Dies Scutum, Oxonii, 19903, p. XXIII (sigla F).
53 Edito da A. JACOB, Les annales du monastère de San Vito del Pizzo, près de Tarente, d’après les notesmarginales du Parisinus Gr. 1624, in Rivista di Studi Bizantini e Neoellenici, XXX (1993), pp. 123-153:131-133.
54 Precisamente ff. 1r, 6r (rr. 1-13), 6v - 7v (r. 8), 7v (r. 18) - 9r (r. 4), 10r (rr. 9-12), 10v (rr. 8-ultimo),11r (rr. 18-ultimo), 12v (rr. 6-14), 13v (rr. 16-ultimo), 15v (rr. 2-18), 15v (r. 23) - 16r (r. 3), 16v (rr. 12-17),18r (rr. 7-12), 19v (rr. 6-12), 20v (rr. 10-14), 21v (rr. 1-6), 22r (rr. 5-10), 22v (r. 5) - 23r (r. 7), 24r (r. 17) -24v (r. 3), 25v (r. 18) - 26r (r. 4), 27r (rr. 4-12), 28r (rr. 1-7), 28v (rr. 17-22), 29r (r. 7) - 29v (r. 1), 30r (r. 23)- 30v (r. 7), 31v (r. 13) - 32r (r. 5), 33r, 33v (r. 10-ultimo), 34r (r. 15-ultimo), 35r (r. 7) - 35v (r. 3), 36r (rr.12 - ultimo), 37r (r. 12) - 37v, 39r (r. 16) - 39v (r. 5), 40v (r. 9) - 41r (r. 9), 42r (r. 16) - 42v (r. 6), 43r (rr. 1-12), 44v (r. 7) - 45r (r. 7), 46r (r. 17) - 46v (r. 10), 47v (r. 11) - 48r (r. 4), 49r (r. 4) - 49v (r. 4), 50v (r. 7),51r (r. 2), 52r - 52v (r. 3), 53r (r. 5) - 53v (r. 7), 54v (rr. 10-14), 56rv, 57v (rr. 9-17), 59v (rr. 6-ultimo), 60v(r. 19) - 61r (r. 7), 61v (r. 10) - 62r (r. 4), 65r-90r.
55 B: ff. 1v - 4v (r. 10), 5r (r. 8) - 5v, 7v (rr. 9-17), 10r (rr. 1-8), 10r (r. 13) - 10v (r. 7), 11r (rr. 1-17), 12v(rr. 15-ultimo), 14r - 15v (r. 2), 15v (rr. 18-22), 16r (rr. 4-ultimo), 16v (r. 22) - 18r (r. 6), 18r (r. 13) - 19v (r.5), 19v (r. 13) - 20v (r. 9), 21v (r. 7) - 22r (r. 4), 22r (r. 11) - 22v (r. 4), 23r (r. 8) - 24r (r. 16), 34r (rr. 1-13),34v - 35r (r. 6), 35v (r. 4) - 36r (r. 11), 36v - 37r (r. 11), 38r - 39r (r. 15), 39v (r. 6) - 40v (r. 8), 41r (r. 10) -42r (r. 15), 42v (rr. 7-ultimo), 43r (r. 13) - 44v (r. 6), 45r (r. 8) - 46r (r. 16), 46v (r. 11) - 47v (r. 10), 48r (r.5) - 49r (r. 3), 49v (r. 5) - 50v (r. 6), 51r (r. 3) - 51v, 52v (r. 4) - 53r (r. 4), 53v (r. 8) - 54v (r. 9), 54v (r. 15)- 55v, 57r - 57v (r. 8), 57v (r. 18) - 59v (r. 5), 60r - 60v (r. 18), 61r (r. 8) - 61v (r. 9), 90v; C: ff. 4v (r. 11) -5r (r. 7), 6r (rr. 14-ultimo), 9r (r. 5) - 9v, 12r-12v (r. 5), 13r-13v (r. 15), 16v (rr. 1-11), 20v (r. 15) - 21r, 24v(r. 4) - 25v (r. 17), 26r (r. 5) - 27r (r. 3), 27r (r. 13) -27v, 28r (r. 8) - 28v (r. 16), 28v (r. 23) - 29r (r. 6), 29v(r. 2) - 30r (r. 22), 30v (r. 8) - 31v (r. 12), 32r (r. 6) - 32v, 33v (rr. 1-9). I ff. 62r (r. 5) - 64v, 91r-94r, 95r-102r furono vergati da un quarto copista, i ff. ff. 102v-103v da varie mani secondarie; il f. 94v è bianco.
56 Specimen in A. BRYER, Byzantine Agricultural Implements: the Evidence of Medieval Illustrations of He-siod’s Works and Days, in Annual of the British School at Athens, LXXXI (1986), pp. 45-80: 55, 67, p. 63 fig.12; lo stesso foglio (59v) è riprodotto in G. DERENZINI, I disegni nei manoscritti delle Opere e Giorni di Esio-do: problemi della tradizione iconografica e testuale, in Arte profana e arte sacra a Bisanzio, a cura di A. IA-COBINI - E. ZANINI, Roma, 1995 (Milion, 3), pp. 447-461: 448, 455 fig. 3.

IL « COPISTA DEL DIGENIS AKRITAS » 145
rho ad “asso di picche” con il nucleo della seconda lettera schiacciato, epsi-lon-sigma con i nuclei delle due lettere spesso di forma oblunga, epsilon-csi,la legatura molto frequente omicron-ypsilon-sigma e quella phi-theta, infinel’articolo toû, formato da tau sovrapposto alla legatura omicron-ypsilon e conil tratto orizzontale legato all’accento.
9. All’opera di una stessa mano sono attribuibili tre manoscritti. Il primoè il Laur. 5.36, codice in carta italiana primitiva contenente i Tria syntagmatadi Nettario di Casole in greco e latino e la redazione completa del resocontodella discussione sul Purgatorio fra Giorgio Bardanes e Bartolomeo 57. Il se-condo manoscritto è il codice di Karlsruhe, Badische Landesbibliothek, Ette-nheim-Münster 6 58, contenente tra l’altro la Liturgia di Giovanni Crisostomocon la traduzione latina di Leone Toscano e la Liturgia di Basilio con la tra-duzione latina di Nicola d’Otranto 59. Il terzo manoscritto è il Laur. 32.20, te-stimone dell’Alessandra di Licofrone in carta filigranata databile ai primi an-ni del sec. XIV 60. Quest’ultimo dato conferma la datazione del codice diKarlsruhe alla fine del sec. XIII proposta dagli studiosi 61, senza poter oraescludere i primi anni del secolo successivo. Nel manoscritto di Karlsruhe ilcopista esibisce una minuscola più controllata rispetto al testimone dei Tria
57 A. M. BANDINI, Catalogus Codicum manuscriptorum Bibliothecae Medicae Laurentianae, Florentiae,1764-1770, I, pp. 60-62; HOECK - LOENERTZ, Nikolaos von Otranto cit., p. 77 n. 45, pp. 97, 99, 101-103 (siglaL1); RONCAGLIA, Georges Bardanès cit., pp. 9, 35, 37, 55 (sigla L), tav. 3 (ff. 6v, 7r); G. DE GREGORIO, TardoMedioevo grecolatino: manoscritti bilingui d’Oriente e d’Occidente, in Libri, documenti, epigrafi medievali:possibilità di studi comparativi. Atti del Convegno internazionale di studio dell’Associazione Italiana dei Pa-leografi e Diplomatisti (Bari, 2-5 ottobre 2000), a cura di F. MAGISTRALE - C. DRAGO - P. FIORETTI, Spoleto,2002, pp. 17-135: 102 e n. 178, 103, tav. XVII (f. 8r).
58 K. PREISENDANZ, Die Handschriften des Klosters Ettenheim-Münster. Neudruck mit bibliographischen Na-chträgen, Wiesbaden, 19732 (Die Handschriften der badischen Landesbibliothek in Karlsruhe, 9), p. 9; HOECK -LOENERTZ, Nikolaos von Otranto cit., pp. 77-82; i due studiosi avevano già notato l’analogia paleografica fra idue manoscritti (p. 77 n. 45).
59 A. JACOB, La traduction de la Liturgie de Saint Jean Crisostome par Léon Toscano, in Orientalia Chri-stiana Periodica, XXXII (1966), pp. 111-162: 116-117, 128; ID., La traduction de la Liturgie de Saint Basilepar Nicolas d’Otrante, in Bulletin de l’Institut Historique Belge de Rome, XXXVIII (1967), pp. 49-107; FED-WICK, Bibliotheca Basiliana Universalis cit., p. 675, sigla k3387; DE GREGORIO, Tardo Medioevo grecolatino cit.,pp. 98, 104-106 (con ulteriore bibliografia), tavv. XVIII-XIX.
60 BANDINI, Catalogus Codicum manuscriptorum cit., II, col. 173; E. B. FRYDE, Greek Manuscripts in thePrivate Library of the Medici, 1469-1510, The National Library of Wales-Aberystwyth, 1996, II, pp. 539, 781;G. CAVALLO, Libri greci e resistenza etnica in Terra d’Otranto, in Libri e lettori nel mondo bizantino. Guidastorica e critica, a cura di G. CAVALLO, Roma-Bari, 1990 (Biblioteca Universale Laterza, 325), pp. 155-178, pp.223-227: 226 n. 73. La filigrana è del tipo “Cercle”, come Briquet 2915 (a. 1305). I ff. 1-2, 83-101 sono di re-stauro umanistico: P. ELEUTERI, Francesco Filelfo copista e possessore di codici greci, in Paleografia e codico-logia greca. Atti del II Colloquio internazionale (Berlino - Wolfenbüttel, 17-21 ottobre 1983), a cura di D.HARLFINGER - G. PRATO, Alessandria, 1991 (Biblioteca di Scrittura e Civiltà, 3), pp. 163-179: 167-168; A. PERO-SA, Un commento inedito all’« Ambra » del Poliziano, Roma, 1994 (Humanistica, 15), p. 112.
61 Lo status quaestionis in DE GREGORIO, Tardo Medioevo grecolatino cit., pp. 105-106 n. 86.

DANIELE ARNESANO146
syntagmata, che è invece caratterizzato da una grafia più barocca, in ragionedella diversa tipologia testuale 62. La capacità del copista di adattare la pro-pria scrittura al tipo di testo risulta più evidente nel Laur. 32.20, nel quale ilkalligrafeîn del codice di Karlsruhe ed il tacugrafeîn del codice dei Triasyntagmata convivono nella stessa pagina, rispettivamente per i versi di Lico-frone e per il relativo commento (Tavv. VII-VIII) 63. Nella versione più ba-rocca, la scrittura si presenta ricca di sovrapposizioni e seminclusioni, a fortecontrasto modulare (soprattutto fra lettere oblunghe e lettere schiacciate); trale opzioni grafiche si noti la forma di beta maiuscolo, alpha maiuscolo moltoinclinato verso il basso, delta minuscolo con ansa vistosamente prolungataverso sinistra, epsilon maiuscolo di grande modulo con il tratto medianosporgente, theta oblungo con il tratto sinistro dritto e quello destro arcuato,kappa maiuscolo di grande modulo compresso lateralmente, kappa minuscoloin legatura con lettera precedente con il primo tratto raddoppiato e occhiella-to, la forma di csi, phi in due tempi con il nucleo schiacciato ed il tratto ver-ticale poco sporgente verso il basso, la legatura alpha-phi, la legatura omi-cron-ypsilon compressa lateralmente, alpha minuscolo sovrapposto alla letteraprecedente con il tratto finale prolungato verso il basso, il compendio di kai.Si noti infine che la particolare abbreviazione della preposizione parà con iltratto mediano di epsilon orizzontale anziché inclinato, notata da Andrè Jacobnel codice di Karlsruhe 64, è presente anche nel Laur. 5.36 65 e nel Laur.32.20 66.
10. Il Par. gr. 2572 fu ultimato nel 1295/6 da Giorgio, protopapa e figliodel prete Leone di Aradeo, che vi copiò una Schedografia, decorandone il te-
62 Cfr. DE GREGORIO, Tardo Medioevo grecolatino cit., p. 105. Lo studioso, inoltre, nota che “la confezionelibraria differisce tra i due manoscritti giacché in quello di Karlsruhe non solo è impiegata la pergamena, mavi è anche apposta una decorazione di buon livello; più in generale, il volume di contenuto liturgico si caratte-rizza per un aspetto meno dimesso e più elegante e omogeneo rispetto al libro ‘da lavoro’ recante i rudimentifondamentali nella quotidiana battaglia dottrinaria contro i ‘vicini’ cattolici” (ibid., n. 184).
63 Come noto, era propria dei copisti salentini più abili la capacità di modificare la grafia in base al testocopiato (anzitutto nel rapporto fra Grundtext e commento); cfr. A. JACOB, Un copiste du monastère de Casole:le hiéromoine Thomas, in Rivista di Studi Bizantini e Neoellenici, XXVI (1989), pp. 203-210: 207-208: « Lesmanuscrits liturgiques de la fin du XIIIe et du début du XIVe siècle offrent un aspect beaucoup moins tarabi-scoté que les manuscrits profanes contemporains et [qu’]ils ne renferment guère d’extravances calligraphiques.Les spécialistes apuliens de livres philosophiques, grammaticaux ou littéraires cherchent du reste à bannir lesfioritures de toute sorte et à adopter un style plus dépouillé lorsqu’ils transcrivent des textes destinés à l’usageliturgique ».
64 JACOB, Une mention d’Ugento cit., p. 233 n. 23.65 Ad es. f. 5r, r. 4 dal basso.66 Ad es. f. 6v, r. 14 e, dal basso, rr. 9, 10, 11; f. 60v, r. 10.

IL « COPISTA DEL DIGENIS AKRITAS » 147
sto con iniziali ornate in stile salentino 67. Alla mano di Giorgio di Aradeovanno attribuiti i ff. 121v (r. 3) - 135r del Vat. gr. 1408, codice in carta fili-granata databile ai primi anni del sec. XIV, contenente i Progymnasmata diAftonio, decorato con inziali identiche a quelle della schedografia parigina(Tav. IX) 68. A questo copista vanno anche attribuiti i ff. 1r-6r (r. 21) del Par.gr. 2970, manoscritto in carta filigranata contenente la Retorica e il De inven-tione di Ermogene 69. La scrittura di Giorgio di Aradeo è uno degli esempipiù rappresentativi della minuscola barocca otrantina. Essa attirò l’attenzionedi Herbert Hunger, il quale dapprima vi scorse l’influenza della “Fettaugen-Mode” 70, successivamente, in base ad una più corretta impostazione storico-grafica, la collocò tra le scritture librarie intrise di elementi della tradizionedocumentaria 71. Tra le analogie grafiche (le quali, è bene ricordarlo, dimo-strano l’identità di mano grazie non alla loro singolarità ma alla loro compre-senza) si notino alpha “en fer de lance”, alpha minuscolo con il nucleo diforma triangolare, la forma di beta maiuscolo, gamma alto con il tatto oriz-zontale leggermente incurvato verso l’alto, pi e tau minuscolo con boule ap-pesa all’attacco del tratto orizzontale, phi “a chiave di violino” speculare con
67 Scheda di PH. HOFFMANN in CH. ASTRUC et al., Les manuscrits grecs datés des XIIIe et XIVe siècles conser-vés dans les bibliothèques de France, I, XIIIe siècle, Paris, 1989, pp. 64-67, nr. 27, tavv. 67-69 (ff. 27r, 38r,120v); GAMILLSCHEG - HARLFINGER - HUNGER, Repertorium der griechischen Kopisten 800-1600, 2, Handschriftenaus Bibliotheken Frankreichs und Nachträge zu den Bibliotheken Grossbritanniens cit., nr. 100. Sulla decora-zione: HOFFMANN, La décoration du Parisinus graecus 2572 cit.; ID., Aspetti della cultura bizantina in Aradeodal XIII al XVII secolo, in Paesi e figure del vecchio Salento, a. c. di A. DE BERNART, III, Galatina, 1989, pp.65-88 (ambedue i contributi sono corredati di numerosi specimina).
68 Inventarium codicum Vaticanorum Graecorum 993-2160, II, Vaticani graeci 1194-1523 [Biblioteca Apo-stolica Vaticana, Sala Cons. Mss. 323], ff. 380v-381r; la filigrana è del tipo “Lettres assemblées”, come Bri-quet 9510 (a. 1305: ARNESANO, Il « Copista del Dioscoride » cit., p. 48 n. 137); il f. 135v è bianco. Per il testocfr. H. RABE, Aphtonius. Progymnasmata, Lipsiae, 1926, p. XXXII (sigla Vw). I ff. 136r-224v sono attribuibili avarie mani del secolo XV-XVI (i ff. 150v-152v sono bianchi): cfr. E. MIONI, L’Antologia greca da MassimoPlanude a Marco Musuro, in Scritti in onore di Carlo Diano, Bologna, 1975, pp. 263-309: 293 e n. 62, 294. Ilcodice appartenne a Fulvio Orsini: P. DE NOLHAC, La bibliothèque de Fulvio Orsini, Paris, 1887 (ristampa Ge-nève, 1976), p. 340 nr. 56.
69 OMONT, Inventaire sommaire cit., III, p. 76. Il codice è composito. I ff. 1-79 sono dei primi anni del sec.XIV (la filigrana è del tipo “Lettres assemblées”, come Briquet 9513); i ff. 16v-28v, 30r-51v, 52v-79v furonovergati da una mano attiva nella cerchia di Droso di Aradeo, la quale appose inoltre delle annotazioni margina-li nel resto del manoscritto: D. ARNESANO, Aristotele in Terra d’Otranto. I manoscritti fra XIII e XIV secolo, inSegno e Testo, IV (2006), in corso di stampa, § 5 (con uno specimen); i ff. 80-100, contenenti la Batracomio-machia, furono vergati da Nettario di Casole, copista della metà del sec. XV: A. JACOB, Deux copies salentinesde l’inscription bizantine de la cathédrale de Bari (Ambrosianus B 39 sup. et Laurentianus 59, 45), in Quellenund Forschungen aus italienischen Archiven und Bibliotheken, LXXIII (1993), pp. 1-18: 8.
70 H. HUNGER, Die Sogenannte Fettaugen-Mode in griechischen Handschriften des 13. und 14. Jahrhunder-ts, in Byzantinische Forschungen, IV (1972), pp. 105-113 (ristampato in Byzantinistische Grundlagenfor-schung, London, 1973, nr. II): 110, tav. VII (f. 49v).
71 H. HUNGER, Elemente der byzantinischen Urkundenschrift in literarischen Handschriften des 12. und 13.Jahrhunerts, in Römische Historische Mitteilungen, XXXVII (1995), pp. 27-40: 34-35, tav. 23 (f. 27r); cfr. an-che ARNESANO, Il « Copista del Dioscoride » cit., p. 46 n. 124.

DANIELE ARNESANO148
il nucleo di piccolo modulo ed il tratto verticale molto prolungato sotto il ri-go, la legatura epsilon-pi, le inclusioni di ny o sigma in omicron, il compen-dio di kai, il compendio di -òn a forma di “=” molto allungato. Si noti infine,nel manoscritto Vat. gr. 1408, il chi monocondiliare decorato che dall’ultimorigo si estende nel margine inferiore, identico a quelli esibiti nel Par. gr.2572 72: l’abile copista di Aradeo porta alle estreme conseguenze le dinami-che intime della “palaeographische Barockzeit”: la trasformazione dell’espe-diente cancelleresco in vezzo librario, della scrittura in disegno, della letterain immagine.
11. I ff. 1r-121v (r. 3) del Vat. gr. 1408, esaminato nel paragrafo prece-dente, furono vergati da una mano (Tav. X, Fig. 1) che collaborò con Giorgiodi Aradeo, alla quale vanno attribuiti i ff. 9-50 del Vat. gr. 2296, codice co-stituito da sezioni eterogenee 73. Ai ff. 9-50 del manoscritto vaticano, prove-nienti da un salterio membranaceo di piccole dimensioni 74, va aggiunto ilVindob. phil. gr. 49, codice cartaceo contenente Iliade (Tav. X, Fig. 2) 75.L’anonimo collaboratore di Giorgio realizza con disinvoltura una minuscolaregolare e chiara, più posata nel salterio, più sciolta e barocca nei testimonidi Aftonio e di Omero, in ragione della diversa tipologia testuale. Si noti ep-silon maiuscolo di piccolo modulo inclinato a sinistra, theta in due tempi in-clinato a sinistra o a destra e talvolta con il tratto orizzontale sporgente fino atoccare la lettera seguente, ny maiuscolo, pi e tau minuscolo con trattino diispessimento all’inizio del tratto orizzontale, tau alto con tratto orizzontaleconvesso 76, phi in due tempi con il nucleo a forma di piccolo triangolo ed il
72 ASTRUC et al., Les manuscrits grecs datés cit., tav. 68 (f. 38r).73 I. COZZA LUZI, Inventarium codicum Graecorum Bibliothecae Vaticanae a 1501 ad 2402 [Biblioteca Apo-
stolica Vaticana, Sala Cons. Mss. 324], f. 229rv. Bibliografia in CANART - PERI, Sussidi bibliografici cit., p. 700;BUONOCORE, Bibliografia dei fondi manoscritti cit., II (Studi e Testi, 319), p. 970. Cfr. anche S. LILLA, I mano-scritti Vaticani Greci. Lineamenti di una storia del fondo, Città del Vaticano, 2004 (Studi e Testi, 415), p. 103.Tra le varie parti che costituiscono il codice c’è un eucologio (ff. 172-179), studiato da A. JACOB, Fragments li-turgiques byzantins de Terre d’Otrante, in Bulletin de l’Institut Historique Belge de Rome, XLIII (1973), pp.345-376: 368-373.
74 A. RAHLFS, Verzeichnis der griechischen Handschriften des Alten Testaments, Berlin, 1914, p. 274, sigla1804; JACOB, Fragments liturgiques byzantins cit., p. 368, tav. IX.
75 HUNGER, Katalog der griechischen Handschriften cit., pp. 171-172; SCIARRA, La tradizione degli scholiailiadici cit., pp. 50-54, tav. 13 (f. 69v); nel margine esterno del f. 14r un lettore ha vergato il testo di una pre-ghiera alla Vergine in lingua romanza: R. DISTILO, Scripta letteraria greco-romanza. Appunti per due nuovi te-sti in quartine di alessandrini, in Cultura Neolatina, XLVI (1986), pp. 79-99 (ristampato in Miscellanea di stu-di in onore di Aurelio Roncaglia a cinquant’anni dalla sua laurea, Modena, 1989, II, pp. 515-535), con unospecimen.
76 Molto raramente il tratto orizzontale è corto e ondulato: si osservi l’identica sequenza -ata in Vat. gr.1408, f. 38r, r. 4 dal basso e Vat. gr. 2296, f. 20r (JACOB, Fragments liturgiques byzantins cit., tav. IX), r. 9.

IL « COPISTA DEL DIGENIS AKRITAS » 149
tratto verticale prolungato sotto rigo, psi con il tratto orizzontale dritto e all’i-nizio piegato ad angolo retto verso l’alto, la legatura alpha-theta con il nu-cleo di alpha ridotto ad un cerchietto 77, la legatura di gamma maiuscolo, disigma e di tau con eta maiuscolo, il compendio di kai.
12. Ho già avuto modo di segnalare l’identità del copista responsabile didue manoscritti aristotelici, il Laur. 72.19 (ff. 1r-59v), contenente Analiticiprimi con il commento di Giovanni Filopono, ed il Magd. Coll. gr. 15 (ff. 9r-10v, 13r-81r), contenente il trattato Sull’interpretazione con il commento diMichele Psello 78. I due manoscritti facevano parte di un’edizione dell’Orga-non e furono prodotti forse su commissione; ambedue sono assai curati nellamise en page, nella decorazione e nella scrittura. Allo stesso copista va attri-buito anche il Par. gr. 1255, manoscritto membranaceo di buona qualità, co-dex unicus del Dialogo contro i Giudei di Nettario di Casole 79, ed il f. 7vdel già citato Par. gr. 2970 80. La scrittura dell’anonimo copista mostra un’in-cipiente rigidità del ductus, tipica di certe manifestazioni della minuscola ba-rocca otrantina degli inizi del sec. XIV. Nitida e leggibile anche nelle parti dicommento, essa è caratterizzata da moderato contrasto modulare, scarsezza dilegature e da un generale schiacciamento; l’andamento curvilineo è ulterior-mente addolcito dall’ondulamento di alcuni tratti, soprattutto quelli orizzontalidi gamma alto, tau e psi. Analogie più specifiche sono la predilezione di al-pha minuscolo, beta maiuscolo di piccolo modulo, theta aperto anche quandonon è in legatura con la lettera precedente, la forma di csi, le legature alpha-phi, pi-iota, sigma-phi, tau-iota. Si noti il doppio lambda con il tratto finaledel secondo prolungato ad abbracciare dal basso la lettera successiva. Tra le
77 Ad es. Vat. gr. 1408, f. 39r, r. 6; Vat. gr. 2296, f. 15r, r. 10.78 ARNESANO, Il « Copista del Dioscoride » cit., p. 29 n. 3; ID., Aristotele in Terra d’Otranto cit. § 4. Descri-
zione rispettivamente di D. HARLFINGER in Aristoteles graecus. Die griechischen Manuskripte des Aristoteles,hrsg. von P. MORAUX, Berlin-New York, 1976 (Peripatoi, 8), pp. 252-253 e di I. HUTTER, Corpus der Byzantini-schen Miniaturenhandschriften, 5, Stuttgart, 1997, 1, pp. 90-92, 2, p. 170 figg. 393-395 (ff. 63v, 66v, 36v), p.171 fig. 396 (f. 69v); digitalizzazione integrale a colori presso http://image.ox.ac.uk/show?collection=magda-len&manuscript=msgr15. I manoscritti sono ambedue cartacei e presentano identiche dimensioni; il codice diOxford è in carta non filigranata (ibid., 5.1, p. 90), quello di Firenze è di carta filigranata databile ai primi annidel sec. XIV (HARLFINGER in Aristoteles graecus cit., p. 252).
79 OMONT, Inventaire sommaire cit., I, p. 277; HOECK, LOENERTZ, Nikolaos von Otranto cit., p. 35 n. 31; A.KÜLZER, Disputationes Graecae contra Iudaeos. Untersuchungen zur byzantinischen antijüdischen Dialoglitera-tur und ihrem Judenbild, Stuttgart-Leipzig, 1999 (Byzantinisches Archiv, 18), p. 192; DE GREGORIO, Tardo Me-dioevo grecolatino cit., p. 99 n. 175. Il binione finale del codice (ff. 102-105) proviene da un manoscritto adue colonne del sec. XII, contenente le omelie di anonimo sul battesimo di Cristo e Santo Stefano: F. HALKIN,Manuscrits grecs de Paris. Inventaire hagiographique, Bruxelles, 1968 (Subsidia Hagiographica, 44), p. 151.
80 Cfr. § 10.

DANIELE ARNESANO150
lettere schiacciate si distinguono delta maiuscolo, sigma, phi “a chiave di vio-lino” speculare e omega.
13. Augusta Acconcia Longo e Andrè Jacob hanno notato l’analogia pa-leografica e codicologica fra l’antologia salentina Vat. gr. 1276 81 e il miscel-laneo Par. gr. 1087 82, contenente tra l’altro il Credo niceno con scolii 83, iprimi versi dell’Oreste 84, il commento dello Ps.-Nonno alle orazioni IV e Vdi Gregorio di Nazianzo 85, alcuni libri del Vecchio Testamento 86 ed una re-dazione breve degli Homerocentra 87. Ambedue i manoscritti sono in carta fi-ligranata databile ai primi anni del sec. XIV 88. In particolare, credo si possaidentificare il copista dei ff. 49r-50r del manoscritto parigino 89 con quello re-sponsabile dei ff. 13r-18v (r. 4), 19r (rr. 1-9), 21r-48r, 49v-50r, 51v-63v, 82r-101r (r. 8), 102r-131v (r. 9), 135r-164v (r. 20), 175r-180v del codice vatica-no 90. All’anonimo copista vanno a mio avviso attribuiti anche i ff. 33r-39r
81 ACCONCIA LONGO - JACOB, Une anthologie salentine cit., p. 154; ulteriore bibliografia in BUONOCORE, Biblio-grafia dei fondi manoscritti cit., II, p. 886; CERESA, Bibliografia dei fondi manoscritti della Biblioteca Vaticana(1981-1985) cit., p. 374; ID., Bibliografia dei fondi manoscritti della Biblioteca Vaticana (1986-1990) cit., p.444.
82 OMONT, Inventaire sommaire cit., I, pp. 217-218. G. CAVALLO, La cultura italo-greca nella produzione li-braria, in I Bizantini in Italia, a cura di G. PUGLIESE CARRATELLI, Milano, 1982, pp. 495-608: 605.
83 Ff. 25r-48v: HALKIN, Manuscrits grecs de Paris cit., p. 110.84 Ff. 49r-50r: A. TURYN, The Byzantine Manuscript Tradition of the Tragedies of Euripides, Urbana, 1957
(Illinois Studies in Language and Literature, 43) (ristampa Roma, 1970 [Studia Philologica, 16]), p. 353; J. IRI-GOIN, La tradition manuscrite des tragiques grecs dans l’Italie méridionale au XIIIe siècle et dans les premiè-res années du XIVe siècle, in Bisanzio e l’Italia. Raccolta di studi in onore di Agostino Pertusi, Milano, 1982,pp. 132-143 (ristampato in La tradition des textes grecs. Pour une critique historique, Paris, 2003, pp. 537-552nr. 32), pp. 133, 139, 140.
85 Ff. 56r-81v: J. MOSSAY, Repertorium Nazianzenum. Orationes. Textus Graecus, 1, Codices Galliae, Pa-derborn-München-Wien-Zürich, 1981 (Studien zur Geschichte und Kultur des Altertums. Neue Folge. 2.Reihe: Forschungen zu Gregor von Nazianz, 1), p. 82.
86 Ff. 88r-100v, 132r-161v: RAHLFS, Verzeichnis der griechischen Handschriften cit., p. 209, sigla 583.87 Ff. 120r-131v: A.-L. REY, Un manuscrit de la Renaissance contenant les Homerocentra: Le Palat. gr.
326 complété par des sections du recueil factice Vallic. F 16, in Scritture, libri e testi cit., pp. 603-616: 607.88 Per le filigrane del Vat. gr. 1276 cfr. ACCONCIA LONGO - JACOB, Une anthologie salentine cit., 1982, pp.
153-154; per le filigrane del Par. gr. 1087 cfr. J. IRIGOIN, Les filigranes de Fabriano (noms de papetiers) dansles manuscrits grecs du début du XIVe siècle, in Scriptorium, XII (1958), pp. 44-50: 46 e n. 5, 47; ID., La tra-dition manuscrite cit., p. 135.
89 Ai ff. 119v (rr. 20-ultimo) e 131v (rr. 19-ultimo) vanno registrati due interventi di una mano salentinadel sec. XV.
90 Specimen in H. FOLLIERI, Codices Graeci Bibliothecae Vaticanae selecti, temporum locorumque ordine di-gesti, commentariis et transcriptionibus instructi, Città del Vaticano, 1969 (Exempla scripturarum, 4), tav. 62(f. 33v). Nell’intero manoscritto si osservano variazioni nel modulo della scrittura, nella corsività, nello spesso-re del tratto e nel colore dell’inchiostro, spesso legate al cambiamento del testo. La distinzione qui propostadella mano anonima dalle altre intervenute nel codice (che, aldilà degli interventi estemporanei, sono una, almassimo due) resta beninteso problematica, in quanto non mancano fra loro analogie significative (tanto che sisarebbe tentati di ipotizzare un solo copista principale, autore non solo di un’antologia testuale ma anche diuno zibaldone grafico). Ciò tuttavia non inficia affatto l’identificazione con la mano intervenuta nel manoscrit-to parigino e, come, si vedrà subito, in un altro vaticano.

IL « COPISTA DEL DIGENIS AKRITAS » 151
del Vat. gr. 1912, membranacei e contenenti brani delle Omelie di Filagatoda Cerami 91, nonché il f. 7r del già citato Par. gr. 2970 92. La scrittura diquesto copista, come quella dell’anonimo esaminato al pragrafo precedente,rappresenta una fase tarda della “palaeographische Barockzeit” in Terra d’O-tranto, caratterizzata da artificiosità, un certo irrigidimento ed un effetto dise-gnato più che scritto. Ne è prova anche il deludente risultato estetico dimo-strato dal copista nei fogli vergati più corsivamente, allorché le mani duecen-tesche, anche nel tacugrafeîn, mantenevano un apprezzabile livello qualitati-vo. Fra le numerose analogie che accomunano i tre manoscritti in questionesi noti la forma di beta maiuscolo e di delta minuscolo, theta oblungo contratto orizzontale sporgente e boule all’estremità iniziale, theta aperto, phi contratto verticale poco o affatto prolungato sotto rigo, la legatura alpha-phi conalpha “en fer de lance” molto inclinato verso il basso, le legature alpha-phied alpha-chi con il nucleo della prima lettera ridotto ad un cerchietto isolato,quella di gamma minuscolo vistosamente spostato verso sinistra 93, epsilon-pi,le legature di iota raddoppiato con lettera precedente (rho, sigma).
14. Nella realizzazione sia del Par. gr. 1087 che del Vat. gr. 1276 il copi-sta di cui si è appena detto ricevette la collaborazione di un altro anonimo,responsabile dei ff. 1r-22v, 25r-48v, 50v-119v (r. 19), 120r-131v (r. 18),132r-178v del parigino e dei ff. 1r-12r, 64r-66r, 67r-81v, 101r (r. 8) - 101v,131v (r. 10) - 134r, 164v (r. 20) - 165r, 167r-174v del vaticano 94. Egli dun-que collaborò con il copista di cui si è detto nel paragrafo precedente nellarealizzazione tanto del manoscritto parigino quanto di quello vaticano. Lagrafia, non priva di un’artificiosa rigidità, testimonia il passaggio dalla fasebarocca della scrittura salentina a quella del ritorno ad una minuscola più so-bria, minuta, priva delle forme più appariscenti. Si noti, tra l’altro, alpha “enfer de lance” con il corpo della lettera molto inclinato, beta maiuscolo con lapancia inferiore sporgente, epsilon maiuscolo di piccolo modulo in un temposolo inclinato verso sinistra, epsilon maiuscolo di grande modulo talvolta con
91 Si tratta di un codice composito, accuratamente descritto da P. CANART, Codices Vaticani Graeci. Codices1745-1962, I, Codicum enarrationes, Città del Vaticano, 1970, pp. 651-664: 657. Bibliografia in CANART - PERI,Sussidi bibliografici cit., p. 658; BUONOCORE, Bibliografia dei fondi manoscritti della Biblioteca Vaticana (1968-1980) cit., II, p. 941; CERESA, Bibliografia dei fondi manoscritti della Biblioteca Vaticana (1981-1985) cit., p.405; ID., Bibliografia dei fondi manoscritti della Biblioteca Vaticana (1986-1990) cit., p. 453.
92 Cfr. § 10.93 Per il Vat. gr. 1912, cfr. ad es. f. 34v, rr. 2, 8 e 10 dal basso.94 Specimen in R. DEVREESSE, Les manuscrits grecs de l’Italie méridionale (histoire, classement, paléogra-
phie), Città del Vaticano, 1955 (Studi e Testi, 183), tav. VIIb (f. 168r).

DANIELE ARNESANO152
un tratto perpendicolare a quello mediano (quest’ultimo prolungato a toccarela lettera successiva), la forma di theta aperto, di csi, phi “a chiave di violi-no” speculare con l’occhiello di forma oblunga, la legatura rho-omicron “astaffa”, la particolare legatura tau-iota 95.
15. I fogli ff. 1-2, 4-74, 76-154 del già citato Ambros. G 53 sup. proven-gono dallo stesso codice al quale appartenevano i ff. 1-25, 30-41 dell’Am-bros. P 75 sup. 96. Il manoscritto originario, in carta filigranata databile fra il1328 ed il 1340, conteneva le Omelie di Filagato da Cerami e fu vergato daun’unica mano 97. Quest’ultima è responsabile anche del Laur. San Marco692, nel quale copiò le Omelie di Basilio ed il Commento al Cantico deiCantici di Gregorio di Nissa (Tav. XI) 98. Il manoscritto laurenziano, carta-ceo, presenta dimensioni e filigrana identiche a quelle del codice di Filaga-
95 Vat. gr. 1276, DEVREESSE, Les manuscrits grecs cit., tav. VIIb, r. 2 dal basso; Par. gr. 1087, ad es. f. 81v,r. 1, r. 13 dal basso.
96 Cfr. § 6. Descrizione in MARTINI, BASSI, Catalogus codicum graecorum cit., rispettivamente pp. 473-474,712-714. Ulteriore bibliografia presso www.ambrosiana.it.
97 C. PASINI, Inventario agiografico dei manoscritti greci dell’Ambrosiana, Bruxelles, 2003 (Subsidia Hagio-graphica, 84), pp. 104-107: 104; G. ROSSI TAIBBI, Sulla tradizione manoscritta dell’omiliario di Filagato da Ce-rami, Palermo, 1965 (Istituto siciliano di studi bizantini e neoellenici. Quaderni, 1), p. 65 (sigla Am); LUCÀ,L’apporto dell’Italia meridionale cit., p. 206. Precisamente, nell’Ambros. G 53 sup. la mano ha vergato i ff.1v-2v, 4r-72v, 78r-79v, 84r-87v, 91r-128v, 139r-154v; dei numerosi fogli lasciati bianchi dal copista (74rv,76r-77v, 80r-83v, 88r-90v, 138v) alcuni (129r-138r) sono stati sfruttati da una tarda mano salentina, la qualeha inoltre inserito e vergato il f. 3rv (che, in seguito a restauro, oggi costituisce un bifoglio artificiale col f. 2)e un ternione (ff. 133-138) la cui filigrana è databile alla metà del sec. XV (PASINI, Inventario agiografico cit.,p. 104). Al f. 73rv altre mani tarde hanno vergato dei testi in caratteri greci e in lingua volgare. Nell’Ambros.P 75 sup. il copista anonimo ha vergato i ff. 1r-25v, 30r-32v, lasciando bianchi i ff. 33r-41v, successivamenteutilizzati in parte (ff. 33r-39r) dalla stessa mano tarda intervenuta nell’Ambros. G 53 sup. (la quale ha inoltreinserito e vergato il binione costituito dai ff. 26-29, la cui filigrana è databile alla seconda metà del sec. XV:cfr. PASINI, Inventario agiografico cit., p. 604), in parte (ff. 39v-41v) da altre mani tarde (che hanno inoltre ag-giunto e vergato il f. 42, isolato), fra le quali l’arciprete galatinese Nicola Schinzari: JACOB, Les annales d’unefamille cit., p. 29; A. JACOB, La tradizione scrittoria a Galatina dal XIII al XVI secolo, in Bollettino Storico diTerra d’Otranto, III (1993), pp. 41-51: 47; alcuni di questi testi sono in caratteri greci e in lingua volgare: R.DISTILO, Testi greco-romanzi del Salento. Una lettera, un contratto e alcune annotazioni dell’ultimo arcipretegreco di Galatina, in Bollettino Storico di Terra d’Otranto, II (1992), pp. 65-76.
98 E. ROSTAGNO - N. FESTA, Indice dei codici greci laurenziani non compresi nel catalogo del Bandini, inStudi Italiani di Filologia Classica, I (1893), pp. 131-232: 192; H. LANGERBECK, Gregorii Nysseni in Canticumcanticorum, Leyde, 1960 (Greogorii Nysseni opera, 6), pp. XXXVIII, XLVI; F. DÜNZL, Gregor von Nyssa. InCanticum canticorum homiliae / Homilien zum Hohenlied, Freiburg, 1994 (Fontes Christiani, 16), I, p. 91 n.298. L’anonimo è responsabile precisamente dei ff. ff. 1r-87v, 89r-156v; il f. 88 è bianco; i ff. 157r-158v sidevono ad un secondo copista. Ai ff. IIv-IIIv una mano secondaria ha vergato una “predica” in caratteri greci ein lingua volgare: O. PARLANGELI, La « predica salentina » in caratteri greci, in Romanica. Festschrift für G.Rohlfs, Halle, 1958, pp. 336-360 (ristampato in Storia linguistica e storia politica nell’Italia meridionale, Fi-renze, 1960, pp. 143-173), pp. 338-341 tavv. 1-3 (ff. IIv-IIIv); ai ff. IVr, I’r si trovano annotazioni varie, men-tre al f. IVv la stessa mano che ha vergato il testo dialettale ha apposto un’annotazione che ricorda la battagliadi Copertino (a. 1352): R. FRANCHINI, La Battaglia di Copertino, in appendice a Parlangeli, La « predica salen-tina » cit., pp. 360-361.

IL « COPISTA DEL DIGENIS AKRITAS » 153
to 99. La scrittura si inserisce fra le tarde manifestazioni della minuscola ba-rocca, caratterizzate da rigidità ed artificiosità; in questo caso si aggiunge lamodesta disinvoltura del copista, con il risultato di una grafia sclerotizzata erozza. Tra le altre analogie si noti alpha maiuscolo con il corpo centrale ri-dotto ad una piccola concentrazione d’inchiostro e con il tratto obliquo ampioed arcuato, theta aperto con ampio occhiello, lambda quasi perfettamente bili-neare, le legature alpha-gamma con gamma allungato verso sinistra, epsilon-pi “a ponte”, epsilon-sigma con un vistoso epsilon “a pera”, il compendio dikai.
16. All’opera di un medesimo copista vanno attribuiti l’AnastasimonCrypt. D. g. VIII (Gr. 151) 100 e parte dell’Horologion Crypt. G. a. VI (Gr.298) 101. I due codici, palinsesti, provengono dal monastero di S. Elia e S.Anastasio di Carbone, come lascia supporre la presenza dei numeri romani“XXXVI” nel primo (f. 1r) e “XXXX” (sic) nel secondo (f. IIv) 102. Tale cir-costanza è confermata dal fatto che l’anonimo copista è a mio avviso respon-sabile anche di alcuni interventi nel noto Eucologio di Carbone (Vat. gr.2005) 103, vergato fra il 1194 ed il 1195 da una mano di formazione graficasalentina 104. L’identificazione da parte di Andrè Jacob dell’archimandrita Gio-na, menzionato nell’anafora, con il monaco messo a capo del monastero da
99 Si tratta del tipo “Lettres et monogrammes”, come Briquet 9732 (a. 1340). Ho riscontrato questa filigra-na in un altro testimone del Commento al Cantico dei Cantici di Gregorio di Nissa, il Par. gr. 1002 (sul qualecfr. LANGERBECK, Gregorii Nysseni cit., pp. XLV-XLVI; DÜNZL, Gregor von Nyssa cit., p. 91 [sigla P]).
100 ROCCHI, Codices Cryptenses cit., p. 370; CRISCI, I Palinsesti di Grottaferrata cit., pp. 38-39, 156-158, 284,tavv. 69-70 (ff. 69v, 186r).
101 ROCCHI, Codices Cryptenses cit., pp. 215-216. Si tratta precisamente dei ff. 8r-32v, 277r-293r; il resto delmanoscritto è stato vergato da un secondo copista salentino (ff. 1r-7v, 33r-276v, 293v-301v). Ai ff. 291v-293ril nostro anonimo ha trascritto una formula confessionale in caratteri greci e lingua volgare: R. DISTILO, Tradi-zioni greco-romanze dell’Italia meridionale, I, Appunti sulla scripta « siciliana » del cod. Crypt. G. a. VI, II,Per le glosse del cod. Crypt. Z. a. IV, in Cultura Neolatina, XLV (1985), pp. 171-200 (ristampato come Ap-punti sulla scripta dei codici Crypt. G. a. VI e Z. a. IV in Káta Latínon. Prove di filologia greco-romanza,Roma, 1990 [Seminario Romanzo, 3], pp. 43-81): 171-184. Alcuni fogli del codice sono palinsesti: CRISCI, IPalinsesti di Grottaferrata cit., pp. 26-27, 107.
102 LUCÀ, Su origine e datazione cit., p. 189.103 S. PARENTI, Una descrizione dell’eucologio di Carbone (Vaticano gr. 2005), in Ecclesia Orans, XVIII
(2001), pp. 397-417. Bibliografia in CANART - PERI, Sussidi bibliografici cit., p. 669; BUONOCORE, Bibliografiadei fondi manoscritti della Biblioteca Vaticana (1968-1980) cit., II, p. 949; CERESA, Bibliografia dei fondi ma-noscritti della Biblioteca Vaticana (1981-1985) cit., p. 410. Il manoscritto è in parte bis rescriptus; il codexantiquissimus è un salterio bilingue e digrafico greco-latino, vergato per la parte latina in beneventana barese:Bibliografia dei manoscritti in scrittura beneventana, Roma, 1, 1993 -, sigla VGR 2005.
104 A. JACOB, Une date précise pour l’Euchologe de Carbone: 1194-1195, in Archivio Storico per la Cala-bria e la Lucania, LXIII (1995), pp. 97-114: 103, 104-107, tavv. 1-2 (ff. 35r, 72v). Gli interventi sono ai ff. 5v(rr. 1-7), 19r (r. 8), 19v (rr. 4-ultimo), 20r (r. 6), 20r (r. 19) - 21v, 24r (rr. 6-17), 25r (rr. 14-17) e riguardanoin particolare una formula salentina di ampliamento della commemorazione dei defunti e l’aggiunta di una par-ticolare formula cristologica: A. JACOB, Épidémies et liturgie en Terre d’Otrante dans la seconde moitié du XI-

DANIELE ARNESANO154
Innocenzo VI nel 1361, ha consentito di datare questi interventi alla secondametà del sec. XIV 105. A questo periodo vanno dunque attribuiti anche i duecodici criptensi, che con la loro provenienza confermano la presenza di uncopista di formazione grafica salentina nel monastero di S. Elia e S. Anasta-sio di Carbone. La scrittura dell’anonimo, come quella esaminata al paragrafoprecedente, appartiene alla fase più tarda della “palaeographische Barockzeit”,ma presenta un ductus più fluido ed un tracciato arrotondato. Il nitore e la re-golarità della catena grafica sono ritmati dall’ingrandimento improvviso di al-cune lettere, che costituiscono anche le analogie più evidenti: gamma, epsi-lon, tau e csi. Si noti anche beta maiuscolo di piccolo modulo, theta aperto eschiacciato, le legature alpha-sigma ed epsilon-rho.
17. Il codice Vat. gr. 2325 è costituito da sezioni eterogenee 106. Come haosservato Andrè Jacob, i ff. 42-65 appartenevano originariamente all’attualelezionario palinsesto Vallic. D 62 107, come anche i ff. 15-18 dell’Ottob. gr.393 108. Alla stessa mano va attribuito anche il canonario cartaceo Ambros. E47 sup., databile in base alle filigrane agli ultimi anni del sec. XIV e aquista-to nel 1606 a Melpignano (Tav. XII) 109. Il codice ambrosiano, che con l’altro
Ve siècle, in Helikon, XXXI-XXXII (1991-1992), pp. 93-126: 105 (sigla V), 108, 111-112 nrr. 5-6; ID., Deuxformules d’immixtion cit., pp. 34-35. Uno specimen in ID., Une date précise cit., tav. 3 (f. 21r).
105 JACOB, Épidémies et liturgie cit., pp. 115-117; ID., Une date précise cit., tav. 3 (f. 21r; il nome di Giona ècitato al r. 5 dal basso).
106 COZZA LUZI, Inventarium codicum Graecorum cit., f. 235r. Bibliografia: CANART - PERI, Sussidi bibliografi-ci cit., p. 702; BUONOCORE, Bibliografia dei fondi manoscritti della Biblioteca Vaticana (1968-1980) cit., II, p.971; CERESA, Bibliografia dei fondi manoscritti della Biblioteca Vaticana (1986-1990), p. 460. Cfr. anche LIL-LA, I manoscritti Vaticani Greci cit., pp. 89, 107, 108.
107 JACOB, Fragments liturgiques byzantins cit., pp. 357-358, tav. V (f. 54r). Sul manoscritto vallicelliano cfr.MARTINI, Catalogo di manoscritti greci cit., pp. 95-96. Il manoscritto fu probabilmente utilizzato a Galatone:M. PETTA, Manoscritti liturgici greci nelle chiese di Galatone, in Studi di storia pugliese in onore di GiuseppeChiarelli, II, Galatina, 1973, pp. 685-706: 694. Ho già avuto modo di confermare questa ipotesi, segnalando lapresenza, nello strato inferiore del codice, di un documento greco relativo probabilmente a questa cittadina(ARNESANO, Il « Copista del Dioscoride » cit., p. 31 e n. 16).
108 JACOB, Fragments liturgiques byzantins cit., pp. 357-358, tav. VI (f. 15r). Il resto del manoscritto è un si-nassario palinsesto, nello strato inferiore del quale si leggono le Pandette di Antioco Monaco vergate in unaminuscola “tipo Scilitze”: S. LUCÀ, I Normanni e la ’rinascita’ del sec. XII, in Archivio Storico per la Calabriae la Lucania, LX (1993), pp. 1-91: 47-48 e n. 187, tav. 15 (f. 98v). Descrizione del manoscritto ottoboniano inFERON, F. BATTAGLINI, Codices manuscripti graeci cit., pp. 205-207; bibliografia in CANART - PERI, Sussidi biblio-grafici cit., p. 217; BUONOCORE, Bibliografia dei fondi manoscritti della Biblioteca Vaticana (1968-1980) cit., I,p. 397; CERESA, Bibliografia dei fondi manoscritti della Biblioteca Vaticana (1986-1990) cit., p. 308.
109 MARTINI - BASSI, Catalogus codicum graecorum cit., p. 317; LUCÀ, L’apporto dell’Italia meridionale cit.,p. 200; bibliografia presso www.ambrosiana.it. Le filigrane sono del tipo “Cloche” (cfr. bifoglio 5/6), simile aBriquet 3967 (a. 1392); tipo “Cercle” (cfr. bifoglio 26/27), simile a Briquet 3220 (a. 1382); tipo “Tête de boeuf”(cfr. bifoglio 84/87), simile a Briquet 14632 (a. 1389). I ff. I-II, 174 sono antiche carte di guardia vergate in una mi-nuscola tradizionale salentina del sec. XII. Il binione costituito dai ff. 170-173 è stato aggiunto e vergato da una ma-no salentina del secolo XV.

IL « COPISTA DEL DIGENIS AKRITAS » 155
manoscritto condivide anche dimensioni, mise en page e decorazione, consen-te dunque di attribuire con maggior sicurezza i membra disiecta del leziona-rio alla fine del sec. XIV. La datazione tarda è confermata dalla scarsezza dielementi barocchi nella scrittura, una minuscola dal tracciato spezzato, rozzaed irregolare che, sullo scorcio della temperie grafica barocca, testimonia l’ef-fetto del generale ritorno alla sobrietà anche nel filone calligrafico o, come inquesto caso, con pretese calligrafiche. Si noti la forma di zeta e di csi, pi etau minuscoli con boule appesa all’attacco del tratto orizzontale, omega conaccento circonflesso attaccato al tratto orizzontale di tau alto precedente, lasovrapposizione di tau su omicron.

DANIELE ARNESANO156
INDICE DEI MANOSCRITTI CITATI
CITTÀ DEL VATICANO
BIBLIOTECA APOSTOLICA VATICANA
Barb. gr.102 p. 137 n. 12354 p. 141Ottob. gr.1 p. 139, tav. III393 p. 154Pii II gr.15 p. 142Vat. gr.1221 p. 143 n. 461276 p. 136 n. 9, p. 150 e n. 88, pp. 151, 152 n. 951408 pp. 147, 148 e n. 76, p. 149 n. 77, tavv. IX, X
fig. 11506 p. 140 n. 341912 p. 151 e n. 932005 p. 1532025 pp. 139-140 n. 302296 p. 148 e n. 76, p. 149 n. 772325 p. 152
ESCORIAL
REAL BIBLIOTECA DEL MONASTERIO
Scorial.Y IV 22 p. 136 n. 8
FIRENZE
BIBLIOTECA MEDICEA LAURENZIANA
Plut.5.36 pp. 145, 1447.8 p. 139 n. 27

IL « COPISTA DEL DIGENIS AKRITAS » 157
32.20 pp. 145, 146, tavv. VII-VIII72.19 p. 149San Marco692 p. 152, tav. XI
GROTTAFERRATA
BIBLIOTECA DEL MONUMENTO NAZIONALE
Crypt.A. d. XI (Gr. 79) p. 138 e n. 17G. a. VI (Gr. 298) p. 153D. g. VIII (Gr. 151) p. 153Z. a. XLIV (Gr. 59) p. 136 e n. 8Z. a. LXXII (Gr. 382) p. 136 n. 8
KARLSRUHE
BADISCHE LANDESBIBLIOTHEK
E. M.6 p. 145
MILANO
BIBLIOTECA AMBROSIANA
Ambros.A 178 sup. p. 143 n. 46D 62 sup. p. 140D 65 sup. p. 140E 18 sup. p. 141, tav. IVE 20 sup. p. 137E 47 sup. p. 154, tav. XIIG 5 sup. pp. 139, 141G 36 sup. p. 140 n. 32G 53 sup. pp. 142, 152 e n. 97L 116 sup. p. 143P 75 sup. p. 152 e n. 97Q 57 sup. p. 140 n. 32
NAPOLI
BIBLIOTECA NAZ. VITTORIO EMANUELE III
II A 35 p. 140 n. 33ex Vindob. gr.15 p. 142

DANIELE ARNESANO158
NARDÒ
BIBLIOTECA DELLA CURIA VESCOVILE
Cinquecentina s.n. p. 141, tav. V
OXFORD
MAGDALEN COLLEGE
gr.15 p. 149
PARIS
BIBLIOTHÈQUE NATIONALE
Coisl.190 p. 143Par. gr.1002 p. 153 n. 991087 p. 150 e n. 88, pp. 151, 152 n. 951255 p. 1491304 p. 143 e n. 462572 pp. 146, 1482574 p. 137 e nn. 12, 14, p. 138, tavv. I-II2773 p. 1432970 pp. 147, 149, 151
ROMA
BIBLIOTECA VALLICELLIANA
Vallic.C 7 pp. 142, 143 n. 46, tav. VID 62 p. 154
VERONA
BIBLIOTECA CAPITOLARE
134 p. 139
WIEN
ÖSTERREICHISCHE NATIONALBIBLIOTHEK
Phil. gr.2 p. 140 n. 3349 p. 148, tav. X fig. 2158 p. 139310 p. 140 n. 32Suppl. gr.37 pp. 143-144 n. 51