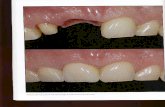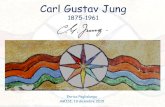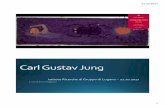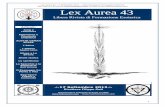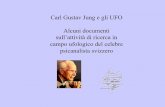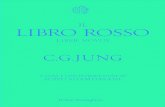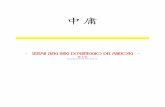I.I.S. “G. Leopardi - E. Majorana · STRATEGIE DIDATTICHE ... Il Consiglio di Classe si è...
Transcript of I.I.S. “G. Leopardi - E. Majorana · STRATEGIE DIDATTICHE ... Il Consiglio di Classe si è...
I.I.S. “G. Leopardi - E. Majorana” Classico - Scientifico – Scienze Umane
PP OO RR DD EE NN OO NN EE
COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE A.S. 2015-2016
5^ A SCIENZE UMANE
MATERIA DI INSEGNAMENTO
DOCENTE
ITALIANO - LATINO CORELLI SUSANNA
STORIA PETTARIN SILVIA
FILOSOFIA D’AGARO PAOLA
INGLESE DEL BEN SUSANNA
SCIENZE UMANE FURLANETTO CLAUDIA
MATEMATICA - FISICA ROMANO LUDOVICO
SCIENZE PETROCCIONE FRANCESCA
STORIA DELL’ARTE PELLEGRINI SILVA
SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE PASTORI M. GRAZIA
RELIGIONE BEACCO CLAUDIA
COORDINATORE DI CLASSE D’AGARO PAOLA
VERBALIZZANTE MELINTE CORNELIU
STUDENTI RAPPRESENTANTI DI CLASSE BOVE BEATRICE CIPOLAT ANNA
GENITORI RAPPRESENTANTI DI CLASSE BATTISTUTTA BRUNO MORETTO PATRIZIA
PREMESSA AL PIANO DI LAVORO
ANALISI DELLA SITUAZIONE DI PARTENZA
Il gruppo classe si compone di 23 allievi di cui 2 maschi. Rispetto allo scorsoanno vi è stato un solo inserimento mentre un allievo non fa più parte dellaclasse. Nessuno studente è stato impegnato nell'esame di verifica del debitoformativo mentre 6 di loro risultano in questi giorni impegnati nelle verificheriguardanti le parziali lacune rilevate in sede di scrutinio finale della classeprecedente. La nuova arrivata, che proviene dallo stesso indirizzo di scuola, èstata accolta positivamente e partecipa a pieno titolo all’attività scolastica. Laclasse sembra pertanto aver mantenuto una sua coesione che la predisponea lavori di gruppo e ad attività comuni. Tre allievi sono impegnati, a diversotitolo, in attività musicali e/o sportive che però non dovrebbero pregiudicare lanormale frequenza. Il comportamento in classe è corretto e rispettoso, sia tra compagni che neiconfronti degli insegnanti, e la soglia di attenzione durante le lezioni èsufficientemente alta. Gli interventi nel corso delle stesse sono adeguati equasi sempre pertinenti. Il rendimento complessivo si mantiene ad un livellosuperiore alla media. Purtuttavia, va rilevata una certa passivitànell'accogliere gli stimoli sia educativi che didattici, nonostante vi siano nelgruppo classe buone potenzialità e una lodevole propensione allo studio.Nel complesso, la competenza comunicativa (da cui deriva quella linguistico-lessicale) si mantiene inferiore alle attese. Il quadro generale fin qui descritto,se da un lato conforta il corpo docente, dall'altro lo spinge a proseguire sullastrada della richiesta di una maggiore autonomia nella rielaborazione deicontenuti proposti e di una loro consapevole fruizione una volta acquisito unefficace metodo di decodificazione e rielaborazione critica degli stessi. Ingenerale ci si aspetta dai ragazzi un apporto più personale, dinamico econsapevole alle attività, non finalizzato al solo conseguimento di valutazionieccellenti. La classe si avvale dell'attività di sostegno.
FINALITA’ EDUCATIVE E OBIETTIVI DIDATTICI GENERALI
Per la visione d’insieme degli obiettivi educativi e didattici, si fariferimento al P.O.F. e, in particolare, alle competenze-chiave di cittadinanza,il cui conseguimento deve costituire il traguardo ultimo e prioritario dell’azionedidattica nella sua completezza, come sancito dal D.M. 22.10.2007(Regolamento recante norme in materia di adempimento dell’obbligo diistruzione). In riferimento alla situazione della classe, gli insegnanti siadopereranno in modo che gli studenti perseguano, più specificamente, leseguenti competenze-chiave:
• acquisire autonomia e senso di responsabilità nel portare avanticompiti e progetti;
• elaborare i pensieri e comunicarli in modo chiaro, corretto edefficace;
• abbandonare l’acquisizione mnemonica dei contenuti in direzione diuna più autonoma e consapevole elaborazione degli stessi.
OBIETTIVI DISCIPLINARI
In generale gli allievi saranno tenuti a:
• portare a termine i compiti loro assegnati;• esprimersi correttamente e utilizzare quanto più possibile il lessico
specifico delle varie discipline;• identificare e classificare fatti e fenomeni;• porre in relazione tra loro fatti e fenomeni anche di ambiti disciplinari
diversi;• applicare con metodo la tecnica acquisita in contesti dati;• comprendere e interpretare le diverse realtà con cui vengono in
contatto;• esporre con coerenza ed in modo chiaro le conoscenze acquisite;• argomentare le ragioni delle proprie tesi nell’ambito di una discussione;• riconoscere possibili collegamenti fra contenuti di discipline diverse;• esprimersi in modo il più possibile obiettivo e consapevole nel processo
di autovalutazione;• motivare le proprie scelte.
In particolare, nel lavoro domestico dovranno dimostrare puntualitàe precisione.
Per quanto attiene agli obiettivi delle singole discipline si rimanda aquanto indicato da ciascun insegnante nel proprio piano di lavoro.
STRATEGIE DIDATTICHE
I docenti adotteranno sia la lezione frontale tradizionale, nella fase dipresentazione di un argomento o come premessa alle varie attività, sia lalezione dialogata o interattiva nelle fasi di approfondimento. In alcunediscipline verrà attuato il lavoro per gruppi adeguatamente strutturati. Inclasse si cercherà di privilegiare la tecnica della spiegazione attraverso ilmetodo induttivo o della scoperta guidata. In tutte le discipline si provvederà agraduare in modo adeguato il passaggio dalle pre-conoscenze ai nuovi
contenuti, evitando scarti troppo ampi tra prerequisiti e nuovi dati. Gli erroridegli allievi saranno utilizzati in senso positivo, come feedback per l’attività direcupero.
Se le verifiche dovessero evidenziare lacune e/o difficoltà da partedegli studenti dovranno essere effettuate prioritariamente attività di recuperoin classe; qualora le difficoltà persistessero, gli allievi potranno essereindirizzati allo sportello didattico che sarà attivo per tutte le discipline. Va dasé che tale intervento potrà dare i suoi frutti solo se finalizzato al recupero dicarenze ben definite e circoscritte. Qualora se ne ravvisi la necessità e visiano le condizioni per farlo, verranno attivati corsi di recupero pomeridiani aiquali potranno partecipare gruppi ristretti di allievi. Al fine di valorizzare leeccellenze e di stimolare gli allievi più motivati ad arricchire il proprio bagaglioculturale e il proprio curriculum si potranno attivare, in orario pomeridiano,micro-stage di approfondimento su argomenti specifici, possibilmente pluri-disciplinari e “appetibili” per il loro contenuto di attualità o di interesse locale.Tale approfondimento dovrà sfociare nella produzione di testi (articoli,dispense, testi multimediali, grafici…). Il tutto nell'ottica di una didattica percompetenze. Nei limiti consentiti dalle caratteristiche di ciascuna disciplina, si cercherà diprediligere le modalità del lavoro di gruppo e del laboratorio e di indurre iragazzi alla risoluzione di casi o problemi il più possibile pratici. Gli allievi verranno aiutati ad applicare le conoscenze nei vari modi e contesti,evitando atteggiamenti schematici e settoriali.
STRUMENTI DI OSSERVAZIONE, VERIFICA E VALUTAZIONE
La valutazione avrà per oggetto sia il processo di apprendimento,sia il comportamento nelle situazioni scolastiche. Si terrà conto dei progressiottenuti rispetto alla situazione di partenza ed in itinere, di eventuali fattoriostacolanti nonché dello sviluppo delle capacità, abilità e competenzestabilite dai singoli docenti.
Le verifiche saranno frequenti per favorire l’impegno costante degliallievi. Nei limiti del possibile, si cercherà di fissare le prove con largo anticipoe in modo tale da non concentrare due prove scritte in una sola giornata.
Come da delibera del C.d.D., non meno di due saranno le provescritte (laddove previste) ed altrettante quelle orali nel primo quadrimestre;non meno di tre le scritte e due le orali nel secondo. Le verifiche potrannoessere diversificate: scritte, orali ma anche scritte valide per l’orale. Essepotranno interessare diverse tipologie di elaborato: composizioni di varianatura, traduzioni, questionari, soluzione di problemi, test ed altro. Allatradizionale interrogazione si affiancherà la presentazione alla classe di lavoridi approfondimento individuali o di gruppo. Elementi di valutazione sarannoraccolti anche durante la lezione dialogata.
Si verificheranno, con un atteggiamento di costante osservazione, iprogressi nell’impegno, nell’attenzione, nell’organizzazione del lavoro, nelsenso di responsabilità, nell’adattabilità, nel senso critico e autocritico, nelrispetto degli altri. Verrà valutata positivamente la capacità dell’allievo diriconoscere i propri errori e di auto-correggersi.
Il C.d.C. stabilisce i criteri di corrispondenza tra voti (che andrannodall’1 al 10) e livelli di conoscenza e abilità. I criteri fanno riferimento a quantogià stabilito in sede di Collegio dei Docenti e riportato nel P.O.F.
ATTIVITA' INTEGRATIVE E PROGETTI MULTIDISCIPLINARI IN ORARIOCURRICOLARE ED EXTRA CURRICOLARE
Queste le attività già attuate o da attuarsi alle quali altre si aggiungeranno incorso d'anno:
• Partecipazione a Pordenonelegge;• Olimpiadi di italiano;• Incontro con i migranti dell'associazione “Nuovi vicini”;• Conferenze in lingua inglese (date e temi da definirsi);• Incontro con lo psichiatra Fulvio Tesolin (27 ottobre)• Uscita ad Andreis e Barcis (orientativamente a marzo)• Viaggio di istruzione: dovrà coniugare finalità di tipo educativo con quelle
di tipo formativo e si svolgerà in tempi e luoghi ancora da definirsi.
Verranno inoltre valutati, di volta in volta, proposte e suggerimenti provenientisia dai ragazzi stessi, sia dalla scuola, sia da enti, organizzazioni e agenzieesterne ad essa.Il dettaglio delle varie attività è consultabile all'interno dei piani di lavoro dellesingole discipline.
PROGETTO CLIL
Il Consiglio di Classe si è attivato nel reperire risorse umane in possesso deirequisiti necessari per svolgere una o più attività in lingua inglese nellediscipline non linguistiche. Al momento è in fase di progetto una unitàdidattica dal titolo: “Archetypes, symbols and collective unconscius in CarlJung” a cura della professoressa Francesca Costa. Ogni ulteriore progettonell'ambito del CLIL è demandato agli organi superiori, in ottemperanza alledirettive del MIUR.
COMPETENZE:
Asse dei linguaggi
• Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italianaadeguandolo a diversi ambiti comunicativi: sociale, culturale, artistico –letterario, scientifico, tecnologico e professionale (partecipare inmaniera costruttiva agli OO.CC; collaborare nella stesura delleregole di convivenza civile all’interno dell’Istituto; partecipare inmaniera responsabile alle attività “fuori aula”; condurrediscussioni in classe, interrogazioni, colloquio esame finale).
• Analizzare e interpretare e produrre testi scritti di vario tipo (leggere ecommentare il giornale in classe; produrre e pubblicare articoli,recensioni; partecipare a concorsi).
• Padroneggiare le lingue straniere per interagire in diversi ambiti econtesti e per comprendere gli aspetti significativi della civiltà degli altripaesi in una prospettiva interculturale (intrattenere rapporti epistolari- anche tramite canali multimediali e social-network - con coetaneistranieri; assistere a rappresentazioni teatrali in lingua erecensirle).
• Fruire consapevolmente del patrimonio artistico anche ai fini della tutelae della valorizzazione (elaborare e realizzare la scheda tecnica diun’opera d’arte - pittura, architettura, scultura, fotografia, film,musica...- per una esposizione in pubblico o durante una visitadidattica).
• Riconoscere le linee fondamentali della storia letteraria ed artisticanazionale anche con riferimento all’evoluzione sociale, scientifica etecnologica (laboratorio di lettura di testi – narrativi, poetici, teatrali- appartenenti ad uno stesso genere o di opere intere provenientida culture diverse. Prodotto finale: relazione su traccia fornitadall’insegnante, esposizione in classe e dibattito, stesura di unamappa concettuale).
• Produrre testi multimediali (realizzare brevi sintesi o presentazioni inpower-point; fotografare con didascalie per illustrare le fasi di unaattività; selezionare e organizzare materiale reperito in internet).
Asse matematico
• Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico,rappresentandole anche sotto forma grafica (Risolvere quesiti cheriguardino situazioni di vita reale in ambito economico; operare congrandezze fisiche, riconoscere la loro relazione e saperla esprimere
graficamente).
• Confrontare ed analizzare figure geometriche, individuando invarianti erelazioni (descrivere e rappresentare lo spazio; risolvere i problemi delmondo reale o interni alla matematica attraverso la modellizzazionegeometrica).
• Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi (risolvereproblemi di applicazione dell’algebra alla geometria; risolvere problemidi fisica o di economia risolvibili attraverso modelli matematici;risolvere problemi che richiedono l’uso di strumenti informatici).
Asse scientifico-tecnologico
• Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni, appartenenti alla realtànaturale e artificiale e riconoscere nelle sue varie forme i concetti di sistema edi complessità.
Asse storico-sociale
• Comprendere, anche in una prospettiva interculturale, il cambiamento e ladiversità dei tempi storici in dimensione diacronica attraverso il confronto fraepoche e in dimensione sincronica attraverso il confronto tra areegeografiche e culturali. Condividere principi e i valori per l’esercizio dellacittadinanza.(Relazionarsi con coetanei e adulti provenienti da realtà geografichediverse; saper ricavare elementi di arricchimento personale dal dialogointerculturale; riconoscere affinità e diversità nel patrimonio di valori diciascuna cultura; accettare e accogliere la diversità; affrontare e vincerei pregiudizi e gli stereotipi).
UNITA' DI APPRENDIMENTO
L'unità di apprendimento, in fase di elaborazione, avrà per tema le migrazionie potrà servire da riferimento per la strutturazione di percorsi attraverso i qualidare avvio all'orale dell'esame di stato.Le materie coinvolte saranno, indicativamente, tutte le materie umanistiche enon solo. Il prodotto finale potrebbe essere un prodotto multimediale dapresentare in occasione dello spettacolo “Linguaggi diversi”, che come ognianno si terrà a ridosso della fine delle lezioni.
Il progetto, ideato e condotto dalla professoressa Furlanetto, è consultabilenelle sue linee essenziali nella tabella qui di seguito.
Per il Consiglio di ClasseLa coordinatricePaola D'Agaro
Unità di Apprendimento Interdisciplinare
LE MIGRAZIONI NELL'EPOCA DELLA GLOBALIZZAZIONE
Prodotti Realizzazione di vari strumenti in momenti successivi, quali interviste, elaborati scritti, mappe, libri, animazioni teatrali, cartelloni ecc. con cui documentare racconti di vita di migranti/rifugiati in Italia.
Fasi dell'uda Prodotto 1: realizzazione interviste con persone migranti (attraverso l'Associazione Nuovi Vicini) Prodotto 2: realizzazione elaborati scritti a carattere narrativo e saggistico. Per la parte saggistica verranno prese in considerazione informazioni geopolitiche, storiche, antropologiche, culturali sul paese di provenienza dei migranti di cui si intende raccontare la storia. Prodotto 3 (eventuale partecipazione di qualche allievo della classe): realizzare video o altro prodotto da presentare alla giornata “Linguaggi diversi”
Competenze di cittadinanza
IMPARARE A IMPARARE
ABILITA’ Saper acquisire ed interpretare le informazioni. Individuare collegamenti e relazioni tra le informazioni. Organizzare il proprio apprendimento, individuando, scegliendo ed utilizzando varie fonti e varie modalità di informazione. Essere consapevoli delle diversità dei metodi utilizzati nei vari ambiti disciplinari. Saper utilizzare le tecnologie della comunicazione e dell'informazione per studiare, fare ricerca e comunicare.
PROGETTARE Saper progettare per tappe successive una ricerca che preveda: interviste, elaborazione di racconti biografici, approfondimenti interdisciplinari, realizzazione di prodotti con cui comunicare l'esperienza realizzata nella giornata 'Linguaggi diversi'.
COMUNICARE Saper padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi della prima lingua e, in parte, della seconda lingua, per poter effettuare le interviste a migranti in lingua inglese.
COLLABORARE E PARTECIPARE Saper collaborare con i compagni mettendo a
disposizione abilità e assumendo le proprie responsabilità, non solo individualmente ma anche nel gruppo, valutando meriti ed errori propri ed altrui. Verranno inoltre sviluppati o consolidati: senso di responsabilità, autonomia, puntualità, precisione, adattabilità, sensibilità all'altro, empatia, rispetto delle esigenze altrui.
COMPETENZE CIVICHE Acquisire consapevolezza di alcuni valori, come quello della solidarietà, messa in opera attraverso "l'adozione" dei racconti di vita di alcuni migranti. Sapersi relazionare con sensibile disponibilità e responsabilità con bambini della scuola primaria, con i quali condividere, rinnovandolo, il senso della solidarietà verso persone che per necessità sono state costrette a migrare. Aprirsi all'esercizio della giustizia e della solidarietà in un contesto multiculturale
CONTENUTI DISCIPLINARI** Per competenze e
abilità specifiche si rinvia ai piani di lavoro delle singole discipline coinvolte
Aprirsi all'esercizio della giustizia e della solidarietà in un contesto multiculturale
Laboratori di geo-politica con il prof. Cristiano Riva Approfondimenti storici (prof.ssa Pettarin) Le migrazioni nell'epoca della globalizzazione Migrazioni e lavoro Approfondimento antropologico legato alle migrazioni di oggi e ai paesi di provenienza degli intervistati Osservatorio sociale sul razzismo nel nostro territorio. La metafora del viandante in Nietzsche Readings about “Immigration” Cambiamenti climatici e migrazioni Rielaborazione in forma narrativa e saggistica delle storie dei migranti. Partecipazione allo spettacolo 'Lo straniero' di A. Camus Preparazione incontri con i migranti “L’INCONTRO CON LO STRANIERO. DAI TEMPI DELLA BIBBIA AGLI STRANIERI DELLA PORTA ACCANTO”
DISCIPLINE Storia/Geografia Storia Scienze umane Filosofia Inglese Scienze Italiano Religione
Tempi Primo quadrimestre
Preparazione teorica multidisciplinare sul tema delle migrazioni. Le migrazioni forzate. Migrazioni e lavoro. Migrazione e globalizzazione Preparazione interviste, previa preparazione sulle migrazioni in atto dall'Africa e dal Medio Oriente verso l'Europa Incontro con alcuni migranti tramite l'Associazione "Nuovi vicini" Acquisizione conoscenze approfondite sul contesto storico, antropologico, culturale della storia migrante "adottata" – incontri di geo-politica con il prof. Cristiano Riva
Approfondimento storico con prof.ssa Pettarin
Secondo quadrimestre
Preparazione di un prodotto con cui documentare le conoscenze apprese e trasmettere la sensibilità acquisita lavorando al tema. Partecipare alla giornata 'Linguaggi diversi'
Materiali Libri di testo Articoli di giornale Eraldo Affinati, La città dei ragazzi. F. Geda, Nel mare ci sono i coccodrilli. Storie migranti Limes
Docenti coinvolti Prof.ssa Beacco, prof. Riva, prof.ssa Pettarin, prof.ssa Furlanetto, prof.ssa Corelli, prof.ssa D'Agaro, prof.ssa
Petroccione, prof.ssa Del Ben
Valutazione competenze raggiunte
Saranno predisposte delle verifiche sia individuali che di gruppo – possibile prova esperta - per la valutazione delle competenze raggiunte
IIS Leopardi Majorana
PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE VAU
DISCIPLINA: ITALIANO
Docente:Susanna Corelli
Presentazione della classe e situazione di partenza:
La classe, composta da 23 allievi (21 femmine e 2 maschi) di cui una nuova allieva proveniente da altra classe del nostro Istituto, dimostra in generale buona disponibilità all’ascolto e capacità di attenzione, interesse e buona motivazione nei confronti della materia. È presente un ampio gruppo con buone capacità e metodo di studio adeguato ed un ridotto numero di studenti il cui lavoro risulta difficoltoso e scarsamente organizzato. Il metodo di lavoro della classe è in genere bene organizzato. La classe si avvale delle attività di sostegno.
Programmazione per competenze:
Gli obiettivi e i risultati di apprendimento, declinati in competenze, abilità e
conoscenze, sono dichiarati sul POF della scuola a cura del Dipartimento di
Lettere secondo la normativa vigente.
Obiettivi specifici della disciplina
Educazione letteraria conoscenze
Riconoscere i generi letterari e le diverse forme testuali.
Sapere contestualizzare testi e fenomeni letterari.
Comprendere e utilizzare i linguaggi specifici.
Riconoscere le linee evolutive di un genere letterario abilità
Comprendere e riassumere testi letterari in prosa e in poesia
Analizzare aspetti lessicali, retorici, stilistici, metrici di testi letterari
Collocare i testi nel loro periodo storico e culturale competenze
Operare confronti tra i testi di uno stesso autore e di autori diversi
Educazione linguistica
conoscenze
conoscere le tematiche affrontate ed esporle con correttezza, proprietà,
fluidità
abilità
a.s. 2015-2016
Contestualizzare i testi letterari all’interno del relativo periodo storico.
Comprendere e analizzare con precisione brani d’autore facendo gli opportuni riferimenti culturali e linguistici
Migliorare la competenza lessicale attiva e passiva (in particolare conoscere e utilizzare la specifica terminologia disciplinare).
competenze
Saper produrre analisi scritte di testi letterari e brevi saggi su temi culturali
Produrre testi argomentativi
Organizzazione dei contenuti
Nello svolgimento del programma si sono privilegiati i seguenti percorsi:
Ricostruzione delle temperie culturale per cenni essenziali, con particolare attenzione ai momenti e alle mode letterarie del momento;
Contestualizzazione degli autori nel loro tempo, con particolare attenzione ai rapporti con la tradizione e con le nuove esperienze letterarie;
Studio della biografia: richiamo degli episodi essenziali della vita di un autore, funzionali alla ricostruzione della personalità e della psicologia di quest’ultimo;
Studio della poetica: ricostruzione delle linee fondamentali in rapporto al quadro letterario del periodo;
Lettura dei brani antologici: proposta di un commento tematico preferito alla parafrasi letterale dei versi.
Modulo 1 (ripresa e approfondimento di quanto svolto l’anno
precedente)
Neoclassicismo e Romanticismo
Alessandro Manzoni: -la vita e le opere.- Il Conte di Carmagnola e L’Adelchi -I Promessi Sposi. Testi: Il monologo di Adelchi, Il coro dell’atto terzo – brani antologizzati dalle diverse edizioni dei “Promessi Sposi”.
Modulo 2 (settembre - ottobre)
Giacomo Leopardi: la vita - Lo Zibaldone di pensieri - Le operette morali –Lo
stile - I Canti - ideologia e società; testi: “Dialogo della natura e di un
Islandese”, “Dialogo di Tristano ed un amico”- “L’Infinito” - “Ultimo canto di
Saffo” - “La sera del dì festa” - “A Silvia” - “Canto notturno di un pastore
errante dell’Asia” - “La quiete dopo la tempesta” - “Il sabato del villaggio” - “Il
IIS Leopardi Majorana
passero solitario” – “Le ricordanze” - “La ginestra, o il fiore del deserto”, “A se
stesso”.
Modulo 3 (novembre) L’area del Positivismo
Positivismo e Naturalismo: componenti culturali e filosofiche; principi poetici e
tecniche narrative. Zola e il romanzo sperimentale.
Verismo: Naturalismo e Verismo: elementi di continuità e tratti originali. Limiti
cronologici e rappresentanti.
Giovanni Verga La vita. Il percorso letterario. Il ciclo dei Vinti. La tecniche
dell’impersonalità artistica: regressione del narratore discorso indiretto libero,
narratore popolare.
Modulo 4 (dicembre gennaio)
Il Decadentismo
Definizione e limiti cronologici. Il contesto filosofico e culturale. La crisi della
ragione. La crisi dell’io. Le poetiche del Decadentismo.
Simbolismo. I caratteri della nuova poesia. Il poeta e la società
Estetismo. La vita come un’opera d’arte. Wilde e Huysmans (cenni).
Le avanguardie storiche (cenni).
Il rinnovamento delle forme narrative. Caratteri principali del romanzo del
Novecento.
Il Decadentismo in Italia Pascoli e D’Annunzio
Giovanni Pascoli Centralità dell’esperienza biografica. Il fanciullino: una
poetica decadente. Le principali raccolte poetiche. Temi e simboli della
poesia pascoliana. Lo sperimentalismo linguistico.
Gabriele D’Annunzio. Vita e arte. Il superomismo dannunziano. La
produzione narrativa. La produzione poetica. La fase “notturna”.
Il Futurismo. Linee programmatiche. Filippo Tommaso Marinetti: il profeta
dell’arte del futuro.
Il Crepuscolarismo. Caratteri della poesia crepuscolare. I principali temi e
rappresentanti.
Modulo 5 (febbraio marzo) La narrativa italiana: crisi della forma
romanzesca e sue trasformazioni.
Italo Svevo. La vita e il percorso letterario. La coscienza della crisi e
l’inettitudine umana. Una vita. Senilità. La coscienza di Zeno.
Luigi Pirandello. La vita e il percorso letterario. La coscienza della crisi dell’io.
La poetica dell’umorismo. Le novelle. I romanzi: Il fu Mattia Pascal (lettura
integrale). Uno, nessuno, centomila. Il teatro: Sei personaggi in cerca
d’autore.
Modulo 6 (marzo aprile) Novità e tradizione nella poesia
a.s. 2015-2016
Umberto Saba. «Psicoanalitico prima della psicanalisi». Il rapporto tra
esperienza biografica e poetica. La struttura e i temi del Canzoniere.
Giuseppe Ungaretti. L’essenzialità e il dolore. Il dolore della guerra. Vita di un
uomo.
Eugenio Montale. La vita e il percorso letterario. Ossi di seppia. Principali
sviluppi della lirica montaliana.
La poesia ermetica. Salvatore Quasimodo, Mario Luzi.
Cenni su altri poeti del Novecento: Rebora, Campana, Sereni, Caproni,
Zanzotto.
Modulo 7 (aprile maggio) Il dibattito culturale nell’Italia repubblicana
La difficile definizione di Neorealismo. Alberto Moravia, Elio Vittorini, Cesare
Pavese.
La narrativa italiana dopo gli anni ’50
Sperimentalismo poetico e narrativo.
Altri autori del Novecento (Gadda, Fenoglio, Calvino, P.Levi, Pasolini,
Morante, Meneghello).
Nel corso dell’anno gli studenti dovranno leggere e presentare almeno due
libri scelti nel multiforme panorama della narrativa moderna e
contemporanea.
Tutti gli studenti dovranno leggere almeno cinque capitoli dei Malavoglia (I III
IX X XV), il Fu Mattia Pascal e la Coscienza di Zeno.
Modulo trasversale di educazione linguistica In questo percorso, rispondendo al rinnovato interesse per la varietà linguistica, si intende rafforzare le competenze degli allievi rispetto alle forme dell’analisi testuale, del saggio breve e dell’articolo di giornale. Allo svolgimento del modulo, iniziato fin dal primo anno del triennio, saranno dedicate alcune ore per esercitazioni, momenti di confronto, di discussione e di pratica delle varie tipologie testuali. La riflessione sui testi letterari, poetici e narrativi sarà condotta parallelamente al percorso di educazione letteraria. Obiettivi
OBIETTIVO DI FINE QUINQUENNIO
Comprendere e analizzare testi
Ricavare informazioni da testi diversi
Comprendere in maniera autonoma testi letterari e non
Integrare le informazioni testuali con quelle inter ed extratestuali
Migliorare le capacità logiche e critiche
Riassumere e Sintetizzare testi
Effettuare sintesi tra più testi dello stesso tema
IIS Leopardi Majorana
Esporre con ordine e Chiarezza
Costruire autonomamente schemi e mappe concettuali per facilitare l’esposizione
Consolidare le competenze ortografiche e morfosintattiche
Arricchire la competenza lessicale in relazione a diverse situazioni comunicative
Produrre Produrre testi diversi per impostazione (saggio breve, articolo di giornale) con riferimento a diversi registri stilistici.
Argomentare Confrontare diverse modalità argomentative
Produrre testi argomentativi su temi dati
Riconoscere aspetti argomentativi in testi letterari e non
Usare strutture argomentative più complesse rispetto agli altri anni
Applicare metodi di indagine narratologica e poetica
Applicare in maniera autonoma, anche su testi non noti, strumenti formali appresi negli anni precedenti
Usare la scrittura comunicativa
Produrre articoli di cronaca per diverse destinazioni editoriali, adeguando registro stilistico, qualità e quantità di informazione
Costruire titoli per articoli dati
Si sottolinea che la lettura e l’analisi di alcuni canti del Paradiso è stata svolta
nell’anno scolastico precedente.
Gli obiettivi e i risultati di apprendimento, declinati in competenze, abilità e
conoscenze, sono dichiarati sul POF della scuola a cura del Dipartimento di
Lettere secondo la normativa vigente.
Attività di particolare valenza culturale
La classe parteciperà al progetto “Adotta uno spettacolo” (“Lo straniero.
Un’intervista impossibile” o “Amleto a Gerusalemme”).
UDA
È in fase di progettazione un’UDA legata alle tematiche delle migrazioni in cui
sarà coinvolta anche questa materia (Italiano), in particolare a partire dalla
visione dello spettacolo “Lo straniero. Un’intervista impossibile” scelto dalla
classe nell’ambito del progetto “Adotta uno spettacolo”.
a.s. 2015-2016
Strategie didattiche:
Per favorire l’apprendimento, la lezione frontale, indispensabile per
l’inquadramento di periodi e autori, sarà affiancata dalla lettura e analisi
guidata di testi, laboratori in cooperative learning, esercitazioni scritte ed orali.
Dove possibile sarà privilegiata una prospettiva interdisciplinare, intesa ad arricchire il significato del fenomeno letterario. Inoltre per evitare una visione esclusivamente nazionale della letteratura verrà impostato un approccio comparativo alla letteratura, evidenziando relazioni, interdipendenze, motivi dominanti che legano esperienze letterarie geograficamente distinte. Sarà favorita la partecipazione degli studenti alle iniziative culturali proposte dalla scuola o da altri Enti (conferenze, proiezioni cinematografiche, laboratori); sarà favorita anche la partecipazione degli studenti a proiezioni cinematografiche e rappresentazioni teatrali che abbiano validità artistica e culturale.
Strumenti didattici:
Verranno utilizzati in prevalenza i testi scolastici in uso (libri di testo e
dizionari), integrati dagli appunti degli studenti, ed eventualmente da materiali
forniti dall’insegnate anche audiovisivi. Gli alunni saranno invitati anche a
servirsi dei testi della biblioteca e di supporti informatici.
Strumenti di verifica
Nel POF sono esplicitate le tipologie e le forme di verifica utilizzate in itinere e
i criteri di valutazione adottati al termine di ogni periodo valutativo secondo la
normativa vigente.
Le verifiche orali avranno la forma di colloqui, l’esposizioni di un argomento,
analisi e comprensione di brani d’autore, esercizi di comprensione di brani,
eventualmente verranno proposti questionari a risposta aperta o a scelta
multipla.
Le verifiche scritte consisteranno in elaborati in relazione agli ambiti testuali
affrontati e alle tipologie proposte nell'Esame di Stato (prove di analisi del
testo o saggi brevi) e saranno in numero congruo, secondo quanto indicato
nel POF.
Criteri di verifica e valutazione
Nel POF sono esplicitate le tipologie e le forme di verifica utilizzate in itinere e
i criteri di valutazione adottati al termine di ogni periodo valutativo secondo la
normativa vigente
IIS Leopardi Majorana
Nella valutazione si terrà conto dei seguenti elementi:
conoscenza dei temi affrontati
correttezza, proprietà, fluidità espressive nell’esposizione di temi culturali
capacità di organizzare un’esposizione o un testo scritto centrati, esaurienti, coerenti;
precisione nella comprensione e nell’analisi dei testi studiati
attenzione ed interesse dimostrati
costanza nello studio
diligenza e senso di responsabilità
cura ed attenzione nel lavoro domestico
Attività di recupero
Il recupero verrà svolto in itinere attraverso l’assegnazione di esercizi in
classe e a casa, la correzione, il laboratorio in cooperative learning, ulteriori
spiegazioni. Costituirà attività di recupero anche la correzione delle prove
scritte e il chiarimento di concetti durante le interrogazioni.
Gli allievi in difficoltà potranno inoltre usufruire degli sportelli organizzati dalla
scuola. I genitori saranno informati sull’andamento dei figli attraverso il
registro elettronico, la pagella di fine quadrimestre.
Attività di approfondimento
Eventuali attività di approfondimento saranno costituite da percorsi di ricerca
a partire dagli argomenti studiati.
IIS Leopardi Majorana
PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE VAU
DISCIPLINA: LATINO
Docente:Susanna Corelli
Presentazione della classe e situazione di partenza:
Gli allievi dimostrano in genere buona disponibilità all’ascolto e capacità di
attenzione. La maggioranza della classe dimostra interesse discreto per la
materia anche se una parte presenta ancora incertezze nella conoscenza
degli elementi fondamentali di morfologia, sintassi e del lessico di base. Il
metodo di lavoro appare in generale sufficientemente organizzato; il lavoro a
casa non è per tutti sufficientemente accurato. La classe si avvale delle
attività di sostegno.
Programmazione per competenze:
Gli obiettivi e i risultati di apprendimento, declinati in competenze, abilità e
conoscenze, sono dichiarati sul POF della scuola a cura del Dipartimento di
Lettere secondo la normativa vigente.
Organizzazione dei contenuti
Formazione linguistica
Ripasso e consolidamento della morfologia, delle principali strutture del periodo e della sintassi dei casi già affrontati, degli elementi fondamentali di sintassi del periodo, dei principali costrutti verbali (settembre-maggio);
Elementi nuovi di sintassi dei casi e del periodo incontrati durante la comprensione e la traduzione dei testi (durante tutto l’anno).
Educazione letteraria (nuclei essenziali) La poesia elegiaca (ripresa e approfondimento) Ovidio, vita e opere; gli Amores, l’Ars amandi, Metamorphoseon Libri
(settembre)
L’età giulio-claudia. Il quadro storico culturale; le linee principali della
letteratura; i generi poetici; la prosa nella prima età imperiale: la storiografia;
gli autori scientifici e la trattatistica.
a.s. 2015-2016
Seneca: vita, opere: Dialoghi, Epistulae ad Lucilium, De brevitatae vitae, le
tragedie; l’Apocolocyntosis (ottobre – novembre);
La satira sotto il principato: Persio (le Satire); Lucano (Bellum civile); Petronio
(il Satyricon). (Novembre-dicembre)
L’età dai Flavi a Traiano
La poesia: Stazio; Quintiliano (Istitutio oratoria); Plinio il Giovane
(Panegyricus, Epistulae); Tacito e la storiografia; Marziale e l’epigramma; la
satira: Giovenale, (dicembre-marzo);
L’età di Adriano e degli Antonini
Svetonio, Apuleio e il romanzo (marzo aprile)
Gli inizi della letteratura cristiana: Ambrogio, Agostino: vita e opere (maggio)
Verranno forniti spunti critici e sarà richiesta la lettura personale di almeno un
saggio critico.
Autori
Ovidio (settembre – ottobre) in traduzione;
Seneca (ottobre – novembre) De brevitate vitae, Epistulae ad Lucilium.
Di ciascun autore verrà proposta un’ampia lettura di traduzione e per alcuni
una selezione di brani in lingua latina.
Verrà eventualmente proposto un percorso antropologico anche
pluridisciplinare che risponda agli interessi della classe attraverso brani scelti
d’autore
Strategie didattiche:
Nel corso dell’anno vi sarà una attività di consolidamento e recupero delle
conoscenze e delle competenze linguistiche di base già apprese, anche
attraverso studi di comprensione su brani d’autore; si completerà quindi lo
studio di alcuni aspetti della sintassi del periodo e della sintassi del verbo. Per
l’inquadramento di periodi e autori verrà utilizzata la lezione frontale,
affiancata dalla lettura e analisi guidata di testi, laboratori in cooperative
learning, esercitazioni scritte ed orali.
Strumenti didattici:
Verranno utilizzati in prevalenza i testi scolastici in uso (libri di testo e
dizionari), integrati dagli appunti degli studenti, ed eventualmente da materiali
IIS Leopardi Majorana
forniti dall’insegnate. Gli alunni saranno invitati anche a servirsi dei testi della
biblioteca e di supporti informatici.
Strumenti di verifica
Nel POF sono esplicitate le tipologie e le forme di verifica utilizzate in itinere e
i criteri di valutazione adottati al termine di ogni periodo valutativo secondo la
normativa vigente.
Le verifiche orali avranno la forma di colloqui, l’esposizioni di un argomento,
traduzione e analisi di brani d’autore, esercizi di comprensione di brani.
Come verifica scritta sarà proposta la comprensione e/o traduzione di
semplici brani, eventualmente accompagnata da domande su lingua e
contenuto; si effettueranno alcune verifiche sugli autori studiati attraverso
questionari o testi letterari con traduzione a fronte da analizzare e
commentare.
Criteri di verifica e valutazione
Nel POF sono esplicitate le tipologie e le forme di verifica utilizzate in itinere e
i criteri di valutazione adottati al termine di ogni periodo valutativo secondo la
normativa vigente
Nella valutazione si terrà conto dei seguenti elementi:
conoscenza delle strutture e del lessico fondamentale della lingua;
capacità di applicare le proprie conoscenze nell’esecuzione di esercizi;
autonomia nella comprensione dei testi
precisione e proprietà della traduzione italiana
correttezza, proprietà, fluidità espressive nell’esposizione di temi culturali
capacità di organizzare un’esposizione o un testo scritto centrati, esaurienti, coerenti;
conoscenza dei temi affrontati
precisione nella traduzione e nell’analisi linguistica e culturale dei brani d’autore studiati
attenzione ed interesse dimostrati
cura ed attenzione nel lavoro domestico
Attività di recupero
Il recupero verrà svolto in itinere attraverso l’assegnazione di esercizi in
classe e a casa, la correzione, il laboratorio in cooperative learning, ulteriori
a.s. 2015-2016
spiegazioni. Costituirà attività di recupero anche la correzione delle prove
scritte e il chiarimento di concetti durante le interrogazioni.
Il recupero delle conoscenze e delle competenze linguistiche di base verrà
svolto attraverso l’assegnazione di esercizi in classe e a casa, la correzione,
il laboratorio in cooperative learning, ulteriori spiegazioni e spunti di
riflessione su somiglianze e differenze tra le strutture della lingua italiana e
latina. Costituirà attività di recupero anche la correzione delle prove scritte.
Gli allievi in difficoltà potranno inoltre usufruire degli “Sportelli didattici” o di
eventuali corsi di recupero organizzati dalla scuola. I genitori saranno
informati sull’andamento dei figli attraverso il registro elettronico e le pagelle
di fine quadrimestre.
Attività di approfondimento
Eventuali attività di approfondimento saranno costituite da percorsi di ricerca
individuali a partire dagli argomenti studiati.
Classe V AU
PIANO DI LAVORO DI FILOSOFIA Docente: Paola D’Agaro
a.s. 2015-2016
Libro di testo: AA.VV.”Il discorso filosofico”, B.Mondadori, vol.3
SITUAZIONE DELLA CLASSE
Il gruppo classe mantiene un atteggiamento positivo e apparentemente interessato nei confronti della disciplina, ma la partecipazione alle lezioni si conferma poco attiva e propositiva. L’impegno non è sempre costante e comunque non del tutto dimensionato alle attese che rimangono alte, date le buone capacità che allievi ed allieve hanno saputo esprimere in tante occasioni. Il comportamento durante le lezioni è corretto. La relazione con l’insegnante è buona. Le capacità di analisi, sintesi e rielaborazione autonoma dei contenuti emergono più occasioni. Ma va denunciata una tendenza all’acquisizione passiva dei contenuti, acquisizione che spesso risulta mnemonica e poco critica. In generale, la classe necessita di sostegno motivazionale e di continue sollecitazioni. PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE Al termine dell’anno gli allievi dovranno essere in grado di:
- usare correttamente concetti e termini fondamentali del linguaggio della disciplina sia nell’esposizione orale che in quella scritta, ma anche in contesti diversi come forum, articoli di giornale, dibattiti, presentazioni, ecc...;
- analizzare i concetti; - ricostruire premesse e sviluppi di alcuni tipi di argomentazione; - ricostruire aspetti di continuità e rottura tra diverse ipotesi filosofiche; - ricostruire la rete concettuale di ogni filosofo; - stabilire connessioni possibili tra contesto storico-culturale e pensiero
filosofico; - conoscere, nelle linee fondamentali, le differenze nell'interpretazione
del pensiero di ciascun filosofo; - analizzare e comprendere testi filosofici cogliendone parole chiave e
concetti fondamentali; - costruire mappe concettuali.
METODOLOGIA
Si cercherà, per quanto possibile, di agganciare i contenuti al vissuto degli studenti per facilitarne la comprensione. Si adotterà la lezione frontale sostituendola, quando possibile, con approcci di tipo diverso alla disciplina: lavoro di approfondimento e raccolta dati in piccoli gruppi, esposizione da parte di singoli allievi di percorsi di apprendimento compiuti individualmente, lettura guidata e analisi di testi, costruzione di mappe concettuali, correzione in classe degli esercizi svolti a casa, esposizione degli argomenti con il supporto del videoproiettore, elaborazione di sintesi scritte. Si cercherà di favorire l’autovalutazione e l’autocorrezione soprattutto sul piano della competenza espositiva oltre che dell’acquisizione di contenuti (gli allievi saranno portati ad acquisire una sempre maggiore autonomia e chiarezza nell’esposizione anche attraverso una riflessione continua sulla precisione dei termini utilizzati nelle prove). Si cercherà di scoraggiare l’acquisizione mnemonica e acritica dei contenuti mettendo in evidenza l’inefficacia di questa dal punto di vista dello sviluppo cognitivo. Si cercherà di favorire l’autonomia e il rispetto dei tempi e delle regole. Nell’analizzare i testi, si solleciteranno gli allievi a riflettere sui temi affrontati al fine di costruire quel patrimonio di idee indispensabile per un loro più consapevole vivere civile. Apposite sessioni pomeridiane verranno dedicate, se necessario, all'attività di recupero e/o di approfondimento degli argomenti svolti in classe. STRUMENTI Oltre a libro di testo, fotocopie, materiale audiovisivo e informatico, per il consolidamento delle conoscenze si potranno utilizzare i contributi che studiosi ed esperti interni o esterni alla scuola vorranno dare. Utili strumenti per il recupero e la ripresa dei contenuti potranno essere mappe concettuali, questionari e schemi. Anche gli articoli di giornale potranno essere utilizzati in classe qualora le tematiche affrontate lo richiedessero. VERIFICHE Si utilizzerà, a seconda delle necessità, un’ampia gamma di strumenti di verifica, in itinere e sommativi. Le verifiche in itinere saranno periodiche e andranno a valutare il grado di raggiungimento degli obiettivi per ciascun modulo e il progredire del processo didattico-educativo. Alle canoniche verifiche orali si affiancheranno prove strutturate e semi-strutturate In caso di assenze ripetute e/o non adeguatamente motivate in coincidenza con le prove di verifica, si provvederà a tarare le prove suppletive (da somministrarsi il primo giorno utile successivo all’assenza) su livelli più
alti e nelle modalità decise dall’insegnante. Si cercherà di scoraggiare in questo modo una pratica che comporta una perdita di tempo per tutta la classe e una palese ingiustizia nei confronti di chi decide di sottoporsi in ogni caso alla verifica. VALUTAZIONE Le singole verifiche saranno valutate secondo criteri il più possibile oggettivi e comunque esposti con chiarezza all’intera classe. La sufficienza è fissata attorno al 60% di risposte esatte (se si tratta di questionari o di prove strutturate e semi-strutturate). Il raggiungimento della sufficienza nelle prove orali richiederà:
un’esposizione comprensibile;
l’utilizzo di una terminologia chiara anche se non sempre specifica;
un’autonomia di qualche minuto (almeno due - tre) nel rispondere ai quesiti più vasti;
la comprensione di più della metà dei quesiti in almeno una delle sue formulazioni che andranno dalla forma più complessa (che richiede pertanto il massimo sforzo interpretativo) a quella più semplice, “a percorso guidato” (che prevede, quindi, una e una sola risposta);
l’esposizione sicura di almeno un argomento a scelta dell’allievo. La valutazione, in particolare nei casi di lezione dialogata, di discussione in classe sugli argomenti trattati o di controllo dei compiti per casa, potrà avvenire anche tramite i giudizi di “sufficiente”, “buono”, “insufficiente”, ecc. Va da sé che il peso assegnato a queste prove in sede di verifica sommativa, sarà minore rispetto a quello delle prove vere e proprie, orali o scritte che siano. Va aggiunto che verrà valutata positivamente la capacità dell’allievo di riconoscere i propri errori e di auto-correggersi quanto quella di esprimere il proprio pensiero divergente e di dimostrare autonomia critica distaccandosi dai luoghi comuni e dalle idee mutuate dai mass media o acquisite acriticamente dai compagni e/o dall’insegnante. La valutazione finale terrà contro della partecipazione, dell’interesse, dell’autonomia nel comprendere e nel rielaborare un argomento ma anche dei progressi raggiunti durante tutto il percorso nonché di eventuali fattori ostacolanti. È necessario che l’allievo raggiunga la sufficienza in ognuna delle unità didattiche proposte. A tale scopo, a ciascun allievo verrà data la possibilità di porre rimedio ad eventuali insufficienze attraverso il ripasso degli argomenti e la proposta di interventi di recupero singoli e collettivi (sportelli per il recupero). Saranno organizzate, se necessario, prove di verifica apposite finalizzate al recupero delle insufficienze.
CONTENUTI E LORO SCANSIONE TEMPORALE
1 La sinistra hegeliana e Feuerbach settembre
2 Marx e il materialismo ottobre
3 Il Positivismo ottobre
4 Schopenhauer, Kierkegaard novembre
5 Nietzsche, Freud e la critica della razionalità dicembre-gennaio
6 Da Horkheimer a Foucault: per una teoria critica della società.
gennaio-febbraio
7 La filosofia di Heidegger tra esistenzialismo ed ermeneutica
marzo
8 Lineamenti fondamentali delle filosofie della contemporaneità: la filosofia della mente, la bioetica, il pensiero della differenza sessule
aprile
9 Archetypes, symbols and collective unconscious in Carl Jung*
aprile
10 Ripasso generale maggio-giugno
* Il modulo si inserisce nel quadro dell'insegnamento secondo la metodologia CLIL e sarà affrontato in collaborazione con la professoressa Francesca Costa. UNITA' DI APPRENDIMENTO
In sinergia con le diverse discipline e come contributo all’Uda che quest'anno ha come tema trasversale: “Le migrazioni nell'epoca della globalizzazione” verrà affrontato lo studio della metafora del viandante in Nietzsche.
PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE V AU DISCIPLINA: STORIA
Docente: Silvia Pettarin
Presentazione della classe e situazione di partenza Nei confronti di questa disciplina proseguono l’interesse e l’attenzione degli studenti. La partecipazione in classe deve essere in genere sollecitata, nonostante gli studenti siano disponibili alle proposte dell’insegnante e una parte di essi sia capace di interventi pertinenti. Si auspica una più ampia partecipazione attiva degli studenti e una maggior autonomia negli interventi, in particolare su temi storici che consentano di collegarsi alla stretta attualità. Programmazione per competenze L’insegnamento della Storia promuove le seguenti competenze
Comprendere che ogni avvenimento storico è noto sulla base di fonti o testimonianze adeguatamente interpretate e interrogate.
Saper cogliere ogni avvenimento nella sua complessità, inserendolo in una rete di rapporti temporali, spaziali, causali.
Capire come lo studio del passato offra strumenti indispensabili per comprendere il presente.
ssere consapevoli di come studiare e conoscere le diversit nel tempo e nello spazio consentano di comprendere e accogliere le diversit c e coesistono nel mondo contemporaneo.
Queste competenze sono acquisite quando lo studente conosce e comprende i temi trattati; conosce la terminologia specifica; sa cogliere somiglianze e differenze tra epoche diverse; è in grado di valutare la qualità delle fonti e di avere gli strumenti critici che gli consentano di interpretare fatti ed eventi rilevanti; espone in forma chiara e coerente le conoscenze acquisite; sa stabilire autonomamente connessioni con altre discipline. Si tratta di un percorso che gli studenti affrontano dai primi due anni del triennio, in modo eterogeneo, e c e dovrebbero in quest’anno completare. L’insegnamento della Storia contribuisce a sviluppare nello studente numerose Competenze trasversali: leggere e interpretare testi e documenti ricercare fonti e dati cogliere e coniugare relazioni spazio-temporali effettuare confronti tra realt socio-culturali diverse; documentare il proprio lavoro.
Programma Libro di testo: P. Cataldi e aa., Il nuovo La storia e noi, 3, G.B. Palumbo Editore.
L'età dell'Imperialismo e la prima guerra mondiale
L'avvento del Fascismo in Italia
Il mondo tra le due guerre
Totalitarismi e società di massa
La seconda guerra mondiale
La Resistenza e la nascita della Repubblica in Italia
L'Europa e la guerra fredda
Dalla guerra fredda ai giorni nostri (per quanto possibile)
Gli organismi dell'Unione Europea
Gli organismi internazionali
Tali argomenti permetteranno di trattare anche alcuni elementi di Educazione Civica. Verranno inoltre svolti alcuni dei percorsi monografici di approfondimento e verranno analizzate alcune delle raccolte di fonti proposti dal testo in adozione. Nell’affrontare i temi in programma non mancheranno riferimenti e confronti con la situazione contemporanea e collegamenti con le altre discipline. La disciplina collabora con alcuni approfondimenti alla realizzazione dell’UDA intitolata Le migrazioni nell’epoca della globalizzazione e con la partecipazione ad iniziative inerenti il tema dell’UDA. Strategie didattiche: Per favorire il profilo educativo, culturale e professionale di ogni studente, si intendono attivare strategie finalizzate alla risoluzione di problemi complessi ricorrendo a lezione frontale, lezione dialogata e confronto di opinioni; lettura di saggi critici, monografie o articoli di rivista o di quotidiano; approfondimenti individuali ed attività di gruppo; attività relative alla realizzazione dell’UDA eventuale partecipazioni ad Progetti segnalati dalla scuola o da enti esterni. Strumenti didattici Libro di testo; contributi da riviste specializzate, quotidiani, siti di informazione e di approfondimento, testi di storia su temi monografici; proiezione di video e filmati, partecipazione a conferenze. Strumenti di verifica Verific e orali verific e scritte anc e sotto forma di terza prova dell’ same di Stato; relazioni e approfondimenti individuali (comprese le attività relative all’UDA). Criteri di verifica e valutazione La valutazione si baserà su un numero congruo di verifiche orali (anche in forma di terza prova) e scritte, su eventuali approfondimenti individuali; sull’attivit svolta per l’UDA e per gli altri progetti a cui la classe partecipa;
sulla partecipazione in classe sulla continuit e puntualit nell’impegno sulla crescita delle competenze degli studenti. La valutazione dell’esposizione orale terr conto anc e delle capacit e della correttezza espressiva, della ricchezza lessicale, della conoscenza del linguaggio proprio della disciplina. Attività di recupero Qualora sia necessario, il recupero verrà effettuato in itinere, in classe e con l’assegnazione di specifico lavoro pomeridiano. Le competenze e il metodo di lavoro verranno recuperati e/o sviluppati anche nelle attività relative alla realizzazione dell’UDA e/o in altri progetti. CLIL Grazie alla disponibilità della prof. Francesca Costa verranno effettuati degli approfondimenti in Inglese sull’uso del cartone animato ad integrazione di alcuni temi storici (la satira dei cartoons di Walt Disney contro il Nazismo; Hiroshima raccontata da un anime giapponese). Attività di approfondimento
- Pordenonelegge 2014 - Progetto “Il quotidiano in classe” - Conferenza sulla storia dell’industrializzazione a Pordenone nel
secondo dopoguerra
PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 5A Scienze Umane
A.S. 2015/2016
disciplina : lingua e civiltà straniera inglese
docente: prof.a Susanna Del Ben
PRESENTAZIONE DELLA CLASSE E SITUAZIONE DI PARTENZA:
Dalle prime osservazioni il livello generale della classe appare buono. Per
quanto riguarda il comportamento è generalmente corretto: gli allievi seguono
la lezione, eseguono i compiti, mentre negli interventi si distingue un gruppo
più assiduo e partecipativo rispetto al resto dei compagni.
PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE:
combinare la pratica delle abilità di listening, speaking, con lo sviluppo
sistematico delle abilità di writing e delle attività di vocabulary
comprendere una varietà di messaggi orali in contesti diversificati
saper sostenere una conversazione funzionale alla situazione
comunicativa
produrre testi scritti di vario tipo con chiarezza logica e precisione
lessicale
comprendere in maniera globale testi scritti relativi a tematiche culturali
dell’ambito di studi
riconoscere i generi testuali funzionali alla comunicazione nell’ambito
scientifico e del linguaggio letterario
comprendere e interpretare testi letterari, analizzandoli dal punto di
vista degli aspetti formali, collocandoli nel contesto storico-culturale
attivare modalità di apprendimento autonomo nella scelta degli
strumenti di studio e nell’individuazione di strategie idonee
STRATEGIE DIDATTICHE:
presentazione di testi orali per lo sviluppo dell’ascolto a viva voce o
registrati con situazioni comunicative di progressiva complessità
differenziate per contesto, elementi referenziali, registro di lingua
presentazione di testi scritti relativi a vari aspetti della vita e della
cultura dei paesi stranieri di lingua inglese
lavori individuali, di gruppo, a coppie e monitoraggio
revisione in classe di compiti domestici
esercitazioni e simulazioni
approfondimenti relativi al programma
lezione frontale e lezione dialogata
STRUMENTI DIDATTICI:
Utilizzo di : libri di testo, fotocopie, lavagna, registratore, dizionario
monolingue, cd, dvd, lettore cd o dvd, appunti o dispense dell’insegnante,
articoli di giornale e/o riviste, testi di supporto, proiettore, internet, computer.
CONTENUTI
Libro di testo:
“Performer FCE Tutor” Student’s Book + Workbook edizioni Zanichelli;
fotocopie da altri manuali di lingua e di letteratura;
Per la lettura del testo letterario si sceglieranno testi brevi, significativi,
accessibili linguisticamente, rilevanti dal punto di vista della motivazione, del
valore, della rappresentatività del genere, preceduti da una presentazione
dell’autore e del periodo storico-culturale.
Le unità di lingua si intendono comprensive di tutti i loro contenuti (Grammar,
Vocabulary, Reading, Writing, Use of English, Listening, Speaking).
settembre: unit 10 Relationships
ottobre : unit 11 Crime
novembre : Charles Dickens – extracts from “Hard Times”
dicembre : R.L.Stevenson – extracts from “The Strange Case of Dr.Jekyll and
Mr.Hyde”
gennaio : Oscar Wilde – extracts from “The Picture of Dorian Gray”
febbraio : James Joyce – extracts from “Dubliners” and “Ulysses”
marzo : Virginia Woolf – extracts from “Mrs.Dalloway”
aprile : Samuel Beckett – extracts from “Waiting for Godot”
maggio : unit12 Money
STRUMENTI DI VERIFICA
Compiti scritti in classe : comprensione, lessico, grammatica, produzione
scritta, quesiti di letteratura. Interrogazioni orali.
CRITERI DI VERIFICA E VALUTAZIONE
Le verifiche saranno scritte e orali in numero adeguato (due scritti e due orali
nel primo periodo; tre scritti e due orali nel secondo periodo). Per lo scritto si
richiede competenza nelle abilità di produzione, grammatica, lessico,
comprensione di lettura e analisi testuale. Per l’orale si richiede competenza
nelle abilità di ascolto, parlato, esposizione e/o efficacia comunicativa.
ATTIVITA’ DI RECUPERO :
Qualora necessario verrà svolto recupero in itinere.
ATTIVITA’ DI APPROFONDIMENTO
Partecipazione della classe a conferenze in lingua inglese.
Per quanto riguarda l’UDA sull’immigrazione si prevede di svolgere brani di
interesse sulla tematica “immigration”.
E’ prevista integrazione di esercizi per consolidamento della grammatica con
materiale in fotocopia e dispense da differenti manuali graduati per livelli.
31 ottobre 2015 prof.a Susanna Del Ben
I.I.S. Leopardi-Majorana
PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 5°Au.
DISCIPLINA: MATEMATICA.
Docente: Ludovico Romano.
Presentazione della classe e situazione di partenza:
Il comportamento in classe è corretto e rispettoso, sia tra compagni che nei confronti del docente e anche la soglia di attenzione durante le lezioni è sufficientemente alta. Gli interventi nel corso delle stesse sono adeguati e quasi sempre pertinenti. Dalla prima verifica scritta è apparso necessario approfondire le tecniche di risoluzione delle disequazioni di 2° grado, delle disequazioni fratte e dei sistemi. Il quadro generale fin qui descritto non può essere arricchito da ulteriori dettagli a causa del poco tempo avuto a disposizione. Inoltre alcune uscite e partecipazioni della classe a manifestazioni e conferenze di vario genere hanno ulteriormente ridotto le possibilità d’incontro. Gli studenti sembrano comunque seguire con interesse le attività didattiche fin qui proposte e manifestano, in qualche caso, livelli di partecipazione attiva e propositiva.
Programmazione per competenze:
OBIETTIVI E COMPETENZE
Le competenze specifiche della disciplina sono:
1. utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico e algebrico, rappresentandole anche sotto forma grafica.
2. individuare le strategie appropriate per la soluzione dei problemi.
3. visione storico-critica del pensiero matematico.
4. analizzare dati ed interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche con l’ausilio di rappresentazioni grafiche, usando consapevolmente gli strumenti di calcolo o le potenzialità offerte da applicazioni specifiche di tipo informatico.
a.s. 2015-2016
PROGRAMMAZIONE DEI CONTENUTI DI MATEMATICA
Unità didattica Competenze
Conoscenze/Contenuti disciplinari
Abilità
DISEQUAZIONI DI 2° GRADO,
DISEQUAZIONI FRATTE,
EQUAZIONI IRRAZIONALI E CON IL VALORE
ASSOLUTO
1-2-4 · risoluzione di disequazioni fratte
· risoluzione di disequazioni polinomiali
· risoluzione di equazioni irrazionali.
· risoluzione di equazioni con il valore assoluto
· risoluzione di disequazioni con il valore assoluto
· Conoscere la tecnica per risolvere disequazioni fratte.
· Utilizzare lo schema dei segni capendo il suo significato.
· Saper risolvere sistemi di disequazioni con disequazioni fratte e di secondo grado.
· Saper distinguere tra l’uso dello schema di intersezione e quello dei segni.
· Equazioni irrazionali · Equazioni e
disequazioni con il valore assoluto.
FUNZIONI E LORO PROPRIETA’
1-2-4 • Principali proprietà di una funzione: dominio, segno,
• iniettività, suriettività, biettività, ( (dis)parità, (de)crescenza, periodicità, funzione inversa, funzione composta.
• Individuare dominio, segno, iniettività, suriettività, biettività (*), (dis)parità, (de)crescenza, periodicità (solo con analisi grafica, “a vista”),
• Determinare la forma analitica della funzione inversa di una funzione data
• Costruire il grafico cartesiano della funzione inversa, per simmetria rispetto alla bisettrice del 1° quadrante
• Riconoscere la struttura di una funzione composta attraverso l'analisi della sua forma analitica (finalizzata alla derivazione)
• Trasformare geometricamente il grafico di una funzione.
I.I.S. Leopardi-Majorana
LIMITI DI FUNZIONI REALI
1-2-3-4 • Nozioni base della topologia • Successioni convergenti a
un valore della variabile indipendente e punti di accumulazione (preparazione all’idea di “tendere a…”)
• Introduzione intuitiva al concetto di limite, al finito e all'infinito, e loro scrittura simbolica.
• Primi teoremi sui limiti (unicità del limite, permanenza del segno, confronto, solo enunciati e interpretazione)
• Algebra dei limiti, le forme indeterminate, i limiti notevoli
• Applicare i primi teoremi sui limiti
• Calcolare il limite di somme, prodotti, quozienti e potenze di funzioni razionali intere e fratte, semplici funzioni esponenziali e logaritmiche e/ o irrazionali
• Calcolare limiti che si presentano sotto forma indeterminata di funzioni razionali intere e fratte, semplici funzioni esponenziali e logaritmiche e/ o irrazionali
• Calcolare limiti ricorrendo ai limiti notevoli
FUNZIONI CONTINUE 1-2-3-4 • Il concetto di funzione continua
• Punti di discontinuità • Il concetto di asintoto nei
vari casi
• Studiare la continuità o discontinuità di una funzione in un punto
• Calcolare gli asintoti di una funzione
• Disegnare il grafico probabile di una funzione
DERIVATA DI UNA FUNZIONE
1-2-3-4 • Il problema della tangente ad una curva e la definizione di tangente
• La derivata di una funzione • Derivabilità e continuità • Derivate delle funzioni
elementari • Algebra delle derivate
• Calcolare la derivata di una funzione mediante le derivate fondamentali e le regole di derivazione relative a funzioni razionali intere e fratte, semplici
• Calcolare la retta tangente al grafico di una funzione
• Applicare le derivate alla fisica
TEOREMI SULLE FUNZIONI DERIVABILI
1-3-4 • Concetto di massimo e minimo assoluto e relativo di una funzione
• Punti di flesso
• Determinare i massimi e i minimi mediante la derivata prima
• Determinare i flessi mediante le derivate
STUDIO DI FUNZIONE 1-3 • Funzioni algebriche razionali intere e fratte
• Studiare una funzione polinomiale e tracciare il suo grafico
• Studiare una funzione algebrica razionale fratta e tracciare il suo grafico
a.s. 2015-2016
CALCOLO INTEGRALE 1-2-3-4 • Primitiva e integrale indefinito di una funzione
• Integrali immediati semplici • Il problema delle aree e il
concetto di integrale definito di una funzione
• Le proprietà dell’integrale definito e il suo calcolo.
• Calcolare gli integrali indefiniti di funzioni mediante gli integrali immediati
• Calcolare l’integrale di funzioni polinomiali
• Calcolare gli integrali definiti mediante il teorema fondamentale del calcolo integrale
N.B. Si rammenta che la realizzazione quanto riportato nella precedente tabella può essere soggetto a eventuali modifiche, tagli o aggiunte qualora dovessero sorgere particolari esigenze durante il corso dell’anno.
Strategie didattiche:
• lezione frontale; • lezione dialogata; • lavori di gruppo; • approfondimenti individuali;
Strumenti didattici:
• libro di testo; • testi extrascolastici di vario genere; • appunti dalle lezioni; • strumenti informatici e multimediali.
� Strumenti di verifica
• verifiche scritte; • verifiche orali; • lavori autonomi di approfondimento.
Criteri di verifica e valutazione
S’intende verificare la padronanza degli strumenti utili (linguaggio scientifico adeguato, correttezza formale, padronanza degli oggetti matematici utili alla risoluzione di problemi) alla comprensione dei fondamentali concetti della disciplina al fine di una successiva rielaborazione originale degli stessi. In ogni caso i criteri di valutazione saranno subordinati a quanto previsto dal P.O.F.
Attività di recupero
• Somministrazione di specifici esercizi di rinforzo;
I.I.S. Leopardi-Majorana
• ricerche in rete; • materiali da altri libri di testo; • verifiche di recupero sia scritte che orali; • lavori autonomi di approfondimento
Attività di approfondimento
• eventuali ricerche in rete di materiali di interesse storico; • eventuali approfondimenti di natura multidisciplinare in collaborazione
con il docente di filosofia.
I.I.S. Leopardi-Majorana
PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 5°Au.
DISCIPLINA: FISICA.
Docente: Ludovico Romano.
Presentazione della classe e situazione di partenza:
Il comportamento in classe è corretto e rispettoso, sia tra compagni che nei confronti del docente e anche la soglia di attenzione durante le lezioni è sufficientemente alta. Gli interventi nel corso delle stesse sono adeguati e quasi sempre pertinenti. Il quadro generale fin qui descritto non può essere arricchito da ulteriori dettagli a causa del poco tempo avuto a disposizione. Inoltre alcune uscite e partecipazioni della classe a manifestazioni e conferenze di vario genere hanno ulteriormente ridotto le possibilità d’incontro. Gli studenti sembrano comunque seguire con interesse le attività didattiche fin qui proposte e manifestano, in qualche caso, livelli di partecipazione attiva e propositiva.
Programmazione per competenze:
OBIETTIVI E COMPETENZE
Le competenze specifiche che l’insegnamento di questa disciplina concorre a sviluppare nell’ultimo anno di Liceo sono:
1. Osservare ed identificare fenomeni reali. 2. Affrontare e risolvere semplici problemi di fisica, usando gli strumenti
matematici adeguati al percorso didattico 3. Avere consapevolezza dei vari aspetti del metodo sperimentale,
dove l’esperimento è inteso come interrogazione ragionata dei fenomeni naturali, analisi dei dati e dell’affidabilità di un processo di misura, costruzione e/o validazione di modelli.
4. Comprendere e valutare le scelte scientifiche e tecnologiche che interessano la società in cui vive.
a.s. 2015-2016
PROGRAMMAZIONE DEI CONTENUTI DI FISICA Unità didattica Competenze Conoscenze/Contenuti
disciplinari Abilità
La temperatura 1-2-3 • Conoscere il concetto di temperatura
• L’equilibrio termico • Il principio zero della
termodinamica • La dilatazione termica • Proprietà termometriche
dei gas • Il gas perfetto
• Calcolare la variazione di corpi solidi e liquidi sottoposti a riscaldamento.
• Riconoscere i diversi tipi di trasformazione di un gas.
• Applicare le leggi di Boyle e Gay-Lussac alle trasformazioni di un gas.
• Sapere utilizzare l’equazione di stato di un gas perfetto.
Il calore 1-2-3-4 • Calore e lavoro • Propagazione del calore • I Passaggi di stato
• Comprendere come riscaldare un corpo con il calore o con il lavoro.
• Calcolare la temperatura di equilibrio
• Descrivere le modalità di trasmissione dell’energia termica.
• Descrivere i passaggi tra i vari stati di aggregazione molecolare.
• Calcolare l’energia impiegata nei cambiamenti di stato.
• Interpretare il concetto di calore latente.
Cenni di termodinamica
1-3-4 • Sistema termodinamico • Stato termodinamico • Primo principio della
termodinamica • Trasformazioni
termodinamiche • Secondo principio della
termodinamica
• Saper applicare le leggi delle trasformazioni termodinamiche
• Semplici applicazioni dei principi della Termodinamica.
I.I.S. Leopardi-Majorana
LE CARICHE ELETTRICHE
1-3 · Distinguere cariche elettriche positive e negative. · Conoscere alcuni fenomeni elettrostatici elementari: elettrizzazione per strofinio, contatto e per induzione. · Forza d’interazione elettrica, legge di Coulomb, e confronto con la forza di gravitazione universale · Principio di sovrapposizione
· Saper esporre con il linguaggio specifico e precisione formale i contenuti acquisiti · Collegare fenomeni di elettrizzazione alla presenza di cariche elettriche. · Riconoscere e descrivere fenomeni elettrici. · Descrivere fenomeni di elettrizzazione per strofinio, contatto e induzione. · Distinguere corpi conduttori e isolanti. · Saper applicare il Principio di sovrapposizione per determinare la forza d’interazione tra più cariche
IL CAMPO ELETTRICO
3 · Conoscere le caratteristiche del campo elettrostatico generato da una carica puntiforme. · Potenziale elettrico, differenza di potenziale e superfici equipotenziali.
· Saper collegare il concetto di forza al concetto di campo · Il campo elettrostatico generato da più cariche puntiformi · Collegare il concetto di energia potenziale al concetto di potenziale. · Descrivere il moto di una carica in termini di campo e di potenziale usando l’analogia con il caso gravitazionale.
L’ELETTROSTATICA 1-2-4 · Equilibrio elettrostatico · Proprietà di un conduttore carico in equilibrio elettrostatico · Capacità di un conduttore e di un condensatore piano · Energia immagazzinata in un condensatore
· Individuare le condizioni di equilibrio elettrostatico nei conduttori. · Descrivere il campo e il potenziale elettrico in situazioni di equilibrio elettrostatico. · Definire la densità superficiale di carica. · Calcolare campo elettrico e potenziale nei conduttori in equilibrio elettrostatico. · Definire e utilizzare la capacità elettrica dei conduttori.
LA CORRENTE ELETTRICA
1-4 · Conoscere come si genera la corrente elettrica nei conduttori metallici · Conoscere la conduzione elettrica nei solidi, nei liquidi e nei gas.
· Descrivere la corrente elettrica in termini di particelle cariche in movimento.
a.s. 2015-2016
I CIRCUITI ELETTRICI
1-4 · Conoscere la forza elettromotrice. · Conoscere la resistenza. · Conoscere le leggi di Ohm. · Resistenze in serie ed in parallelo · La potenza elettrica.
· Riconoscere le relazioni fra grandezze elettriche in contesti reali. · Conoscere le procedure di misurazione delle grandezze elettriche. · Valutare l’energia nei fenomeni elettrici. · Mettere in relazione circuiti elettrici e schemi elettrici. · Individuare la funzione dei circuiti elettrici nei dispositivi d’uso comune. · Analizzare quantitativamente circuiti resistivi.
IL CAMPO MAGNETICO
1-2-4 · Conoscere le caratteristiche dell’interazioni tra magneti, tra magneti e fili percorsi da corrente, tra due fili percorsi da corrente · Campo magnetico generato da un filo, da una spira, da un solenoide percorsi da corrente · Conoscere la legge che esprime la Forza di Lorentz e il suo effetto sul moto di una carica in un campo magnetico uniforme · Proprietà magnetiche della materia: sostanze diamagnetiche, paramagnetiche e ferromagnetiche · Definizione di flusso del campo magnetico attraverso una superficie.
· Saper esporre con il linguaggio specifico e precisione formale i contenuti acquisiti · Formalizzare problemi di fisica relativi al moto delle cariche in un campo magnetico e applicare le relazioni note per la loro risoluzione · Formalizzare problemi di fisica relativi al campo magnetico generato da uno o più corpi conduttori percorsi da corrente e applicare le relazioni note per la loro risoluzione.
L’INDUZIONE ELETTRO - MAGNETICA
1-2-4 · Conoscere alcuni fenomeni di induzione elettromagnetica · La legge dell’induzione di Faraday-Neumann, la Legge di Lenz e la Legge di Lorentz. · Corrente alternata · Il campo magnetico terrestre
· Descrivere il fenomeno dell'induzione e, in particolare, la legge di Lenz · Descrivere il funzionamento essenziale di un generatore e di un motore
LE ONDE ELETTROMAGNETICHE
· Le onde elettro magnetiche (cenni qualitativi) · Lo spetto elettromagnetico e la relazione alle sue bande di interesse tecnologico
· Saper descrivere le onde elettromagnetiche in diversi contesti della vita reale
N.B. Si rammenta che la realizzazione quanto riportato nella precedente tabella può essere soggetto a eventuali modifiche, tagli o aggiunte qualora dovessero sorgere particolari esigenze durante il corso dell’anno.
I.I.S. Leopardi-Majorana
Strategie didattiche:
• lezione frontale; • lezione dialogata; • lavori di gruppo; • attività di laboratorio. • approfondimenti individuali;
Strumenti didattici:
• libro di testo; • testi extrascolastici di vario genere; • appunti dalle lezioni; • strumenti informatici e multimediali.
� Strumenti di verifica
• verifiche scritte; • verifiche orali; • lavori autonomi di approfondimento.
Criteri di verifica e valutazione
S’intende verificare la padronanza degli strumenti utili (linguaggio scientifico adeguato, correttezza formale, padronanza degli oggetti matematici utili alla risoluzione di problemi) alla comprensione dei fondamentali concetti della disciplina al fine di una successiva rielaborazione originale degli stessi. In ogni caso i criteri di valutazione saranno subordinati a quanto previsto dal P.O.F.
Attività di recupero
• Somministrazione di specifici esercizi di rinforzo; • ricerche in rete; • materiali da altri libri di testo; • verifiche di recupero sia scritte che orali; • lavori autonomi di approfondimento
Attività di approfondimento
• eventuali ricerche in rete di materiali di interesse storico; • eventuali approfondimenti di natura multidisciplinare in collaborazione
con il docente di filosofia.
I.I.S. Leopardi-Majorana
PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE
5AU
SCIENZE UMANE
CLAUDIA FURLANETTO
Presentazione della classe e situazione di partenza;La classe conferma le caratteristiche finora espresse: buone capacità, buone motivazioni, serietà e disponibilità agli approfondimenti proposti. Particolare attenzione verrà dedicata quest'anno ad un'accurata preparazione all'esame di stato, con esercitazioni mirate sia scritte che orali. Tuttavia – data la buona disponibilità della classe – verranno proposti significativi approfondimenti, che ruoteranno attorno al tema dell'immigrazione, tema scelto per la realizzazione dell'uda. La classe – nell'ambito di un approfondimento del tema delle istituzioni psichiatriche – ha incontrato e intervistato lo psichiatra, dott. Fulvio Tesolin. Il contributo alla realizzazione dell'uda da parte delle discipline di Scienze umane è fondamentale e si rinvia allo schema generale allegato alla premessa per maggiori informazioni.
Programmazione per competenze:
□ COMPETENZE PER ASSI CULTURALI
Asse culturale dei linguaggi (Pedagogia - Sociologia - Antropologia)
Competenza 1
“Analizzare, comprendere e interpretare autonomamente testi delle Scienze Umane sia nella loro specificità disciplinare, che nella loro complessità interdisciplinare”.
Capacità/Abilità
a.s. 2015-2016
- Analizzare ed interpretare testi complessi, cogliendone i nessi concettuali espliciti ed impliciti.
- Padroneggiare le strutture concettuali di un testo sia a livello disciplinare che in un’ottica interdisciplinare.
Competenza 2
“Produrre, anche in formato multimediale, varie tipologie di testi articolati in maniera interdisciplinare e utilizzando le terminologie specifiche”.
Capacità/Abilità
- Elaborare testi con aperture interdisciplinari, facendo uso anche di strumenti multimediali.
- Utilizzare in modo consapevole e mirato le terminologie specifiche sulla base del proprio patrimonio lessicale.
Asse culturale storico-sociale (Pedagogia - Sociologia - Antropologia)
Competenza “Comprendere, in maniera autonoma e critica, il cambiamento e la diversità dei fenomeni e dei modelli educativi e socio-culturali collocandoli in una dimensione sia diacronica, attraverso il confronto fra epoche, sia sincronica attraverso il confronto fra aree geografiche e culturali ”.
Capacità/Abilità
- Operare autonomamente confronti tra prospettive socio-educative diverse, collocandole nella loro corretta dimensione storico-culturale e analizzandone tutti gli elementi espliciti ed impliciti.
I.I.S. Leopardi-Majorana
- Analizzare le radici storiche e culturali di alcuni fenomeni socio-educativi del mondo contemporaneo, individuandone gli elementi di continuità e discontinuità storica.
- Comprendere il cambiamento in relazione agli usi, alle abitudini e al vivere quotidiano, analizzandone le cause.
Asse culturale scientifico-tecnologico (Sociologia)
Competenza “Osservare, descrivere e interpretare in maniera autonoma i vari fenomeni appartenenti alla realtà umana e sociale, riconoscendo e analizzando nelle loro varie forme i concetti di sistema e complessità”.
Capacità/Abilità
- Individuare e descrivere autonomamente le diverse chiavi interpretative dei fenomeni antropologici e socio-educativi, inseriti anche in sistemi complessi, utilizzando specifici modelli di riferimento.
- Saper utilizzare gli strumenti della ricerca in una prospettiva multidisciplinare per poter condurre semplici indagini empiriche.
□ CONOSCENZE
PEDAGOGIA
Durante il quinto anno l’approccio allo studio della Pedagogia diventa più arti-colato in quanto sono affrontate, in un’ottica interdisciplinare, importanti pro-blematiche di cultura pedagogica tipiche dell’età contemporanea (internazio-nalizzazione dei sistemi educativi, educazione alla cittadinanza e ai diritti umani, educazione permanente, mass media e nuove tecnologie didattiche, educazione e multiculturalità, disabilità e didattica inclusiva, servizi di cura alla persona). Ad una delle suddette problematiche va dedicata una semplice ricerca empirica, utilizzando gli strumenti principali della metodologia della ri-cerca. Fondamentale è anche lo studio di alcuni dei principali autori della Pe-
a.s. 2015-2016
dagogia del Novecento. Quest’anno è prevista la lettura dell’opera di M. Montessori “ Educare alla libertà”.
Contenuti - La disabilità e la didattica inclusiva
- I servizi di cura alla persona
- La formazione alla cittadinanza
- L’educazione ai diritti umani e i diritti dei minori
- L’educazione permanente e la formazione di adulti e anziani
- La scuola e le nuove prospettive europee
- L’educazione multiculturale e interculturale
- I mass media e le nuove tecnologie didattiche
- L’attivismo pedagogico e le “scuole nuove
- J. Dewey e l’attivismo pedagogico americano
- M. Montessori e la “Casa dei bambini”
- E. Claparède e l’educazione funzionale
- C. Freinet e l’educazione cooperativa
- J. Maritain e l’umanesimo integrale
- G. Gentile e l’attivismo idealistico
SOCIOLOGIADurante il quinto anno lo studio della Sociologia è finalizzato all’analisi di al-cuni concetti e problemi sociologici fondamentali (l’istituzione, la socializza-zione, la devianza, la mobilità sociale, i mezzi di comunicazione di massa, la secolarizzazione, la critica della società di massa, la società e la politica, i processi di globalizzazione, il Welfare state) oltre all'applicazione della Socio-logia nell'ambito delle politiche di cura e di servizio alla persona (salute, fami-glia, inserimento sociale e scolastico dei disabili). Per questi temi è prevista la lettura di pagine significative tratte da autori classici e contemporanei.
Contenuti
I.I.S. Leopardi-Majorana
- Le istituzioni e le organizzazioni sociali
- La conflittualità sociale: teorie di E. Durkheim, K. Marx e M. Weber
- La stratificazione sociale
- La devianza
- L’industria culturale e la società di massa
- La religione e la secolarizzazione
- La politica e il potere
- Il Welfare State
- La globalizzazione
- La salute, la malattia e la disabilità
- Le nuove sfide per l’istruzione
- La ricerca sociologica e gli strumenti di indagine
ANTROPOLOGIA
Durante il quinto anno sono trattate le grandi culture-religioni mondiali e la loro interpretazione del mondo e della vita umana. Inoltre, si approfondiscelo studio dei metodi di ricerca specifici dell’Antropologia. E’ prevista anche la la lettura di brani antologici dei principali autori.
Contenuti - L’essenza e il significato della religione
- La dimensione rituale
- Lo sciamanesimo
- La religione nella preistoria
- Il simbolismo religioso
- Le grandi religioni: Cristianesimo, Islam, Induismo, Buddismo, Ebraismo
- Le religioni “altre”
- La ricerca sul campo
a.s. 2015-2016
- L’evoluzione del concetto di “campo”
Strategie didattiche:Lezione-spiegazione con parte più attiva del docente; lezioni dialogate con gli studenti anche per consentire un feedback sulle proposte del docente; lavori di gruppo variamente articolati; visite guidate.
Strumenti didattici:Manuali, libri della biblioteca, libri personali, internet, strumenti multimediali.
Strumenti di verifica
Prove scritte e orali. Alla classe verranno proposte solo verifiche strutturate secondo il modello proposto all'esame di Stato.
Criteri di verifica e valutazione
Ci si attiene ai criteri indicati nel POF.
Attività di recupero
Eventuali corsi di recupero a fronte di difficoltà diffuse nella classe.
Attività di approfondimento
Si veda l'uda allegata alla premessa, dal titolo LE MIGRAZIONI NELL'EPOCA DELLA GLOBALIZZAZIONE.
MATERIA : Scienze DOCENTE : Prof.ssa Petroccione Francesca FINALITA’ DELL’EDUCAZIONE SCIENTIFICA L'educazione scientifica mira a far acquisire conoscenze e abilità. Le conoscenze si basano su contenuti che l'allievo fa propri, su quel sapere che diviene pian piano patrimonio culturale, base per nuove conoscenze; le abilità si basano su procedimenti operativi; è il saper fare non solo manuale, guidato da intuizioni, ma anche sorretto da una mente che ragiona. La scienza è un sapere ottenuto tramite l'osservazione attenta delle cose e degli eventi, tra i quali spesso esistono connessioni logiche che portano a regole generali di causa ed effetto. Gli allievi devono allora essere guidati a osservare la realtà che li circonda in modo scientificamente corretto e sollecitati ad individuare problemi, formulare ipotesi e tentare risposte, sviluppando atteggiamenti critici nei confronti del mondo. SITUAZIONE DI PARTENZA La classe in generale dimostra un buon livello di attenzione durante le spiegazioni, partecipa spontaneamente al dialogo e si dimostra sempre disponibile a collaborare. L’impegno in generale appare abbastanza soddisfacente. PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE CHIMICA ORGANICA E BIOCHIMICA
Proprietà dei composti organici Competenze Indicatori Saper classificare Saper riconoscere e stabilire relazioni
- classificare gli isomeri in strutturali e stereoisomeri
- correlare la reattività di un composto organico con la presenza di eteroatomi
- classificare le reazioni organiche in base al comportamento degli atomi o dei gruppi di atomi
- correlare la temperatura di fusione e di ebollizione di un composto organico con la sua massa molecolare
- correlare la solubilità in acqua di un composto organico con la presenza nella molecola di gruppi idrofili o lipofili
Classificazione dei composti organici Competenze Indicatori Saper classificare Saper riconoscere e stabilire relazioni Saper applicare le conoscenze acquisite alla vita reale
- rappresentare la struttura delle molecole organiche
- classificare gli idrocarburi in alifatici e aromatici
- assegnare il nome ai composti organici appartenenti alle diverse classi secondo la Nomenclatura IUPAC
- correlare la natura dei gruppi funzionali con la loro reattività nei composti organici
- descrivere diffusione, utilizzo ed effetti tossici di alcuni composti organici
Le biomolecole e i polimeri
Competenze Indicatori Saper classificare Saper riconoscere e stabilire relazioni Saper applicare le conoscenze acquisite alla vita reale
- individuare nelle biomolecole le corrispondenti unità costitutive
- correlare la struttura delle biomolecole con la loro funzione biologica
- classificare i polimeri di sintesi in polimeri di poliaddizione e polimeri di condensazione
- descrivere l’utilizzo di alcuni polimeri di sintesi
Il metabolismo energetico: la fotosintesi
Competenze Individuare collegamenti e relazioni Acquisire ed interpretare le informazioni
Indicatori - collegare la fotosintesi alla
produzione di materia organica - correlare il percorso degli
elettroni durante le reazioni luminose con la produzione di ATP e di NADPH
- descrivere il ciclo di Calvin mettendo in relazione i prodotti
della fase luminosa con la riduzione di CO2
- identificare nel glucosio e nella G3P le molecole chiave del metabolismo degli organismi autotrofi
Il metabolismo energetico: la respirazione cellulare
Competenze Saper effettuare connessioni logiche Saper riconoscere e stabilire relazioni Saper applicare le conoscenze acquisite alla vita reale
Indicatori - Identificare nella glicolisi la
prima fase della demolizione del glucosio
- illustrare le due vie che può prendere il piruvato in presenza e in assenza di ossigeno
- analizzare le tappe fondamentali del ciclo di Krebs evidenziando quelle esoergoniche
- correlare la discesa degli elettroni lungo la catena di trasporto con il processo chemiosmotico
- spiegare i vantaggi della fermentazione in carenza di ossigeno
- identificare nella rigenerazione del NAD+ lo scopo della fermentazione
- identificare alcuni prodotti alimentari ottenuti con il processo di fermentazione
La biologia molecolare del gene
Competenze Acquisire ed interpretare le informazioni Saper riconoscere e stabilire relazioni
Indicatori - descrivere la struttura a doppia
elica del DNA evidenziando la disposizione antiparallela dei due filamenti di nucleotidi
- descrivere la duplicazione semiconservativa del DNA
- identificare nel codice genetico il mezzo per tradurre il messaggio scritto nel DNA nella sequenza di amminoacidi
di una proteina - descrivere come il messaggio
genetico del DNA viene trasferito all’RNA
- illustrare il ruolo dell’RNA di trasporto e dei ribosomi nella sintesi proteica
- illustrare le tre fasi del processo di traduzione
SCIENZE DELLA TERRA
La struttura interna della Terra Competenze Indicatori Acquisire e interpretare informazioni
- riconoscere l’importanza dei metodi geofisici, delle informazioni dirette e delle esperienze di laboratorio per costruire un modello dell’interno della Terra
- distinguere i meccanismi responsabili del calore terrestre
- descrivere la struttura stratificata del nostro pianeta e spiegarne l’origine in termini di differenziazione
- spiegare l’origine del Campo Magnetico Terrestre
- collegare lo studio del paleomagnetismo alla datazione delle rocce
La tettonica delle placche Competenze Indicatori Saper collocare le conoscenze scientifiche in una dimensione storica Saper riconoscere e stabilire relazioni Utilizzare le conoscenze acquisite per interpretare correttamente fenomeni geologici
- analizzare le prove e i punti deboli delle teorie che riguardano la dinamica delle placche
- individuare i meccanismi alla base del movimento delle placche
- individuare le relazioni esistenti tra l’attività sismica e i diversi tipi di margini di placca
- spiegare come varia la
profondità dei terremoti in base alla distanza dalla fossa nelle zone di subduzione
- giustificare la natura del vulcanesimo delle zone di subduzione e delle dorsali oceaniche
L’espansione dei fondali oceanici Competenze Indicatori Saper riconoscere e stabilire relazioni Utilizzare le conoscenze acquisite per interpretare correttamente fenomeni geologici
- riconoscere il valore di prova dell’espansione alle anomalie magnetiche dei fondi oceanici
- motivare come l’età dei sedimenti permette di risalire all’età del fondo oceanico
- fornire una spiegazione del fatto che gli oceani attuali non contengono sedimenti più antichi di 170 milioni di anni
- spiegare il meccanismo delle faglie trasformi
- associare la formazione di catene di isole e di monti sottomarini alla presenza di punti caldi
I margini continentali Competenze Indicatori Saper riconoscere e stabilire relazioni Utilizzare le conoscenze acquisite per interpretare correttamente fenomeni geologici
- associare ciascun tipo di margine continentale ai fenomeni di espansione e compressione della crosta
- illustrare il fenomeno della subduzione
- spiegare la formazione di un sistema arco-fossa
- motivare la distribuzione delle fosse oceaniche
- collegare i margini di placca convergenti all’orogenesi
Contenuti disciplinari Gli idrocarburi Caratteristiche del carbonio. Rappresentazione delle molecole organiche. Alcani e cicloalcani. Alcheni e alchini. Idrocarburi aromatici. I gruppi funzionali Alogenoderivati. Alcoli, fenoli ed eteri. Aldeidi e chetoni. Acidi carbossilici e loro derivati. Esteri e saponi. Composti organici azotati: ammine e ammidi. Le molecole della vita e i polimeri Carboidrati. Lipidi. Aminoacidi, peptidi e proteine. Acidi nucleici. Classificazione dei polimeri: polimeri di addizione e di condensazione. La fotosintesi Struttura della foglia e del cloroplasto. La fase luminosa e il ciclo di Calvin. La respirazione cellulare e la fermentazione Le tre tappe della respirazione cellulare: glicolisi, ciclo di Krebs, fosforilazione ossidativa. Le fermentazioni. La biologia molecolare del gene La duplicazione del DNA. Il codice genetico. Il passaggio dell’informazione genetica dal DNA all’RNA alle proteine. Tettonica delle placche Costruzione di un modello dell’interno terrestre. Litologia dell’interno della Terra. Magnetismo terrestre. Suddivisione della litosfera in placche. Terremoti, attività vulcanica e tettonica delle placche. Morfologia e struttura del fondo oceanico. Modalità e prove dell’espansione oceanica. I tre tipi di margine continentale. Collisioni e orogenesi.
Tempi di realizzazione
Sett. – Ott.
Nov. – Dic.
Dic. – Gen.
Feb. - Marzo
Apr. - Maggio
STRATEGIE DIDATTICHE
1. Lezione frontale e dialogata 2. Attività sperimentali in laboratorio 3. Visione di filmati e animazioni 4. Escursione sul territorio
STRUMENTI DIDATTICI
1. Libri di testo (A. Bosellini “Le Scienze della Terra – Tettonica delle placche” ed. Zanichelli; De Franceschi, Passeri “La realtà e i modelli della Chimica” ed.linx; Sylvia S. Mader “Immagini e concetti della Biologia – Biologia molecolare, genetica, evoluzione” ed. Zanichelli)
2. Fotocopie tratte da testi integrativi e riviste scientifiche 3. Versioni digitali dei testi in adozione. 4. Strumenti informatici 5. Campioni, materiali, attrezzature e reagenti in dotazione al
laboratorio di Scienze STRUMENTI DI VERIFICA
1. Verifiche orali 2. Verifiche scritte (test a scelta multipla, vero/falso, questionari a
risposta aperta, relazioni, risoluzioni di esercizi) CRITERI DI VERIFICA E VALUTAZIONE
1. Acquisizione dei fondamenti della disciplina (conoscenze e
competenze) 2. Interesse e partecipazione 3. Impegno nello studio 4. Approfondimenti personali
ATTIVITA’ DI APPROFONDIMENTO
1. Uda: cambiamenti climatici e migrazioni 2. Itinerario escursionistico nell’area di Andreis-Barcis
Pordenone, 31 ottobre 2015 Firma del docente Francesca Petroccione
ISIS Leopardi Majorana
PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE Classe 5AU
DISCIPLINA: STORIA DELL'ARTE
Docente:Pellegrini Silva
Presentazione della classe e situazione di partenza:
Per le caratteristiche generali della classe e gli obiettivi educativi comuni, si
rimanda alla relazione introduttiva del piano di lavoro di classe.
La classe si dimostra interessata agli argomenti finora proposti nelle
attività svolte in classe -
Programmazione per competenze:
1. essere in grado di costruirsi un quadro sufficientemente esauriente
dell’evoluzione stilistica di un determinato periodo, in relazione ai fatti
storici, individuando nessi e relazioni reciproche;
2. in situazioni nuove distinguere e riconoscere, in base all’omogeneità
espressiva, centri di correnti culturali e artistiche;
3. acquisita la conoscenza di un certo numero di opere e correnti
essere in grado di individuarne implicazioni e conseguenze culturali;
4. mettere in relazione fenomeni e opere considerate con eventi
appartenenti ad altri campi disciplinari individuando reciproche
corrispondenze.
Contenuti :
Primo Quadrimestre
1. Neoclassicismo :
Interpretazione ed idealizzazione dell’antico nelle esperienze artistiche
neoclassiche.
Introduzione storica, linee evolutive e caratteri stilistici.
Analisi delle personalita' emergenti: J. L. David, A.Canova.
a.s. 2015-2016
Studio dell’opera di Canova, David, Ingres;
2. Romanticismo:
Introduzione storica, linee evolutive e caratteri stilistici.
Il paesaggio nel periodo romantico: Constable, W.Turner, G.Friedrich.
L'opera di T.Gericault e E.Delacroix.
Il concetto di "Pittoresco" e quello di "Sublime".
Studio dell’opera del bacio di Hayez e cenno del film di Visconti “Senso”
3.Realismo:
Introduzione storica e caratteri stilistici del Realismo francese.
Conseguenze dell'invenzione della fotografia in campo artistico.
Brevi cenni sulla pittura di paesaggio: la "Scuola di Barbizon".
L'opera di .Courbet, Millet e Doumier.
I Macchiaioli;
4.Impressionismo:
Cenni storici e caratteri stilistici della produzione impressionista.
Analisi delle personalita' emergenti: Manet, Monet, Renoir, Degas;
5.Postimpressionismo:
L'opera di P. Gauguin, P. Cezanne, V. Van Gogh.
Cenni sull’influenza dell’arte giapponese sulla cultura del tempo. Pointillisme:
l'opera di G.Seurat
Secondo Quadrimestre:
Dalla belle epoque alla prima guerra mondiale:
6. I Fauves e gli espressionisti tedeschi.
Analisi delle personalita' emergenti: Klimt, Munch, Kokoscha, Schiele
dalle avanguardie alle ultime ricerche:
ISIS Leopardi Majorana
7. Astrattismo, cubismo, futurismo, dadaismo ,surrealismo, razionalismo in
architettura e l’esperienza del Bauhaus
Analisi delle personalità emergenti: Boccioni, Braque, Picasso; Kandinsky,
Matisse, Wright, Le Courbusier, Duchamp, Man Ray, Max Ernst, Magritte,
Dalì (contenuto complementare analisi del film “un cien andalou”).
8. Esperienze del secondo dopoguerra: Informale e Pop Art.
9. Dalla Pop Art Alle videoinstallazioni contemporanee
Contenuti complementari :
Arte , fotografia e cinema;
dalle avanguardie storiche alle ricerche attuali;
cenni di storia del cinema sperimentale;
segno, gesto e materia nelle esperienze europee e americane;
il rifiuto dell’oggetto;
la crisi dell’opera come espressione;
l’arte come riflessione concettuale;
arte, nuove tecnologie e nuovi media;
l’immagine della città contemporanea;
il rapporto spazio-tempo nelle nuove ricerche;
oltre la terza dimensione;
l’arte e la psicanalisi.
Strategie didattiche:
Lezioni frontali e lezioni dialogate, con esteso ricorso alle immagini;
• conduzione di esercitazioni in classe, anche con modalità di lavoro di
gruppo;
• affidamento a ciascun alunno delle ricerche personali di approfondimento in
biblioteca ed in internet;
a.s. 2015-2016
• discussione guidata sulla presentazione dei lavori di ricerca svolti.
Il libro di testo viene utilizzato con sistematicità, in quanto strumento
necessario da cui partire per costruire una preparazione di base condivisa,
ma il metodo didattico adottato si propone lo sviluppo consapevole delle
competenze attraverso una didattica attiva e partecipata.
Strumenti didattici:
Libro di testo e brani di antologia, schede di lavoro su fotocopie;
presentazioni di Power Point;
aula multimediale, biblioteca d’istituto.
Dvd dedicati ai vari temi.
Strumenti di verifica
Per accertare il livello di padronanza della materia saranno valutati:
prove domande aperte, anche con funzione di simulazione della Terza prova
dell’esame di stato ;
esposizione delle ricerche personali con presentazioni di Power Point ;
presentazione di tesine su supporto cartaceo ;
Verifica orale: interventi degli alunni spontanei o richiesti dall’insegnante;
colloqui-interrogazioni , prove scritte , durante lo svolgimento delle sequenze
didattiche o a conclusione di unità didattiche.
Criteri di verifica e valutazione:
comprensione della domanda e coerenza della risposta, conoscenza
dell’argomento, chiarezza espositiva, possesso del linguaggio specifico;
migliorate competenze rispetto al livello di partenza e capacità rielaborative.
Le verifiche in itinere e la valutazione, espressa con votazione numerica da
2 a 10, registrerà i risultati raggiunti in base a conoscenze, competenze,
capacità.
TABELLA DI CORRISPONDENZA TRA VOTI E LIVELLO DI
APPRENDIMENTO
ISIS Leopardi Majorana
4 Mancata acquisizione degli elementi essenziali, gravi errori - espressione
disorganica
5 Incompletezza e frammentarietà nell'apprendimento – scarsa pertinenza -
lacune espressive
6 Apprendimento degli elementi essenziali – espressione sufficientemente
corretta e lineare
7 Sicurezza nelle conoscenze e nell'espressione - qualche incertezza non
determinante
8 Conoscenze approfondite ed articolate - sicurezza espositiva
9 Conoscenze approfondite e rielaborate - ricchezza espressiva - sicurezza
espositiva
10 Conoscenze approfondite e rielaborate - ricchezza espressiva - sicurezza
espositiva - assenza di errori di ogni genere
Attività di recupero
Le attività di recupero verranno condizionate dalla situazione della singola
classe: se è la maggioranza degli studenti ha dimostrato problemi
nell’apprendimento della disciplina ciò comporterà necessariamente un
rallentamento nello svolgimento del programma didattico e il recupero si
svolgerà in orario curricolare ed in itinere.
Attività di approfondimento:
Uda, ricerca degli autori e/o periodi attinenti al tema da svolgere in itinere in
modo trasversale concordata dal consiglio di classe.
PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE: 5AuDISCIPLINA: SCIENZE MOTORIE
Docente: Maria Grazia Pastori
Presentazione della classe e situazione di partenza:
La classe, da una prima analisi e osservazione in questo inizio di anno scolastico, mostra un alto livello di motivazione e un comportamento corretto durante le lezioni. I livelli di partenza sono globalmente più che sufficienti e diversificati per interessi, capacità e predisposizione.
Programmazione per competenze:
– utilizzare in modo consapevole le capacità condizionali e coordinative– saper valutare le proprie capacità e prestazioni– saper svolgere attività di diversa durata e intensità– saper utilizzare un linguaggio motorio espressivo– consolidare le tecniche di base dei giochi sportivi e delle attività pratiche
affrontate– assumere corretti stili di vita per la tutela della salute– sviluppare una relazione adeguata con l’ambiente naturale
ABILITA'
– cogliere le informazioni spaziali, temporali e corporee per il controllo del movimento
– realizzare in modo efficace l'azione motoria richiesta– riconoscere ed applicare i principi generali e le regole base di alcune
discipline– relazionarsi positivamente mettendo in atto comportamenti corretti e
collaborativi– adottare nella vita quotidiana comportamenti responsabili per la tutela
della propria salute, delle persone e dell'ambiente
CONOSCENZE
L' alunno a conclusione del percorso educativo dovrà conoscere:
gli aspetti teorici legati all’attività pratica svolta • le modificazioni strutturali del corpo in rapporto allo sviluppo • le potenzialità del movimento del corpo, le funzioni fisiologiche in relazione al movimento e le posture corrette • il ritmo delle azioni proprie ed altrui • il linguaggio specifico della materia comprendente anche pratiche del linguaggio espressivo-gestuale • i principi elementari di prevenzione e di
attuazione della sicurezza personale in palestra e negli spazi aperti • attività motorie in ambiente naturale
Strategie didattiche:
Le proposte didattiche seguiranno una programmazione inclusiva e flessibile. Il lavoro pratico prevede esercitazioni individuali, a coppie, a piccoli gruppi, a squadre. Si fornirà un numero ampio e diversificato di proposte per valorizzare propensioni, capacità e interessi degli studenti. Le attività seguiranno una progressiva distribuzione dei carichi e delle difficoltà di esecuzione nel rispetto dei diversi ritmi di apprendimento. Il lavoro sarà guidato e sollecitato dall'insegnante anche se il raggiungimento di alcune competenze implica la capacità di sapersi organizzare sia in modo autonomo sia in gruppo.
Strumenti didattici:saranno utilizzati tutti gli strumenti, materiali ed attrezzature sportive a disposizione (attrezzi codificati e non) in modo da rendere pertinente e varia la proposta didattica.Per gli alunni esonerati o quando si riterrà opportuno si farà uso di materiali informativi.
Strumenti di verifica:
Al termine delle UD viene proposta un'esercitazione pratica di verifica volta a stabilire il percorso effettuato da ogni alunno. Potranno esssere utilizzate anche prove scritte e\o orali.ICriteri di verifica e valutazione
La valutazione avviene attraverso l'osservazione costante e comprende il miglioramento delle capacità e del livello tecnico raggiunto rispetto al livello di partenza, le competenze essenziali apprese; la conoscenza teorica di alcuni contenuti; la partecipazione alle lezioni, la continuità dell'impegno, l'interesse e la volontà di ricercare i propri miglioramenti. Infine la partecipazione e il coinvolgimento da parte degli studenti ad attività sportive e motorio- espressive anche non strettamente curricolari costituiranno elementi utili per la valutazione. Attività di approfondimento
Partecipazione alle attività del C.S.S. comprendente le attività sportive individuali, i tornei interni alla scuola a eventuali altri progetti ed iniziative in ambito motorio.Possibile intervento di esperti per la trattazione di argomenti specialisticiIniziative legate all'educazione alla salute
Argomenti inerenti la tematica dell'UDA.
I.I.S. LEOPARDI MAJORANA
PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 5AU
DISCIPLINA: RELIGIONE
Docente: Claudia Beacco
Presentazione della classe e situazione di partenza:
Della classe 5Au 17 studenti si avvalgono dell'Insegnamento della Religione Cattolica. Il comportamento di tutti gli studenti è corretto e l'atteggiamento dimostrato nei confronti della disciplina è positivo. La classe partecipa attivamente alla lezione con interventi che dimostrano interesse e ciò consente lo svolgimento di un'attività didattica serena e stimolante. La preparazione specifica è nel complesso buona. Programmazione per competenze: COMPETENZE TRASVERSALI (cfr. L. 169/2008 e D.M. 27 gennaio 2010 n. 9)
C3 Comunicare C4 Collaborare e partecipare C5 Agire in modo autonomo e responsabile C7 Individuare collegamenti e relazioni C8 Acquisire ed interpretare l’informazione M3 Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi S1 Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni relativi alla realtà naturale e artificiale
COMPETENZE IN USCITA ( cfr. Intesa firmata 28 giugno 2012)
Al termine dell'intero percorso di studio lo/a studente/ssa sarà in grado di:
1. sviluppare un maturo senso critico e un personale progetto di vita; 2. riflettere sulla propria identità attraverso confronto con il messaggio
cristiano; 3. aprirsi all'esercizio della giustizia e della solidarietà in un contesto
multiculturali; 4. cogliere la presenza e l'incidenza del cristianesimo nella storia e nella
cultura per una lettura critica del mondo contemporaneo;
5. utilizzare consapevolmente le fonti autentiche della fede cristiana; 6. interpretarne correttamente i contenuti, secondo la tradizione della
Chiesa; 7. restare aperto nel confronto ai contributi di altre discipline e tradizioni
storico-culturali;
CONOSCENZE
ABILITÁ
riconosce il ruolo della religione nella società e ne comprende la natura in prospettiva di un dialogo costruttivo fondato sul principio della libertà religiosa;
motiva le proprie scelte di vita, confrontandole con la visione cristiana, e dialoga in modo aperto, libero e costruttivo;
conosce l'identità della religione cattolica in riferimento ai suoi documenti fondanti, all'evento centrale della nascita, morte e risurrezione di Gesù Cristo e alla prassi di vita che essa propone;
si confronta con gli aspetti più significativi delle grandi verità della fede cristiano-cattolica, tenendo conto del rinnovamento promosso dal Concilio ecumenico Vaticano II, e ne verifica gli effetti nei vari ambiti della società e della cultura;
studia il rapporto della Chiesa con il mondo contemporaneo, con riferimento ai totalitarismi del Novecento e al loro crollo, ai nuovi scenari religiosi, alla globalizzazione e migrazione dei popoli, alle nuove forme di comunicazione;
individua, sul piano etico-religioso, le potenzialità e i rischi legati allo sviluppo economico, sociale e ambientale, alla globalizzazione e alla multiculturalità, alle nuove tecnologie e modalità di accesso;
conosce le principali novità del Concilio ecumenico Vaticano II, la concezione cristiano-cattolica del matrimonio e della famiglia, le linee di fondo della dottrina sociale della Chiesa.
distingue la concezione cristiano-cattolica del matrimonio e della famiglia: istituzione, sacramento, indissolubilità, fedeltà, fecondità, relazioni familiari ed educative, soggettività sociale.
NUCLEI TEMATICI
Le competenze sopra enunciate verranno perseguite attraverso lo sviluppo delle seguenti Unità di Apprendimento:
1. SCELTE CONSAPEVOLI E PROGETTI DI VITA
2. LE RELIGIONI DEL LIBRO E LE RELIGIONI ORIENTALI 3. LE RELIGIONI PONTI DI PACE 4. IL RAPPORTO TRA FEDE E PSICANALISI 5. LA DOTTRINA SOCIALE DELLA CHIESA E IL CONCILIO
VATICANO II 6. SOCIETÀ CONTEMPORANEA E BISOGNI VEICOLATI DAI MEDIA 7. ELEMENTI DI ESCATOLOGIA CRISTIANA
STRATEGIE DIDATTICHE Potranno essere utilizzati lezioni frontali, discussioni in classe, lavori di gruppo, utilizzo degli strumenti audiovisivi e di mezzi informatici, fotocopie, visite guidate, incontri con esperti. Saranno privilegiate anche tutte le occasioni di approfondimento realizzabili attraverso offerte del territorio. La scelta delle diverse strategie d’intervento sarà volta a favorire la partecipazione attiva ed il coinvolgimento diretto di ogni alunno, considerando che spesso l’esiguo numero di ore annuali (circa 32) e la complessità della materia costituiscono una difficoltà oggettiva ad un esauriente svolgimento della programmazione.
STRUMENTI DIDATTICI Libro di testo: S. Bocchini (2011), Nuovo Religione e Religioni, EDB, Bologna. Altri strumenti: Bibbia, quaderno, uso Web 2.0, film, giornale, fotocopie, testi poetici e musicali, arte. STRUMENTI DI VERIFICA La verifica dell’apprendimento degli alunni verrà effettuata con modalità differenziate, tenendo conto dell’eventuale evoluzione della classe e del grado di difficoltà delle tematiche proposte. Potranno essere strumenti di verifica esposizioni orali, questionari, testi scritti, prodotti multimediali. CRITERI DI VERIFICA E VALUTAZIONE La valutazione del profitto sarà espressa con la seguente scala: non sufficiente (NS) sufficiente (S) buono (B) distinto (D) ottimo (O) eccellente (E). Si basa sulla partecipazione attiva e collaborativa in classe, sulla disponibilità alla ricerca e all’approfondimento domestico, sui contributi originali presentati criticamente.