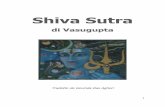Home Opinioni Economia Cultura Spettacoli Cinema … sutra in sanscrito di quasi duemila anni fa si...
Transcript of Home Opinioni Economia Cultura Spettacoli Cinema … sutra in sanscrito di quasi duemila anni fa si...

0 Tweet
Corriere della Sera » Il Club de La Lettura » Articolo » C’era una volta lo yoga. E poi gli yogaRitorno ai 195 «sutra» da dove tutto è cominciato. Trovata qualche risposta, si aprono questioni ulterioriC’era una volta lo yoga. E poi gli yogaIn una nuova versione commentata, ecco il testo redatto quasi duemila anni fa da Patañjali. Filosofia? Religione? Ginnastica? Certo non una «lista organizzata di temi», come appare, ma una disciplina complessa. Che Obamavuole sostenere e che il premier indiano rilancia in chiave nazionalista
«Liberatoria, onnicomprensiva, minuziosa e istantanea»: con queste parole il sutra 54 del terzo quarto degli Yogasutra descrive la comprensione del mondo cui mira lo yoga. L’alternativa è lo stato di ignoranza e confusionedescritto dal sutra 5 del secondo quarto, quel «non vedere come stanno le cose» che «fa ritenere il perituro imperituro, l’impuro puro, il disagevole agevole, il nonsé sé». Lo yoga è il metodo per giungere alla visionetrasparente della realtà. Metodo estremamente impegnativo: disciplina, sistema, viaggio ai limiti della conoscenza e della padronanza di sé; ascesi, meditazione.Nei sutra in sanscrito di quasi duemila anni fa si stenta a riconoscere l’odierno yoga di massa: ginnastica di tendenza, rilassamento, fitness, diete naturali e potenza sessuale. Negli ultimi decenni lo yoga ha conquistatomilioni di praticanti, molti in Occidente. Proliferano scuole e maestri, riviste, siti e centri specializzati. Cresce il business di centinaia di multinazionali. Lo yoga è persino diventato un affare di Stato. Per incoraggiarne ladiffusione negli Stati Uniti, il presidente Obama ha messo sul piatto soldi pubblici. Hanno gridato allo scandalo i difensori del dogma americano per cui il governo non finanzia le fedi. Lo yoga non è una religione, ha allorareplicato l’incauto Obama, scatenando stavolta l’ira dei tanti sostenitori d’uno yoga spirituale, non mercificato.Il primo ministro indiano Narendra Modi, intanto, ha risucchiato lo yoga nel progetto nazionalista indù. Nel novembre scorso il suo governo ha istituito un ministero autonomo dedicato alla promozione della medicinaayurvedica, dell’omeopatia e, appunto, dello yoga. Un mese dopo, il segretario generale delle Nazioni Unite, il coreano Ban Kimoon, ha accolto la proposta dello stesso Modi e ha istituito la giornata mondiale dello yoga. Ilprossimo 21 giugno si festeggerà in 170 Paesi, Italia inclusa, il primo International Day of Yoga.Con l’espandersi del fenomeno, crescono domande cui è impossibile rispondere in modo netto. Che cos’è davvero lo yoga? È una religione? È parte dell’induismo? Può un cristiano praticarlo? E un musulmano?All’aumentare dell’incertezza risponde la caccia al vero yoga, quello puro, classico, incontaminato. La caccia comincia proprio con gli Yogasutra, il più celebre testo in materia, ammesso dalla Princeton University Press nelpantheon dei grandi libri delle religioni insieme alla Genesi e alla Bhagavadgita. Questa raccolta di sutra, ovvero di brevi passi contenenti enunciati, è stata presumibilmente composta nell’area centrosettentrionale dellapiana del Gange tra il secondo e il quarto secolo dopo Cristo. Ne sarebbe stato autore Patañjali, un filosofo indiano di cui si sa molto poco. Dal 12 maggio lo Yogasutra sarà ancor più accessibile in italiano grazie allatraduzione di Federico Squarcini, che per Einaudi ha stabilito per l’occasione una nuova edizione critica dell’originale. Il volume correda i testi sanscrito e italiano con l’introduzione del curatore, cento pagine di note sutra persutra, un apparato intertestuale e l’indice analitico. Hanno collaborato Gianni Pellegrini per la traduzione e Marco Guagni per l’apparato.Con i suoi Yogasutra, lo storico delle religioni dell’università di Venezia, direttore del primo Master italiano in Yoga studies, si è proposto di rispondere ai tanti travisamenti di un testo difficile, spesso banalizzato. Squarcini nonva a caccia del vero yoga; si rifiuta di cercare negli Yogasutra «uno yoga sempiterno, incorruttibile e perennemente uguale a se stesso». Lo storico si sottrae parimenti al pregiudizio che vede negli Yogasutra un testo«incoerente, asistematico e bizzarro». Al contrario, il lavoro storicofilologico dello studioso e la sua analisi ci offrono un’opera che «presenta un alto livello di coerenza logica e di unitarietà».La chiave del lavoro di Squarcini è nel punto di vista. Fin qui la ricerca sugli Yogasutra si è concentrata per lo più sulla ricezione del componimento, sulle interpretazioni e gli usi successivi. Federico Squarcini ha adottato laprospettiva opposta. Si è disinteressato, quasi provocatoriamente, della ricezione posteriore e ha invece messo ogni energia nella ricostruzione del contesto in cui s’è formata l’opera. L’introduzione al volume ci mostradunque gli Yogasutra immersi nel loro tempo, prodotto di un «poliedrico habitat intellettuale, popolato da predecessori, avversari, antesignani e rivali». In un ambiente caratterizzato dalla «levatura del dibattito e dallasofisticazione speculativa», l’autore degli Yogasutra si misurò con le tradizioni brahmaniche, ma anche con quelle jaina, tantriche e vedantiche, e soprattutto con il nascente buddhismo mahayana.Davanti al dilemma su come si possa entrare in contatto con la vera realtà delle cose, gli autori buddhisti dei primi secoli dopo Cristo non si chiesero più «che cosa sia» il mondo dei fenomeni, ma si soffermarono piuttosto su«come sia» possibile conoscerlo. Nacquero da questa svolta, nello scambio tra sapienti e testi, gli Yogasutra. Essi contengono 195 sutra ripartiti in equa misura in quattro quarti, disposti, scrive il traduttore, «secondo unprocedere sistematico e una serrata logica sequenziale ». È un testo quasi senza verbi, «programmaticamente conciso, ermetico e finanche ostile». Davanti al quale è decisiva la competenza e l’agilità del lettore.A una lettura superficiale, i sutra di Patañjali possono apparire come «una breve lista organizzata di temi», ma essi sono «i puntuali snodi di un sistema metatestuale», che «spalancano la visione di una sterminata distesa» dirinvii, allusioni, sottotesti. Perciò il fulcro di quest’edizione critica sono le dieci pagine di apparato, in cui si raccolgono i rimandi, le concordanze e i paralleli ai testi di varie tradizioni buddhiste con cui dialoga, mentre redige ilsuo testo, l’autore degli Yogasutra. Nel fitto reticolo di opere e autori, precedenti e contemporanei, «immersi in forme di pratica intellettuale a noi non del tutto note», emerge l’originalità degli Yogasutra. Essi analizzano «conimpressionante acume», scrive Squarcini, ciò che ci separa dal rischiaramento della natura delle cose, ovvero «l’iperattività della mente, le ragioni dei turbamenti che vengono dalle rappresentazioni di sé, l’avvicendarsiincessante dei flussi dei pensieri».È qui la grandezza degli Yogasutra. Tutti rivolti alla cognizione, essi pervengono a «una nuova sintesi tra il piano cognitivo e metarappresentativo e quello praticoesperienziale». Se yoga, come traduce Squarcini, significa«metodo per», quello degli Yogasutra è metodo unito a un modello di conoscenza: unione di teoria e prassi. Ogni fase degli Yogasutra, anche il controllo della respirazione e le posizioni del corpo, è parte di una sequenzaprecisa, d’una progressione sistematica di pratiche da cui è atteso un effetto domino. Allora la coltre che separa dal «vedere come stanno le cose» si assottiglia. Vengono messi in stallo, arrestati, i pensieri che inibiscono ilcontatto immediato con l’esperienza sensibile. Un gorgo di esperienze coagula la visione trasparente; per Squarcini, è come «l’aggregarsi compatto di un batuffolo di peluria raccolto dall’incedere di un mulinello di vento».Questa è la sfida estrema dello yoga, «metodo per». C’è molto in palio. Molto più del benessere degli americani e del nazionalismo di Narendra Modi. In questione c’è la capacità dell’uomo di vedere davvero il mondo,secondo il modello fissato dal sutra 41 del primo quarto: «Così è la gemma completamente trasparente, capace di prender la tinta di qualsiasi oggetto le sia posto dinnanzi».Marco Ventura© RIPRODUZIONE RISERVATATag:disciplina, Patanjali, yogaLeggi tutti gli 'Articoli'Articolo precedenteArticolo successivo
Condividi 20
Nessun CommentoNon c'è ancora nessun commento.Devi fare la LOGIN per scrivere un commento.Per accedere all'AREA PERSONALE è necessario effettuare prima la LOGINPlayer Cultura
ADVBanner Bookcity
Consiglia 101 Condividi
La Foto Corriere Tv
Rosso fuoco
< EVENTI
Cerca
Home Opinioni Economia Cultura Spettacoli Cinema Sport Salute Tecnologia Scienze Motori Viaggi 27ora
ACCEDI

CERCA libri autore o libro
Banner cortiTweets di @La_Lettura EventiGli Egizi, i Medici, Massud. Lapislazzuli, il potere azzurro
Fino all'11 ottobreMuseo degli Argenti, Palazzo Pitti / La SpecolaFirenzeGiro d’Italia con 429 artistiCosì Milano diventò una capitale europeaCerca Rizzoli
Copyright 2012 © RCS Mediagroup S.p.a. Tutti i diritti sono riservati | Per la pubblicità RCS MediaGroup S.p.A. - Divisione Pubblicità
RCS MediaGroup S.p.A. - Divisione Quotidiani Sede legale: via Angelo Rizzoli, 8 - 20132 Milano | Capitale sociale: Euro 762.019.050 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n.12086540155 | R.E.A. di Milano: 1524326
Hamburg Declaration
Gazzetta | Corriere Mobile | El Mundo | Marca | Dada | RCS Mediagroup | Fondazione Corriere | Fondazione Cutuli Servizi | Scrivi | Nuovo Titolare della Privacy | Cookie policy e privacy
Foto Il club de La Lettura Eventi Libri Elzeviri Scuola Quiz Dizionari Archivio storico Video Cultura e società 50mila giorni You Crime 150 anni d'Italia
CULTURA