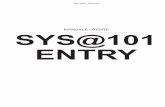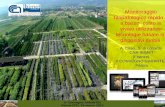Home - Associazione Amici di Pescia · 2020. 2. 13. · mente idonea. Su indicazione...
Transcript of Home - Associazione Amici di Pescia · 2020. 2. 13. · mente idonea. Su indicazione...

RIVISTA DI CULTURA IN VALDINIEVOLE n. 65 - Gennaio 2020
“Abbraccio in fede”(Foto di Lorenzo Scacchia)
Rivista di cultura in Valdinievole
dell’Associazione “Amici di Pescia”Responsabile, Enrico Nistri
Direttore editoriale, Carla PapiniRedattore, Marco Ricci
anno XXV, n. 65Gennaio 2020
La rivista viene inviata gratuitamente ai sociQuota annuale
Socio ordinario Euro 25,00Socio sostenitore Euro 60,00 con donoVersamento sul c.c.p. n. 11155512
intestato all’Associazione “Amici di Pescia”Direzione, redazione e amministrazione
Via Santa Maria, 1 - 51017 PesciaCasella Postale n. 75
E-mail: [email protected]: [email protected]
Autorizzazione del Tribunaledi Pistoia n. 472/1995
Stampa “Tipolito Vannini” - Buggiano (PT)
SOMMARIOPag.
»
»»
»
»
»
»
»
»
»
500 anni della nostra Diocesieditoriale Progetto chiesto da mons. Giovanni DeVivo per una ricerca sulla origine e suiprimi tempi della diocesi di Pesciadi Amleto SpiccianiLettera ai relatori di Amleto SpiccianiLa religiosità della Valdinievole nei primianni del Cinquecentodi Amleto SpiccianiLe fonti per la storia ecclesiasticapesciatina. Relazioni, visite, storie di Manuel RossiUn caso di santità simulata? Dorotea diLanciole tra genuino slancio penitenzialee strumentalizzazioni politichedi Giulio BizzarriFra Giovanni da Pescia e la difesa delladottrina savonarolianadi Alberto CocoIl monastero pesciatino di San Michele ela predicazione savonaroliana all’iniziodell’epoca modernadi Amleto SpiccianiLe origini della “Misericordia” di Pesciadi Fabrizio MariIl ramo pesciatino dei Benivieni fiorentini, amici del Savonaroladi Michele PappalardoIl Crocifisso delle Benedettine di santaMaria Nuova a Pesciadi Paolo Vitali
2
3
56
9
11
13
15
18
20
22
500 ANNI DELLA DIOCESI DI PESCIA

500 ANNI DELLA NOSTRA DIOCESIEDITORIALE
In occasione delle celebrazionidel quinto centenario della fon-dazione della diocesi di Pescia,questo numero di Nebulae è de-dicato alla pubblicazione di al-cuni contributi presentati, inmodo più ampio, al convegno“Religiosità popolare in Valdinie-vole all’inizio del Cinquecento”tenuto a Pieve a Nievole neigiorni 5 e 6 ottobre 2019, con ladirezione di Amleto Spicciani.Convegno che si è svolto nell’am-bito delle annuali Tavole Ro-tonde del Centro studi storici “S. Pietro a Neure”, divenuto re-centemente sezione locale del-l’Istituto Storico Lucchese.Come abbiamo indicato nel Som-mario stampato in copertina, aisaggi riassuntivi di alcune rela-zioni portate al convegno pieva-rino sono stati premessi tre scrittidi Amleto Spicciani: le parole in-troduttive da lui pronunciate inapertura di quel convegno; la let-tera precedentemente inviata airelatori; un progetto iniziale di ri-cerca storica.Il testo di questo progetto fu re-datto da Spicciani nel 2009 suesplicita richiesta del compiantovescovo di Pescia mons. Gio-vanni De Vivo, in vista del confe-rimento di relativo incarico diricerca a persona scientifica-mente idonea.Su indicazione dell’Università diPisa, mons. De Vivo nel 2011 af-fidò al dott. Manuel Rossi il com-pito di condurre una ricercastorica sulle origini della diocesidi Pescia, i cui sorprendenti risul-
tati, più volte pubblicamente resinoti, hanno aperto la strada esono stati la guida di ricerche pa-rallele, che si sono affiancate allelinee principali delineate dalRossi.Alcune di queste ricerche sonoconfluite nel convegno pievarino
di cui – in attesa della pubblica-zione sugli Atti di tutti i contri-buti redatti nella loro completez-za – Nebulae offre in questo nu-mero una significativa panora-mica.
La redazione
Nebulæ / 65 2

3 Nebulæ / 65
PROGETTO CHIESTO DA MONS. GIOVANNI DE VIVO PER UNA RICERCA SULLA ORIGINE
E SUI PRIMI TEMPI DELLA DIOCESI DI PESCIAdi Amleto Spicciani
Gennaio 2009
Con bolla data a Roma il 15aprile 1519, papa Leone X eressela diocesi di Pescia, come prela-tura esente dal proprio vescovo diLucca, elevando la pieve diSanta Maria di Pescia a pre-positura collegiata. E ne at-tribuì la richiesta alpesciatino Baldassarre Tu-rini, chierico lucchese e suodatario, e al pievano in ca-rica di Santa Maria, Lo-renzo Cecchi. Ottavio Bantiha recentemente pubblicatouna nuova edizione anchedi tale bolla di erezione, nelvolume O. BANTI, Pescia:la città e il Vescovato nellabolla del papa BenedettoXIII del 17 marzo 1727,Pisa 2002; volume con ilquale si è aperta una collanaeditoriale, voluta dall’at-tuale vescovo di Pescia, inti-tolata «Fonti e studi per lastoria della diocesi di Pe-scia», diretta da AmletoSpicciani, presso l’Editorepisano ETS.Questa nuova edizione dellabolla leonina ha posto in evi-denza la gravità del vuotostoriografico pesciatino, tanto ariguardo delle vicende di storiasociale e politica locale quanto, ein modo ancor più marcato, perquelle ecclesiastiche diocesane. Sipuò asserire – al di là dei pochistudi locali non critici – che non
sappiamo quasi nulla non solodelle vicende o situazioni che de-terminarono la costituzione interra diocesana lucchese dellanuova diocesi di Pescia, maanche ignoriamo gli eventi suc-
cessivi a tale fatto, prima e poidopo il 1727, quando la diocesidivenne vescovile. Si tratta di unvuoto storiografico che contrastacon la ricchezza della documen-tazione superstite conservataanche negli archivi pesciatini del
Capitolo e della Curia. Tanto piùche nel prossimo 2019 si po-trebbe pensare a una scadenzascientificamente utile per cono-scere la storia di questa terra pe-sciatina che per secoli fermò
l’avanzata fiorentina versoLucca, determinando unconfine prima soltanto po-litico (dal 1339 al 1519) epoi anche diocesano. Ditale situazione tuttora si vi-vono le conseguenze, chearricchiscono la vita tantospirituale quanto sociale diquesta terra, oggi artificial-mente collocata nella pro-vincia di Pistoia, benchécon cultura e tradizioni as-solutamente non pistoiesi,ma piuttosto nostalgica-mente tese ancora versoLucca.Si impone dunque scientifi-camente un graduale la-voro di ricerca in piùambiti, tra loro coordinatie comparati. Intanto è ne-cessario un serio scavo do-cumentario sia negli archi-vi romani della Sede Apo-stolica, specialmente negliatti pubblicati e nella super-stite documentazione pri-
vata di papa Leone, sia negliarchivi lucchesi. Dal 1519 in poisono disponibili gli archivi civilied ecclesiastici pesciatini, ormaiaccuratamente e scientificamenteordinati e ben fruibili. È infattimolto necessario – al di là dei
Pescia. Cattedrale di Santa Maria.(Foto di Lorenzo Scacchia)

Nebulæ / 65 4
pochi lavori dei cultori di storialocale –, affrontare le figure degliultimi pievani lucchesi della finedel secolo XV e quelle dei primiproposti pesciatini, a partiredallo sconosciuto Lorenzo Cec-chi, nel 1519 ultimo pievano epoi primo canonico proposto.Come pure andrà studiata la fi-gura del pesciatino BaldassarreTurini, primo arcidiacono delnuovo consesso canonicale dellaprepositura pesciatina, e delquale la grande storia parla comemunifico mecenate romano.Anche l’organizzazione internadella prepositura va chiaramentecompresa, secondo il modello de-lineato da papa Leone X, che af-fidava al collegio canonicale diSanta Maria di Pescia i poteri digoverno, in un difficile e spessocontrastato equilibrio tra l’interoCapitolo canonicale e la figuradel canonico proposto che taleCapitolo presiedeva.Il modello istituzionale leoninoandrà poi opportunamente collo-cato nell’alveo della storia socio-politica locale, almeno nel sensoche, attraverso la fondazione deibenefici canonicali operata dal-l’aristocrazia locale, si determinòuna interessante e fruttuosa fu-sione tra società laica e Chiesa,di cui è rimasta come stupendatestimonianza almeno la com-mittenza artistica e architetto-nica anche oggi vanto delladiocesi pesciatina. Non a casopapa Leone stabilì che il bene-fico canonicale del propostofosse, alternativamente, di patro-cinio della famiglia Turini e diquella dei Cecchi. I Cecchi, an-cora presenti a Pescia nei loroantichi palazzi, hanno un loro
prezioso archivio famigliare chepotrà essere studiato.Occorrono poi edizioni seria-mente condotte di documentistoricamente fondamentali. Nelmedesimo anno 1519 il neo pro-posto Lorenzo Cecchi indisse unsinodo diocesano, con il qualeannunziava al clero lucchese, in-cluso nella nuova diocesi, l’esen-zione diocesana e insiemeemanava una serie di disposi-zioni disciplinari che manife-stano le idee e i tentativi diriforma anteriori a Trento. Nelmedesimo anno, i canonici pe-sciatini fecero approvare dallaSede Apostolica, tramite gli ap-positi delegati, le costituzioni ca-pitolari che ci introducono nellacomprensione della vita spiri-tuale e liturgica della preposi-tura. Sia le disposizioni sinodalisia le costituzioni capitolari sonotuttora inedite. Ugualmente ine-dito è il grosso volume dei ver-bali della visita apostolica cheGiovan Battista Castelli effettuònel 1575, descrivendo accurata-mente le chiese, gli oratori, gliospedali e i monasteri della dio-cesi pesciatina. Ignoriamo deltutto i rapporti della prepositurapesciatina e il Concilio di Trento,anche se sono rimasti in edizionea stampa i testi dei sinodi cele-brati dai proposti di Pescia du-rante il secolo XVII. Proprio aquesto proposito, si pone il pro-blema – di cui abbiamo qualchesentore – della figura del cano-nico proposto, posto a capo delladiocesi secondo il modello cano-nicale loenino e come poiemerga, non senza forti e dura-turi contrasti, nel pieno ruolo diordinario diocesano dopo e in
conseguenza del Concilio diTrento. Esiste infatti una abbon-dante documentazione proces-suale che pone in evidenza ilcontrasto del Capitolo con il pro-prio presidente, che era appuntoil canonico proposto. Interes-sante in tale contesto giudiziarioparrebbe anche la figura del ca-nonico arcidiacono, prima di-gnità capitolare dopo quella delproposto, a iniziare dal canonicoBaldassarre Turini, che tra l’altrotrasmise ai successori il ricchis-simo e pingue beneficio di Lu-peta, a Vico Pisano, ottenuto daClemente VII. Altra fonte im-portante è indubbiamente costi-tuita dal fondo pergamenaceodel Capitolo, e specialmentedalle bolle non conosciute diAdriano VI e di Clemente VII,al quale fondo andrà unita l’ab-bondante corrispondenza inter-corsa tra il proposto, il Capitoloe la Sede Apostolica.Riepilogando. Il progetto di ri-cerca dovrà muoversi verso duefondamentali obiettivi, partendoda un razionale e accurato scavoarchivistico. È necessario arri-vare all’edizione dei testi essen-ziali per la storia della diocesinella sua origine e nei suoi primiaggiustamenti formali e istitu-zionali. Contemporaneamente laricerca non potrà non sfociarenella redazione di un saggio sto-riografico che ponga le basi dipartenza di uno studio storicodella diocesi di Pescia. Tale stu-dio non potrà non inserirsi nellagrande storia, qui riflessa neirapporti e nei contrasti tra loStato moderno toscano e la resi-stenza opposta al suo espandersidalla repubblica di Lucca.

Per il convegno di Pieve a Nievole
LETTERA AI RELATORI
Febbraio 2019
Cari amici,prima di tutto un sincero ringra-ziamento per avere con grandegenerosità accettato di collabo-rare con me ad una ricerca sui di-versi aspetti della religiositàpopolare nella Valdinievole, al-l’inizio dell’epoca moderna. No-stra unica ricompensa saràl’incontro e la conoscenza di unarealtà vivacissima, come già find’ora intravediamo per quel pocoche lascia trasparire l’opacitàdella documentazione superstite.Purtroppo non abbiamo alle no-stre spalle una città, ma unterritorio culturalmente sbia-dito ed eterogeneo, come èappunto la nostra valle, né iosono stato capace di superarei condizionamenti del tempoche viviamo per offrirvi la ga-ranzia di un interesse più par-tecipato. Tuttavia abbiamotrovato ospitalità presso l’as-sociazione “Amici di Pescia”che ci offrono la loro rivista«Nebulae» per un numerounico messo a nostra com-pleta disposizione, dove po-tremo anticipare, almenosinteticamente, i risultati dellenostre ricerche che discute-remo il 5 e il 6 ottobre pros-simo in una Tavola Rotondadel Centro Studi di Pieve aNievole, ospiti di quella par-rocchia.Non ci deve né scoraggiare némortificare il fatto che il no-stro programma di ricerca,nell’attuale contesto tanto po-
litico quanto ecclesiastico, nonabbia trovato nessun sostegno eche nessuna istituzione a cui hobussato abbia risposto alla mia ri-chiesta di aiuto. E invece pur-troppo anche la più modestadelle ricerche storiche ha bisognodi sostegno finanziario, che noinon abbiamo. Ciò limiterà certa-mente i risultati, ma non impe-dirà – per la generosità diciascuno di voi – la realizzazionedi una sintesi storica che, sebbeneprovvisoria, dimostri quantoanche pastoralmente sarebbeutile una maggiore conoscenza,anche locale, della crisi religiosa
con cui si aprì l’epoca moderna,in forte analogia con quanto ac-cade ai nostri giorni.Coraggio dunque, convinti comesiamo del valore e della impor-tanza della ricerca scientifica, purmodesta che essa sia. Il metodologico applicato alla conoscenza,cioè la conoscenza razionale, èsempre un passo avanti nel no-stro lungo processo di incivili-mento. Ci basti la soddisfazionedi esserne in qualche modo par-tecipi.Vi saluto cordialmente.
Amleto Spicciani
5 Nebulæ / 65
Fiesole. Chiesa di S. Domenico. Fra Girolamo Sa-vonarola e compagni, dipinto di fra Paolino da Pi-stoia.
Fra Domenico Buonvi-cini da Pescia (partico-lare).

LA RELIGIOSITÀ DELLA VALDINIEVOLE NEI PRIMI ANNI DEL CINQUECENTO
PAROLE INTRODUTTIVE AI LAVORI DEL CONVEGNO DI PIEVE A NIEVOLE
di Amleto Spicciani
Pieve a Nievole, sabato 5 ottobre 2019
Rivolgo subito un sincero e cor-diale saluto a tutti i partecipantia questa nostra Tavola Rotonda,sia al pubblico degli intervenutisia ai relatori delle diversecomunicazioni messe inprogramma.Il tema che abbiamoscelto, in riferimento allaricorrenza dei 500 annidella diocesi di Pescia, è unargomento tanto affasci-nante quanto difficile daessere adeguatamente trat-tato. Indagheremo, all’ini-zio dell’epoca moderna, letracce rimaste della religio-sità cristiana nella Valdi-nievole, cioè nel territoriofiorentino della parteorientale dell’antica diocesidi Lucca.Ci domandiamo infattiquali furono le condizionireligiose, nel quadro poli-tico di allora, alle quali fuimposta o corrispose la fon-dazione della diocesi, intesacome atto di separazione eccle-siastica della Valdinievole fioren-tina dal vecchio alveo lucchese.Lo stato religioso, cioè le mani-festazioni del fatto cristiano nel-l’inquadramento delle istituzioniecclesiastiche, è certamente di
per sé una realtà indipendente oalmeno non condizionante inepoca moderna per la fonda-zione di una diocesi da parte diuna autorità esterna. Tema diffi-cile, dicevo, poiché sappiamoche per la conoscenza del fatto
religioso le fonti documentariedi cui possiamo disporre, perloro stessa natura, non offronosufficienti testimonianze. Moltoa proposito Marino Berengo hascritto che «le forme di devo-zione dei lucchesi si sono, comela massima parte dei loro senti-
menti domestici e civili, perdutinel silenzio». Tuttavia, lui stessoper la Lucchesia ha raccoltomolti dati significativi, comepure dopo di lui il Gandolfi e laAdorni Braccesi. Teniamo ancheconto dei quadri generali di rife-
rimento per la storia reli-giosa del secolo XVI,delineati – ad esempio –dallo Chabod e dal Pro-speri.Questa Tavola Rotonda,che restringe lo sguardocritico alla locale situa-zione religiosa della Valdi-nievole, porterà un contri-buto limitato e immaginoanche, per qualche aspet-to, indiretto; ma comun-que sarà un passo avantinel faticoso cammino dellaconoscenza storica e sicu-ramente un invito e unostimolo per più larghe eapprofondite ricerche.Agli occhi degli storici, ilsecolo XVI appare nel-l’Europa cristiana come untempo di grande inquietu-
dine religiosa; non come tempodi crisi, ma piuttosto di ansia, neldesiderio di un profondo rinno-vamento in risposta alla diffusaangoscia per l’incertezza dellasalvazione eterna. Non si spie-gherebbe altrimenti il subitaneoe sorprendente successo in Ger-
6Nebulæ / 65
Giovanni de’ Medici, papa Leone X

mania delle idee innovative diMartin Lutero. E anche in Italia– ad esempio – assistiamo alla di-rompente e feconda predica-zione del Savonarola e di altriprotagonisti delle novità reli-giose, che anche da noi si ebberonella ricerca di una devozionepiù autentica.Ma il secolo XVI, specialmentenella sua prima parte è anche iltempo degli sconvolgimenti po-litici e sociali, prodottidalle pestilenze, dalle care-stie e soprattutto dalleguerre. Dalle guerre so-prattutto, con i grandi disa-stri economici, morali ereligiosi provocati daglieserciti in lotta: dai soprusi,rapine e violenza di ognigenere che ne derivarono,specialmente durante gliacquartieramenti dei sol-dati. Basta scorrere le pa-gine del nostro cronistaseicentesco Francesco Ga-leotti per rimanere quasiinorriditi dagli sconvolgi-mento avvenuti a Pescianel 1530, per la presenza disettemila soldati dell’eser-cito mandato dal papa perla conquista militare di Fi-renze. E appare altrettantodrammatica la legazione pescia-tina allora inviata a Bologna perfar atto di sottomissione a Cle-mente VII; non in quanto papama come Giulio de’ Medici voltomilitarmente alla conquista di Fi-renze e di tutto il suo territorio,Pescia inclusa.Quali i riflessi di questi avveni-menti sulla religiosità dellagente? Riuscivano a distingueretra la missione del papa, come vi-cario di Cristo, e la persona di
Clemente in guerra per la supre-mazia politica della propria fami-glia? Parrebbe che ci riuscissero,per l’abitudine a vedere nel papae nei vescovi anche e soprattuttodei principi secolari. Parrebbeche la vita religiosa – pure qui inValdinievole – seguitasse il con-sueto suo corso, anche se neces-sariamente possiamo pensareche fosse mortificata e incupitadal contesto violento e antievan-
gelico di allora. Noi non pos-siamo che limitarci a leggerecriticamente le poche tracce chedi quella vita religiosa ci sonopervenute, per una storia purframmentaria della frequenza aisacramenti, dei vari momenti delculto, della conoscenza dellaBibbia, dell’uso dei libri di pietà.Tenendo però conto che dallafine del Quattrocento – forsecome reazione ai tempi – si eraanche diffuso nella pratica reli-
giosa dell’Europa quel feno-meno, pure ricorrente nella sto-ria della Chiesa, della osservanzaformale della precettistica reli-giosa, ciò che gli storici chia-mano “osservantismo”. Cioè siera diffusa una mentalità legali-sta, intesa come accentuazioneesagerata delle azioni esterne conconseguente mancanza di unavera vita interiore. L’ “osservan-tismo” fu soprattutto un fatto ti-
pico della vita monasticadel XV secolo.Come altre volte, anche al-lora quel fenomeno as-sunse pure aspetti violenti,specialmente testimoniatinella vita degli ordini men-dicanti. Rimane comeesempio la cacciata a basto-nate dei frati conventualidal loro convento di SanFrancesco di Lucca daparte dei frati osservanti.Fu una intransigenza reli-giosa che molto probabil-mente creò situazioni didisagio anche a Pescia, tral’antico convento dei con-ventuali di San Francesco eil nuovo insediamentodegli osservanti a Colleviti.Non a caso, nella predica-zione del Savonarola e dei
suoi seguaci – con esempi anchea Pescia – uno dei temi centralifu l’esortazione a superare il for-malismo dei riti, delle vigilie edelle processioni, con una verarinascita interiore della fede cri-stiana. Non le “cerimonie”,come le chiamava il Savonarola,o le “opere esterne”, come di-ceva qui da noi il Benivieni, pos-sono salvare, ma una fede vivache si esprime nelle opere del“ben vivere”. Un esempio im-
7 Nebulæ / 65
Giulio de’ Medici, papa Clemente VII

portante – nel vuoto di altre ana-loghe testimonianze – lo abbia-mo proprio a Pescia nel mona-stero di San Michele, dove è do-cumentato uno spirito di rinno-vamento religioso, nella formaintima della imitazione di Cristo,secondo l’insegnamento dellaDevotio moderna.Naturalmente, lo storico dellaChiesa guarda, e non può fare al-trimenti, alle forme esterne dellavita ecclesiale, alla successionenel tempo delle manifestazionivisibili della fede. Abbiamo anostra disposizione, anche per laValdinievole, i fondi archivisticidei monasteri, dei conventi,delle parrocchie e delle rettorie.Accanto a queste istituzioni, iterzi ordini e le confraternite.Anzi proprio i terzi ordini e leconfraternite furono in Valdinie-vole stupefacenti committenti diopere artistiche e architettoni-che. Dall’alta committenza – adesempio – della confraternita pe-sciatina della Misericordia aquella estremamente modesta –ma appunto perciò più significa-tiva – della compagnia del Rosa-rio di Castelvecchio.Purtroppo l’abbondante docu-mentazione, che le confraternitedella Valdinievole ci hanno la-sciato per il secolo XVI, manife-sta soprattutto la struttura isti-tuzionale che si volle conservare,analoga a quella dei contempo-ranei statuti delle comunità ru-rali, e poche notizie ci forniscedella vita religiosa. Credo peròche una più accurata attenzionealla parte amministrativa di taledocumentazione potrebbe apri-re qualche finestra interessante.Come pure meritano un esamegli archivi degli spedali, e per
Pescia quello veramente pre-zioso di Santa Maria Nuova, dacui abbiamo tra l’altro, e perlungo tempo, gli elenchi delle as-segnazioni delle doti alle fan-ciulle, elenchi che sono unindice importante dello statodella povertà cittadina.
Rimangono del tutto fuori dainostri programmi di ricerca al-cuni temi, e in primo luogo il si-stema beneficiale, cioè l’organiz-zazione degli stipendi ecclesia-stici. Sistema beneficiale vistotanto nell’aspetto della riservapontificia del diritto di asse-gnazione, quanto – all’oppo-sto – del diritto di presentazionedei patroni, cioè dei fondatori ein un certo senso dei proprietaridei beni immobili dai cui frutti siformavano benefici. Per l’uno e
per l’altro motivo, almeno neifatti, la nomina dei parroci edegli altri rettori delle chiese edegli oratori, sfuggiva di mano aivescovi. L’esame in Valdinievoledi queste situazioni interessa inriferimento agli atti di esecu-zione delle disposizioni leonine,che smembravano i benefici par-rocchiali per la costituzione diquelli dei canonici della preposi-tura di Santa Maria, a cui il papaaffidava il governo della nuovadiocesi di Pescia.Un altro tema importante rima-sto questa volta volutamentefuori dalle nostre ricerche èquello della eresia. Ci possiamoinfatti domandare se si diffuseroanche da noi, e in che misura, leidee dei protestanti, visto che in-torno al 1540 se ne trovanotracce tanto a Lucca quanto a Pi-stoia, anche a livello popolare.Infine, per riprendere un di-scorso che ho soltanto accen-nato, in questo nostro incontromanca un esame del contestopolitico locale, della relazionetra politica e religione, tra spiritorepubblicano e fatale dittaturamedicea. Poiché Leone X, Gio-vanni de’ Medici, affidò il go-verno della nuova diocesi diPescia agli esponenti dellegrandi famiglie della aristocraziamercantile pesciatina, è impossi-bile non supporre un condizio-namento della vita religiosa daparte dell’egida medicea.Non a caso quindi e non solo pernecessità di transito, l’impera-tore Carlo V nel 1536 e papaPaolo III nel 1541 ritennero difare sosta a Pescia, ospiti di unadelle più grandi famiglie, legatetanto al nuovo ducato mediceoquanto al papa.
8Nebulæ / 65
Martin Lutero

LE FONTI PER LA STORIA ECCLESIASTICAPESCIATINA. RELAZIONI, VISITE, STORIE
di Manuel Rossi
Pieve a Nievole, sabato 5 ottobre 2019
Il tema che si affronta in questegiornate pievarine – la religiositàpopolare in Valdinievole all’iniziodel Cinquecento – mi pare parti-colarmente delicato e di difficileinquadramento in primisproprio perché scarsamentedocumentato dalle fonti lo-cali. Non è certo un caso chegià a metà Seicento il più im-portante erudito pesciatinodel proprio tempo, France-sco di Ottavio Galeotti, ini-ziasse le proprie Memorieecclesiastiche di Pescia e dellasua Diocesi lamentando ilfatto che «volendo descri-vere le memorie delle chiesedi Pescia e della sua Diocesiconosco di non lo poter farecon quell’esattezza ch’io vor-rei, poiché la mancanza ch’habbiamo di scritture ca-giona che siamo in una gran-dissima oscurità». Ed infattila distruzione di moltefonti – tra cui converrà ricor-dare almeno la perdita, pres-soché completa, dell’antico archi-vio della Pieve di Santa Maria diPescia verosimilmente andatoperduto proprio in seguito al-l’erezione in Propositura nel1519 – rende piuttosto arduotracciare un quadro generalesulla spiritualità, sul credo popo-lare, sulle tradizioni religiose.Nel mio intervento vorrei dun-que delimitare, se non affrontare,il problema della lettura deglieventi e della vita ecclesiastica pe-
sciatina quattro e cinquecentescaalla luce delle principali produ-zioni che hanno descritto o che sisono soffermate sulla storia reli-giosa locale.Questo che potrebbe apparirecome una questione tutto som-mato agevole in realtà pone una
serie di problemi legati in primisall’abbondanza della produzionestoriografica pesciatina la cuimole è davvero imponente. In-fatti se scarse sono le fonti sullastoria ecclesiastica, al contrariosono moltissime le storie scritteda eruditi locali a partire dallaprima età moderna.Ad esempio proprio in bilico trala costruzione di un’immagineideale e la volontà di ricostruire ilproprio passato si colloca il li-
bello letto a Baldassarre Turininel 1519, proprio in occasionedell’elevazione della Pieve in Pro-positura, il quale si basava su treelementi: la storia del territorio,la sua chiesa e le sue famiglie. Treelementi che, come vedremo, co-stituiscono un filo rosso lungo i
secoli.In particolar modo il XVIIsecolo sembra essere un se-colo di particolare impor-tanza nella riflessione storicalocale. Ma del resto lo è ingenerale nella Toscana gran-ducale: si pensi ad esempioalle Istorie fiorentine del-l’Ammirato pubblicate pro-prio nel 1600 seguite dallaCronistoria dell’antichità enobiltà di Volterra del Gio-vannelli nel 1613 o ancoraalle Historie di Siena di Giu-gurta Tommasi edite nel1625. In questo contesto sideve dunque calare l’attivitàdei principali eruditi pescia-tini del secolo: si pensi alleMemorie di Pescia di PlacidoPuccinelli pubblicate nel1664 (anticipando di ben
quindici anni la prima cronacapisana a stampa, ovvero gli An-nali del Tronci i quali verrannopubblicati solo nel 1679) e so-prattutto le opere storiche rima-ste manoscritte del già menzio-nato Francesco di Ottavio Gale-otti.Soprattutto nel caso del Galeottimi pare che si possa evidenziareuna peculiarità sui cui forse con-verrà soffermarci, ovvero l’ap-proccio prettamente erudito alla
9 Nebulæ / 65

questione storica. Sintetizzandobrutalmente si può infatti segna-lare come gli eruditi locali dimo-strino un disinteresse comples-sivo nei confronti dei problemistoriografici generali in favore diuna disamina dei documenti che,non a caso, spesso sono integral-mente trascritti e commentati.Una tradizione che sopravvivrà alungo come ci dimostrano le Sto-rie di Niccolò Poschi, redatte fineSettecento, e su cui torneremo trapoco. Un contatto così assiduo coi do-cumenti testimonia la prassi di la-voro di questi eruditi che di fattocostituivano la punta di un ice-berg costituito prevalentementeda canonici e chierici che informe diverse erano interessati amettere nero su bianco la storiadegli istituti ecclesiastici locali.Infatti mettere nero su bianco si-gnificava non solo condurreun’operazione che noi considere-remmo storiografica o più in ge-nerale culturale, ma un’operazio-ne di rivendicazione e fissazionedi diritti che potevano essere van-tati solo creando un bagaglio giu-ridico probante ed efficace.In tal senso mi sembra che uncaso di particolare interesse in cuiall’intento storico e si uniscequello più pratico di rivendica-zione di diritti sia costituito dalleMemorie o vero ricordi attenentiall’antica e veterana terra diMonte Catino, esemplare cronacaredatta a fine Seicento da GiulioFinocchi del monastero di SantaMargherita di Montecatini epochi anni fa pubblicata da Fa-brizio Mari.Nel caso del Finocchi rintrac-ciamo infatti da un lato la più no-bile delle tradizioni storiografi-che: l’annalistica; infatti propriosecondo il modello annalistico il
Finocchi redasse una vera e pro-pria storia organizzata cronologi-camente. A questa si uniscequella cura e quell’attenzione peril documento – che abbiamo ri-scontrato essere un fenomeno ti-pico della storiografia pesciatina– che lo spinse a trascrivere interepergamene (alcune delle qualinon ci sono giunte, quindi l’ope-razione è doppiamente merito-ria). D’altro canto c’è un secondo ele-mento che non dobbiamo trascu-rare: la necessità di fornire unquadro generale sui diritti, i pri-vilegi ed i doveri della propriachiesa. Così proprio andando avedere gli anni a cavallo dell’ele-vazione in propositura notiamo leseguenti notizie: nel 1518 la pro-cessione fatta a Montecatini con-tro le eresie di Germania(secondo una notizia estratta daun libro di ricordi del convento);nel 1519 l’erezione in propositura(secondo una notizia estrattadalle Memorie di Pescia del Puc-cinelli); la costruzione di unnuovo pulpito; la nomina di unconfratello a Padre Provinciale,nel 1520; il dono di una tovaglia,nel 1521; l’abbattimento di untratto di muro e il costo del sale.Una commistione di notizie ec-clesiastiche ed economiche chederiva da un lato dalla stretta in-terconnessione tra i due aspetti,spirituale e materiale, e dall’altrosuggerita dalle fonti stesse che –essendo state redatte in primoluogo per tenere la contabilità delluogo pio – offrirono al Finocchimolte più informazioni suglieventi materiali del Monasteroche non su quelli spirituali.Tuttavia è quella stessa attenzioneai documenti a fornirci alcune in-formazioni sulle pratiche devo-zionali del proprio territorio,
pratiche che nell’arco di pochianni sarebbero state cancellatedalla normalizzazione post-tri-dentina e che non avrebbero la-sciato altra notizia. Ad esempio èlo stesso Finocchi a tramandarcila tradizione che coinvolgeva letre compagnie presenti nel borgoagli inizi del XVII secolo – dedi-cate a S. Antonio, S. Bastiano e S.Giovanni Battista – di mettere inscena, tra sacro e profano, epi-sodi della vita dei Santi seguiti dauna corsa o palio. È proprio gra-zie alla cronaca del Finocchi chenell’Ottocento lo studioso LeoneLivi poté ricostruire le gare delleconfraternite ovvero quando «sipresentavano nella pubblicapiazza, per esempio, tre fratellidella confraternita di S. Bastianoe due di essi, che il popolo chia-mava farisei, muniti d’arco e fare-tra s’infingevano i feritori delterzo che rappresentava S. Ba-stiano [...] terminata la scena, dicui era sempre spettatore im-menso popolo, deponeano i trecampioni le comiche vesti equindi faceano una corsa dallapiazza fino alla chiesa di S. Ba-stiano nella quale il primo chegiungeva alla meta riportava ilpremio già destinato. Lo stesso sipraticava in quel giorno dai con-fratelli della compagnia di S. An-tonio che simboleggiavano lalapidazione di S. Stefano e quindiad imitazione di quelli di S. Ba-stiano gareggiavan correndo finoalla chiesa dei Padri Agostiniani».Immagini che ci giungono da unpassato e da una tradizione devo-zionale oggi pressoché scom-parsa, ma fortunatamente attesta-ta dalle fonti.
10Nebulæ / 65

11 Nebulæ / 65
Pieve a Nievole,sabato 5 ottobre 2019
Nel febbraio del 1504 una certaDorotea, originaria del villaggiomontano di Lanciole, fu ascol-tata, in una sorta di interrogato-rio preliminare, dal vicariovescovile di Pistoia, il fiorentinoDonato Bocchi, affinché ne po-tessero essere verificate la buonacondotta morale, l'assenza di de-viazioni eterodosse, la veridicitàdelle sue severe pratiche peniten-ziali (digiuno totale, se si eccettuala sola eucarestia) e del suo donoprofetico.L'interrogatorio si svolse in unclima (fuori e dentro il palazzoepiscopale) piuttosto surriscal-dato, al punto che, dopo un con-fino di quattro giorni in unastanza (per il prolungarsi delleindagini), ne fu decretato con ri-luttanza il rilascio su pressionedel domenicano Tommaso Ca-iani, uno dei suoi mentori/padrispirituali, spalleggiato da un nu-trito gruppo di cittadini. L'ecodegli avvenimenti pistoiesi giun-se, per il tramite del Caiani, agliorecchi di Domenica da Paradiso(al secolo Domenica Narducci),la più savonaroliana delle savo-naroliane fiorentine. Da tempoormai la storiografia si è occu-pata di queste sante vive che,stregate dal verbo del frate ferra-rese dopo la condanna e il rogodel 1498 ne portarono avanti ilmessaggio e la missione aposto-
lica. Ciò non stupisce, visto cheproprio il Savonarola, nella suaazione di apostolato finalizzata alrinnovamento del corpo eccle-siale, aveva ritagliato uno spazioimportante e di sorprendentecentralità alla componente fem-minile (sia laica che ecclesia-stica). Dopo un'iniziale interessedi Domenica nei confronti diDorotea (anche quest'ultima erastata travolta e affascinata, comemolti abitanti della Val di For-fora, tra Pescia e Pistoia, dallapredicazione del Savonarola edei suoi adepti, tra i quali Dome-nico Benivieni), presto tra le duei rapporti si fecero tesi: in parti-colare la Narducci cominciò adubitare della sincerità dei di-
giuni della fanciulla di Lanciole,accusata di essere né più némeno che una sguattera (e pureconcubina) del parroco France-sco.Naturalmente non è possibile inquesta sede ripercorrere nel det-taglio tutte le tappe dello scontrotra le due donne, uno scontroche peraltro non può essere ri-dotto ad una baruffa tra prime-donne. Il conflitto tra le dueinfatti è un capitolo, certo signi-ficativo, del più ampio problemadel movimento savonarolianonella prima metà del Cinque-cento.Tra Domenica e Dorotea fu laprima, sulla lunga distanza, aguadagnarsi un posto di tutto ri-
UN CASO DI SANTITÀ SIMULATA? DOROTEA DI LANCIOLE TRA GENUINO SLANCIO PENITENZIALE
E STRUMENTALIZZAZIONI POLITICHEdi Giulio Bizzarri
Lanciole di Val di Forfora. Chiesa di San Bartolomeo

12Nebulæ / 65
spetto nel mare magnum de-vozionale di antico regime (equindi nella Storia), tantoche per lo studioso odiernorisulta un'impresa ardua re-stituire a Dorotea uno spaziostorico autonomo, un postocioè che non sia una mera ap-pendice (per non dire un fa-stidioso 'incidente') dellaparabola esistenziale dellaNarducci. Un fatto è tuttaviacerto: per l'esegeta delle fontiDorotea non sarebbe esistitasenza Domenica, se noncome semplice e sbiadito ri-cordo cronachistico. Lostesso vale per un altro pro-tagonista della vicenda, quelparroco di Lanciole, don France-sco da Pescia, al quale sembrache la fanciulla fosse particolar-mente legata, un personaggiopoco rappresentato nel pa-norama documentario.Grazie ad un attento scavocondotto negli archivi pisto-iesi (soprattutto in quello ve-scovile) ho potuto tuttaviaintuire uno scenario piùcomplesso (e spiritualmentemeno nobile dei sogni profe-tico/escatologici savonaro-liani) all'interno del qualecollocare e inscrivere la vi-cenda di cui fu protagonistaDorotea. Negli atti della Ta-vola Rotonda tenutasi il 5 e 6ottobre 2019, la cui uscita èprevista in primavera, daròrisalto ad attori finora messiin secondo piano (alcunicompletamente trascurati) nelcosiddetto affaire Dorotea: unprete intrigante di Pescia, il giàcitato don Francesco parroco diLanciole, deciso a sfruttare la sua
protetta Dorotea per co-struire per sé e la sua famigliauno spazio egemonico nellaValdinievole nord-orientale enella Val di Forfora, la fami-glia dei Cancellieri, che avevauna fitta rete clientelare cheabbracciava la lunga strisciache collegava il Montalbanocon la Val di Forfora (e checomprendeva anche i centridi Montevettolini e di Mon-tecatini nella Valdinievoleorientale), i frati domenicanidi Pistoia. Alla luce di questeconnessioni (in parte ancorada verificare nel dettaglio), acui possiamo aggiungere lastoria della geografia eccle-
siastica della Val di Forfora trafine Quattro e primi decenni delCinquecento (siamo nel periododella preistoria della prepositura
pesciatina, che tuttavia noncomprenderà mai le parroc-chie di Lanciole e paesi limi-trofi), il caso di Doroteaassumerebbe una fisionomiapiù complessa, irriducibilead un semplice capitolo dellastoria devozionale della To-scana primo-cinquecentesca.
Bibliografia:Per una ricostruzione detta-gliata dell'Affaire Dorotea ri-mando a:I. Gagliardi, Sola con Dio. Lamissione di Domenica da Pa-radiso nella Firenze del primoCinquecento, Firenze 2007,
pp. 23-99.Nei riferimenti bibliografici innota e in appendice sono citati inumerosi studi di Lorenzo Poliz-zotto e di Adriana Valerio.
Lanciole. Dipinto del 1641 di ar-tista ignoto raffigurante la “Ver-gine del rosario” situato all’in-terno della chiesa di San Bartolo-meo.
Lanciole. Dipinto del 1641 di ar-tista ignoto raffigurante la “Ver-gine col bambino e due santi”situato all’interno della chiesa diSan Bartolomeo.

FRA GIOVANNI DA PESCIA E LA DIFESADELLA DOTTRINA SAVONAROLIANA
di Alberto Coco
Pieve a Nievole,sabato 5 ottobre 2019
La condanna a morte di Giro-lamo Savonarola e la sua esecu-zione, avvenuta sul rogo di piazzadella Signoria il 23 maggio 1498,non riuscì a sopire del tutto lavoce dei suoi so-stenitori, i cosid-detti “piagnoni”,molti dei qualicontinuarono a di-fendere e divul-gare la dottrina delfrate ferrarese. Traquesti fra Gio-vanni da Pescia,del convento do-menicano di SanMarco che, nono-stante i divieti im-posti dai superioridel proprio Or-dine, non esitò adar voce alle istan-ze savonaroliane.Nei primi mesi del1500 compose untrattato dal titoloOperecta interroga-toria, nel qualeoltre a riproporre le ben note ar-gomentazioni riguardo la veritàdelle profezie di Savonarola e lanecessità da parte di tutti i cri-stiani di seguirne la dottrina peravere la ricompensa della vitaeterna, affermava che tale ricom-pensa sarebbe stata negata ai de-boli e ai timorosi. Perraggiungere il regno dei cieli iCristiani dovevano non solo,
come l’autore dell’anonimo trat-tato asseriva, dichiarare pubblica-mente il loro credo in Savonarolae giustificare la sua condotta inogni occasione: dovevano ancheopporsi ai peccatori che tenta-vano di cancellare la sua memoriae persino mettere a disposizione
la propria vita per lui. A dimo-strazione di ciò, nella parte finaledel suo trattato, fra Giovanni,lanciava le sue accuse contro fraFrancesco Mei, Procuratore ge-nerale dell’Ordine domenicano,considerandolo un’apostata perla sua opposizione a Savonarola eper aver contribuito alla sua ca-duta. ed essere poi determinato arinforzare le restrizioni di Gioac-
chino Torriani, Maestro generaledell’Ordine. «Fatti avanti», tuo-nava rivolto a fra Francesco, «tuche vivi costantemente nella Ba-bilonia romana, tu che dopo es-sere stato nominato Procuratoregenerale dell’Ordine domeni-cano adesso stai facendo tutto il
possibile per otte-nere la completadistruzione dei se-mi piantati da co-loro che credononel lavoro predettoda Savonarola…Veramente, tupuoi ben vantartidi essere stato unodei principali stru-menti contro quellavoro […]: piùgrande sarà il tuosforzo» continuavafra Giovanni, «piùgrande sarà la ri-compensa che ti ri-serverà l’inferno».Tale attacco venneribadito da fraGiovanni neglistes-si mesi in unalettera ad alcuni
confratelli della CongregazioneTosco-Romana al tempo riuniti incapitolo provinciale a San Dome-nico di Fiesole, nel quale li rassi-curava riguardo il fatto di nonavere alcuna intenzione di ritrat-tare le proprie parole nonostantele persecuzioni a cui era sottopo-sto. Egli non immaginava infattialternativa al sostenere la veritàfino alla fine. «Non posso fare di-
13 Nebulæ / 65
Firenze. Piazza della Signoria col supplizio del Savonarola.

versamente», dichiarava moltosemplicemente. Per lui l’approva-zione o la disapprovazione deisuoi superiori non aveva più va-lore ormai, essendo guidato,come egli credeva, da una auto-rità superiore, per cui di fatto aisuoi occhi veniva meno il doveredi fedeltà ai superiori. Tenuto arispondere per la sua condottasolo a Dio, si allontanò dai suoisuperiori formali e da coloro cheavevano il potere digiudicarlo, persinodallo stesso Vicariogenerale. Ciò dava lalibertà di schierarsitanto contro il po-tere civile, quantocontro quello eccle-siastico, di proporrealternative alle strut-ture sociali esistentie, per di più, di ado-perarsi per renderleeffettive e concrete.Avendo chiaro ciò, èpossibile compren-dere chiaramente laminaccia che essirappresentavano equanto difficile po-tesse risultare raffred-dare gli ardori della militanzapiagnona. Vi è poi un secondotrattato attribuito a fra Giovannida Pescia intitolato Argomentumeiusdem obiectione. In questoscritto viene contrastata la que-stione della confessione diretta diSavonarola, affermando che «Sa-vonarola non ha ritrattato, néavrebbe mai potuto». Fra Gio-vanni afferma che qualsiasi cosasia stata fatta confessare a Savo-narola durante il processo, nientepuò confutare la verità della suavisione sullo stato di corruzionedella Chiesa del tempo e la ur-
gente necessità di una sua ri-forma. Accettare l’idea di una suaritrattazione, estorta con la forzada coloro che avevano tutto l’in-teresse a mantenere lo status quo,era equivalente a credere che laChiesa non fosse corrotta e nonavesse necessità di essere rifor-mata: e questo era palesementefalso. Fra Giovanni espresse leproprie argomentazioni con uncerto impeto sapendo che queste
facevano forte presa ed erano at-tentamente giudicate da coloroche lo appoggiavano all’internodella Congregazione Tosco-ro-mana. Fiducioso nella potenzadel messaggio savonaroliano espazientito dal loro fallimentofino al momento, fra Giovanniimplora i confratelli di agire finoa sacrificare la loro stessa vita.Tuttavia ciò non avvenne e sullafine di Fra Giovanni si possonofare solo supposizioni. Probabil-mente subì la condanna allemassime pene che GioacchinoTorriani, Maestro generale
dell’Ordine, stabilì per coloroche si fossero opposti ai suoi or-dini. Infatti, dopo il maggio del1500 il suo nome scompare dairegistri della CongregazioneTosco-romana mentre sappiamoche al momento della morte ri-copriva l’incarico di Lettore inun convento di conventuali, nonOsservanti, a Cortona. A giudi-care da quelli che furono i risul-tati delle elezioni nel 1500 e nel
1501, i savonaro-liani apparvero su-bire una fortebattuta d’arresto,perdendo le prece-denti posizioni diinfluenza all’internodi alcuni settoridella Congrega-zione.
Bibliografia:
L. Polizzotto, TheElect Nation: TheSavonarolan Move-ment in Florence,1494-1545, Oxford
University Press, New York1994.Fra Giovanni da Pescia, Ope-recta interrogathoria fatta da uncerto amico in chonsolatione ditutti e fedeli dell’opera di FrateHieronymo da Ferrara: la qualedemostra la malvagità e scioc-chezza della chontraria parte chonforti ragioni, MS BNF Magl.XXXV, 116, ff. 79v-104v (legatocon un’altra copia in BNFMagl., XXXVII, 65).[Fra Giovanni da Pescia], Argo-mentum eiusdem obiectione, MSBNF Magl. XXXV, 116.
14Nebulæ / 65
Firenze. Piazza della Signoria. Lapide commemorativa.

15 Nebulæ / 65
IL MONASTERO PESCIATINO DI SAN MICHELEE LA PREDICAZIONE SAVONAROLIANAALL’INIZIO DELL’EPOCA MODERNA
di Amleto Spicciani
Pieve a Nievole,domenica 6 ottobre 2019
Gli studiosi del Savonarola, especialmente quelli che indaganosulla diffusione e sulle conse-guenze della sua predicazione dirinnovamento spirituale e civico,già da molto tempohanno presentato ed esa-minato pure alcune fontipesciatine di particolareinteresse. Mi riferisco so-prattutto a due codicicartacei che provengonodal monastero benedet-tino di San Michele fuoridalla cerchia muraria diPescia. Tali codici, redattiad opera di quelle mona-che, ci hanno trasmessosia una raccolta di letteredi Domenico Benivieni,di cui quarantasei a lorodirette dal 1493 al 1500,sia la trascrizione di duequaresimali e di altre pre-diche a loro tenute tra il1508 e il 1510 dal fratedomenicano Silvestro daMarradi, anche lui, comeil Benivieni, ardente se-guace del Savonarola. In-sieme con queste due principaliraccolte, per lo stesso periodo, lemonache di San Michele cihanno pure trasmesso in copialettere di frati domenicani, alcunedirette a loro e altre ai pesciatini.Nel complesso si tratta quindi ditestimonianze del movimento sa-
vonaroliano nel pesciatino deglianni che precedettero e immedia-tamente seguirono il fatidico 23maggio 1498, il giorno della ese-cuzione del Savonarola e dei suoidue compagni, fra Domenico daPescia e fra Silvestro Maruffi.Di fronte a questa specifica docu-
mentazione, che attesta la diffu-sione pure in Valdinievole delmovimento savonaroliano, siamoindotti a porre anche il problemadi quali potessero essere in essa irisultati pratici della esortazionedi rinnovamento soprattutto spi-rituale che tale movimento espri-
meva. Tenendo conto che la Val-dinievole, come parte orientaledella diocesi di Lucca, era allorapoliticamente fiorentina, separatae indipendente dal governo luc-chese, e che era in procinto di di-ventare un territorio ecclesiasticoesente anche dalla originaria giu-
risdizione del vescovo diLucca (1519).Che malgrado proibi-zioni e ostilità, le mona-che pesciatine di SanMichele dopo la mortedel Savonarola abbianoraccolto, copiato e dif-fuso le lettere di un suofedele seguace, come lofu Domenico Benivieni, eche poi abbiano tra-scritto due quaresimali diun frate domenicanougualmente discepolodel grande ferrarese,unendovi la copiatura dialtre lettere di ferventidomenicani, tutto ciò èuna chiara testimonianzadel clima savonarolianoche allora si era diffusonel territorio circostanteal monastero. Sia a Pe-scia, entro il cerchio delle
mura, sia nell’alta Valdinievole,nei paesi di Lanciole, Crespole eCalamecca della Valdiforfora, sierano infatti formati gruppi dilaici che aderivano con serio spi-rito rinnovato alla predicazionedel movimento savonaroliano,come risulta chiaramente dalla
Pescia. Chiesa di San Michele.

16Nebulæ / 65
presenza specialmente di tre im-portanti frati domenicani, se-guaci ardenti del Savonarola: fraTommaso Caiani, fra Silvestro daMarradi e fra Bartolomeo da Fa-enza, legati a loro volta alla pre-senza pesciatina dello spedalingoDomenico Benivieni, il sottilis-simo filosofo, canonico fioren-tino di San Lorenzo.Una testimonianza diretta delrinnovamento spirituale savona-roliano portato a Pescia dalBenivieni ci viene dunque pa-lesemente dalle sue lettere in-viate alle monache di SanMichele, come a dire alla reli-giosità femminile della grandearistocrazia mercantile pescia-tina («Si dice che voi siete lospecchio di Pescia», diceva aquelle monache fra Silvestroda Marradi durante la pre-dica). Lettere a donne ingrado di leggere e compren-dere gli scritti del Savonarolae attente anche alle vicendesocio-politiche di Firenze ed’Italia, di cui erano spesso in-formate dai portatori delle let-tere, espressamente a ciòincaricati dallo stesso Beni-vieni. Egli tuttavia preferiscescrivere di cose spirituali, ben-ché spesso dica delle annun-ciate tribolazioni e delsuccessivo rinnovamento cheda Firenze verrà non solo allaChiesa ma pure all’Italia, scon-volta dalla presenza armata del redi Francia Carlo VIII. Tanto chele monache nel titolo postumoapposto alla raccolta scrissero:«Comincia le devote epistole delreverendo padre maestro Dome-nico Benivieni fiorentino, le qualimandò alle monache di San Mi-chele fuor di Pescia non le po-tendo più consolare con la viva
voce per la tribolazione della Ita-lia». Volendo probabilmente direche il Benivieni non era più tor-nato stabilmente a Pescia, da cuiperò in realtà si era allontanatoprima della venuta di Carlo VIII(1494). aTribolazioni che toccanoanche Pescia ed entrano addirit-tura pure nel monastero. «Etperò, dilectissime in ChristoYesu» – scriveva il Benivieni il 15agosto 1496 – «hora è el tempo
delle tribolazione et la Terra vo-stra ha incominciato a saggiare levivande che vuole Iddio mandaredalla Ytalia». Ma insisto nel direche nelle sue lettere il Benivieninon smise mai di essere un diret-tore spirituale, astenendosi dapolemiche e denunce di aspetti,allora evidenti, nel governo dellaChiesa e nella pubblica moralità.La perfezione cristiana predicatadal maestro Benivieni alle mona-
che consiste essenzialmente inuna «riforma» del Cristo, del Cri-sto crocifisso, nei loro cuori.Consiste insomma in un cambia-mento del modo di intendere lavita monastica. Vale a dire checonsiste in una vita di fede «vivaet sincera» che, divenendo nel-l’amore imitazione della vita diCristo, sia continuamente ali-mentata dalla orazione mentale.Con il convincimento che la ri-
forma di Cristo nei cuori,cioè la fede «viva», è un donogratuito di Dio, è una luce,un lume, un fuoco che si puòinvocare, accogliere con di-sponibilità, ma non mai me-ritare facendo il bene.La “riforma” del Cristo neicuori delle monache, operatadal lume divino, in quel con-testo storico della vita mona-stica, voleva dire il passaggio,la conversione, dall’esterio-rità del rito alla interiorità diuna fede animata dall’amore:dalla osservanza esterioredelle regole e dei precetti,dalle «cerimonie», come di-ceva il Benivieni, che sono ilcomportamento tipico dei«tiepidi», alla interioritàdell’amore per Gesù Cristocrocifisso. Sono proprio i «tie-pidi», che con fede ma senzaamore, senza vita interiore, os-
servano in modo esatto e precisole prescrizioni, le «cerimonie»appunto, e sono perciò i verigrandi, diabolici nemici («lecarne del diavolo», come lichiama il Benivieni), della perfe-zione della vita cristiana e mona-stica.«Credono molti» – scriveva allemonache il Benivieni – «che laperfectione conshista in cerimo-nie, in dire bene l’ufictio, in sal-
Fiesole. Chiesa di S. Domenico. Fra Giro-lamo Savonarola e compagni, dipinto di fraPaolino da Pistoia (particolare).

Nebulæ / 6517
meggiare bene, in ornamentidella chiesa: non così, non così.Figliuole mia, tucta la perfectionedel cristiano sta di dentro e nondi fuora, in imitare el capo nostroper quella via che io v’ho decto».Ecco dunque che Domenico Be-nivieni dice che non avrà maipace nel suo spirito fintanto chenelle monache pesciatine «nonvegha in tucte riformato el dolciesposo vostro et signiore mio YesuChristo crocifisso». E che ciò av-venga – come già dicevo –«prima per una viva e sincierafede; secondo per una continuaimitatione; tertio per unadolcie et suave meditationeet contemplatione».Cosicché il tema cen-trale delle sue lettere èsempre la fede inGesù Cristo, o ancheil lume della fede,cioè la conoscenzadonata da Dio dicome, nell’amore, imi-tare Cristo. La fede èun dono da chiedere,ma anche da prepararsi aricevere con grande umiltàe semplicità. Infatti la fede inGesù Cristo – scriveva il Beni-vieni – «non s’acquista né per ve-dere miracholo, né per ragioni[…], perché la fede è un lumesopra naturale infuso da Dionell’anima che si apparecchia perhumilità a ricevere questo lume».L’animo dunque può, anzi devedisporsi, prepararsi a ricevere ildono del lume divino in atteggia-mento umile. A questo propositomi pare interessante che il Beni-vieni completi questo suo di-scorso con una realisticaosservazione: nei superbi la fedesi dissolve in una opinione, cioèdiventa un atteggiamento este-
riore, non radicale, diventa ap-punto il formalismo dei «tiepidi».«Et però» – continua il Benivieni– «l’anima superba mancha diquesto lume et bene che gli paiahavere fede non ha vera fede, mapiuttosto una oppenione».È così importante nell’insegna-mento teologico del Benivieni laattiva partecipazione dell’uomoall’opera di salvezza, cioè all’otte-nimento della grazia, che sispinge fino al punto da sostenere,
contro ogni idea di predestina-zione, la capacità umana di di-sporsi, o per meglio dire di aprirsicon il desiderio e con le operebuone all’“acquisto” della fede, aricevere cioè un dono gratuitoma universalmente preparato daDio. Ed infatti il Benivieni cosìscriveva: «El modo d’acquistarequesto lume si è: prima, sforzarsidi credere quanto si può natural-
mente; secondo, humiliarsi adDio nelle orationi con tucto elcuore et donandargli questolume; tertio non cessare mai dibene operare. Et chi in queste trecose persevera senza dubbio al-cuno riceverà da Dio questolume della fede».Un lume dunque che è donato seè richiesto, ma che va anche sa-puto conservare, anzi che deveessere conservato con perseve-rante attenzione. E qui emerge ilmomento più spiritualmente im-portante di tutto l’insegnamentoteologico del Benivieni, quellopiù proprio della vita mona-stica, cioè il momento con-templativo. Quando cioèl’anima lascia la ritua-lità della preghiera e sieleva alla riflessionedell’intelletto, chespinge poi la volontàall’amore.«Et acciocché pos-siate perseverare inqueste dua cose, cioènella vera fede e nellaimitazione di Yesu Chri-
sto» – scriveva dunqueDomenico Benivieni il 27 no-
vembre 1493 – «vi è necessariala tertia cosa, cioè una continuameditatione et oratione, la qualenon consiste in multiplicatione diparole ma in elevatione di mente:pensando qualche volta la gran-dezza di Dio, che di niente hacreato tucto el mondo; pensandola sua sapientia infinita che contanto ordine ghorverna ognicosa; pensando la sua svisceratabontà che [per] l’uomo mortaleet pechatore ha preso carne hu-mana et in quella stentato annitrentatre in sino alla morte dellacrocie».
Pescia. Chiesa di San Michele,Rosone di facciata.

18Nebulæ / 65
Pieve a Nievole,domenica 6 ottobre 2019
All'origine della fondazione dellaCompagnia di Misericordia diPescia vi è un fatto prodigiosoavvenuto nella chiesa di SanFrancesco di questa città, il Lu-nedì dell'Angelodel 1506, che quel-l'anno cadeva il 13aprile. Quel giorno, unascultura lignea raf-figurante la Ver-gine mostrò adalcuni fedeli lì riu-niti alcuni segnimiracolosi. («Nel1506 a 13 aprilel'imagine della glo-riosissima VergineMaria posta all'al-tare della Concet-tione nella chiesadi San Francescomostrò alcuni segnimiracolosi, cheperciò nel Consi-glio generale furnocreati sei operai, che governas-sero dett'altare et amministras-sero l'offerte»), come riportanelle sue Memorie il pesciatinoFrancesco di Ottavio Galeotti,che le scrisse a quasi un secolo emezzo di distanza dall'episodio(sec. XVII).Trovandosi la detta scultura sul-l'altare della Compagnia delleDonne è pure piuttosto proba-bile che fossero proprio le con-
sorelle di questa Compagnia adessere testimoni dell'evento mi-racoloso. Il 20 aprile, una setti-mana dopo questo fatto, alcuniuomini della terra di Pescia siriunirono nella chiesa di SantoStefano per istituire «una Com-pagnia et fraternita di battuti, la
quale sia chiamata et nominata laCompagnia et fraternita dellaMisericordia della terra di Pe-scia, sotto il mantello et custodiadella regina del Cielo». Subitodopo, i detti uomini dichiara-rono lo scopo che doveva averela confraternita: confortare i po-veri afflitti, i malati e i bisognosi,oltre ai miseri giustiziati e a dareonore ai corpi defunti. Osservoincidentalmente come la chiesa
di Santo Stefano fosse, sin dal pe-riodo medioevale, la chiesa civicaper eccellenza, dove si veneravasanta Dorotea, patrona di Pescia,in stretta collaborazione con gliorganismi politici che governa-vano questa terra. Difatti, pro-prio a fianco di questa chiesa, il
canonico luccheseFranciotti accordòalla nascente con-fraternita di Miseri-cordia, con unalettera del 29 aprile,il diritto di erigereun proprio oratorio,che sarà dunque laloro prima sede. Il21 settembre 1507l'oratorio fu consa-crato dal vescovofiorentino Bene-detto Pagagnotti. Abbiamo l'elencodei nomi dei dicias-sette fondatori dellaCompagnia, oltre aquelli che via viaentrarono in senoalla confraternita
anche nei secoli successivi. Tuttii fondatori risultano essere di Pe-scia, ad eccezione di un fioren-tino, due pistoiesi e forse unlivornese. Solo in un caso è indi-cata esplicitamente la profes-sione, il fabbro, mentre di altridue suppongo fondatamente cheuno fosse medico e l'altro farma-cista. Parto da questi ultimi due:il primo è Matteo di PuccinoMainardi, il quale all'11 maggio
LE ORIGINI DELLA “MISERICORDIA”DI PESCIAdi Fabrizio Mari
Pescia. Chiesa di Santo Stefano e Niccolao.(Foto realizzata prima dei lavori di restauro)

19 Nebulæ / 65
1506 risulta far parte del Consi-glio generale, l'organismo legisla-tivo del Comune, come pure aquesta assemblea appartiene ilfarmacista Lorenzo di ser AttoPagni. Il pittore Carlo di Grazia-deo Barzi, fondatore, sarà unodei sei priori entrato in carica il1 novembre 1507. Il Barzi risul-terà eletto di nuovo priore nel1527, mentre l'anno precedenteera stato nominato uno dei quat-tro capitani di parte guelfa. Unaltro socio fondatore, il notaioGiovanni di ser Atto di PieroPagni trascrisse i primi atti fon-danti la Compagnia della Miseri-cordia. Venti anni dopo lotroviamo in qualità di uno degliufficiali sopra la guerra. Un altrosocio fondatore fu ser Girolamodi ser Iacopo di Gherardo Or-landi, in seguito eletto uno dei seipriori di Pescia. È il medesimoche vent'anni più tardi sarà no-minato uno dei due consoli delComune ed in seguito uno deidue conservatori del convento diSan Francesco. Comparirà poicome uno dei quattro ufficialisopra la Sanità e poi di nuovoconsole nel marzo 1528 e nel lu-glio 1529. Un socio che si aggiunse ben pre-sto al sodalizio caritativo pescia-tino, il 20 giugno 1506, Lucan-tonio di Francesco di LudovicoPoschi, risulterà vent'anni dopouno dei sei collegi del Comunenel marzo 1527, nello stessomese in cui, durante un Consi-glio, propose di destinare in ele-mosina nove staia di grano, pocopiù di un quintale e mezzo, ad al-cuni luoghi pii del territorio pe-sciatino, tra cui la Misericordia,affinché fossero destinate ai po-veri. L'antico affetto nei con-fronti della Misericordia di
Pescia non era evidentemente ve-nuto meno anche a più di ventianni di distanza. Analogamente ad altri enti piùmarcatamente ecclesiastici, leprincipali famiglie pesciatine in-serirono nella confraternita i pro-pri famigliari, sia per sinceradevozione religiosa sia per calco-lata opportunità sociale. Avvennecioè quel felice connubio tra ele-menti laici ed ecclesiastici localiche contribuì a rendere Pesciauna vivace realtà sociale ed eco-nomica che sarebbe durata pa-recchi secoli, e che vide, di lì apoco, nel 1519, la creazione daparte di papa Leone X della pre-positura nella antica pieve diSanta Maria.
Scorrendo le pagine delle En-trate ed Uscite dei primi registridella confraternita è possibileavere un quadro preciso dellenumerose attività svolte dai socidella Misericordia. Per incominciare, il primo ca-merlengo, cioè il tesoriere, dellaconfraternita risulta essere unmilanese, certo Giovanni dettoBriansino, altrimenti non cono-sciuto, il quale raccoglie tra tuttii diciassette soci fondatori dicias-sette lire e diciassette soldi peroffrire un cero alla Vergine che sitrova sull'altare della Compagniadelle Donne in San Francesco.Subito dopo comincia la primavera entrata, che risulta dalle ele-mosine ed accatti compiuti neigiorni 1, 2, 3, 9, 10, 17, 21, 23,24, 31 maggio 1506 presumibil-mente nel territorio di Pescia. Ri-sulta interessante notare come iconfratelli chiedessero le elemo-sine principalmente il giorno didomenica (3, 10, 17, 24, 31) e disabato (2, 9, 23), mentre una sola
volta di venerdì (1) e di giovedì(21). E credo che questo vadaprincipalmente spiegato con ilmaggior afflusso di uomini edonne nel giorno della messa do-menicale che si celebrava nellenumerose chiese pesciatine e nelgiorno di sabato, appuntamentosettimanale dedicato al mercatocittadino nella piazza centrale,luogo di scambio di prodottiagricoli ma non solo, che vedevala partecipazione anche di nume-rosi cittadini delle terre vicine.Per gli accatti del mese di giu-gno, che avvengono l'8, il 14, il22 ed il 28, segnalo che l'8 ed il22 cadevano di lunedì, mentre il14 ed il 28 di domenica. Perquelli di luglio, compiuti il 4, il 5,l'11, il 12, il 20, il 25 ed il 26 iconfratelli uscirono per le elemo-sine tre volte di sabato, tre voltedi domenica ed una sola volta dilunedì. Per quanto concerne le Uscite,sono segnate le voci in riferi-mento all'edificazione dell'orato-rio, all'acquisto degli oggettisacri necessari per le frequentiprocessioni, alle attività caritativee all'acquisto dei cataletti perl'esequie dei defunti. Segue un elenco dove si dà contodelle spese sostenute per gli am-malati ed i bisognosi. Il formula-rio usato dal tesoriere è identico,cambia di volta in volta l'importosegnato, che comunque non vamai oltre le due lire di spesa. Unavolta nominata la coppia degli in-fermieri confratelli della Miseri-cordia, si specifica appunto chela spesa è «in nelli ammalati e bi-sognosi». Non viene specificato altro, né illuogo delle cure o dell'aiuto pre-stato, né i nomi di chi ricevevaassistenza.

Nebulæ / 65 20
IL RAMO PESCIATINO DEI BENIVIENIFIORENTINI, AMICI DEL SAVONAROLA
di Michele Pappalardo
Pieve a Nievole,domenica 6 ottobre 2019
Domenico Benivieni è cono-sciuto dagli storici come uno deipiù importanti sostenitori di Gi-rolamo Savonarola.Recenti studi si impe-gnano a far luce sulla suapresenza a Pescia, dove fu“spedalingo” dell'ospedaledi Santa Maria Nuova edirettore spirituale delleMonache di San Michele.Attraverso la documenta-zione attualmente in no-stro possesso, possiamointravedere alcuni mo-menti della sua attività pe-sciatina e i suoi legami conle istituzioni e le realtà lo-cali.
Del suo rapporto con lemonache benedettine ci ri-mangono alcune letteredalle quali emerge la forzadel suo messaggio di rin-novamento spirituale emorale della società.Una lunga lettera testimo-nia i suoi legami con le co-munità di Crespole, Lan-ciole e Calamecca; altri studimettono in luce i suoi contatticon la mistica e profetessa Doro-tea.Per quanto riguarda la sua atti-vità di “spedalingo” sappiamo an-cora poco. Probabilmente otten-ne dal Comune il beneficio del-l'ospedale nel 1481, quando la-sciò l'incarico di Lettore di
Logica allo studio pisano.Sicuramente nel 1495 è ancora“spedalingo” di Santa MariaNuova; infatti in quell'anno lamagistratura fiorentina degliOtto di Guardia e Balia invia unalettera al Vicario di Pescia, Ja-
copo Bongianni, per impedireche il Comune togliesse al savo-naroliano il suo incarico. I magi-strati fiorentini sostengono che“messer Domenico ha risuscitatoet recuperato [l'ospedale] inmodo che e fructi e beni di quellosono convertiti et distribuiti in ho-nore di Dio et de' poveri di GiesùCristo”. Pertanto invitano il Vica-
rio a “lasciare vivere et morire indetto spedale messer Domenico”(La lettera è pubblicata in A.Verde, Lo studio fiorentino, IV, 3,pp. 1494-1495).La lettera lascia anche intuire chel’umanista fiorentino avesse a Pe-
scia una casa, molto pro-babilmente quella indotazione allo spedalingo.Tuttavia a motivo dei suoiincarichi fiorentini – eracanonico di San Lo-renzo –, risulta difficileche risiedesse stabilmentea Pescia.Dallo scritto non emer-gono le cause delle fermeresistenze incontrate dalBenivieni. Sappiamo sola-mente che a partire dal1502 esponenti del movi-mento savonaroliano in-contrarono a Pescia cre-scenti e violente opposi-zioni, che culminarono nel1508, quando fra Silvestroda Marradi dovette inter-rompere la sua attività dipredicatore.Dallo studio delle deliberecomunali potrebbero e-mergere gli appoggi o i le-
gami, pesciatini o fiorentini, chepermisero a Domenico Benivienidi ottenere il beneficio ospeda-liero. L'assegnazione di un inca-rico, come quello di spedalingo,poteva avvenire su raccomanda-zione di personalità influenti. Adesempio, nel 1513 Giuliano de’Medici scrisse al Comune perpresentare Francesco d'Antonio

Nebulæ / 6521
Pucci per l'incarico di SantaMaria Nuova. Le Autorità pe-sciatine rifiutarono la sua candi-datura.Anche Baldassarre Turini, nel1516, divenne spedalingo a Pe-scia su raccomandazione di Al-fonsina Orsini, cognata di papaLeone X.Ad aver presentato Dome-nico Benivieni a Pescia po-trebbero essere stati, anchequella volta, i Medici, poi-ché, almeno fino al 1491,era vicino a questa potentefamiglia, tanto da riceverneun beneficio canonicale inSan Lorenzo.
Ritengo che il savonarolianofiorentino possa essere statolegato al territorio pescia-tino anche da rapporti fami-liari.A Pescia era presente unafamiglia Benivieni, ma ladocumentazione a nostradisposizione non ci con-sente di dire con assolutacertezza se sia la stessa delfiorentino.Per l'erudito seicentescoFrancesco di Ottavio Gale-otti, la famiglia pesciatinadei Benivieni discende-rebbe da Benincasa di Bartolo-meo, proveniente da Firenze oda Crespole (F. Galeotti, Fami-glie di Pescia, Biblioteca Comu-nale di Pescia, Fondo Galeotti,1-A 103).Infatti, in una delibera del Co-mune di Pescia del 29 febbraio1408 si legge che Benincasa diBartolomeo proviene da Fi-renze; mentre un'altra deliberadel 6 settembre 1411, con laquale viene nominato “camar-lingo generale”, riporta che pro-
viene da Crespole. Lo studiosoottocentesco Francesco Inghi-rami nella sua Storia della To-scana, parlando di AntonioBenivieni, fratello di Domenicoe medico del Savonarola, so-stiene che “la famiglia Benivieniè antica di Pescia, ov’era venutada Crespoli… come apparisce dal
giornale della Comunità di Pesciadel 1411”.Una ricerca nella direzione diCrespole risulta tuttavia difficileperché i registri battesimali sonosuccessivi al XVIII secolo.Quello che sappiamo con cer-tezza è che a Firenze esisteva unafamiglia Benivieni, quella di Do-menico.
Il 15 aprile 1495, mentre Dome-nico Benivieni era spedalingo diSanta Maria Nuova e teneva i
suoi contatti epistolari con le mo-nache di San Michele, il Comunenominava il pesciatino Meo diBenincasa Benivieni “contesta-bile”militare per far fronte al pe-ricolo pisano.I Benivieni di Pescia, fino al1610, anno in cui si estinsero,erano ben inseriti nella società
locale. Rivestirono impor-tanti cariche pubbliche,erano imparentati con legrandi famiglie pesciatine,avevano uno stemma e pos-sedevano il sepolcro di fa-miglia nella chiesa di SanFrancesco.Lo stemma dei Benivieni diPescia mi sembra di parti-colare interesse: infatti cor-risponde esattamente allostemma dei Benivieni fio-rentini abitanti nel quar-tiere di San Giovanni, Vaio.Rimando la questione agliesperti di araldica.Indagini più approfonditedelle fonti archivistiche po-tranno dire di più sull'ori-gine dei Benivieni pescia-tini.
Interrogarsi sulle ragioniche condussero a Pesciauna personalità della leva-
tura del savonaroliano fiorentinoo sui suoi legami di parentela coni Benivieni pesciatini, alla finepuò comunque rimanere unaquestione di limitata importanza.In definitiva, quello che vera-mente mi appare rilevante è cheanche nel pesciatino, tra la finedel XV secolo e l’inizio del suc-cessivo, andarono diffondendosi,ad opera di alcuni savonaroliani,quelle istanze di riforma dellaChiesa e della Società che alloraanimavano il mondo cristiano.

Nebulæ / 65 22
Pieve a Nievole,domenica 6 ottobre 2019
Sulla parete del vestibolo dellaBiblioteca Capitolare di Pescia, èappesa una grande tavola in pit-tura che rappresenta ilCrocifisso con la Madda-lena ai piedi. L’opera,attribuita all’artista Albe-rigo Carlini (Vellano 28giugno 1703 - Pescia 27agosto 1775), fu ritiratadai canonici del Duomoe posta in Biblioteca nel1948; in quel periodo, in-fatti, la chiesa di santaMaria Nuova che avevariportato danni significa-tivi conseguenti al bom-bardamento del pontedel Duomo era in rico-struzione e la tavola di-pinta che fungeva daporta a protezione del-l’antico crocifisso ligneoera stata rimossa. Il ne-cessario trasferimento diquesta rara immaginesegnò l'inizio di una seriedi atti che portarono allacessazione di una glo-riosa storia di culto po-polare e di una notorietàreligiosa che si era for-mata nel corso di diversisecoli. Le tracce rimastedi quell'antico culto sono
appunto il presbiterio a cui oggisi può accedere grazie ad unaapertura laterale, protetta da uncancello, posta su via Turini. Ilpiccolo ambiente è dominatodall'altare con l'edicola barocca
che conserva il simulacro.Per comprendere l'edificio e ilrelativo culto che si venne a for-mare grazie alla preziosa statuamedievale è necessario tenerepresente i diversi passaggi co-
struttivi del monastero ela chiesa benedettina disanta Maria Nuova. Nel1948 infatti la navatadella chiesa fu smantel-lata per creare la nuovasala Simonetti, cono-sciuta ai più come “ci-nema Vox”. Nella rico-struzione però si manten-nero le mura perimetrali,la spoglia facciata e il pre-sbiterio che nella rielabo-razione si trasformò inoratorio del SS. Croci-fisso. Ma cerchiamo difare ordine per compren-dere, almeno nelle suelinee essenziali, la storiadella chiesa e quindi dellasua preziosa statua ligneache nel tempo ha cono-sciuto un incredibile de-classamento devoziona-le. La costruzione del-l’edificio ecclesiastico,come del resto di tutto ilcomplesso, fu conclusanella seconda metà delCinquecento sotto gli au-spici del proposto di Pe-scia Giuliano Cecchi che
IL CROCIFISSO DELLE BENEDETTINEDI SANTA MARIA NUOVA A PESCIA
Una devozione tutta da scopriredi Paolo Vitali
Biblioteca Capitolare di Pescia. Crocifisso con laMaddalena ai piedi, opera di Alberigo Carlini.

Nebulæ / 6523
fu ordinario della prelatura Nul-lius da 1541 al 1562. Il mona-stero fu costruito su un anticospedale trecentesco acui era annesso un benpiù antico oratorio in-titolato ai Santi Filippoe Giacomo. Il primospedalingo, eletto dalMagistrato della Co-munità di Pescia, erastato Rustichello, giàrettore della chiesa disanta Margherita aMonzone. Nell’elencodegli spedalinghi piùaccreditati si annovera,ad esempio, il celebreBaldassarre Turini, da-tario di Leone X e diClemente VII, che fueletto dal Comune ilprimo gennaio del1516; i Turini infattiabitavano a pochimetri dallo spedale euno dei maggiori bene-fici, intitolato a sanGiovanni Battista, eraappunto di loro patro-nato. I documenti atte-stano che la sequeladei rettori di santaMargherita eletti comespedalinghi dalla co-munità non fu mai in-terrotta, ed infatti ametà del secolo XVI ilsacerdote BernardinoBetti fu l’ultimo spedalingo e ilprimo cappellano delle monachebenedettine.Il 28 aprile del 1559, nel pienodella riforma tridentina, il propo-sto di Pescia convertì l’antico
spedale in monastero benedet-tino; sei monache provenientidall’altra comunità religiosa di
san Michele (posta fuori PortaLucchese) vi furono trasferiteper fondare il nuovo centro dispiritualità. In quel periodo lecase che si trovavano tra le muracittadine, “via delle tiratoie” e
l’antico oratorio, furono trasfor-mate in struttura monastica; siampliò il chiostro (attuale Piazza
del Grano) e il corpodi fabbrica divennedavvero imponenteinglobando peraltro lemura cittadine cheguardavano quell’am-pia area che oggi co-nosciamo come piazzaXX settembre. Con lacostruzione del nuovomonastero, sorto gra-zie al munifico inter-vento di importantifamiglie, si scelse ditrasferire l’antica isti-tuzione spedaliera deiSanti Giacomo e Fi-lippo nella “chiesadella Morte” posta inborgo san Furello (at-tuale Borgo della Vit-toria), di conseguenzaappunto si ampliò ilnuovo tempio e fu-rono costruite le scalein pietra a doppiarampa per accedereall’ingresso dell’edifi-cio che guarda su viasanta Maria. Nel Cin-quecento e nel secolosuccessivo, come ri-cordano le memorie,la chiesa e la piazza an-tistante furono teatrodi numerosi eventi mi-
racolosi legati ad un “preziosoCrocifisso ligneo”. Merita ricor-dare infatti che questa partico-lare immagine, che oggi puòcostituire vanto e orgoglio dellacittà, è segnalata nel catalogo
Pescia. Chiesa di santa Maria Nuova oggi Oratorio delCrocifisso. Statua lignea del secolo XIV.

delle sculture trecentesche luc-chesi. Come ho accennato prima,questo crocifisso per ben tre se-coli fu sotto l’interesse della pietàpopolare; nella mattinata del 9maggio del 1572, dalle ore 9 alleore 11, fu visto da oltre quattro-cento persone di ogni età, “muo-vere la testa e aprire gli occhi e labocca”; in seguito a questi fattiinspiegabili si ebbero scene rac-capriccianti, come quelle di al-cuni poveri indemoniati che,presentatisi davanti alla tauma-turgica immagine, dopo aver chi-nato la testa, si sentirono sollevatiper la liberazione avvenuta. Il 5luglio dell’anno successivo entròun fulmine nel campanile di que-sta chiesa, fracassando il corni-cione dell’edicola maggiore e lapietra sacra della mensa; inoltreil fulmine squarciò il confessio-nario al cui interno si trovavanoil cappellano don Francesco Ga-leotti e la suora Maria AngelaPagni. In un primo momento idue sventurati furono credutimorti ma dopo le suppliche deifedeli al Crocifisso, si rialzaronoillesi. I presenti gridarono al mi-racolo, il clero locale e il popoloannunciarono che il 5 luglio,giorno in cui la Chiesa celebrasant’Atanasio martire, sarebbestata festa per ricordare l’attoprodigioso. Le memorie nonmancano di riportare i nomi deipersonaggi più famosi che assi-stettero al miracolo, come il pro-posto di Pescia Lorenzo Turini,peraltro titolare del beneficiodella chiesa. Da questo momentoinizia una straordinaria fiorituradi eventi miracolosi e di proces-
sioni interminabili a cui pren-dono parte autorità religiose e ci-vili. Si riporta nelle cronachedell’epoca che le pareti intornoal crocifisso furono tappezzateinteramente da ex voto e si in-centivarono le funzioni liturgi-che. Nei primi giorni didicembre del 1573, ad un annoesatto dai memorabili episodiprodigiosi, la chiesa e il mona-stero furono visitati da GiovanBattista Castelli (Vescovo di Ri-
mini) il quale, nel ricordare l’al-tare maggiore, menziona il croci-fisso antico e gli ex voto, mastranamente non accenna al-l’evento della crescente pietà po-polare. Tuttavia il verbale diricognizione della Visita, benchéappunto non riservi nessuna at-tenzione agli eventi miracolosi,ricorda però il monastero e le at-tività delle monache. Il visitatoredispone la clausura e fa alzare lefinestre dei cameroni perché vi
Nebulæ / 65 24
Pescia. Chiesa di santa Maria Nuova oggi Oratorio del Crocifisso. Statualignea del secolo XIV (particolare).

sia riservatezza. Altresì ilmonaco cassinense Pla-cido Puccinelli, nelle sueMemorie di Pescia editea Milano nel 1662, ri-corda l’eccezionale fon-dazione di questo con-vento. Lo storico eru-dito, benché lontanodalla sua amata Pescia,non manca di sottoli-neare la devozione po-polare intorno al Croci-fisso; interessato a farconoscere al lettore lareligiosità del luogonatio, descrive con mol-ta circoscrizione l’imma-gine taumaturgica non-ché gli eventi che avven-nero tra la piazza e i con-venti femminili del luogo. Nelmenzionare gli episodi miraco-losi pone l’accento su un fattoinedito e cioè che il Crocifisso, supermesso del proposto, venivaportato solennemente per le viecittadine e fatto sostare nei con-venti circostanti; sicuramente lenotizie dei miracoli e della storiaintorno al monastero gli furonotrasmesse dall’erudito localeFrancesco di Ottavio Galeotti ilquale ricorda che le benedettineconservavano in una teca lo“stinco della gamba” di SantaDorotea patrona di Pescia e chedetta reliquia era stata trovata aRoma e trasferita a Pescia grazieall’intervento di Pompeo DellaBarba, medico del Papa Pio IV,il quale emise la bolla di ricono-scimento del monastero e lo“fece esente da tutti i pagamentidi decima”. Come dimostrano le
cronache del tempo, la devo-zione al Crocifisso trova la sua at-testazione di comprovata auten-ticità nell'antichità dell'oggettoligneo. Benché poco conosciuta,ancora oggi, la statua risulta unadelle opere medievali più origi-nali del territorio valdinievolino.La forma del volto, come lastessa posizione del Cristo, ri-chiama lo stile del maestro di Ca-maiore, pertanto la datazione èriferibile agli anni Venti del Tre-cento. D'estrazione lucchese, ilsimulacro, risulta di ottima qua-lità ascrivibile per tipologia ico-nografica al Cristus patiens cheproprio in questa parte del terri-torio conobbe una certa fortunanei primi cinquant'anni del se-colo XIV. Agli storici del Sei-cento, come il Puccinelli eGaleotti, la statua non dové ri-manere inosservata, tant'è che
nel menzionare la particolare sto-ria devozionale, ricorda che ilCrocifisso proveniva, secondo te-stimonianze orali, dall'antica ret-toria di santa Margherita inMonzone. Insomma è probabileche proprio nel Cinquecento inquesta opera sacra, i fedeli comele stesse monache, si ricono-scesse il forte legame spiritualetra l'antico ospedale intitolato asanta Maria Nuova e il nuovomonastero e che la statua avesseacquistato nel tempo un alto va-lore sacramentale quasi tauma-turgico. Nel novembre del 1679,a seguito di due mesi di pioggiacontinua, le acque del fiume Pe-scia si alzarono a dismisura e perscongiurare l’alluvione, il popolopesciatino e il clero decisero difare una lunga processione con ilCrocifisso; appena il simulacrofu riposto nell’edicola “si vide un
Nebulæ / 6525
Pescia. Chiesa di santa Maria Nuova oggi Sala mons. Angelo Simonetti.

raggio di sole da tanto tempo de-siderato”. Tali miracoli non rima-sero certo infruttuosi tant’è chenel maggio del 1720 fu bene-detto il nuovo altare e costruitoil nuovo fronte dell’edicola. Nelmaggio del 1753, a conclusionedei lavori, il popolo assisté ad unmiracolo davvero sorprendente:durante la celebrazione annuale,donna Elisabetta Anna Simoni di46 anni - affetta da tosse con-vulsa e ribelle - fu portata difronte alla scultura, poiché ormaiinferma, e addirittura gli fu postasul petto una benda di lino cheera stata toccata dal costato delCrocifisso. La liberazione dalmorbo fu immediata con grandesorpresa dei presenti e delle be-nedettine del convento che gri-darono al miracolo. L’eventoebbe una certa risonanza e sidette alle stampe la singolarepubblicazione del canonicoFrancesco Cheli “La Gratitudinee il trionfo”. Ovvero distinta re-lazione della miracolosa imma-gine di Gesù crocifisso di santaMaria Nova, edita a Livorno nel1762. Il 9 maggio 1767, la ricor-renza religiosa fu celebrata conmaggiore solennità, tant'è che lebenedettine concessero l'adora-zione del crocifisso per diversigiorni. Durante la funzione litur-gica suor Francesca Binda delconvento di san Giuseppe riuscìad alzarsi dalla lettiga e seguirein coro la Messa. I fatti prodi-giosi dunque si ebbero anche allapresenza del Vescovo DonatoMaria Arcangeli; in quel maggiodel 1767 le celebrazioni furonodavvero imponenti e gli eventi
religiosi si tennero in piazza perconsentire la grande partecipa-zione del popolo; la predica per-tanto fu tenuta dal Padreconventuale Giovanni Pieri. Allaprocessione parteciparono tuttele compagnie della città, i magi-strati e l'autorità civili; memora-bile fu la presenza del Vescovoche seguì tutto il percorso di pre-ghiera a piedi scalzi. Le memorieriportano che in tale occasione,al passaggio del Crocifisso, si eb-bero episodi di guarigione im-provvisa. A quel periodo risale laricostruzione della chiesa non-ché l’esecuzione della tavola di-pinta precedentemente menzio-nata. Sotto l'altare maggiore fuposta una lapide in pietra che ri-corda la ricostruzione dell'edi-cola, ad opera di Giorgio diIppolito Cassiani di Pescia. Neiprimi anni dell’Ottocento il mo-nastero benedettino fu sop-presso e il fervore devozionaledel popolo subì certamente unabattuta d’arresto. Tuttavia l'ul-
tima grande manifestazione po-polare si ebbe nel marzo del1940, quando il Vescovo AngeloSimonetti indisse per il VenerdìSanto una processione con il Si-mulacro per scongiurare l'en-trata dell'Italia nel secondoconflitto mondiale. La chiesa poirimase officiata almeno fino al1948, in quell'anno infatti si de-cise di trasformare l'aula in unasala conferenze e di erigere ilmuro tra la nuova destinazione el'antico presbiterio. La devo-zione al Crocifisso ligneo da ma-nifestazione popolare sitrasformò ben presto in un'atti-vità di preghiera privata; neglianni cinquanta del Novecento ilpiccolo ambiente sacro fu affi-dato alle cure dell'associazionelaicale “Apostolato della pre-ghiera” diretta da Caterina Ma-gnani, perdendo definitivamenteil ricordo del luogo claustrale ela devozione all'antico Crocifissodelle Monache di santa MariaNuova.
Nebulæ / 65 26
Pescia. Antico chiostro delle monache oggi piazza del Grano.

Nebulæ / 6527
INCONTRI STORICIAL PALAGIO
DA COSIMO IL VECCHIO AGIANGASTONENei giorni di Sabato 9 e Sabato16 Febbraio 2019, al Palagio, ilprof. Lo Conte ha tenuto due in-contri con la storia sulla famigliaMedici, in occasione dei 500anni dalla morte di Cosimo.
Pescia. Cattedrale di Santa Maria, ambone.
(Foto di Paolo Landi)
Pescia. Cattedrale di Santa Maria,cattedra episcopale.(Foto di Paolo Landi)
CATTEDRALE DI SANTA MARIA. PARTICOLARI DOPO IL RESTAURO

28Nebulæ / 65
TEATRO PACINI
RIQUALIFICATI SPAZI
PUBBLICITARIPer festeggiare i 30 anni di impe-gno e attività sul territorio, il 23Aprile 2019 l’Associazione ha ri-qualificato i due spazi pubblici-tari posti all’ingresso del TeatroPacini.“Pescia e il suo teatro” e “Pesciae la musica” il titolo dei pannellirealizzati grazie al contributo diVincenzo e Maria Gabriella Pace.
Il 30 Marzo 2019 è stato festeg-giato, con un Concerto al Pala-gio ed una Conviviale pressol’Hotel Villa delle Rose di Pe-scia, il 30º compleanno degli“Amici di Pescia”.
30º ANNIVERSARIO DELLA NOSTRA ASSOCIAZIONE

29 Nebulæ / 65
La gita sociale della nostra Asso-ciazione ha fatto tappa Dome-nica 6 Ottobre nell’incantevolecittà di Siena. In una bella gior-nata di sole i soci partecipantihanno potuto così ammirare ilcentro storico. Foto di grupponella splendida Piazza delCampo, famosa anche per ilPalio.
INCONTRI CON LA STORIA
PROCESSO STORICOANNO DOMINI 1339
Sabato 7 Settembre 2019 è stata organizzata dallanostra Associazione una rievocazione storica di uncaso criminale realmente accaduto a Pescia nel-l’anno 1339.In collaborazione con la Pro Loco di Serravalle Pi-stoiese e i Rioni Storici di Pescia, l’evento si è svoltonella Sala Consiliare del Palazzo del Vicario a Pe-scia, dopo una sfilata in costume lungo la PiazzaMazzini.
GITA SOCIALE A SIENADOMENICA
6 OTTOBRE 2019

30Nebulæ / 65
Il 14 Dicembre è stata presentata la stampa di Nataletratta da un’opera grafica del Maestro Dino Birindelli:“Arco tra via Sterponi e via Battisti”.
PRESENTATA AI SOCI LA STAMPA DI NATALE 2019
ARCO TRA VIA STERPONI
E VIA BATTISTI
500 ANNI DELLA DIOCESI
La Diocesi di PesciaStudi per il V centenario
Il 23 Ottobre 2019, nel prestigioso Refettorio del Conserva-torio di S. Michele, si è concluso il progetto volutodagli“Amici di Pescia” con la presentazione del volume celebrativodei 500 anni della Diocesi, realizzato con il contributo dellaFondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia.Il testo, curato da Paolo Vitali, contiene gli Atti del Convegnodi Studi che l’Associazione aveva organizzato nell’Aprile 2017.

Nebulæ / 6531

32Nebulæ / 65