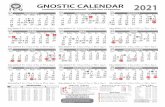Gnosis
description
Transcript of Gnosis

SERVIZIO PER LE INFORMAZIONI E LA SICUREZZA DEMOCRATICA
PER ASPERA
AD VERITATEM
RIVISTA DI INTELLIGENCE E
DI CULTURA PROFESSIONALE
N.5 maggio-agosto 1996
------------------------------ © Servizio per le informazioni e la Sicurezza Democratica ------------------------------

Anche per l'albero c'è speranza: se viene tagliato, ancora ributta
e i suoi germogli non cessano di crescere; se sotto terra invecchia la sua radice
e al suolo muore il suo tronco al sentore dell'acqua rigermoglia e mette rami come nuova pianta.
(Giobbe 14, 7-9)
------------------------------ © Servizio per le informazioni e la Sicurezza Democratica ------------------------------

INDICE
Saggi e articoli
Oscar Luigi SCALFARO - Discorso al Parlamento in occasione del 50° anniversario della Repubblica italiana Anna FERRI e Silvana LOTTI - Il Trattato di Maastricht: moneta unica e prospettive politiche future Leonardo MAZZA - La acquisizione di informazioni riservate: diritto alla privacy e diritto alla notizia Onorato SEPE - Aspetti procedurali del giudizio di responsabilità Mirko VALENTI - Gli organismi d'intelligence: idee per un progetto per il futuro
Documentazione di interesse
Senato della Repubblica - XIII Legislatura - Resoconto sommario del programma di Governo presentato il 22 maggio 1996 dal Presidente del Consiglio dei Ministri Prof. Romano PRODI Comitato Parlamentare per i Servizi di informazione e sicurezza e per il segreto di Stato. - Relazione sui documenti trasmessi dalla Procura della Repubblica di Milano. Rilievi e valutazioni Commissione Diocesana "Giustizia e Pace - - Diocesi di Milano" - Autonomie regionali e federalismo solidale Relazione generale sulla situazione economica del Paese (1995). - L'evoluzione dell'economia nel 1995 Camera dei Deputati - XII Legislatura - Proposta di Legge n. 842 "Norme in materia di informazione e sicurezza dello Stato, di segreto di Stato, di informazioni classificate" presentata dagli On.li DORIGO, COSSUTTA ed altri Senato della Repubblica - XII Legislatura - Disegno di Legge n. 437 "Nuove norme in materia di istituzione e ordinamento dei servizi per le informazioni e la sicurezza e disciplina del segreto di Stato" presentato dai Sen. DE NOTARIS, RONCHI ed altri Senato della Repubblica - XII Legislatura - Disegno di Legge n. 812 "Nuovo ordinamento dei servizi di informazione per la sicurezza e disciplina del segreto di Stato" d'iniziativa del Sen. RAMPONI
Normativa e giurisprudenza di interesse
Decreto Legislativo 12 febbraio 1993 n. 39 Tribunale di Madrid (Spagna) - Sentenza 6 febbraio 1996
I Servizi di informazione e sicurezza degli altri Paesi
Stati Uniti: Central Intelligence Agency
Recensioni e segnalazioni bibliografiche
Giorgio BOATTI - Enciclopedia delle spie William COLBY and Peter FORBATH - La mia vita nella CIA Emilio Raffaele PAPA - Discorso sul federalismo Carlo SARZANA di S.IPPOLITO - L'uso della realtà virtuale e dei sistemi multimediali nel processo penale Le Monde du Reinsegnement - Riforma non traumatica dell'intelligence USA International Herald Tribune - Le riforme dell'Intelligence Le Monde du Reinsegnement - USA: Informazione economica e competitiva
Notizie sui collaboratori
------------------------------ © Servizio per le informazioni e la Sicurezza Democratica ------------------------------

CONTENTS
Essays and articles
Oscar Luigi SCALFARO - Speech before Parliament for the 50th Anniversary of the Italian Republic Anna FERRI e Silvana LOTTI - The Maastricht Treaty: single currency and future political implications Leonardo MAZZA - Gathering confidential information: right to privacy and right to information Onorato SEPE - Procedural aspects of the responsiblity judgement Mirko VALENTI - Intelligence bodies: ideas for a project for the future
Documents of interest
Senate - XIII th Parliament - Summary of the Government programme presented by Prime Minister Romano PRODI on 22nd May 1996. Parliamentary Oversight Committee on the Intelligence and Security Services and on State Secrecy. - Report on the documents transmitted by the Milan Prosecutor's office. Remarks and assessment. Diocesan committee "Justice and Peace" - Milan Diocese - Regional authonomy and a federalism in the spirit of solidarity. General report on the national economic situation (1995). - Economic developments in 1995. Chamber of Deputies - XIIth Parliament - Bill n. 842 "Provisions on national Intelligence and Security, on State secrecy and classified information" by Deputies DORIGO, COSSUTTA and others Senate - XIIth Parliament - Bill n.437 "New provisions on the establishment and regulations of Intelligence and Security Services and the discipline of State secrecy" by Senators DE NOTARIS, RONCHI and others Senate - XIIth Parliament - Bill n.812 "New provisions on the Intelligence and Security Services and the discipline of State secrecy" by Sen. RAMPONI.
Legislation and jurisprudence
Legislative Decree n.39 of 12.02.1993 Kingdom of Spain: Court of Madrid: Judgement of 6th February 1996
Other Countries Intelligence and Security Services
United States of America: the Central Intelligence Agency.
Reviews and bibliographic recommendations
Giorgio BOATTI - Enciclopedia delle spie William COLBY and Peter FORBATH - La mia vita nella CIA Emilio Raffaele PAPA - Discorso sul federalismo Carlo SARZANA di S.IPPOLITO - L'uso della realtà virtuale e dei sistemi multimediali nel processo penale Le Monde du Reinsegnement - Riforma non traumatica dell'intelligence USA International Herald Tribune - Le riforme dell'Intelligence Le Monde du Reinsegnement - USA: Informazione economica e competitiva
News on our collaborators
------------------------------ © Servizio per le informazioni e la Sicurezza Democratica ------------------------------

Oscar Luigi SCALFARO - Discorso al Parlamento in occasione del 50° anniversario della Repubblica italiana
Onorevoli Presidenti della Camera e del Senato, un grazie e un saluto. E un saluto caloroso a voi tutti qui presenti - tutti! - in particolare ai Costituenti, qui presenti o che ci ascoltano da lontano. Un saluto a chi è in ascolto in Patria e a chi è in ascolto all'estero, agli italiani all'estero. Con un pensiero di riconoscenza a tutti: a tutto il popolo italiano, che in questi cinquant'anni ha operato, e opera, con sacrificio e con amore, qui tra noi e in tante parti, italiani, nel mondo, sempre per l'Italia... Sempre per l'Italia! 2 giugno 1946 - il popolo italiano, con voto libero, personale, segreto, a suffragio universale votando anche le donne (conquista di civiltà che si era espressa la prima volta nel precedente marzo per far risorgere i liberi comuni), il popolo italiano ha scelto, come forma istituzionale dello Stato, la Repubblica. Nello stesso giorno ha eletto l'Assemblea Costituente. Era come il tirar delle somme di oltre due decenni di dittatura fascista, di cinque anni di guerra distruttrice di uomini e di cose e di due anni di lotta di liberazione. Si giungeva così al primo traguardo. Dentro quei tre grandi e tremendi eventi, violazioni di libertà e sofferenze di ogni genere: il no alla libera espressione del pensiero, i tribunali speciali, carceri, confino, esilio e infinite grandi e piccole, note e ignote eroiche resistenze alla dittatura. La libertà ha sempre un prezzo e chi vi crede deve pagarlo ogni giorno; e se pochi sono disposti a pagarlo, il prezzo per costoro diventa altissimo, quasi insostenibile. Quanti caddero per via senza poter godere dell'alba della libertà! Allora furono in molti a credere davvero nei valori essenziali e negli ideali per i quali fu eroico il vivere e dovere il morire. Ma il 2 giugno fu risurrezione: la Patria risorge, sceglie una forma di Stato nuova che ha radici antiche nella nostra storia; dalle Repubbliche marinare gloriose e potenti, alla Repubblica Romana, che nel suo Statuto proclamò libertà e fratellanza. Gli eletti iniziarono a scrivere la Carta Costituzionale, il nuovo patto che unisce il Popolo, ogni cittadino alla Patria, diventata Stato democratico fondato sui diritti della persona umana, diritti riconquistati per tutti da chi non chiese sconto alcuno sull'altissimo prezzo. L'animo ripensa a quel clima di nuovo, a quella volontà di ricominciare, di ricostruire, di tornare a vivere. Il contrasto tra il nostro spirito pieno di speranza e la realtà che ci circondava era aspro e capace di sgomento; città distrutte, comunicazioni annientate, migliaia e migliaia di persone stroncate e molte ancor più annientate nello spirito, anche se tornate vive da prigionie inumane. Sulle macerie, la libertà riconquistata accendeva negli animi entusiasmo, voglia di lavorare, di recuperare. Avevamo tante ferite sanguinanti e, prima fra tutte, la divisione tra italiani, ultima tragica eredità della dittatura: i fratelli hanno ucciso i fratelli. Dopo cinquant'anni, la storia non può mutare, né il mutarla può essere fonte di pacificazione; la storia prosegue e scrive, e deve scrivere altre pagine. Se fossimo capaci di porre la parola "fine" a diatribe, a polemiche che, molte volte hanno turbato gli animi e scavato divisioni nel nostro popolo! Se fossimo capaci... ma lo siamo capaci, se lo vogliamo davvero. Nelle molteplici celebrazioni dei 50 anni della Resistenza ho ripetuto sempre parole e auspici di pacificazione. È un processo, quello della pacificazione, che ha fatto già molta strada, ma per concludersi deve poggiare su termini semplici e veri. Anzitutto nessuno vuole, nessuno può mutare la storia, e fu storia il no alla libertà, alla vita democratica violando i diritti essenziali della persona umana.
------------------------------ © Servizio per le informazioni e la Sicurezza Democratica ------------------------------

Fu storia l'eroismo, e ne esprimiamo riconoscenza, di chi non cedette alla violenza di ogni genere in nome della fede nella libertà. Né può mutarsi la valutazione dei fatti storici che non consente di porre sullo stesso piano chi ha lottato per la dignità e la libertà dell'uomo e chi ha combattuto sulla sponda opposta. La Pace è figlia della verità, della chiarezza. Ma guardiamo, tutti insieme, guardiamo con rispetto a chi lottò comunque in buona fede, con la retta convinzione di combattere per la Patria; e chiniamo il capo alla memoria di coloro che sacrificarono la vita nella serena coscienza di adempiere a un sacro dovere. Ripeto le parole che il Poeta rivolgeva al Re spentosi a Oporto: "Ora, Signore, anch'egli è morto, come noi morimmo, Dio, per l'Italia". In questa pagina di pacificazione non si può non imbattersi in altra questione, che vorrei il Parlamento esaminasse per vedere se non sia, come a me pare, e come mi parve e scrissi quando ero Ministro dell'Interno, "ormai idonea a soluzione": mi riferisco alla tredicesima disposizione transitoria della Costituzione, in relazione al divieto per i successori maschi dei Savoia di entrare in Italia. Anche qui non si vuole mutare né turbare la storia, ma solo affrontare questo problema con una visione, il più possibile giuridicamente attuale e, soprattutto, umana. Veda il Parlamento quale possa essere oggi, dopo quasi cinquant'anni, la validità, l'efficacia di questa norma. Di fronte alla Repubblica, universalmente accettata dal popolo italiano, decida il Parlamento. La Repubblica, certo, non ha timori... la Repubblica, certo, non ha timori! Fra otto giorni, il 10 giugno, saranno cinquantasei anni dalla dichiarazione dell'ultima guerra: una vera pacificazione può cancellare le conseguenze che possono essere cancellate, poiché ve ne è molte che nessuno potrà cancellare mai! La più valida conclusione è quella di rendere sempre attuali le parole icastiche che la Costituzione esprime con efficacia all'articolo 11: L'Italia ripudia la guerra. Questa mattina un Cappellano militare, decorato di medaglia d'oro, ci ha fatto pregare per i Caduti di tutte le guerre e di tutti i fronti. Da Costoro, che pagarono il prezzo più alto, esce per noi un solenne e impegnativo invito alla Pace. Non penso sia mio compito un esame storico di questi 50 anni. Mi fermo sinteticamente su momenti qualificanti del passato per poi esaminare qualche problema presente. • Anzitutto nel contesto internazionale la scelta di alleanza con i popoli liberi, a cominciare dagli Stati Uniti d'America, fu scelta di pace e portò ad anni di pace. • Il sogno di un'Europa unita divenne volontà politica e iniziò con tanto entusiasmo il viaggio che ancora oggi ci trova fortemente impegnati. • Il grave pericolo sovietico, che fu ben più che minaccia in tanti momenti e in tante parti del mondo, fu così contenuto con decisione ed efficacia, e fu Pace. • Vivaci scontri politici e sociali trovarono nello Stato democratico fermezza e capacità di dialogo e portarono a trasformazioni considerevoli con sensibile elevazione delle condizioni di vita del nostro popolo. La vita economica si estese dai grandi centri e si moltiplicò nelle città e nei paesi, con una potenza vitale e una creatività senza pari. Grande lode ai coraggiosi che seppero rischiare, moltiplicando lavoro e benessere. Grande lode alle migliaia di lavoratori, impegnati nella mirabile ripresa del nostro popolo. • I Sindacati, usciti dalla clandestinità, iniziarono e condussero un dialogo, a volte assai aspro, ma sempre indispensabile alla vita democratica. • Non si vinse il pesante divario tra Nord e Sud, malgrado grandi impegni di mezzi, e oggi si deve constatare, con preoccupazione, che il divario, la distanza, lo squilibrio sono di gran lunga accentuati. Questa è piaga grave che richiede intervento saggio e forte dello Stato. • Quante realizzazioni in 50 anni di democrazia, quanta strada percorsa sostanzialmente insieme anche tra posizioni assai dialettiche e, a volte, marcatamente e vivacemente contrapposte! • La proclamazione dei diritti inviolabili dell'uomo, sancita nella nostra Costituzione, ebbe fedele applicazione: la libertà fu affermata e difesa. Ma due mali gravi hanno colpito la nostra vita democratica in questi cinquant'anni:
------------------------------ © Servizio per le informazioni e la Sicurezza Democratica ------------------------------

il terrorismo, aggressione sanguinaria all'ordinamento dello Stato; la corruzione, che minava dall'interno lo Stato e ne feriva gravemente la fiducia dei cittadini. Il terrorismo non portava con sé finalità di arricchimento, ma mirava ad abbattere lo Stato contrapponendogli visioni e fini troppe volte quasi deliranti; un no allo Stato attuato con violenza indiscriminata che ha fatto delitti innumerevoli e fini a se stessi, irrazionali e crudeli. All'inizio, non tutti si schierarono per lo Stato e contro gli aggressori dello Stato: e fu scelta senza né princìpi, né dignità; poi si generò una solidarietà sentita ed efficace e divenne solidarietà di popolo; fu questa che donò forza allo Stato per vincere la difficile prova. Oggi si può ben dire che dopo le armi si sono arresi gli animi, e la quasi totalità dei responsabili, con le parole, o più ancora con la vita, hanno riconosciuto l'errore e il male. Leggo cosa scrive un giovane di quella terribile stagione che ha già scontato, e sta scontando, molti anni della sua lunga pena: "Ciò che rimane di quel periodo, soprattutto nella mente di chi volente o nolente, lo ha vissuto in prima persona, sono i lutti, le inutili morti in nome di una rivoluzione politica impossibile e fuori della storia". E prosegue: "Rimane il fallimento di tanti giovani (presuntuosi) che anche attraverso la riflessione in carcere si sono resi conto di avere sbagliato tutto: il fine non giustifica i mezzi, né viceversa". Qui finisce il breve stralcio di un lungo e considerevole scritto. Con il passare degli anni il delitto non muta né nome, né sostanza e la giustizia verso le vittime, e chi ne ha sofferto e ne soffre, merita rispetto; ma lo Stato democratico se vuol essere ricco di umanità non può non fermarsi per cercare una via che non abbia i caratteri della generalità, ma valutando con intensa cura le singole situazioni, sia idonea a tutelare quei diritti, senza mai spegnere la speranza. Altrettanto grave, di una gravità più corrosiva del tessuto dello Stato, la corruzione. Straripamento di competenze da parte dei partiti politici, prevaricazioni, sete di ricchezza, ubriacatura di potere, sono alla base di questa degenerazione che ha duramente ferito la coscienza democratica del nostro popolo allontanandolo dalle Istituzioni. Occorrono, a mio avviso, due precisazioni: Anzitutto è vero che con i colpevoli sono stati travolti non pochi del tutto innocenti. Questo è oggettivamente male, perché ingiusto; persone ferite in ciò che hanno di più geloso, la propria onorabilità, gettati in pasto alla pubblica opinione ignara, - presentati come colpevoli, a volte arrestati, poi dichiarati innocenti; uomini politici raggiunti da avvisi di garanzia il cui processo dopo mesi e mesi giace senza una decisione di colpevolezza o di assoluzione. Non può chiamarsi giustizia. Ma non può mancare l'elogio e il grazie a quei Magistrati che, sereni e giusti, hanno accertato abusi gravi e chiamato i responsabili a risponderne. È stato ed è servizio alla giustizia, è servizio alla stessa democrazia. Inoltre, mi pare opportuno tornare a volgere attenzione al delicato, ma indispensabile problema della vita dei partiti, dei movimenti politici. In passato, per reagire giustamente a gravi degenerazioni e a inammissibili compromessi, fu stabilita tra l'altro, per legge, l'illiceità, salvo limiti assai ristretti, del sovvenzionamento ai partiti. Ora il problema è di salvaguardare la libertà e la trasparenza della vita politica, condizioni essenziali di fiducia; esclusione quindi di ogni legame con interessi di parte, di categoria e di gruppi, interessi che condizionano in modo illecito, i doveri e la responsabilità dell'eletto dal Popolo. Il problema è di consentire ai partiti, ai movimenti politici, di svolgere il proprio compito senza compromissioni o sotterfugi; il problema è che senza questa mediazione tra i cittadini e le Istituzioni, la democrazia rischia seriamente la sua essenza pluralistica del tutto vitale ed essenziale. Il cittadino deve essere tranquillo sulla linearità, trasparenza, correttezza della vita democratica; deve poter leggere senza fatica non solo l'esterno, ma l'interno dello svolgersi, del muoversi di ogni organismo necessario alla vita dello Stato democratico. Una grande bufera ha largamente mutato la classe politica a cominciare dal 1992.
------------------------------ © Servizio per le informazioni e la Sicurezza Democratica ------------------------------

Questo non breve e faticoso periodo di transizione ha mutato assetti politici, ha fatto sorgere nuovi movimenti, ha reso particolarmente viva, e a volte assai accesa, la dialettica politica. Ha costretto per motivi diversi a due successivi scioglimenti del Parlamento ogni volta dopo due anni di vita, e anche di intensa e meritoria attività delle due Assemblee legislative. Vi sono dunque situazioni di malessere che è doveroso enunciare per poterle affrontare con determinazione. Emergono sempre più vive e motivate le richieste di autonomia e di federalismo, di abbattere una concezione centralistica dello Stato. Le diverse Regioni e i cittadini stessi chiedono che si riconosca loro il diritto di sostanziale autonomia per assumersi responsabilità dirette e poterne rispondere. L'affermazione regionalistica nella nostra Carta Costituzionale non nasce dalla negazione dell'unità del popolo e dello Stato, ma nel pensiero dei Costituenti, regionalismo è anzitutto un no severo e motivato all'accentramento del potere, e una rivendicazione di veder riconosciuta la identità e con essa la dignità stessa delle diverse Regioni dell'Italia, ciascuna ricca di forze vitali, di energie diverse, di caratteristiche peculiari. Nacque la Regione, ma poco maturò una coscienza regionale, un sentirsi regione e cittadini della propria Regione. L'autonomia fu parziale e molte volte finì per presentarsi al cittadino come una moltiplicazione di istituzioni e di uffici, come una complicazione anziché, come era negli auspici, una semplificazione a vantaggio dei cittadini stessi. Il tema federalista, la questione del decentramento ci richiama a quanto i Costituenti hanno precisato senza equivoci all'articolo 5 della Costituzione in riferimento alle autonomie locali. In quell'articolo, non certo a caso, si ripete la impegnativa formula dell'articolo 2: "La Repubblica, una e indivisibile, riconosce ... la Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali", confermando l'indiscusso presupposto dell'unità nazionale e la preesistenza del diritto all'autonomia, che non è certamente, né lo potrebbe, concessione o elargizione dello Stato. Ma questo richiamo deve farci concentrare l'attenzione sui Comuni, non dimenticando le Provincie. L'Italia è patria dei Comuni, e i Comuni sono naturalmente vivi e sentiti nella vita del nostro Popolo, nella vita di ogni cittadino. Una visione ampia, completa, della riforma deve impegnarsi a dare pienezza di vitalità a questa autonomia che rimane punto vitale di equilibrata organizzazione dello Stato. È anche necessario il rapporto Stato-Comuni, Provincie, Stato-Autonomie locali, ma è indispensabile che sia armonizzato nel rapporto Stato-Regioni; ed è opportuno che, negato il centralismo statale, si garantiscano gli enti locali anche dal possibile centralismo regionale, egualmente dannoso per ogni autonomia. È questa una grande pagina della annunziata più ampia, Riforma dello Stato, che nelle discussioni, nei pregevoli studi e lavori parlamentari, ha toccato il sistema bicamerale, ha toccato la stabilità governativa, ha toccato una diversa struttura della Presidenza della Repubblica; ma ha confermato, pressoché in modo unanime, la difesa delle prerogative del Parlamento, suprema espressione della Sovranità Popolare. Riforma più volte affrontata e studiata, ma che ancora non ha trovato la necessaria volontà politica per essere attuata. E la volontà politica non può essere di una parte sola, anche maggioritaria, del Parlamento; non tanto perché norme costituzionali richiedono maggioranze diverse e maggiori per mutare la Costituzione, ma soprattutto perché la Riforma della Carta Costituzionale deve poter nascere, come fu nel 1948 per la Costituzione, da una volontà corale che consenta ad ogni cittadino di riconoscersi in quel documento fondamentale per la vita del Popolo Italiano. Questa volontà politica costituisce la prova di volere davvero scrivere pagine nuove nella nostra Costituzione. Mi fermo alla enunciazione, poiché, ripeto, è compito, è competenza del Parlamento, di tutte le forze politiche presenti nel Parlamento, nessuna esclusa. E non si può ancora attendere, né sarebbe valida una risposta generica; la risposta deve essere chiara, lineare, razionale ed efficace. Questa pagina di largo respiro democratico deve essere scritta e attuata e vissuta; deve saper fare sintesi tra una autonomia vera e vitale e l'Unità nazionale condizione essenziale e preesistente allo stesso dettato
------------------------------ © Servizio per le informazioni e la Sicurezza Democratica ------------------------------

Costituzionale. Unità nazionale, che è soprattutto unità di popolo, condivisione di speranze e di sacrifici, di conquiste e di sconfitte. Unità che questo nostro popolo sa affermare e rendere intoccabile. Ma non basta. È doveroso constatare con serena obiettività che, specie in particolari momenti, la fiducia del cittadino nello Stato va affievolendosi, e rischia di mutarsi in protesta, in ribellione. Ho già parlato di casi gravi di corruzione, che non lasciano indenni i settori più delicati della vita dello Stato. Ma desidero qui sottolineare l'antica e non risolta questione, peraltro vitale, del rapporto Cittadino-Stato. E' ancora alquanto raro, se non eccezionale, il dialogo tra cittadino e Stato, un dialogo aperto e fiducioso. In tante occasioni, in tanti rapporti, l'Amministrazione dello Stato si comporta come chi non crede nelle dichiarazioni rese dal cittadino; e il cittadino è immediatamente, di fronte all'Amministrazione pubblica, in posizione di difesa, a volte legittima, a volte no. Non si tratta in genere di cittadini ribelli al concetto stesso di Stato; si tratta piuttosto di chi teme, nello Stato, nei suoi uffici, di non trovare voce amica e comprensiva, e risponde con diffidenza, come chi sospetta quasi di esserne raggirato. Sono passati decenni da quando la voce autorevole di De Gasperi e il severo richiamo di Vanoni proponevano un rapporto di limpida schiettezza, di lealtà, di collaborazione. Bisogna lavorare con intensità perché questo rapporto si ricostruisca. Occorre coraggio per una semplificazione indispensabile dei rapporti, per una limpidità accessibile, una disponibilità delle amministrazioni pubbliche la più ampia, per essere in grado di servire il cittadino, di servirlo davvero, perché senta che lo Stato è la casa comune. Ho il dovere di aggiungere che queste considerazioni, queste constatazioni, nulla tolgono ai meriti di migliaia di dirigenti, di dipendenti fino ai più umili, che consumano trentacinque, quaranta e più anni negli uffici pubblici con sacrificio, con puntualità, con onestà e tante volte senza una parola di gratitudine. Costoro troppe volte sono piuttosto vittime di procedure defatiganti, di adempimenti eccessivi o poco comprensibili. L'altra tremenda questione è una concentrazione di umana sofferenza ed è un richiamo sostanziale di giustizia: la disoccupazione. Scendendo dal Nord all'estremo Sud, la percentuale sale in modo preoccupante: il 10, il 20, il 55... il 66 per cento per le donne in Sicilia! L'ho constatato qualche settimana fa. Ognuno sa che è piaga della società di oggi, che è piaga dell'Europa... Se ne discute in ogni incontro internazionale ed è tema all'ordine del giorno dei paesi più industrializzati (G7). Ma quando la piaga invade più della metà del corpo... si teme per la vita! Qui, prima che impegno politico e sociale, prima che programma politico, qui è la coscienza umana che non può, non vuole non deve trovare pace, se non si è fatto tutto il possibile e l'impossibile per affrontare un problema che coincide con la dignità della persona umana. La grave questione diventa gravissima quando si considera la situazione dei giovani. Dico a voi del Parlamento, a voi del Governo, a voi responsabili dell'economia e della finanza: non possiamo, assolutamente non dobbiamo, spegnere nei giovani la speranza. Guai a noi! Non si tratta di rispondere domani o doman l'altro alla storia, si tratta di rispondere oggi, di rispondere adesso alla nostra coscienza e a chi, parte del nostro popolo, soffre e ancora attende. Si aggiunga l'incubo della criminalità organizzata che può fare proseliti tra giovani disperati. Della criminalità non ho parlato perché è totalmente alla attenzione dello Stato che non risparmia impegno e sacrifici. Quante vittime e quanti delitti! Lo Stato, con la Magistratura, le forze dell'ordine, con le forze armate a presidio territoriale, ha risposto come non mai a questa invasione di potere illegittimo e violento, ha scoperto colpevoli, ha colpito connivenze, ha moltiplicato la sua presenza vigile ed efficace. La strada è irta di difficoltà: i silenzi, le compromissioni, i pentiti che sono di aiuto, ma possono anche volersi servire dello Stato per le loro vendette, le difficoltà negli uffici giudiziari e per gli stessi avvocati, sono tutti ostacoli da superare con volontà ferma e determinazione. Occorre mettere la popolazione in condizioni di liberarsi da motivate paure e da antichi pregiudizi per
------------------------------ © Servizio per le informazioni e la Sicurezza Democratica ------------------------------

schierarsi compatta con chi lotta senza tregua per liberare il nostro paese da questo male sanguinario e degradante. Solo citando le maggiori questioni, che sono aperte davanti a noi all'inizio dei secondi cinquant'anni, si vede che c'è lavoro per tutti: per il Capo dello Stato, per il Parlamento, per il Governo, per le Regioni, per gli Enti locali che attendono, specie i Comuni, i Sindaci di poter avere i mezzi per i compiti che la legge a loro riconosce e impone. C'è lavoro per tutti, privati e pubblici. E' parso che la Politica avesse lasciato il passo all'azione della Magistratura e che diventasse sempre più difficile il dialogo e la collaborazione tra i poteri dello Stato. E' indispensabile che la Politica riprenda il suo spazio, la sua alta responsabilità, non sostituibile altrimenti, senza creare una seria patologia nella vita dello Stato. E' altrettanto indispensabile che i poteri dello Stato siano tra loro coordinati, collaborativi, in perfetta armonia, ciascuno libero e responsabile nel proprio settore di competenza e tutti a servizio del bene comune, del bene del popolo che interpretano, rappresentano e nel cui nome operano. Sì, è necessario che la politica riprenda lo spazio che le compete. La POLITICA, tutto maiuscolo, quella che è arte per i greci, è servizio per i cristiani, è totale disponibilità per il bene del Popolo, per chiunque creda nel dovere di donare intelligenza e cuore alla Comunità di cui fa parte.
* * * Mi rivolgo ancora una volta a tutti voi, qui presenti o che ascoltate da lontano. Ho pensato che la più fedele celebrazione di questo primo cinquantennio della nostra Repubblica richiedesse un esame responsabile per riprendere la strada affrontando le questioni più ardue, più urgenti, più attese, più dovute secondo giustizia. Sappiamo tutti che vi sono temi che richiedono, per essere risolti, una quasi unanimità di intenti e di volontà politica. Sono i temi che più direttamente attengono alla Persona Umana e quindi alla famiglia, ai giovani, alla scuola, al lavoro; e quelli che sono vita per tutto il nostro popolo: la sicurezza, la certezza del diritto, la integrità e la dignità della Patria comune, la Pace. Riprendiamo il cammino nelle diverse responsabilità, nella vitale dialettica con la pluralità di convinzioni filosofiche, politiche, sociali, religiose, ma tutti tendenti al maggior bene del nostro Popolo. Incontreremo difficoltà, ostacoli, fatiche. In questi 50 anni le difficoltà e le fatiche non furono né poche né piccole: una grande fede nella libertà ci ha sostenuti, il servizio all'uomo, specie a quello che più soffre, ci ha sospinti. Se saremo uniti, e metteremo in comune soprattutto le avversità, il cammino sarà meno aspro. In passato i nostri Maggiori pagarono di persona. Ora ascoltiamo: "La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale". E' l'articolo 2 della Costituzione, che in quest'Aula anche io, giovanissimo, votai con gli altri. Se giuriamo di viverlo a qualsiasi costo, ce n'è a sufficienza per servire degnamente il popolo italiano per il prossimo cinquantennio! Grazie!
------------------------------ © Servizio per le informazioni e la Sicurezza Democratica ------------------------------

Anna FERRI e Silvana LOTTI - Il Trattato di Maastricht: moneta unica e prospettive politiche future
1. Premessa Il presente articolo si pone l'obiettivo di fornire un quadro, che non ha la pretesa di essere esaustivo, del processo che ha portato alla creazione e allo sviluppo dell'Unione europea, affrontando al contempo le problematiche, di notevole portata, che attualmente vengono poste all'attenzione dell'opinione pubblica europea e in particolare italiana - considerato che fino al giugno del corrente anno la Presidenza del Consiglio dei Ministri dell'Unione è stata affidata al governo del nostro paese - anche in relazione all'avvio della Conferenza intergovernativa dei Capi di Stato e di Governo degli Stati dell'Unione. Si tenterà inoltre di definire, in via del tutto generale, quali sono le principali sfide che gli Stati dell'Unione dovranno affrontare per consentire la realizzazione degli "Stati Uniti d'Europa", obiettivo - in parte previsto dallo stesso Trattato di Maastricht - senza dubbio ambizioso e tale da richiedere non solo un superamento, o meglio, un ampliamento del progetto politico previsto dal trattato stesso, bensì l'acquisizione da parte di tutti i "cittadini europei" di una maggiore consapevolezza della sua rilevanza anche attraverso una nuova e reale adesione all'ideale europeista.
2. Nascita e sviluppo dell'Unione Europea Le origini del processo che ha portato gradualmente alla creazione della comunità europea vanno individuate nella situazione politica ed economica internazionale esistente alla fine della seconda guerra mondiale. L'Europa cessava di costituire il centro nevralgico della politica internazionale avendo, tra l'altro, perso il ruolo di potenza coloniale, e risultava chiara la divisione del mondo in due blocchi, uno strettamente legato, sia sul piano politico che economico, agli Stati Uniti e l'altro sotto il controllo dell'URSS. In questo nuovo scenario politico si inserivano le problematiche di carattere economico dell'Europa rappresentate principalmente dalla necessità di procedere alla ricostruzione industriale post-bellica e, più in generale, di sanare il dissesto economico che investiva i paesi vinti così come quelli vincitori. La costituzione di organizzazioni internazionali come le Nazioni Unite, il GATT, la BIRS, il FMI e l'elaborazione dello stesso Piano Marshall furono finalizzate proprio alla creazione di condizioni favorevoli alla ripresa degli scambi commerciali internazionali, al raggiungimento di una nuova stabilità monetaria internazionale, a fornire strumenti di aiuto e sostegno allo sviluppo. Nel 1948 nacque l'OECE proprio al fine di gestire i fondi del Piano Marshall destinati alla ricostruzione dell'Europa, trasformata, nel 1951, nell'OCSE a cui aderirono, in un quadro di più ampia collaborazione extraeuropea, anche gli Stati Uniti, il Canada e il Giappone. Nel 1954 fu costituita la UEO, nell'ambito della quale gli Stati aderenti (Francia, Germania, Italia, Belgio, Paesi Bassi, Lussemburgo e Gran Bretagna) si impegnavano a collaborare in campo politico e militare. Nel 1959, nell'ambito del Consiglio d'Europa, gli Stati aderenti si impegnavano invece a favorire una più stretta unione politica, economica, culturale e sociale dei paesi europei. Accanto alle problematiche di carattere economico, in Europa veniva avvertita in maniera pressante anche la necessità di realizzare un'unione di carattere politico-federale. Gli Stati Uniti, dal canto loro, assunsero un atteggiamento di estremo favore verso la creazione di un'Europa occidentale forte e unita sia sul piano politico che economico, in quanto questa avrebbe costituito una maggiore garanzia della capacità di far fronte sia alle pressioni esterne provenienti dal blocco sovietico che interne derivanti dai partiti comunisti nazionali. In questo contesto si inserì la dichiarazione del Ministro degli Esteri francese Robert Schuman, il 9 maggio 1950, il quale sostenne la necessità, per la salvaguardia della pace mondiale, di avviare concrete iniziative finalizzate a mettere in comune le principali materie prime strategiche dell'Europa, ossia il carbone e
------------------------------ © Servizio per le informazioni e la Sicurezza Democratica ------------------------------

l'acciaio. Questa proposta avrebbe potuto costituire un valido strumento per risolvere il problema franco-tedesco, legato da una parte all'annosa rivalità tra questi due paesi e dall'altra a quello delle limitazioni alla sovranità tedesca, stabilite a conclusione della guerra, concernenti in particolare il disarmo imposto alla Germania che si rifletteva soprattutto sulla possibilità di procedere alla ricostruzione dell'industria pesante tedesca. Si pensò quindi di sottoporre quest'ultima al controllo di un ente internazionale, senza che ciò costituisse una misura punitiva ai danni di un paese sconfitto in quanto il medesimo controllo o, per meglio dire, "messa in comune" delle risorse, avrebbe coinvolto anche altri paesi europei. Fu quindi firmato a Parigi il 18 aprile 1951 il trattato istitutivo della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio (CECA), al quale aderirono oltre alla Francia e alla Germania, anche Italia, Belgio, Paesi Bassi e Lussemburgo (questi ultimi tre già costituenti il BENELUX). L'adesione alla CECA comportò l'impegno da parte dei paesi membri ad accettare limitazioni alla propria sovranità nazionale nell'ambito del settore carbosiderurgico, che venne sottratto al controllo dei governi nazionali, per essere affidato totalmente all'ente comunitario. I risultati derivanti dalla creazione di questo mercato comune settoriale furono talmente inaspettati da spingere i paesi aderenti ad ampliare tale tipo di collaborazione anche ad altri campi. Dopo il fallimento del tentativo di creare una comunità a scopi di difesa (CED) e la conseguente battuta di arresto nel processo di integrazione europea, il 25 marzo 1957 vennero firmati a Roma i trattati istitutivi della Comunità Economica Europea (CEE) e della Comunità Europea per l'Energia Atomica, più nota come EURATOM. Alla luce delle scelte sia sotto il profilo istituzionale che delle competenze che vennero operate con il trattato di Roma, si può dire che prevalse sulla tesi federalista quella "funzionalista" secondo la quale il processo di integrazione economica e politica doveva avvenire gradualmente e spontaneamente. La creazione di queste comunità fu finalizzata a realizzare un'integrazione progressiva dei mercati degli Stati membri e delle loro economie in un mercato comune, nonché un sistema economico comune, in vista dell'integrazione degli Stati membri in un'organizzazione politica di tipo federale o confederale, quale risultato, in un periodo più o meno lungo, della stessa integrazione economica. Il trattato CEE in particolare prevedeva il passaggio dall'unione doganale (area esente da dazi interni e con un unico dazio comune esterno da applicare agli Stati terzi) ad un mercato comune, ossia ad un'area di libera circolazione dei fattori produttivi in cui si procedesse all'armonizzazione delle politiche statali in vari settori (agricolo, trasporti, fiscale, ecc.) in vista della realizzazione di un'unione economica. (1) In particolare, gli obiettivi da realizzare erano la libera circolazione delle merci, l'istituzione di un'unione doganale, l'adozione di una politica agricola comune, la libera circolazione di persone, servizi e capitali, una politica comune dei trasporti, la salvaguardia del regime di libera concorrenza. La CEE consentì agli Stati membri un rapido sviluppo economico nel corso degli anni '50 e '60, permettendo in particolare all'Italia di trasformarsi da paese principalmente agricolo a paese industrializzato. Ciò favorì la graduale adesione alla comunità di altri paesi europei, in tempi successivi, quali Gran Bretagna, Danimarca, Irlanda, Grecia, Spagna, Portogallo, Austria, Finlandia e Svezia. Ciò che concerneva l'ambito della politica economica e monetaria fu affrontato nel trattato di Roma fissando princìpi generali. L'obiettivo previsto dal trattato CEE in materia fu infatti quello di realizzare la convergenza delle politiche economiche nazionali in vista della realizzazione dell'Unione economica e monetaria. Si riconobbe che per la realizzazione del mercato comune e dell'integrazione economica era necessario coordinare le politiche economiche e ravvicinare le legislazioni nazionali, nonché si affermò la necessità di adottare una politica monetaria comune che fosse fonte di equilibrio e stabilità sia dei cambi che dei prezzi all'interno del mercato comune. Date queste premesse, gli articoli che nel trattato vennero dedicati specificamente alla politica monetaria (artt. 103-109) non prevedevano tuttavia appositi vincoli per le autorità monetarie nazionali, né un loro impegno a coordinarsi in materia. Per ciò che concerne invece la politica economica comune, il trattato CEE affidò al Consiglio dei Ministri esclusivamente il compito di provvedere al coordinamento delle politiche economiche nazionali degli Stati membri (art. 145), favorendo la cooperazione intergovernativa in ambito comunitario. Prevaleva in tal modo la convinzione che in un mercato comune caratterizzato dalla libera concorrenza la
------------------------------ © Servizio per le informazioni e la Sicurezza Democratica ------------------------------

convergenza delle economie nazionali si sarebbe realizzata spontaneamente grazie ai meccanismi del libero mercato. Il Trattato CEE si limitava a stabilire (artt. 108-109) che, qualora uno Stato membro avesse registrato un grave squilibrio nella bilancia dei pagamenti, tale da creare distorsioni nel mercato comune e turbative alla politica commerciale comunitaria, la Commissione avrebbe potuto indicare le misure di intervento ritenute più idonee a sanarlo. Qualora queste non fossero state risolutive, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, su proposta della Commissione e previo parere del Comitato Monetario, avrebbe potuto riconoscere al paese interessato il cd. "concorso reciproco", ossia concedere consistenti sostegni economici, sia attraverso il FMI che con il contributo degli altri Stati membri. Qualora anche questi non si fossero rivelati risolutivi, la Commissione poteva autorizzare lo Stato interessato ad adottare misure di salvaguardia, a condizione che queste incidessero il più limitatamente possibile sul mercato comune e che fossero adeguate all'entità dello squilibrio verificatosi. Inoltre la Commissione poteva ricorrere a misure volte ad evitare alterazioni dei traffici derivanti dai provvedimenti restrittivi adottati dal paese in difficoltà nei confronti di paesi terzi. Le misure di salvaguardia potevano comunque essere revocate o modificate dal Consiglio, con una delibera a maggioranza qualificata. La Comunità, inoltre, nel corso degli anni, ha affidato ulteriori competenze in materia di politica economica ad organi comunitari, in parte previsti dallo stesso Trattato di Roma, quali il Comitato monetario, il Comitato dei governatori delle banche centrali, il Fondo europeo di cooperazione monetaria (Fecom) e il Comitato di politica economica. Il Comitato monetario, costituito dai rappresentati della Commissione e degli Stati membri, aveva il compito di formulare pareri per la Commissione e il Consiglio. Il Comitato dei governatori delle banche centrali coordinava le politiche monetarie delle banche centrali nazionali e formulava pareri per il Consiglio, mentre il Fondo europeo di cooperazione monetaria (Fecom) aveva il compito di sovrintendere al funzionamento dello SME. Venne inoltre affidata al Consiglio dei Ministri dell'Economia e delle Finanze (Ecofin) il compito di sovrintendere ("sorveglianza multilaterale") alle politiche economiche nazionali e alla loro compatibilità con gli obiettivi comunitari in materia.
3. Il Sistema Monetario Europeo (SME): un primo passo verso l'unione monetaria Il primo decisivo impulso al coordinamento e alla convergenza in campo monetario è stato impresso con la creazione nel 1979 del Sistema Monetario Europeo (SME), a seguito della risoluzione del Consiglio europeo di Bruxelles del 5 dicembre 1978, attuato con gli accordi di Basilea del 13 aprile 1979, conclusi tra le banche centrali degli Stati membri e noti anche come Accordi Europei di Cambio. Con la creazione dello SME si intendeva dar vita ad un'area di stabilità monetaria europea, volta a favorire un ritorno progressivo al pieno impiego, un avvicinamento dei livelli di vita nazionali, l'eliminazione delle differenze regionali, nonché uno sviluppo comune in vista della realizzazione di una vera e propria unione economica. Il sistema monetario europeo, stabilito con gli accordi di Basilea e tuttora vigente, si basa sui seguenti punti: - la moneta base dello SME è l'ECU (ossia "unità di conto europea") costituito da un paniere di monete nazionali la cui composizione è determinata da quantità fissate delle valute degli Stati membri. Questa composizione viene periodicamente riesaminata e può essere modificata, purché il valore esterno dell'ECU rimanga invariato, ossia purché tale revisione investa esclusivamente la composizione interna della moneta europea in relazione al valore assunto dalle valute che la costituiscono, ma non il suo valore esterno. L'ECU può essere utilizzato dalle autorità monetarie nazionali per regolare le proprie operazioni finanziarie, come denominatore del meccanismo di cambio e per le operazioni relative ai meccanismi di intervento e credito; - le autorità monetarie nazionali dei paesi aderenti si sono accordate per fissare un "tasso centrale" in termini di ECU della propria moneta, impegnandosi inoltre ad intervenire per difendere tale tasso qualora la sua oscillazione rischiasse di superare il valore centrale prefissato di uno scarto superiore al 2,25% (all'Italia, al momento degli accordi, fu riconosciuta la possibilità di ricorrere ad una banda allargata pari al 6%). In sostanza quindi, ciascuna moneta nazionale assume un valore in ECU la cui variazione deve
------------------------------ © Servizio per le informazioni e la Sicurezza Democratica ------------------------------

avvenire entro e non oltre una determinata banda di oscillazione e ciò deve essere garantito da appositi interventi monetari da parte delle rispettive banche centrali nazionali; - viene creato un "indicatore di divergenza", ossia un sistema di controllo sulle fluttuazioni dei cambi delle monete dello SME, che permetta di individuare la moneta che più delle altre si discosti dal valore della media comunitaria e pertanto di intervenire con misure di politica economica adeguate prima che il valore del tasso di cambio della moneta interessata raggiunga i margini di fluttuazione prefissati. È possibile dire che lo SME ha permesso la creazione di un'area di stabilità monetaria europea, determinando altresì un "effetto disciplina" sui paesi a più alto tasso di inflazione e favorendo una maggiore responsabilità dei governi partecipanti nell'adozione delle decisioni di politica economica, rafforzando tra l'altro lo spirito di collaborazione tra i partners. Risultava evidente tuttavia, a dieci anni dalla conclusione degli accordi di Basilea, quanto fosse importante per la realizzazione di una vera e propria unione monetaria che gli Stati membri accettassero di rinunciare alla propria sovranità nazionale in un settore che tradizionalmente a questa era affidato, considerato che tra l'altro non tutti gli Stati membri aderivano allo SME (Gran Bretagna e Grecia). Era inoltre evidente la mancanza di un adeguato coordinamento delle politiche economiche nazionali che incidono direttamente sulle variabili reali del sistema economico. Se pertanto, grazie agli accordi europei di cambio, si era riusciti a garantire una riduzione del tasso d'inflazione all'interno della comunità, analogo successo non era stato raggiunto nel risolvere adeguatamente il problema dei deficit del bilancio pubblico e delle bilance dei pagamenti, situazione che, tra l'altro, impediva un reale e consistente miglioramento delle economie più deboli.
4. Il Trattato di Maastricht sull'Unione Europea (TUE): aspetti relativi all'unione monetaria Un'ulteriore e decisiva tappa nel processo di integrazione europea è stata rappresentata dalla firma, il 17 febbraio 1986, dell'Atto Unico Europeo, entrato in vigore il 1° luglio 1987, con il quale i dodici paesi membri si sono impegnati, oltre che a favorire la realizzazione di un mercato caratterizzato dalla libera circolazione delle persone, delle merci, dei servizi e dei capitali, anche ad adottare politiche comuni nei settori della ricerca e della tecnologia, nonché a garantire una maggiore cooperazione in materia di politica regionale, agricola, ambientale, sociale e sanitaria. A tali fini, furono apportate alcune modifiche ai trattati istitutivi che garantissero procedure decisionali più efficaci e democratiche di quelle vigenti, quali la possibilità per il Consiglio dei Ministri di adottare le proprie decisioni in alcuni settori, anziché all'unanimità, a maggioranza qualificata e la partecipazione più diretta del Parlamento europeo al processo decisionale del Consiglio dei Ministri. Nel preambolo dell'Atto Unico Europeo venne inoltre riproposto l'obiettivo della realizzazione dell'unione economica e monetaria. Nel 1988 il Consiglio europeo incaricò un comitato ad hoc costituito dai governatori delle banche centrali nazionali e presieduto da Jacques Delors, allora anche presidente della Commissione, di studiare e proporre le tappe concrete per la realizzazione dell'unione monetaria. Il Rapporto Delors che scaturì dai lavori di questo Comitato, reso noto nell'aprile del 1989 come relazione sull'Unione economica e monetaria in Europa, sosteneva che tale unione dovesse essere il frutto di un unico processo, articolato in tre fasi successive, alle quali effettivamente si procedette, almeno in parte, e tuttora si sta procedendo, attraverso le decisioni e secondo le modalità fissate nelle successive riunioni del Consiglio europeo. Quest'ultimo, riunitosi a Madrid nel giugno 1989, stabilì che la prima fase sarebbe stata avviata a partire dal 1° luglio 1990, per concludersi nel dicembre 1993. Questa avrebbe dovuto essere caratterizzata dalla piena liberalizzazione del mercato dei capitali (a partire proprio dal 1° luglio 1990), dal completamento del mercato unico (entro il 31 dicembre 1992) e da una maggiore convergenza delle politiche economiche nazionali, con particolare riguardo all'impegno da parte degli Stati aderenti ad evitare disavanzi eccessivi di bilancio e soprattutto il relativo finanziamento monetario. Dal punto di vista della politica monetaria, tutte le valute sarebbero dovute entrare a far parte dello SME e a tutte avrebbe dovuto essere applicata la banda di fluttuazione ordinaria pari al 2,25% rispetto al tasso centrale, eliminando così la possibilità di ricorrere alla banda allargata. Avrebbe dovuto inoltre essere
------------------------------ © Servizio per le informazioni e la Sicurezza Democratica ------------------------------

accentuato il ruolo di "sorveglianza multilaterale" del Consiglio dei Ministri dell'Economia e delle Finanze, nonché rafforzato il ruolo dell'ECU. Al fine di realizzare i suddetti obiettivi, la Comunità adottò due apposite decisioni (nn. 90/141 e 90/142 del 12.3.1990), volte in particolare a garantire un maggiore coordinamento delle banche centrali nazionali in materia di politica monetaria. Durante il successivo Consiglio europeo tenutosi a Roma il 27 e 28 ottobre 1990 si stabilì l'avvio della seconda fase a partire dal 1° gennaio 1994 e gli Stati membri si impegnarono ad un ulteriore rafforzamento del coordinamento delle politiche monetarie nazionali, al fine della realizzazione dell'unione monetaria e della moneta unica. Sulla base degli impegni presi a Roma, gli Stati membri svilupparono i lavori della Conferenza intergovernativa che portò, nel febbraio 1992, alla conclusione del trattato sull'Unione europea, firmato nel Consiglio europeo di Maastricht, con il quale è stata stabilita la realizzazione della seconda e terza fase dell'unione economica e monetaria. Il Trattato è stato sottoscritto formalmente il 7 febbraio 1992 ed è stata prevista la sua entrata in vigore a partire dal 1° gennaio 1993 (data, tra l'altro, di completamento del mercato unico) qualora "tutti gli strumenti di ratifica saranno depositati". Il Trattato è composto da "Disposizioni comuni" che fissano princìpi generali e indicazioni specifiche relative ai membri dell'Unione Europea. Tali disposizioni modificano i Trattati CEE che, in tale nuova versione, costituiscono l'asse portante del nuovo Trattato. Contiene altresì, "disposizioni" che modificano i Trattati CECA ed EURATOM; "disposizioni" relative alla Politica Estera e di Sicurezza Comune; "disposizioni" relative alla Cooperazione nei settori della Giustizia e degli Affari Interni; "disposizioni finali" che contengono in particolare una clausola di revisione generale del Trattato da attivare nel 1996; 12 "Protocolli" che garantiscono alcune esenzioni a favore del Regno Unito e della Danimarca rispetto all'Unione Economica e Monetaria, nonché la preservazione della legislazione antiabortista in Irlanda; 33 "dichiarazioni" interpretative delle disposizioni del Trattato. L'accordo prevede l'instaurazione di un'unione tra i paesi già membri della comunità europea, sostanzialmente fondata su quelli che sono stati definiti "tre pilastri" portanti, consistenti in: - la preesistente Comunità europea, nell'ambito della quale è compresa la realizzazione dell'unione economica e monetaria; - la politica estera e di sicurezza comuni (PESC); - la cooperazione in materia di giustizia e affari interni. Gli obiettivi dell'Unione possono pertanto essere individuati (2): - nella realizzazione di un progresso economico e sociale equilibrato, che sia anche sostenibile e attuabile non solo attraverso l'instaurazione del mercato comune, ma anche con il rafforzamento della coesione economica e sociale, nonché con la creazione di un'unione economica e monetaria basata su una moneta unica; - nell'adozione di una politica estera, di sicurezza e di difesa comuni attuate attraverso l'affermazione sullo scenario internazionale di un unico soggetto europeo; - nella tutela dei diritti e degli interessi dei cittadini degli Stati membri con il relativo riconoscimento di una vera e propria cittadinanza dell'Unione; - in una stretta cooperazione nel settore della giustizia e degli affari interni. Per la realizzazione dei suddetti obiettivi ruolo centrale viene affidato al Consiglio europeo, organo di indirizzo politico dell'Unione, composto dai Capi di Stato e di Governo degli Stati membri e dal Presidente della Commissione europea, il quale imprime all'Unione l'impulso necessario al suo sviluppo e ne definisce gli orientamenti politici generali, riunendosi almeno due volte l'anno sotto la presidenza dello Stato membro che detiene la presidenza del Consiglio dei Ministri. Il Titolo VI del trattato è dedicato alla politica economica e monetaria, sulla quale il presente lavoro in particolare si soffermerà. Gli artt. 102A-104C riguardano la politica economica e gli artt. 105-109 la politica monetaria; gli artt. 109A-109D contengono disposizioni istituzionali e gli artt. 109E-109M disposizioni transitorie. Il complesso di queste norme è finalizzato alla creazione di un'unione monetaria e alla realizzazione di un forte coordinamento delle politiche economiche nazionali attraverso impegni e condizionamenti sempre più stringenti. È infatti prevista la costituzione di una nuova istituzione, il Sistema europeo di banche centrali (SEBC) di
------------------------------ © Servizio per le informazioni e la Sicurezza Democratica ------------------------------

cui faranno parte la Banca Centrale Europea (BCE) e le Banche centrali nazionali. L'organizzazione e le competenze del SEBC e della BCE, nonché la creazione dell'Istituto Monetario Europeo, sono regolate rispettivamente dal Protocollo sullo Statuto (53 articoli) e dallo Statuto dell'IME, ai quali vanno aggiunte una serie di dichiarazioni e protocolli, allegati al trattato, concernenti le procedure per i disavanzi eccessivi, i criteri di convergenza e altro. Al fine di realizzare l'unione economica e monetaria viene affidato al Consiglio dei Ministri il compito di elaborare "gli indirizzi di massima da sottoporre al Consiglio Europeo, al quale compete, congiuntamente alla Commissione e agli Stati membri, esercitare il controllo sulla effettiva realizzazione del coordinamento e sul rispetto dei criteri di convergenza, con l'ausilio del Parlamento europeo. In quest'ambito, è riconosciuto al Consiglio europeo il potere di rivolgere raccomandazioni e comminare sanzioni. È da sottolineare che mentre sul piano della politica economica si fa riferimento esclusivamente ad un forte coordinamento degli Stati membri che tuttavia conservano le loro responsabilità in materia, per ciò che concerne la politica monetaria si prevede un trasferimento di sovranità a favore delle istituzioni comunitarie, nonché precisi vincoli e criteri che tali istituzioni e i governi nazionali devono rispettare, al fine di garantire la stabilità e la disciplina di bilancio. In particolare, è previsto l'impegno dei governi nazionali a : - contenere il disavanzo di bilancio entro il 3% del PIL, il debito pubblico entro il 60% del PIL e il tasso di inflazione ad un livello che si discosti al massimo dell'1,5% dal livello medio di inflazione dei tre paesi membri aventi il minor tasso. I tassi di interesse nominali a lungo termine non dovranno inoltre registrare uno scarto superiore al 2% rispetto alla media dei tre paesi "più virtuosi" in materia di inflazione; - a permanere nello SME almeno per due anni prima della realizzazione della moneta unica, in modo che sia garantita la stabilità interna dei tassi di cambio. È inoltre fatto divieto alla BCE e alle Banche centrali nazionali di concedere "scoperti di conto" o altro tipo di facilitazioni creditizie alle amministrazioni statali, regionali o locali. Questi vincoli sono finalizzati a costituire le premesse, da realizzare in più fasi, per la creazione, al più tardi il 1° gennaio 1999, della moneta unica europea. A questo fine, ruolo fondamentale verrà svolto, oltre che dalla BCE e dal SEBC (organi che si andranno di seguito a descrivere più dettagliatamente), da altre due istituzioni: il Comitato economico e finanziario, destinato a sostituire, nella terza fase, il Comitato monetario, e l'Istituto monetario europeo, attivo a partire dal 1° gennaio 1994 (data di avvio della seconda fase), con l'obiettivo di favorire il coordinamento delle politiche monetarie e consentire la realizzazione, nella terza fase, del SEBC. L'IME è stato fondato allo scioglimento del Comitato dei Governatori delle Banche Centrali della Comunità Europea (costituito nel 1964), assumendone funzioni e attribuzioni. È importante sottolineare che tale Comitato ha contribuito fortemente all'unificazione monetaria, partecipando alla stesura dell'Atto Unico Europeo e allo schema di realizzazione delle fasi dell'Unione economica e monetaria prevista dal già citato rapporto Delors, nonché del Trattato di Maastricht. L'Istituto, che ha contribuito in maniera consistente al processo dell'unificazione monetaria continuando il lavoro sviluppato dal Comitato dei Governatori nel corso della prima fase dell'UEM, ha compiuto il 1° gennaio 1996 il suo secondo anno di attività. Con sede a Francoforte, opera in modo permanente con proprie strutture ed è dotato di piena personalità giuridica, bilancio autonomo e articolata struttura organizzativa. All'IME compete il coordinamento delle politiche monetarie e del cambio e la preparazione del passaggio alla moneta unica, in vista della sua sostituzione, durante la terza fase, da parte della Banca Centrale Europea (BCE). Secondo il Trattato di Maastricht, quest'ultima avrà il compito di: - autorizzare "in via esclusiva" l'emissione di banconote all'interno della Comunità, emissione che potrà avvenire anche attraverso le banche centrali nazionali; - approvare il volume del conio delle monete metalliche coniate dagli Stati membri; - emanare regolamenti aventi portata generale e obbligatori in tutti i loro elementi, direttamente applicabili sul territorio degli Stati membri, nonché formulare raccomandazioni, decisioni e pareri. Risulta, pertanto, riconosciuta nella BCE una nuova fonte di produzione normativa nell'ambito della Comunità, sottoposta all'eventuale ed esclusiva giurisdizione della Corte di Giustizia, senza che il Parlamento europeo possa esercitare sugli atti prodotti dalla BCE alcun potere di intervento. Gli organi della BCE saranno il Consiglio direttivo e il Comitato esecutivo.
------------------------------ © Servizio per le informazioni e la Sicurezza Democratica ------------------------------

Il Comitato esecutivo sarà costituito da un Presidente, un Vice Presidente e altri 4 membri. I membri del Comitato esecutivo e i Governatori delle Banche centrali nazionali costituiranno invece il Consiglio direttivo. La Banca Centrale Europea (BCE) e le Banche centrali nazionali costituiranno il SEBC, che avrà il compito di: - definire e attuare la politica monetaria della Comunità; - effettuare le operazioni sui cambi, in linea con quanto previsto dall'art. 109; - detenere e gestire le riserve ufficiali in valuta estera degli Stati membri; - promuovere il regolare funzionamento dei sistemi di pagamento. L'art. 109J conferisce inoltre al Consiglio ("riunito nella composizione dei Capi di Stato e di Governo") il potere di deliberare, entro il 31 dicembre 1996, l'avvio della terza fase qualora si siano realizzate le condizioni di stabilità e di convergenza economiche, accertate sulla base di apposite relazioni presentate dalla Commissione e dall'Istituto monetario europeo e concernenti la realizzazione di "un alto grado di sostenibile convergenza", verificato in base a: - il raggiungimento di un alto grado di stabilità dei prezzi; - la sostenibilità della situazione della finanza pubblica; - il rispetto dei margini normali di fluttuazione dei cambi previsti dallo SME; - livelli dei tassi di interesse a lungo termine che riflettano la stabilità della convergenza raggiunta. Fondamentale sarà pertanto, per la realizzazione della terza fase, l'adozione di una politica comune dei tassi di interesse. Qualora saranno soddisfatti questi criteri, tenuto conto dei risultati dell'integrazione dei mercati, della situazione delle bilance dei pagamenti nazionali, con particolare riguardo alle partite correnti, e considerata l'evoluzione dei costi monetari del lavoro, il Consiglio dovrà verificare, a maggioranza qualificata, sulla base delle valutazioni espresse dal Consiglio dei Ministri economici e finanziari, se ciascuno Stato e la maggioranza di essi soddisfino le condizioni per la realizzazione della moneta unica e se sia opportuno passare alla terza fase della UEM, stabilendone eventualmente la data di inizio, tenendo conto che tra il momento della decisione e quello della data di avvio dovrà trascorrere almeno un anno. Qualora tale decisione dovesse, al contrario, portare ad una valutazione negativa circa la possibilità di avviare la terza fase, questa avrà comunque inizio a partire dal 1° gennaio 1999. In quest'ultimo caso, il Consiglio europeo, sei mesi prima della scadenza ultima, dovrà decidere, sulla base dei suddetti parametri, quali paesi potranno essere ammessi a pieno titolo a partecipare all'UEM e quali invece dovranno essere considerati "Stati membri con deroga", condizione che comporterà, per questi ultimi, forti limitazioni alla loro partecipazione alle decisioni adottate dalle istituzioni dell'Unione in materia monetaria. Gli Stati membri con deroga potranno comunque richiedere al Consiglio europeo, quando lo riterranno opportuno, di valutare la loro adeguatezza ad entrare a pieno titolo nell'UEM. È possibile dire, pertanto, che con l'avvio della terza fase le politiche monetarie nazionali dovrebbero essere totalmente trasferite in ambito comunitario e gestite dal SEBC, mentre ogni Stato conserverà l'esercizio della propria sovranità in materia di politiche economiche e di bilancio, tenendo tuttavia sempre conto che si tratta di questioni di interesse comunitario e impegnandosi a coordinarsi in materia nell'ambito del Consiglio. Su questo tema infatti si può parlare non certo di un trasferimento di sovranità nazionale, bensì di una sorta di limitazioni ad essa o, più precisamente, di un suo "esercizio comune". Largo margine è in quest'ambito lasciato alle trattative intergovernative e ben poco viene affidato a criteri automatici, tanto che i maggiori poteri vengono riconosciuti ad un organo quale il Consiglio economia e finanze di cui fanno parte proprio i rappresentanti dei governi nazionali, laddove in generale non sono previste apposite "sanzioni", se non di natura politica, per gli Stati che non dovessero rispettare gli accordi presi. Nella realizzazione degli obiettivi fissati a Maastricht viene generalmente riconosciuta l'importanza che avrà un serio e reale impegno politico alla creazione dell'unione economica e monetaria. Per quanto concerne l'Italia, bisogna tener presente che, come per gli altri Stati membri, l'adesione all'unione economica e monetaria comporterà una modifica della costituzione economica e in particolare un maggiore vincolo all'adozione delle politiche di bilancio, che dovranno aderire ad un modello uniforme comunitario e dovranno essere destinate alla riduzione inderogabile dei deficit di bilancio e del debito pubblico. Bisogna inoltre considerare che se con l'avvio della terza fase dovranno realizzarsi un sistema di cambi fissi, la stabilità dei prezzi nonché la sottrazione della politica monetaria al controllo delle autorità monetarie
------------------------------ © Servizio per le informazioni e la Sicurezza Democratica ------------------------------

nazionali, sarà necessario adeguare le politiche economiche nazionali a questa nuova realtà, tenendo altresì conto del fatto che saranno definitivamente preclusi al governo sia la possibilità di ricorrere al canale monetario interno per immettere moneta nel sistema economico, sia il ricorso alla banca centrale nazionale per coprire i deficit di bilancio, data la definitiva indipendenza di questa dall'autorità politica nazionale. Ciò richiederà, non solo all'Italia, bensì ad ogni Stato membro, una maggiore flessibilità degli altri fattori economici, quali ad es. la mobilità del fattore lavoro, la libertà negli investimenti, la variabilità dei tassi di interesse e dei costi, l'elasticità della spesa pubblica e del bilancio statale. Il trattato di Maastricht ha tuttavia sollevato, dopo la sua conclusione, una serie di problematiche, politiche ed economiche, di non facile soluzione che, a tutt'oggi, sono di estrema attualità. La prima di queste problematiche è emersa con la mancata ratifica del Trattato da parte della Danimarca con il referendum del 2 giugno 1992, che ha posto la questione della possibilità o meno, per una parte dei paesi membri della già esistente comunità europea, di procedere alla realizzazione dell'Unione. Nel settembre del 1993 la lira e la sterlina irlandese sono inoltre uscite dallo SME (mentre la dracma greca non ne ha mai fatto parte), con la conseguenza che la determinazione del tasso di cambio delle suddette valute risulta stabilita nel libero mercato senza che le banche centrali siano tenute ad intervenire per sostenerlo. Successivamente si sono verificate una serie di crisi valutarie che hanno investito la peseta spagnola, l'escudo portoghese e la sterlina irlandese, con il conseguente ricorso, per queste valute, ad un allargamento della banda di fluttuazione. Le ragioni di queste crisi successive sono state da diversi commentatori individuate sia nella volontà del governo tedesco di adottare una politica monetaria restrittiva, finalizzata a garantire l'unificazione tedesca senza causare un'impennata nel tasso di inflazione, sia nell'incertezza circa la realizzazione dell'Unione monetaria così come era stata prevista dal trattato di Maastricht, anche in relazione alla citata mancata ratificata del trattato da parte della Danimarca. Altro elemento di non scarsa rilevanza è che la liberalizzazione del mercato dei capitali a partire dal 1° luglio 1990 ha determinato il venir meno delle restrizioni valutarie nazionali esistenti precedentemente alla suddetta liberalizzazione, realtà che ha reso molto più difficoltoso il controllo e l'intervento sui cambi. È emersa così l'estrema difficoltà di mantenere una situazione di libera circolazione dei capitali e delle merci, nonché cambi fissi, in assenza di una reale politica monetaria comune, sebbene tutti gli Stati aderenti abbiano ribadito il proprio impegno a realizzare l'unione economica e monetaria prevista dal trattato sull'unione europea. A tali vicende si sono aggiunte le diatribe concernenti il presunto accentramento legislativo comunitario e, in particolare, la ripartizione del potere politico e legislativo tra le istituzioni comunitarie e quelle nazionali, nonché i contrasti tra paesi come la Francia, la Germania e la stessa Italia, che ritengono di contribuire in modo eccessivo al finanziamento della comunità-unione e paesi come la Spagna, il Portogallo e la Grecia, che invece affermano di non ricevere gli aiuti necessari a risollevare le loro regioni depresse. Il peggioramento della situazione economica degli Stati membri, in particolare sotto il profilo dell'occupazione e del grave indebitamento di alcuni di essi, nonché la profonda crisi dello SME, che rischia di mettere in discussione l'evoluzione delle fasi previste a Maastricht per la realizzazione della UEM, costituiscono, a tutt'oggi, alcune delle questioni che rischiano di bloccare la realizzazione dell'unione, nonostante il successivo risultato positivo del referendum in Danimarca nel giugno '93 e l'entrata in vigore del trattato, con il deposito dell'ultima ratifica da parte della Germania, il 1° novembre 1993.
5. Il Vertice di Madrid Parte delle problematiche sorte successivamente alla conclusione del TUE è stata affrontata al Consiglio europeo di Madrid, svoltosi il 15 e 16 dicembre 1995, a conclusione del semestre di presidenza spagnola. Il vertice dei Capi di Stato e di Governo dei 15 Stati membri dell'UE si è riunito con l'obiettivo di affrontare una serie di questioni - che si andranno qui di seguito sinteticamente ad esaminare - al fine di pervenire all'elaborazione di una piattaforma di riferimento per la discussione che avrà luogo durante la Conferenza intergovernativa (CIG), la cui apertura era prevista, all'epoca del Vertice, per la primavera del corrente anno. Il Trattato di Maastricht stabilisce infatti la convocazione di questa conferenza allo scopo di procedere alla
------------------------------ © Servizio per le informazioni e la Sicurezza Democratica ------------------------------

revisione del trattato stesso, per quanto concerne taluni aspetti riguardanti le istituzioni dell'Unione e il loro funzionamento (questioni procedurali), la politica estera e di sicurezza comuni e la cooperazione giudiziaria. Il Vertice di Madrid ha consentito, innanzitutto, di fissare l'apertura, a Torino, dei lavori della suddetta CIG al 29 marzo 1996. Per quanto concerne le questioni di carattere monetario, è stata sciolta la discussa questione riguardante il nome da attribuire alla futura moneta unica. Si è stabilito infatti che questa si chiamerà "Euro", mentre per quanto concerne la determinazione delle fasi per il completamento della UEM sono state confermate le date previste dal trattato di Maastricht. I Capi di Stato e di governo dei 15 paesi della UE hanno preso atto, come del resto era già avvenuto nel corso del vertice svoltosi a Maiorca nel settembre precedente, del fatto che difficilmente la fase finale della UEM potrà essere avviata prima del 1° gennaio 1999. Come si è detto, sei mesi prima di questa data il Vertice dei Capi di Stato e di Governo dovrà valutare, sulla base dei dati economici e finanziari definitivi del 1997, quali paesi sono in grado, in relazione ai noti parametri, di entrare a far parte della UEM. Altra questione da definire sarà quella relativa ai rapporti tra la moneta unica e le monete nazionali dei paesi che eventualmente rimarranno esclusi dall'unione monetaria. Sulla possibilità di realizzare l'unione monetaria procedendo in maniera differenziata, ossia tra i paesi che progressivamente saranno nelle condizioni economiche per aderirvi, si sono espressi sia il Presidente Chirac che il Cancelliere Kohl. Entrambi hanno ribadito la convinzione, già manifestata in altre sedi in precedenza, che la realizzazione della UEM non potrà prescindere da un consolidamento dell' "asse franco-tedesco", sostenendo altresì che, in quest'ottica, potrà essere opportuno aderire alla logica del cd. "opting in", secondo la quale si potrà procedere all'integrazione tra quegli Stati che, di volta in volta, saranno in grado e vorranno farlo. Tale posizione è stata successivamente confermata dal Presidente della Bundesbank, Hans Tietmeyer, il quale ha affermato, in un convegno di industriali tedeschi tenutosi a Francoforte, che "non può esserci unione monetaria se non ne fanno parte Francia e Germania". Tietmeyer ha inoltre sostenuto la disponibilità tedesca ad accettare un ritardo nei tempi previsti dal Trattato di Maastricht, ma non una revisione dei parametri che devono essere considerati irrevocabili. (3) Tale questione risulta attualmente di particolare delicatezza per quanto concerne la situazione di alcuni Stati aderenti. Com'è noto, infatti, l'Italia è uscita dallo SME, svalutando la propria moneta, mentre alcuni paesi membri, come la Spagna e il Portogallo, hanno proceduto all'allargamento della banda di oscillazione delle rispettive monete nazionali. Per quanto concerne l'Italia, per poter partecipare all'Unione monetaria, sarà necessario procedere al: - rientro nello SME, peraltro previsto dal Trattato di Maastricht, per tutti i paesi aderenti, due anni prima dell'avvio dell'unione monetaria; - risanamento della finanza pubblica, accompagnato da una situazione politica di maggiore stabilità; - controllo sul tasso d'inflazione, da mantenere a livelli meno elevati. Nel corso del 1994 e del 1995, la realizzazione di questi obiettivi è stata ostacolata dalla scarsa credibilità politica del nostro paese, attraversato da continue crisi di stabilità governativa, dalle quali sono derivati un incremento del differenziale del tasso d'interesse italiano rispetto al tasso tedesco, un'erosione del cambio nel corso del 1994 e una sua rapida caduta nel corso del 1995, con il conseguente aumento della sperequazione esistente tra la situazione monetaria del nostro paese e quella dell'economia reale, che risulta invece in netta ripresa anche grazie agli effetti benefici derivanti dalla svalutazione della lira. A Madrid si è stabilito inoltre che la CIG dovrà discutere la possibilità di un allargamento della UE agli Stati dell'Europa orientale, a Malta e a Cipro, nonché ad alcuni paesi dell'area mediterranea, nordafricana e mediorientale, quali Marocco, Tunisia, Algeria, Egitto, Israele e altri. L'eventualità di un allargamento della UE verso il sud del Mediterraneo era già stata precedentemente affrontata durante la conferenza euro-mediterranea, svoltasi a Barcellona il 27 e 28 novembre 1995 e conclusasi con una Dichiarazione approvata all'unanimità dai paesi partecipanti (4). Tale dichiarazione prevede, oltre all'intenzione di creare, entro il 2010, un'area di libero scambio tra l'UE e i paesi nordafricani e mediorientali partecipanti alla conferenza, anche l'impegno a favorire una più intensa collaborazione sul piano culturale, politico ed economico, che tenga in particolare conto la necessità di affrontare adeguatamente il problema dei flussi migratori diretti ai paesi della UE e provenienti dalle aree geografiche del Mediterraneo del sud. In particolare, è stata dichiarata la volontà di affrontare una simile
------------------------------ © Servizio per le informazioni e la Sicurezza Democratica ------------------------------

tematica agendo sulle principali cause del fenomeno, ricorrendo a soluzioni che prevedano un sostegno alla formazione professionale in loco e che comportino investimenti di capitali a favore dell'occupazione e della modernizzazione di tali sistemi economici. Sulla base della dichiarazione sottoscritta dalla UE a Barcellona, al vertice di Madrid, gli Stati partecipanti hanno stabilito che, dopo sei mesi dalla conclusione della CIG, i paesi che hanno presentato la propria candidatura all'Unione verranno sottoposti ad un attento e severo monitoraggio volto a verificare l'idoneità di questi all'ingresso nella UE sulla base di criteri economici. La Commissione europea dovrà elaborare un proprio rapporto in merito e le trattative per l'adesione verranno avviate solo con quei paesi che saranno giudicati idonei. È importante ricordare, a questo proposito, che la questione dell'ingresso di nuovi paesi nella UE è strettamente connessa alla necessità di riformare le procedure decisionali all'interno delle istituzioni dell'Unione (e, in particolare, del Consiglio dei Ministri) che già allo stato attuale, caratterizzato da un'Unione a 15, risultano eccessivamente complesse e articolate e, pertanto, non in grado di garantire la capacità dell'Unione di adottare decisioni pronte ed efficaci. Situazione che è evidentemente destinata a complicarsi in una prospettiva di futuro allargamento della UE. È indubbio che tale tematica sarà centrale nei dibattiti che avranno luogo nell'ambito della CIG e già da più parti è stato sottolineato come un serio esame di un'ipotesi di allargamento dei membri della UE non possa prescindere da una preventiva soluzione alle questioni di carattere istituzionale e procedurale. Nell'ambito del Vertice di Madrid è stato infine concluso un accordo di cooperazione con il Mercato comune dell'America del Sud (Mercosur, costituito da Argentina, Paraguay, Uruguay e Brasile), che prevede l'impegno a realizzare tra i paesi firmatari una zona di libero scambio, entro il 2005, che favorisca l'integrazione economica, politica, commerciale, industriale e culturale, nonché un clima di stabilità economica e di sicurezza giuridica che faciliti le esportazioni dei paesi dell'Unione in tale area extraeuropea.
6. I principali temi nell'agenda del 1996 La Conferenza Intergovernativa (CIG), inauguratasi a Torino il 29 e 30 marzo scorsi, si prefigge, come si è detto, l'obiettivo di migliorare il funzionamento della UE e creare le condizioni che consentano di affrontare sia le sfide interne che esterne ad essa. Una prima questione che va preliminarmente evidenziata è che, in questi ultimi due anni, si è diffuso nei paesi membri un certo scetticismo circa la realizzabilità dei progetti fissati a Maastricht secondo i tempi e i modi previsti. Ciò può essere ricondotto a varie ragioni. Principale problema attuale è quello legato alla mancata convergenza di molti Stati aderenti verso i valori della finanza pubblica e dell'inflazione fissati a Maastricht, con la conseguente possibilità di procedere alla realizzazione degli obiettivi del trattato in forma ristretta, costituendo così un'Europa "a due velocità". Sebbene infatti tutti i paesi aderenti, fatta eccezione per il Regno Unito e la Danimarca, siano desiderosi di partecipare fin dall'inizio alla UEM, diffusi sono i timori di alcuni paesi, come ad esempio la Spagna, di essere danneggiati da un eventuale mercato europeo diviso in due gruppi separati. Viene quindi spesso richiamata la necessità di definire in maniera più chiara i futuri rapporti tra i paesi che parteciperanno alla moneta unica e quelli che eventualmente ne dovessero momentaneamente rimanere esclusi, prevedendo per questi ultimi meccanismi di rientro (opting in) e politiche di sostegno economico per la realizzazione di tale obiettivo. Tuttavia, tutti gli Stati, pur riconoscendo l'inderogabilità dei criteri di convergenza previsti dal trattato di Maastricht, sottolineano che l'obiettivo centrale da realizzare è quello della riduzione del deficit del bilancio pubblico nazionale e soprattutto del debito. Inoltre la Spagna, il Portogallo e l'Irlanda richiedono un impegno da parte dei partners a rafforzare le politiche di sostegno allo sviluppo dei paesi e delle aree depresse o comunque economicamente più deboli, tenendo conto che, di recente, il Presidente Chirac ha proposto di introdurre tra i criteri di convergenza anche il tasso di disoccupazione. Da parte di diversi osservatori, è stato infatti sottolineato che la creazione dell'unione monetaria non può prescindere dalla definizione di quello che dovrà essere il ruolo dell'Unione per ciò che concerne la politica economica, nonché dalla decisione di quali interventi questa intende operare nell'economia reale, in
------------------------------ © Servizio per le informazioni e la Sicurezza Democratica ------------------------------

particolare per affrontare il problema dell'occupazione che affligge tutti gli Stati membri. Per l'Italia, sotto il profilo dei criteri di convergenza, il problema centrale è quello del debito pubblico, sul quale, tuttavia, sono in molti a ritenere che avrebbe un indubbio effetto benefico l'eventuale riduzione dei tassi d'interesse derivante proprio dalla partecipazione dell'Italia alla UEM e alla valuta comune europea. Ciò significa che, quasi paradossalmente, per l'Italia l'adesione all'UEM faciliterebbe la realizzazione di quella convergenza sul debito che tuttavia costituisce, insieme al rientro nello SME, condizione essenziale per la sua partecipazione. Importante è inoltre il vincolo posto a Maastricht sulla stabilità dei prezzi interni, che l'Italia dovrà conciliare con la crescita dell'economia reale. È indubbio tuttavia che, al di là di queste problematiche di natura strettamente monetaria, la maggiore sfida per l'Italia è quella di dimostrare ai partners europei di essere in grado di tollerare un'unione a cambi fissi accompagnata da una situazione caratterizzata da un contenuto livello del tasso d'inflazione. Più in generale, il diffuso sentimento di disillusione nei confronti della UEM è da ricondurre al fatto che i cittadini europei, soprattutto in alcuni paesi, come ad esempio l'Austria, avvertono questa Unione come un'imposizione esterna che comporta principalmente sacrifici e vincoli, piuttosto che come un'opportunità positiva per tutti i cittadini dell'Europa unita. Come si è avuto modo di notare in precedenza, quindi, si può ritenere che, al di là delle questioni di carattere propriamente monetario, sussiste la necessità di definire e concordare questioni di carattere politico, ossia di esternare una reale volontà politica di procedere all'Unione europea. Diversi commentatori e addetti ai lavori hanno osservato in proposito che il rilancio dello spirito europeista deve essere favorito da parte di coloro che parteciperanno alla CIG, nel corso di questo anno e del prossimo, rendendo il più possibile edotta l'opinione pubblica di quanto avviene durante i lavori, di quali sono le posizioni e quali le proposte di ciascuno Stato membro, in poche parole attraverso il tentativo di rendere trasparente e accessibile l'attività dell'Unione ai cittadini europei, superando i limiti dell'ambito tradizionalmente ristretto delle trattative intergovernative e diplomatiche. La realizzazione di una solida unione economica e monetaria non può ormai prescindere (come del resto anche per gli altri settori - giustizia, sicurezza interna, politica estera - cui tale unione si vorrebbe allargare) dal consenso generale e politico dei cittadini europei a tale progetto. È necessario pertanto che il sentimento di esclusione ed estraneità che molti di questi avvertono nei confronti delle istituzioni europee venga sostituito dalla partecipazione diretta ad esse. Ciò potrà avvenire attraverso una reale democratizzazione del "sistema Europa", per realizzare la quale diversi osservatori propongono di intervenire sulla legge elettorale, "europeizzando" i parlamenti nazionali attraverso la partecipazione dei parlamentari alle delegazioni presso il Consiglio, estendendo le competenze della Corte di Giustizia, aumentando il potere di codecisione del Parlamento europeo. In proposito, bisogna ricordare che tra le questioni da affrontare alla CIG vanno annoverate proprio quelle relative alle riforme istituzionali e procedurali. In particolare, si ritiene necessario, come da molti è stato osservato, procedere ad una razionalizzazione delle procedure decisionali all'interno delle istituzioni europee, che comporti innanzitutto una loro riduzione e omogeneizzazione, a prescindere dai settori nei quali le decisioni di volta in volta devono essere adottate. Un consistente contributo al miglioramento di quell'efficienza delle istituzioni europee, di cui in precedenza si è sottolineata l'importanza, verrebbe apportato sia dalla decisione di estendere il ricorso al voto a maggioranza qualificata, in luogo di quello all'unanimità, sia da una più incisiva applicazione del principio di sussidiarietà. In proposito, si ritiene di dover rilevare la portata, quanto meno sotto un profilo teorico, di questo principio, laddove venga inserito nell'attuale dibattito italiano concernente l'eventuale riforma in senso federalista della nostra forma di Stato. Osservando infatti le linee evolutive di altri paesi europei, e soprattutto di quelli aventi una tradizione e una storia politica più simili a quella italiana, quali ad esempio la Germania, nonché della stessa Unione europea, sembra emergere una realtà che arriva progressivamente ad attribuire alle "regioni" dell'Europa un ruolo centrale e crescente nel creare uno spazio economico adeguato nel quale le imprese europee possano svilupparsi e sostenere la concorrenza internazionale. Molti osservatori ritengono infatti, sebbene in proposito non sussista un accordo generale, che il ruolo centrale dello Stato sia destinato ad affievolirsi, se non addirittura a dissolversi, a favore, da una parte, di autorità locali operanti in territori più ristretti rispetto a quello nazionale propriamente inteso e, dall'altra, di autorità e istituzioni che riuniscono in un ben più ampio contesto le entità statuali, quale, ad esempio,
------------------------------ © Servizio per le informazioni e la Sicurezza Democratica ------------------------------

vorrebbe essere l'Unione europea. Si ritiene quindi evidente che il dibattito sul tema federale che attualmente impegna l'Italia dovrebbe o potrebbe essere affrontato con maggiore consapevolezza e portare a soluzioni probabilmente più adeguate ed efficienti, laddove si rivolgesse l'attenzione anche a quello che accade nel contesto della UE e soprattutto alle possibili evoluzioni future di questa. È necessario ideare, inoltre, un sistema che regoli la partecipazione degli Stati membri alla Commissione, che rischierebbe un eccessivo "affollamento" se ad essa fossero ammessi automaticamente i rappresentanti di tutti gli Stati aderenti, tenendo altresì presente il futuro allargamento dell'Unione. Per ciò che concerne la definizione della politica estera e di sicurezza comune (PESC), la questione jugoslava ha messo tragicamente in evidenza l'enorme difficoltà di una sua realizzazione, oltre alla necessità di risolvere la questione dell'eventuale assorbimento dell'Unione Europea Occidentale (UEO) nell'Unione Europea. D'altro canto, la difesa è un settore tradizionalmente gestito in esclusiva dai governi nazionali e sulla quale molti Stati sono restii ad accettare limitazioni consistenti di sovranità e ancor meno ad operare definitivi trasferimenti di questa. Sull'organizzazione di una politica comune di difesa un certo peso dovrà inoltre comunque avere la definizione dei rapporti in questo contesto con gli Stati Uniti. I recenti avvenimenti francesi, con particolare riferimento alla ripresa unilaterale degli esperimenti nucleari da parte di questo paese, non hanno certamente contribuito, visti anche gli attriti che ne sono derivati con alcuni partners, tra cui l'Italia, ad un progresso in questo settore. Analoghe difficoltà vanno rilevate per quanto concerne la cooperazione, prevista a Maastricht, in materia di giustizia e affari interni. Sono emerse infatti numerose difficoltà di natura tecnica nell'armonizzazione delle rispettive legislazioni nazionali, dovute anche alla ritrosia degli Stati membri a modificare normative e consuetudini consolidate. Non ultima per importanza è inoltre la generale indifferenza nell'applicazione dell'accordo di Schengen, accompagnata da ostacoli tecnici dovuti in alcuni casi alla mancata ratifica dell'accordo stesso o alla necessità, come nel caso dell'Italia, di varare apposite norme che ne consentano l'applicazione. Sussiste infine il problema del già citato allargamento dell'Unione ad altri paesi, tra cui quelli dell'Europa orientale, sul quale sembra esserci, allo stato attuale, un generale accordo, fatta eccezione per la Turchia. Va ricordato infatti che, il 3 dicembre 1995, il Parlamento europeo ha ratificato l'accordo doganale con la Turchia, la quale si è impegnata, tra l'altro, ad abolire, a partire dal 1° gennaio 1996, i dazi alle importazioni di prodotti industriali provenienti dai paesi della UE, in previsione di una vera e propria adesione futura a questa. I rapporti con la Turchia sono stati tuttavia piuttosto travagliati, e lo sono tuttora, anche a causa delle numerose e gravi violazioni dei diritti umani commesse dal governo turco ai danni della popolazione curda. La ratifica dell'accordo doganale ha costituito, secondo alcuni commentatori internazionali, un tentativo da parte della UE, peraltro fallito, di sostenere alle elezioni politiche che si sono successivamente svolte il 24 dicembre in Turchia il partito di centro-destra, "filoeuropeista". La questione dell'adesione della Turchia alla UE è quindi destinata ad ulteriori rallentamenti e comunque risulta tuttora da definire. La Conferenza intergovernativa, che si è aperta a Torino il 29 marzo scorso, dovrà quindi affrontare le numerose questioni sinteticamente delineate, provvedendo a negoziare una riforma del trattato di Maastricht che tenga conto della realtà esistente e che ponga le basi per l'effettivo avviamento della UEM al più tardi il 1° gennaio 1999, in un clima di incertezza monetaria e politica e di dubbia percezione, da parte dei cittadini europei, di quelli che sono i reali interessi comuni da perseguire.
7. La Conferenza Intergovernativa (CIG) di Torino: il semestre di Presidenza italiano e le prospettive future Come si è detto, il 29 marzo 1996 segna due avvenimenti importanti: l'apertura del Consiglio Europeo di Torino e la Conferenza Intergovernativa per la revisione dei Trattati. Dalle problematiche trattate e dalle decisioni che si prenderanno dipenderà l'intero futuro del Trattato di Maastricht che determinerà anche la possibilità di realizzazione della stessa Unione monetaria, che dovrà essere ultimata entro il 1999. I lavori della Conferenza avranno la durata di un anno e si dovranno sviluppare secondo il programma presentato dal governo italiano, il cui orientamento politico è stato approvato da tutti i Capi di Stato e di
------------------------------ © Servizio per le informazioni e la Sicurezza Democratica ------------------------------

Governo. L'attuale presidenza irlandese e la prossima olandese, saranno vincolate politicamente dalle linee guida tratteggiate a Torino. La scala delle priorità del programma indicata al termine della Conferenza, pur dovendo essere rispettata, lascerà comunque ampio spazio alle soluzioni da adottare, secondo le diverse necessità. Il processo di integrazione, basato sulle capacità individuali di ciascun paese partecipante, dovrà seguire le politiche e le linee d'azione tratteggiate dal Trattato con l'obiettivo fondamentale del rispetto dei bisogni primari dei cittadini europei, quali: - la promozione dell'occupazione; - la protezione dell'ambiente; - la tutela della libertà e della sicurezza, individuale e collettiva, attraverso l'arricchimento del concetto di cittadinanza europea e dei diritti che ne derivano; - la lotta ai fenomeni criminali (terrorismo e traffico di droga), applicando metodi comuni riguardanti il rafforzamento della cooperazione negli affari interni e nella giustizia. Lo stesso metodo comunitario è stato inoltre proposto per affrontare il problema dell'emigrazione; - il rispetto dei livelli decisionali. È emersa l'importanza primaria del problema dell'adattamento delle istituzioni attraverso meccanismi e procedure da seguire nel futuro, in modo tale da adeguarle alle necessità dell'integrazione dando così la possibilità all'Unione di affermare la propria identità esterna. Il tema dell'occupazione è stato il problema centrale del Consiglio Europeo e si è potuto constatare che la creazione dei posti di lavoro rappresenta l'obiettivo principale per tutto il mondo politico europeo. Riguardo a questa scottante e grave questione, il Consiglio Europeo ha preso in considerazione tutti i lavori presentati dagli Stati membri, il più recente dei quali è il Memorandum francese sul modello sociale europeo. Dall'analisi della gravità del problema è emerso che si dovrà procedere ad un patto europeo di fiducia (promosso dal Presidente Santer alla Commissione), riguardante esclusivamente l'occupazione, da realizzarsi attraverso la crescita economico-industriale e l'incremento della competitività. Questo patto potrà comportare, in seguito, una revisione delle prospettive finanziarie. Il tema dell'occupazione, come si vedrà meglio nel successivo paragrafo, è stato uno degli argomenti centrali discussi nel Consiglio Europeo di Firenze, alla luce delle esperienze già individuate dai rispettivi Capi di Stato e di Governo nelle precedenti riunioni tenutesi a Essen, Cannes e Madrid. A questo proposito sono state avviate azioni comunitarie per stimolare gli investimenti pubblici e privati nelle infrastrutture, nella ricerca, nell'innovazione tecnologica e nella formazione, tutti settori potenzialmente creatori di lavoro. Il Ministro Agnelli ha inaugurato la Conferenza Intergovernativa per la revisione dei Trattati richiamando le priorità fissate nelle conclusioni del Consiglio Europeo e anticipando sommariamente gli obiettivi italiani approvati di recente dal Governo. Il Primo Ministro Major, dopo aver espresso la sua preoccupazione circa la grave situazione creatasi per l'economia del Regno Unito a seguito della diffusione illimitata di notizie allarmanti, e non del tutto accertate dal punto di vista scientifico, concernenti l'epidemia di encefalopatia spongiforme, derivata dalla consumazione di carni bovine infette provenienti dalla Gran Bretagna, ha sensibilizzato i partecipanti ad affrontare il problema a livello europeo e non strettamente nazionale. Questa argomentazione è stata appoggiata, nella conferenza stampa finale, dal Presidente del Consiglio Dini e dal Presidente della Commissione Santer. Il Cancelliere Kohl ha richiamato l'attenzione sul rispetto del principio di sussidiarietà e sull'alleggerimento degli oneri di rilevazione statistica che alcune norme comunitarie pongono a carico di piccole e medie imprese. Nel complesso, è comunque emersa la preoccupazione manifestata dai vari ministri degli Esteri di non riuscire nella attuazione di quanto avviato. Il Ministro Kinkel ha sottolineato l'aspirazione tedesca a realizzare un'Europa federale composta da Stati e regioni che, pur nella loro comunanza, mantengano vive le rispettive peculiarità. Ha espresso inoltre la volontà del popolo tedesco di assumersi le proprie responsabilità europee e ha formulato proposte circa l'ampliamento della UE, l'estensione del voto a maggioranza e la creazione di una politica estera e di sicurezza comune. Il Ministro Charette ha delineato quattro punti fondamentali: - il mantenimento, nell'ambito del processo di integrazione, della "natura federale" dell'Unione, evitando
------------------------------ © Servizio per le informazioni e la Sicurezza Democratica ------------------------------

che questa degeneri in una semplice area di libero scambio; - la creazione dell'identità del cittadino europeo garantendogli la sicurezza interna; - l'introduzione di meccanismi di flessibilità in materia economica per i paesi partecipanti all'Unione europea, in maniera tale da non creare paralisi o avanzamenti troppo lenti nel processo di integrazione, anche in considerazione della realtà politica ed economica internazionale. I paesi scandinavi hanno privilegiato le tematiche ambientali e occupazionali, mentre i paesi del BENELUX hanno proposto l'introduzione di normative che garantiscano l'equilibrio tra le istituzioni all'interno di tutti i paesi. Il Portogallo e l'Irlanda hanno richiamato la necessità della solidarietà nella realizzazione dell'Unione europea. Il ministro Westendorp, che ha anche l'incarico di Presidente del Gruppo di Riflessione, omaggiato per il suo contributo pluriennale in favore della costituzione dell'Europa unita, ha affermato la volontà della Spagna di continuare a sostenere la politica di integrazione. Dopo l'intervento dei ministri degli Esteri appartenenti all'Europa Centrale e Orientale, nonché di Malta e Cipro, il Ministro Agnelli ha espresso la volontà della Presidenza italiana di tenere informati tutti i paesi candidati all'adesione sullo sviluppo dei futuri negoziati e di fare affidamento sul sostegno dei 15 sulla revisione del Trattato. C'è da segnalare che, in concomitanza con l'inizio del Consiglio Europeo e della Conferenza Intergovernativa, a Torino hanno avuto luogo anche incontri e manifestazioni di carattere sociale, culturale e imprenditoriale ai quali hanno preso parte anche il Ministro Agnelli e l'ambasciatore Ferraris. L'ampia partecipazione alle manifestazioni svoltesi nella città ha confermato l'interesse dell'Italia al problema europeo e ha contribuito anche al successo della Conferenza sotto il profilo organizzativo e logistico. A chiusura del Consiglio Europeo di Torino, i candidati all'adesione alla UE (i Paesi dell'Europa Centrale, Orientale e mediterranea) sono stati invitati a partecipare allo scopo di essere informati dei lavori della Conferenza. Sebbene il lavoro svolto del Consiglio Europeo di Torino sia stato proficuo e caratterizzato da proposte ambiziose, si è allo stesso tempo realisti nel pensare che non sarà affatto facile rispettare l'impegno di concludere il negoziato in un così breve tempo, ossia entro il primo semestre del 1997.
8. Il Consiglio Europeo di Firenze Il Consiglio Europeo, svoltosi a Firenze il 21 e 22 giugno scorsi, che ha, tra l'altro, concluso il semestre di presidenza italiana dell'Unione europea, ha affrontato alcune delle tematiche delineate nei paragrafi precedenti, fissando le basi e delineando i princìpi che dovranno guidare la prosecuzione dei lavori per la riforma del trattato di Maastricht, che si terranno nel corso della presidenza irlandese prima, e olandese poi, e che dovranno concludersi entro la primavera del 1997. Va evidenziato, in primo luogo, quello che è stato da diversi commentatori definito il "piccolo capolavoro diplomatico" del governo italiano, consistente nel successo ottenuto nel raggiunto accordo con il governo inglese circa il problema della cd. "mucca pazza". È stato infatti ribadito che la tutela della salute dei cittadini comunitari costituisce il primo obiettivo dell'Unione e pertanto è stato stabilito che l'embargo sulle carni provenienti dalla Gran Bretagna verrà sospeso da parte degli altri paesi dell'Unione solo gradualmente e a seguito dei controlli effettuati dalla UE e in particolare del Comitato veterinario dell'Unione. Analoga sospensione avrà luogo, per tappe successive, sulle merci dirette ai paesi del Terzo Mondo. Per quanto concerne l'unione economica e monetaria, è stato raggiunto un accordo intorno ad un cd. "patto di stabilità", in base al quale gli Stati membri si sono impegnati ad evitare i disavanzi eccessivi del bilancio pubblico e a considerare la soglia del 3% rispetto al PIL, fissata a Maastricht, come limite massimo che potrà essere superato solamente in casi del tutto eccezionali e temporanei. È stata rinviata al vertice europeo straordinario, che si terrà a Dublino il prossimo ottobre, la definizione delle sanzioni che il Consiglio potrà comminare agli Stati membri che non dovessero attenersi a tale "patto". In proposito, è stata ribadita la necessità di procedere ad un'integrazione differenziata, secondo la quale avanzeranno nel cammino dell'Unione economica e monetaria quei paesi che saranno in grado e vorranno farlo, stabilendo procedure e condizioni per l'ammissione di quegli Stati che vorranno aderire successivamente. In ogni caso, anche questi ultimi dovranno adottare le proprie decisioni di politica economica e monetaria, tenendo conto che si tratta di questioni di carattere e interesse comune.
------------------------------ © Servizio per le informazioni e la Sicurezza Democratica ------------------------------

Mentre è stato ribadito, nel rapporto presentato dai Ministri finanziari della UE, che la stabilità dei prezzi, unitamente a solide politiche monetarie e di bilancio, costituisce la premessa fondamentale per garantire la stabilità dei tassi di cambio e per poter quindi procedere alla creazione dell'EURO, sono stati confermati i parametri fissati a Maastricht, da raggiungere comunque entro il 1997, laddove si è invece convenuto sulla necessità di ritardare i tempi di attuazione dell'Unione economica e monetaria. L'avvio della moneta unica dovrebbe quindi aver luogo a partire dal 1° gennaio 1999. Sono inoltre state tracciate le linee essenziali di quello che è stato definito lo "SME 2", ossia il meccanismo che regolerà i rapporti di cambio tra l'EURO e le monete nazionali che in primo momento rimarranno escluse dall'unione monetaria. Secondo il rapporto presentato dai Ministri finanziari della UE, la partecipazione allo "SME 2" avverrà su base volontaria e dovrà prevedere, per le monete che ne faranno parte, margini di fluttuazione piuttosto ampi al fine di evitare manovre speculative. Lo "SME 2" costituirà in ogni caso il "passaggio obbligato" per i paesi che di volta in volta decideranno di aderire all'unione monetaria. Pertanto è stato affidato al Consiglio Ecofin, congiuntamente al Comitato economico e finanziario, alla Commissione e alla BCE, il compito di svolgere un'attività di controllo e accertamento sulle politiche dei tassi di cambio dei paesi non partecipanti all'unione monetaria, anche al fine di evitare distorsioni e ripercussioni sul mercato unico. In vista del vertice di Dublino, il Consiglio, l'IME e la Commissione sono attualmente inpegnati a definire: - gli elementi principali del rapporto che caratterizzerà i paesi partecipanti all'unione monetaria e quelli che invece ne resteranno momentaneamente esclusi; - la disciplina fiscale dei paesi che parteciperanno fin dall'inizio alla terza fase della UEM; - lo stato giuridico dell'EURO, nonché il modello e la descrizione dettagliata delle banconote e delle monete; - il quadro normativo, organizzativo e logistico necessario al SEBC per svolgere le proprie funzioni. Altro tema discusso nel corso del vertice di Firenze è stato quello concernente la disoccupazione. Secondo la maggior parte dei commentatori, su questo fronte va riconosciuto il fallimento del Presidente della Commissione Santer, sostenuto dal Presidente Prodi, di rilanciare un piano europeo di lotta alla disoccupazione. Il "patto di fiducia" proposto da Santer era infatti finalizzato ad ottenere dai Quindici lo stanziamento di circa 27.000 miliardi di fondi comuni da utilizzare per interventi strutturali a sostegno dell'occupazione negli Stati membri. In particolare, si proponeva il finanziamento di reti transeuropee di trasporti e telecomunicazioni finalizzate al rilancio della crescita economica e pertanto alla creazione di nuovi posti di lavoro. Tale proposta sembra essere stata, di fatto, ostacolata soprattutto dal cancelliere Kohl, il quale ha sostenuto la necessità di affrontare tale classe di problemi, non tanto a livello macroeconomico, con interventi "di tipo keynesiano", quanto piuttosto su base microeconomica, su scala nazionale o regionale. La stabilità e la riduzione dell'inflazione sono, secondo Kohl, i migliori strumenti di politica sociale. La decisione sullo stanziamento dei fondi a sostegno delle reti transeuropee e dell'occupazione è stata pertanto rinviata alle decisioni dei ministri finanziari, che, tuttavia, già da diverso tempo, hanno assunto una posizione contraria a tale tipo di interventi comunitari. Al Consiglio Europeo si è altresì raggiunto, con il consenso di tutti i paesi membri riuniti a Firenze, esclusi i britannici, un accordo molto importante in materia di sicurezza internazionale: la creazione dell'FBI dell'Unione Europea. Per tutti, la convenzione su "Europol" ha costituito un passo avanti nella istituzione di un organismo di polizia comunitario, nel rispetto del termine del giugno 1996, stabilito l'anno scorso a Cannes. Finora "Europol" era attiva solo come unità antidroga, con sede a L'Aja, e con funzioni di scambio di dati su persone e reati legati al narcotraffico. In futuro "Europol" avrà invece una competenza ad ampio raggio: dai furti al traffico di materiale nucleare, dalla lotta all'immigrazione clandestina alla prevenzione del terrorismo. La controversia sorta con la Gran Bretagna, che ha determinato il ritardo nella definizione dell'accordo, è stata superata ribadendo il riconoscimento della Corte di giustizia europea di Lussemburgo quale foro competente per tutte le controversie legate all'interpretazione e all'applicazione della convenzione su "Europol", stabilendo tuttavia un meccanismo di opting out che riconosce al Regno Unito la possibilità di sottrarsi alla Corte di giustizia per eventuali dispute, afferenti alla convenzione "Europol", tra Stati o tra Stati e cittadini. Per quanto concerne, infine, le questioni istituzionali, ogni decisione è stata rinviata al vertice straordinario
------------------------------ © Servizio per le informazioni e la Sicurezza Democratica ------------------------------

dei Quindici che si terrà a Dublino in ottobre sotto la presidenza irlandese. A conclusione del semestre di presidenza dell'Unione, il Governo italiano ha presentato un rapporto che, oltre a fornire un quadro di questa prima fase della CIG, potrà costituire una valida griglia di riferimento che sarà sviluppata e arricchita solamente qualora verrà definita una ben precisa volontà politica da parte dei Paesi membri dell'Unione di realizzare gli ambiziosi obiettivi fissati a Maastricht. (1) L'art. 2 del trattato stabilisce che "La comunità ha il compito di promuovere, mediante l'instaurazione di un mercato comune e il graduale ravvicinamento delle politiche economiche degli Stati membri, uno sviluppo armonioso delle attività economiche nell'insieme della Comunità, un'espansione continua ed equilibrata, una stabilità accresciuta, un miglioramento sempre più rapido del tenore di vita e più strette relazioni fra gli Stati che ad essa partecipano". (2) L'articolo B, Titolo I, delle "Disposizioni comuni" stabilisce che l'Unione si prefigge come obiettivo da conseguire "promuovere un progresso economico e sociale equilibrato e sostenibile, segnatamente mediante la creazione di uno spazio senza frontiere interne, il rafforzamento della coesione economica e sociale e l'instaurazione di un'unione economica e monetaria che comporti a termine una moneta unica, in conformità delle disposizioni del presente trattato". A tal fine si ritiene necessario "uno sviluppo armonioso ed equilibrato delle attività economiche nell'insieme della Comunità, una crescita sostenibile, non inflazionistica e che rispetti l'ambiente, un elevato grado di convergenza dei risultati economici, un elevato livello di occupazione e di protezione sociale, il miglioramento del tenore e della qualità della vita, la coesione economica e sociale e la solidarietà tra gli Stati membri" (Art. 2, Titolo II), nonché "una politica commerciale comune; un mercato interno caratterizzato dall'eliminazione, fra gli Stati membri, degli ostacoli alla libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali; un regime inteso a garantire che la concorrenza non sia falsata nel mercato interno; il ravvicinamento delle legislazioni nazionali nella misura necessaria al funzionamento del mercato comune" (Art. 3, Titolo II). (3) Crf. articolo pubblicato sul Corriere della Sera del 14.1.1996. (4) Ministri degli Esteri dei 15 Stati della UE, di Malta, Marocco, Tunisia, Algeria, Egitto, Israele, Libano, Siria, Giordania e Mauritania, nonché Yasser Arafat.
------------------------------ © Servizio per le informazioni e la Sicurezza Democratica ------------------------------

Leonardo MAZZA - La acquisizione di informazioni riservate: diritto alla privacy e diritto alla notizia
1. Dall'epoca in cui, nel 1890, apparve nella Harvard Law Review il lavoro di due noti avvocati bostoniani, Warren e Brandeis, dal titolo "The right to Privacy", il diritto alla riservatezza della vita privata è stato oggetto di raffinate elaborazioni dogmatiche, anche se nella nostra esperienza giuridica si è pervenuti con ritardo a delineare i tratti precisi di una organica Geheimnissphäre. Soltanto qua e là voci isolate, prima di assistere, a partire dagli anni cinquanta, ad un rovesciamento di tendenza, ad un totale ribaltamento della situazione in conseguenza di palpabili aggiornamenti tecnologici, talora devastanti, che hanno determinato un vero e proprio assault on privacy. Il che ha portato la dottrina a saggiare ogni aspetto dell'informazione e degli strumenti di raccolta di dati ritenuti rilevanti, in maniera da contenere una progressiva invasività del privato che, soprattutto nell'ultimo decennio di questo secolo, non trova nel passato alcun paragone; ragione per cui oggi non deve apparire provocatorio domandarsi entro quali limiti possa configurarsi un "diritto alla notizia" che, se può trovare una barriera nella tutela dell'altrui riserbo, non la incontra di certo in astratto, ma in funzione del contenuto della informazione trasmessa e, pertanto, nella misura complessiva degli interessi dalla medesima implicati. Non a caso Elias Canetti scrive che "la parola libertà serve ad esprimere una tensione importante. L'uomo vuole sempre andare via, e se il luogo dove si vuole andare non ha nome, se è indefinito, senza confini, allora si chiama libertà". Il diritto di essere informati, per inerire anche ad argomenti di vitale interesse, e fra essi alle vicende attinenti all'esercizio del potere pubblico, soddisfa, dunque una esigenza di rilievo costituzionale - pur se non azionabile nelle sedi giudiziarie - e postula perciò un pluralismo che appaghi le pretese dell'utente. E proprio in vista di porre un argine a quel diritto, attorno al tema della libertà, si è costruita in dottrina una opinione ormai largamente dominante circa l'esistenza nel nostro sistema di una tutela generale della privacy che, pertanto, non può più considerarsi circoscritta a specifici aspetti (segretezza della corrispondenza e delle comunicazioni, tutela dell'immagine e così via), espressamente disciplinati da singole disposizioni di legge. Di certo la nostra Costituzione non muove da un concetto "funzionale" della libertà di pensiero, poiché non bada tanto ai contenuti, ma al procedimento del dialogo e del dibattito in contraddittorio; non è cioè una tale libertà orientata ad un fine, ma all'utile, pur se non appare possibile scorgere poi all'interno della Carta fondamentale una scala di valori e operare, quindi, un bilanciamento fra beni tutelati, anche allorché vengano attinti i valori di vertice come la dignità umana (che si ricollega alla c.d. Intimsphäre), i quali comportano un aumento del Kontrolldichte. Il diritto alla privatezza è solitamente descritto in chiave negativa, più che in positivo: non ingerenza dei poteri normativi, amministrativi e giurisdizionali in una sfera propria ed esclusiva dell'uomo e della sua spontanea socialità, non divulgazione di notizie concernenti la propria persona ed anche di ciò che di per sé non rientra nella sfera del lecito, fuori dalla stretta necessità di servire un interesse pubblico. Ma l'interprete non può accontentarsi di questa visione: deve anche spingere lo sguardo più a fondo per cogliere i profili della privatezza, ossia di ciò che pertiene all'individuo e non alla collettività in generale, in termini positivi. Ed allora ci si avvede della presenza del diritto all'oblio, vale a dire a non veder rievocati avvenimenti pubblici nei quali il singolo è stato in passato implicato (fuori da un interesse pubblico attuale), o addirittura a cambiar vita, ad essere un altro o ad essere lasciato "solo". 2. In questo quadro d'insieme deve essere affrontato e risolto il problema circa la individuazione dei limiti entro i quali i Servizi d'informazione e sicurezza, regolamentati dalla legge 24 ottobre 1977 n. 801, hanno il diritto di acquisire informazioni riservate concernenti attività istituzionali o la sfera privata di singoli cittadini. Nella Relazione del Comitato parlamentare per i servizi di informazione e sicurezza e per il segreto di Stato, trasmessa ai Presidenti dei due rami del Parlamento il 5 marzo 1996, viene espressamente affermato che i limiti in questione "sono fissati in rapporto alle finalità stesse dei Servizi, così come la legge le determina, oltre che in rapporto al fondamentale dovere di fedeltà alla Costituzione". Se, dunque, vengono raccolte
------------------------------ © Servizio per le informazioni e la Sicurezza Democratica ------------------------------

informazioni riservate che periodicamente affluiscono agli apparati di intelligence, non attinenti alla integrità dello Stato, alla difesa della sua indipendenza ed alla sicurezza dell'ordinamento democratico contro ogni forma di eversione, l'acquisizione di tali informazioni "è in contrasto con i compiti istituzionali ed è perciò illegittima". Questo principio, icasticamente enunciato nella premessa, è poi più volte ribadito nel corso dell'elaborato ed in diversi punti, sotto differenti profili; viene espresso il convincimento che "la natura" delle informazioni concernenti aspetti della vita privata delle persone e la non corrispondenza ai fini istituzionali del Servizio rendono le stesse illegittimamente acquisite. In altri brani della citata Relazione si riferisce che il Governo è stato sollecitato ad una rigorosa vigilanza sugli archivi dei Servizi, per accertare se vi fossero tracce di deviazioni dai compiti istituzionali ed un'illecita strumentalizzazione delle informazioni coperte dal riserbo, come il Comitato ha ritenuto si sia verificato nel caso della illegittima raccolta di notizie da non divulgare sulle indagini concernenti Tangentopoli e su alcuni magistrati della Procura di Milano, riconducibili alla produzione informativa della "Fonte Achille". L'acquisizione di tali informazioni, sostiene il Comitato, appare del tutto estranea ai compiti istituzionali del SISDe: non solo, ma nel prosieguo della Relazione, viene inoltre sostenuto che, in caso di acquisizione da una fonte confidenziale di notizie riservate non pertinenti agli scopi istituzionali, la soluzione giusta da adottare sarebbe quella di distruggerle e l'atteggiamento da adottare nei confronti della fonte medesima sarebbe quello di disattivarla o di orientarla in altra direzione. Nel citato documento si pone anche l'accento sulla illegittima finalizzazione delle informazioni riservate acquisite sul conto dei magistrati della Procura di Milano, destinate alla apertura di dossiers che servivano a delegittimarli e, quindi, sull'uso distorto e ricattatorio di notizie di interesse istituzionale (attività di dossieraggio sfruttata come illecito strumento di pressione). Un tal modo di argomentare suscita l'interesse all'approfondimento e alla discussione, specie quando evita di considerare il problema del bilanciamento tra interesse all'acquisizione e interesse alla diffusione della notizia riservata alla luce pure di taluni princìpi richiamati dalla nostra Costituzione anche al di là del suo articolo 21 che enuncia la libera manifestazione del pensiero. Sicché, per un corretto inquadramento della complessa tematica inerente alla organizzazione degli Archivi dei Servizi di informazione e sicurezza, secondo canoni di legalità e trasparenza, non può prescindersi da alcune considerazioni preliminari in ordine all'ambito di legittima esplicazione delle attività informative demandate ai predetti Servizi. 3. Non sembra revocabile il dubbio che ogni Stato democratico abbia il diritto di ricercare informazioni riservate e di acquisire notizie in qualsiasi modo rilevanti per la difesa della propria integrità e della sicurezza pubblica a prescindere dalla loro "verità". La salvaguardia di questi beni è infatti reclamata da qualsiasi società civile, sia pure oggi in un mutato contesto interno ed internazionale: l'informazione diviene così parte indispensabile dell'attività di prevenzione dello Stato rispetto ad eventi o ad atti di minaccia, che costituiscano un pericolo o addirittura una lesione dell'ordine costituzionale. Sinteticamente, senza scendere nei dettagli, dall'esame della intelaiatura del nostro sistema si ricava che questi obiettivi di fondo vengono raggiunti attraverso apposite strutture, deputate allo svolgimento dei cennati compiti informativi, da individuarsi nelle Forze di polizia (con le varie articolazioni, alle volte troppo complesse e tra le quali stenta a penetrare la cultura del coordinamento) e nei Servizi di informazione e sicurezza. Le prime spendono la loro attività nei settori della sicurezza pubblica e privata, traducentesi in talune limitazioni della sfera giuridica di libertà dei destinatari (in forme solitamente negative) e finalizzata al bene comune negli aspetti tradizionalmente riportati all'ordine pubblico, alla sicurezza pubblica, ai "boni mores", al corretto svolgimento della vita sociale ed alla prevenzione e repressione delle attività illecite, secondo le indicazioni contenute nell'art. 1 della legge 1° aprile 1981, n. 121. I servizi sono da collocarsi, invece, su un piano completamente diverso da quello tipico delle tradizionali Forze di polizia, la cui funzione preminentemente, pur se orientata, come detto, alla tutela delle istituzioni democratiche, persegue soprattutto obiettivi di prevenzione e repressione dei reati. 4. Le peculiarità dell'attività di intelligence dei Servizi sono scandite dagli artt. 4 e 6 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, che additano l'ambito finalistico in cui devono operare nella tutela della sicurezza interna ed esterna dello Stato, concepita come interesse della comunità nazionale unitariamente intesa alla propria integrità territoriale, alla propria indipendenza ed alla sua stessa sopravvivenza.
------------------------------ © Servizio per le informazioni e la Sicurezza Democratica ------------------------------

Più in particolare, l'azione di intelligence, quale processo articolato di raccolta, analisi e valutazione di notizie utili alla formulazione e definizione dell'iter decisionale dell'Esecutivo - notizie non disponibili se non attraverso una capillare ricerca e penetrazione in aree sensibili o in ambienti resi interessanti dalla particolare e peculiare evoluzione della congiuntura storica - è preordinata al raggiungimento di uno specifico obiettivo strategico, vale a dire di porre l'Esecutivo medesimo nelle migliori condizioni di svolgere (in virtù di un flusso costante di informazioni acquisite e poi analizzate su temi di rilevante valore contingente) la propria politica decisionale in merito alla sicurezza globale dello Stato, intesa così nella sua più ampia accezione di difesa del corpo sociale, dell'integrità territoriale, dell'economia e delle Istituzioni del paese. Certamente viene anche qui in primo piano una attività di prevenzione; ma il contenuto di una tale azione di intelligence è strumentale rispetto agli eventi od agli atti di minacce, pericolo o lesione della sicurezza dello Stato. Si tratta, a ben vedere, di una prevenzione strategica, in quanto l'anzidetta attività, pur svolgendosi ad ampio raggio, è mirata e deve, quindi, rivolgersi non necessariamente o non esclusivamente verso contesti ad alta e comprovata densità criminale, ma in direzione di ogni settore, ambiente e persona dai quali, in atto od in potenza, possano scaturire problemi per la sicurezza dello Stato, non sempre inquadrati o rapportabili a concrete ipotesi di reato: nell'attuale momento storico ogni aerea del sociale, dell'economia e della politica è, infatti, potenzialmente portatrice di rischi e minacce per la sicurezza della compagine statuale. Nel progetto finalistico disegnato dal legislatore del 1977 trova ampia giustificazione, anzi si radica, il diritto-dovere dei Servizi di indagare e sorvegliare persone sospette dovunque esse abbiano ad agire e ad operare: nell'ambito della delinquenza comune, della criminalità organizzata e di quella minorile (in continua e drammatica espansione e per troppo tempo trascurata), dello spionaggio militare ed economico o nei confronti di quanti si può temere che preparino attentati all'ordine democratico o azioni violente contro la struttura costituzionale dello Stato. Una penetrante ed incisiva attività di prevenzione è in questo senso sicuramente necessaria ed indispensabile: la stessa opinione pubblica non esiterebbe ad esprimere un severo giudizio di biasimo verso un governo che si lasciasse sorprendere, ad esempio, da un tentativo insurrezionale e che dovesse confessare di non avere avuto alcun sospetto e/o allertamento circa la sua preparazione. 5. Resta però da approfondire un profilo assai delicato: occorre individuare con nitidezza di contorni la linea di demarcazione tra l'attività lecita di raccolta di dati ed informazioni e l'attività illecita, in quanto contraria alle finalità descritte dal sistema normativo in vigore. Ebbene una tale linea va ravvisata nell'esistenza o non di una base sufficientemente ragionevole per sorvegliare un determinato ambito plurisoggettivo o soggettivo e per seguirne le varie attività, ivi comprese quelle relazionali intra moenia. In altri termini, la liceità di una siffatta attività informativa risiede nel ragionevole sospetto che l'avvenimento di cui ci si occupa ed i personaggi che vi sono implicati siano in effetti portatori di una minaccia per la sicurezza dello Stato. È ovvio che non possono essere indicati rigidi schemi astratti, in quanto la ragionevolezza del sospetto, che costituisce il punto nodale del discorso, muta da ambiente ad ambiente ed è relativizzato alle contingenze storiche del periodo in cui si opera ed anche perché nel connesso apprezzamento non può negarsi la sussistenza di un margine di discrezionalità. Una valutazione tale risente invero della soggettività dei giudizi di ciascun protagonista della vicenda, i quali sono espressione dei processi discrezionali interni attribuibili ai soggetti cui spetta determinare l'ambito delle attività in genere. Ma la discrezionalità alla quale si è fatto ora cenno non tracimerà mai nell'arbitrio se le concrete determinazioni operative si attengono alle linee direttrici che trovano la loro fonte normativa nella responsabilità delle autorità tassativamente individuate nella citata legge n. 801/1977 (Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministri competenti, Direttori dei Servizi). Perché l'estrinsecazione dell'attività dei Servizi in comportamenti formalmente rivestiti di illegalità (in tal senso l'indagine condotta nei confronti di taluno ben potrebbe configurare violazione di diritti protetti a livello costituzionale come la dignità della persona umana o la inviolabilità del domicilio) non risulti contrastante con l'assetto normativo vigente e con la filosofia della Carta fondamentale, non pare dubbio che essa debba vincolarsi all'esclusiva preservazione della comunità nazionale e della Costituzione. Il comportamento permeante l'azione informativa deve cioè essere strettamente indispensabile per la tutela del supremo interesse della sicurezza dello Stato, secondo un ragionevole rapporto di mezzo a fine. Il che
------------------------------ © Servizio per le informazioni e la Sicurezza Democratica ------------------------------

trova conforto e conferma nell'esame della giurisprudenza costituzionale, la quale ha ripetutamente ribadito, in una priorità di scala gerarchica dei valori, l'assoluta preminenza dei beni relativi alla sicurezza interna ed esterna dello Stato, tale da giustificare non solamente l'affievolimento di altri valori pure essi tutelati dalla Carta, ma anche da garantire, sulla base enunciata, una proporzione tra difesa ed indebolimento di interessi secondo un approccio definitorio-bilanciatorio. 6. Alla luce delle considerazioni che precedono, alcune esemplificazioni valgono a chiarire meglio i tratti di quella linea di demarcazione di cui si è sopra detto: possono scorgersi aspetti di illiceità nell'attività indagativa svolta su taluno, la quale invada la sua vita privata, nel caso in cui non sussista alcun fondato indizio per ritenere che quella determinata persona si proponga di infrangere le leggi o di mettere a repentaglio la sicurezza dello Stato. In una siffatta ipotesi non sarebbe, invero, ravvisabile alcuna finalità pubblica di prevenzione che renda compatibile con il sistema determinate forme di attività dei Servizi di sicurezza, formalmente classificabili quindi, come "illecite" alla stregua dell'ordinamento vigente. Ma occorre scendere ancor più nel particolare ed appuntare l'attenzione su di un aspetto di basilare importanza: bisogna, cioè, esaminare i due distinti momenti in cui si articola la ricerca informativa da parte dei Servizi. Si tratta della raccolta delle notizie e del successivo uso delle stesse. Anche qui non può procedersi per rigide schematizzazioni: è sempre necessario avere presente la singola vicenda per potersi correttamente orientare. Sicché, nel caso di indagine giustificata, gli organi operativi ad essa preposti non possono limitarsi a scandagliare un solo aspetto che riguarda la vita relazionale dell'interessato. Da una indagine allargata potrebbero, infatti, emergere risultanze che non rilevano neanche indirettamente per i fini istituzionali dell'Ente, in quanto non toccano la persona pubblica e la minaccia di sue non inverosimili o prossime attività illegali, non concernono cioè la pericolosità dell'uomo, così come al contrario potrebbero affiorare elementi o dati di interesse per gli anzidetti scopi anche in vista dell'attivazione di ulteriori indagini, fermo restando in ogni caso il divieto di una loro divulgazione. Attesa la stretta connessione fra la sottoposizione di taluno a particolare sorveglianza e ad attività informativa e le finalità di tutela del supremo interesse della sicurezza dello Stato, ne deriva che l'utilizzazione delle notizie raccolte nel contesto dell'esempio sopra riportato, è, nella prima ipotesi, rigorosamente preclusa all'Amministrazione: quelle notizie non possono dar luogo a provvedimenti, iniziative, vincoli o condizionamenti per l'Amministrazione medesima, né tantomeno possono ricevere pubblicità. Diversamente si configurerebbe un abuso, e quindi un illecito. È questa, in buona sostanza, la conclusione cui pervenne lo Jemolo tanti anni orsono quando sottolineava che colui il quale guardi alla realtà delle cose ritiene impossibile negare allo Stato una attività di prevenzione, che implica anche la necessità di compiere indagini riservate: la libertà non la si difende non volendo misure eccezionali in presenza di situazioni eccezionali, ma segnando per tempo le vie secondo cui dovrà svolgersi l'azione dello Stato in queste ipotesi, anziché lasciare il tutto all'improvvisazione del momento entro cui, nel nome della salus publica, suprema lex possono compiersi i peggiori arbitri, a meno di non volersi rassegnare con Popper a ritenere che la migliore forma di limitazione in materia risulta soltanto dalla responsabilità dell'uomo che agisce. La Relazione del Comitato parlamentare prospetta in chiave propositiva l'esigenza di dar corso alle riforme da esso in precedenza formulate in data 6 aprile 1995, evidenziando che, per individuati oggetti di indagine, il Comitato sia dotato di poteri che l'art. 82 della Costituzione riconosce alle Commissioni parlamentari d'inchiesta, vale a dire che venga equiparato a tali fini all'autorità giudiziaria. Non è peraltro chi non veda come l'attribuzione di siffatti poteri, sia pure opportunamente mirata per settori, costituisca un grave attentato alla autonomia di cui necessariamente debbono essere muniti i Servizi per poter svolgere la loro attività a vantaggio e nell'interesse della collettività nazionale, specie quando fosse riconosciuto un potere di controllo (oltre che sulla responsabilità politica dell'esecutivo) anche sulla gestione tecnica. Non da ora si è detto che il profilo della tutela della riservatezza richiama necessariamente il più generale tema della persona umana: non è un atto di fede, ma un convincimento che non necessita di particolari dimostrazioni, tanto palese è la sua evidenza. Con l'esprit de finesse, tipica dei giansenisti di Port Royal, può ben ripetersi che: "toute la dignitè de l'homme est en la pensée"; guai, però, a non accorgersi per tempo che l'uomo è la più fragile delle canne, ma è una canna pensante e, come ha scritto Pascal, quand'anche l'universo lo volesse schiacciare, egli sarebbe più nobile di colui che tenta di farlo, perché mentre l'universo nulla conosce, l'uomo ha consapevolezza di stare per morire.
------------------------------ © Servizio per le informazioni e la Sicurezza Democratica ------------------------------

Onorato SEPE - Aspetti procedurali del giudizio di responsabilità
(*) Il sistema dei controlli amministrativi delineato dagli artt. 100, 125 e 130 della Costituzione, nel confermare il tradizionale controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti sugli atti del Governo, ha attribuito a quest'organo anche il controllo successivo sulla gestione del bilancio dello Stato e quello sull'attività finanziaria degli enti pubblici. Tale sistema, tuttavia, improntato ancora ad una concezione formalistica dell'attività di controllo, volta soprattutto alla funzione della mera verifica di conformità alla legge e trascurando di fatto lo sviluppo di controllo sui risultati, ha mostrato crescenti limiti a fronte della rapida evoluzione dell'Amministrazione degli ultimi decenni. Questa ha visto, da un lato, un progressivo decentramento di funzioni e il corrispettivo moltiplicarsi dei centri di spesa, dall'altro la sempre più spiccata centralità del momento finanziario rispetto a quello meramente amministrativo nell'attività dello Stato e degli enti pubblici. Pertanto, si sono susseguiti nel tempo interventi normativi e ipotesi di riforma che, in mancanza di una globale revisione del sistema dei controlli, hanno tentato di adeguare progressivamente il sistema alle nuove esigenze. La questione ha assunto uno specifico rilievo quando il problema dei controlli, con particolare riferimento alla loro carenza, ha messo a nudo la difficoltà di garantire l'Amministrazione dalle interferenze dei partiti politici e dalla corruzione di amministratori e funzionari. Ove si presti attenzione ai recenti diffusi fenomeni di corruzione, c.d. "Tangentopoli", che hanno così profondamente inciso sul buon andamento e la trasparenza dell'attività della pubblica amministrazione e coinvolto numerosi soggetti ricoprenti alti livelli istituzionali, evidenziando il ruolo di supplenza svolto dalla Magistratura penale, non può trascurarsi il rischio di pericolo che può derivarne per la sicurezza nazionale. Per queste ragioni, uno sguardo sull'evoluzione di questi temi può essere interessante anche per la nostra rivista. Con la legislazione degli ultimi anni si è cercato, dunque, di orientare il sistema dei controlli, dall'area, prima predominante, del controllo "preventivo di legittimità" a quello "successivo della gestione", individuando strumenti, modelli e parametri in linea con la crescente domanda di controlli moderni ed efficienti per arginare da un lato la corruzione degli amministratori in favore del principio di trasparenza della pubblica amministrazione, dall'altro per assicurare una corretta gestione delle risorse. In tale ambito, importanza decisiva riveste la recente riforma che ha decentrato la Corte dei conti su base regionale, introducendo nuovi e più efficaci strumenti funzionali al controllo preventivo di legittimità, nonché a quello successivo del bilancio e del patrimonio dello Stato, indirizzo che potrà trovare anche specifico rilievo in un rinnovato quadro di rapporti tra istanze centrali dello Stato e autonomie.
1. L'obbligo di denuncia In occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario 1996 il Procuratore generale della Corte dei conti ha sottolineato che il contenzioso contabile ha subito una trasformazione rivoluzionaria non solo per il decentramento dell'organo giudicante e di quello requirente ma anche per le sostanziali modifiche normative dei procedimenti istruttori di competenza delle sezioni regionali. Contemporaneamente anche gli organi centrali preesistenti hanno trovato un assetto diverso: le sezioni riunite, le sezioni ordinarie divenute di appello, la stessa procura generale hanno assunto dimensioni e assegnate funzioni differenti. In particolare si è accentuato l'indirizzo a favorire il coordinamento dell'intero apparato ed il tentativo di garantire una continuità giurisprudenziale e l'equilibrio fra le pronunce provenienti ormai da venti differenti sedi regionali. Come si è già avvertito è il procuratore regionale che oggi esercita il potere di iniziativa nei giudizi di responsabilità in base alle notizie di fatti dai quali possono emergere danni per i soggetti pubblici addebitabili ad amministratori ovvero a dipendenti. La procura, come in passato, può attingere informazioni
------------------------------ © Servizio per le informazioni e la Sicurezza Democratica ------------------------------

da qualsiasi fonte, quindi anche da notizie stampa o da denunce di privati. La prevalente fonte normativa rimane tuttavia l'art. 53 del t.u. 1934, n. 1214, cui occorre aggiungere l'art. 83 del r.d. 18 novembre 1923, n. 2440 e l'art. 20 del t.u. 10 gennaio 1957, n. 3. Tali precetti impongono, nell'ambito dell'organizzazione statale, un obbligo di denuncia a carico di funzionari dirigenti che vengano a conoscenza di fatti dannosi direttamente ovvero a seguito di rapporti di loro dipendenti; se l'accertamento deriva da una ispezione è lo stesso ispettore che dovrà provvedere alla denuncia alla procura (art. 12 d.p.r. 30 giugno 1972, n. 7489). Si tratta di precetti che sono venuti assumendo, anche per la spinta pretoria della giurisdizione, un profilo che li fa considerare applicabili a tutto il settore pubblico. Per le regioni vi è una previsione specifica contenuta nell'art. 32 della l. 19 maggio 1976, n. 335 che impone tale obbligo di denuncia a carico di amministratori e funzionari dirigenti. Ovviamente allorché le norme prevedono l'obbligo di denuncia l'omissione comporta una responsabilità di soggetti obbligati nel caso di dolo o colpa grave, e, nel caso di ispettori, anche per l'omessa rilevazione di irregolarità. Con l'art. 1, 3° comma della l. n. 20 del 1994 si è stabilito che ove si verifichi, per il soggetto pubblico, la prescrizione del diritto al risarcimento del danno, derivante proprio per effetto dell'omissione o di ritardo nella denuncia del fatto, i soggetti responsabili dell'omissione o del ritardo della denuncia rispondono anche del danno erariale verificatosi. L'azione del procuratore è proponibile entro i cinque anni dalla data in cui è maturata la prescrizione. Indubbiamente tale disposizione viene a porre a carico di coloro che sia pure per colpa o per comportamento doloso non hanno rispettato l'obbligo di effettuare, entro i termini previsti, la regolare denuncia, una non lieve responsabilità di un evento dannoso al quale sono rimasti estranei. Ciò confermerebbe che nel processo contabile la finalità di prevenzione ed il profilo sanzionatorio sono nettamente caratterizzati e non secondari come nella responsabilità civile a cui per decenni la giurisprudenza ha voluto accomunare il processo dinanzi alla Corte dei conti. (1)
2. L'iniziativa processuale e l'invito a dedurre L'iniziativa processuale nel giudizio di responsabilità, diversamente dal processo di conto caratterizzato dall'automaticità, parte dalla citazione in giudizio fatta dal procuratore regionale. Prima della notificazione l'atto viene trasmesso al presidente della sezione il quale, con propria determinazione, apposta in calce, fissa la data dell'udienza di discussione ed il termine entro il quale le parti possono costituirsi, prendere visione degli atti e presentare memorie. Deve avvertirsi che nella legislazione recente vi è una novità di rilievo rispetto alla situazione precedente. L'art. 5 del d.l. n. 453 del 1993, convertito nella legge 14 gennaio 1994, n. 19, ha introdotto l'invito a dedurre che ha dato luogo nelle prime pronunce giurisprudenziali a conclusioni contrastanti. La sezione siciliana (23 marzo 1994, n. 38) ha ritenuto che si tratti di un presupposto processuale la cui mancanza comporta l'impossibilità dell'instaurazione del giudizio (tesi che oggi sembra la più accoglibile) mentre la sezione per la Sardegna (12 marzo 1994, n. 116) ha ritenuto che la mancata formulazione dell'invito prima della rituale notifica dell'atto di citazione non possa portare alla nullità della citazione per inammissibilità della domanda. Ad avviso della sezione le nullità devono essere tassativamente indicate e, nella specie, l'istituto dell'invito non appare strettamente attinente alla tutela del diritto di difesa. Sostanzialmente conforme alla tesi della sezione sarda STADERINI il quale osserva che lo scopo della norma non sembra essere quello di avvertire formalmente il chiamato in giudizio quanto quello di informarlo allo scopo di evitare l'inizio di un processo a suo carico se egli può dimostrare senza ombra di dubbio la sua estraneità di fronte al fatto contestato dal procuratore. (2) In qualche decisione si parla dell'avviso come di uno strumento di garanzia e collaborazione (sez. II, 16 maggio 1994, n. 123; id. sezione Lazio, 17 novembre 1994, n. 25); ovvero come strumento di garanzia dell'inquisito (sezione Lombardia, 24 marzo 1994, n. 31); ovvero come semplice mezzo di conoscenza che il procuratore regionale acquisisce nell'interesse della giustizia e del destinatario dell'invito (sez. Veneto, 2 marzo 1994 n. 8). In uno scritto sull'argomento, che ripete il contenuto della decisione n. 123 del 1994 della sezione per il Lazio, si cerca di meglio qualificare la natura e la portata dell'avviso di garanzia. Non si tratta di un atto avente la funzione di rendere edotto un cittadino del fatto che si inizia una indagine a suo carico. Nel giudizio risarcitorio dinanzi alla Corte dei conti l'invito non è un avviso che viene inviato prima di effettuare
------------------------------ © Servizio per le informazioni e la Sicurezza Democratica ------------------------------

una indagine preliminare ma un momento diverso, quando si sono già individuati i fatti considerati dannosi e si sono riscontrati degli elementi di responsabilità a carico di qualcuno. "La funzione dell'invito non consiste nell'avvertire l'agente di amministrazioni pubbliche che si inizia una indagine che lo riguarda". L'invito si indirizza ad un soggetto che è stato già indagato e che si appalesa come probabile danneggiante. La funzione dell'invito è quella di contestare specifici fatti, determinati in tutti i loro elementi costitutivi, qualificati come fatti dannosi, dando la possibilità di dedurre in ordine agli stessi. (3) In realtà la collocazione dell'avviso nel processo contabile, nel quale non esiste, come invece è nel processo penale, il giudice per le indagini preliminari al quale il procuratore chiede il rinvio a giudizio, costituisce un ibrido. Non si può dire che esso abbia una mera funzione di informazione perché il presidente della sezione, allorché riceverà l'atto di citazione da notificare potrebbe (dovrebbe?) anche verificare se l'invito sia stato regolarmente inviato e quale esito abbia avuto. Nella realtà è l'atto stesso di citazione che nella parte conclusiva dovrebbe contenere gli estremi dell'avvenuto invio dell'invito e del suo esito, nonché delle valutazioni date dalla procura alla risposta fornita dall'invitato. Tuttavia l'invito, specie se rimane senza alcun intervento di colui al quale è stato inviato, non integra una condizione dell'azione del procuratore, ma rimane un presupposto processuale la cui mancanza, costituendo una violazione della legge, si traduce nella inammissibilità della domanda di instaurazione del giudizio. Ne deriva che, nonostante la sua sostanziale diversità rispetto agli atti di garanzia previsti nei procedimenti penali, l'invito introdotto dalla legge n. 19 del 1994 costituisce un adempimento prodromico del giudizio ed ha carattere di necessità ed indispensabilità. Ne consegue che la sua mancanza costituisce vizio non sanabile e non consente l'apertura del dibattimento.
3. L'atto di citazione e la vocatio in jus L'introduzione del giudizio di responsabilità avviene attraverso l'atto di citazione a comparire formulato dal procuratore regionale. La citazione deve, ovviamente, indicare la sezione territorialmente competente, l'ufficio del pubblico ministero che agisce, il nome, il cognome, domicilio, residenza o dimora del convenuto, l'oggetto della domanda, l'esposizione dei fatti e la qualificazione giuridica del convenuto in relazione ai fatti dannosi contestati. Deve essere precisato su quali motivi si fonda la domanda con la indicazione dei mezzi di prova o dei documenti di cui il p.m. intende valersi e dei documenti che offre in comunicazione. Deve contenere la domanda, indirizzata al presidente della sezione, della fissazione di udienza e l'invito a costituirsi in segreteria entro i termini fissati dal presidente. Nel silenzio delle norme di procedura, che sono tutte di antica data, deve ritenersi che la citazione dovrebbe anche dare contezza dell'avvenuto invio dell'invito a dedurre e del suo esito. Si è posto il problema di una possibile nullità dell'atto di citazione nel caso di omessa indicazione della sezione regionale ma la questione sembra del tutto bizantina. È evidente che il procuratore intimante parla per la sezione nella quale è incardinato né è legittimato a chiedere un processo presso una sezione diversa. Allorché il giudizio si svolgeva al centro vi erano a Roma due sezioni giurisdizionali con competenza promiscua ed era il presidente della Corte che determinava l'assegnazione ad una di esse. Oggi il problema non sussiste più e lo stesso presidente della sezione regionale non può che assegnare il processo alla propria sezione. Quindi il problema si porrà soltanto se in futuro verranno create articolazioni diverse o distaccate della sezione regionale. Anche la previsione di nullità per difetto di sottoscrizione dell'atto di citazione o del decreto presidenziale attiene più ai formalismi che alla sostanza. Comunque se fatti del genere si verificano essi sottolineano difetti di organizzazione degli uffici ausiliari che, comunque, prima della partenza o notificazione di un qualsivoglia atto, sono tenuti a verificarne la regolarità formale, anche per non incorrere in responsabilità. Basti pensare all'impossibilità di reiterare la notifica di una citazione priva delle necessarie sottoscrizioni per la sopravvenuta scadenza dei termini o per il sopraggiungere di prescrizioni.
4. L'iscrizione a ruolo ed il procedimento L'atto di citazione predisposto dal procuratore, oltre ad avere la funzione di vocatio in jus ha anche quella di precisare l'oggetto della domanda sulla quale si sollecita l'intervento del giudice. L'atto viene notificato e devono decorrere non meno di sessanta giorni dalla notifica a quello dell'udienza (centoventi se il
------------------------------ © Servizio per le informazioni e la Sicurezza Democratica ------------------------------

convenuto è fuori d'Italia). L'iscrizione della causa a ruolo e la fissazione dell'udienza da parte del presidente devono precedere la notifica dell'atto di citazione. Il deposito del fascicolo in segreteria e la nomina del relatore hanno luogo successivamente. La parte si può costituire personalmente oppure avvalersi della difesa di un avvocato iscritto nell'albo dei professionisti ammessi al patrocinio dinanzi alla Cassazione. Documenti e memorie, eccezioni ed indicazioni di mezzi di prova si attuano mediante il deposito in segreteria del fascicolo contenente la comparsa di risposta alla citazione, la copia dell'atto di citazione e l'eventuale nomina, con procura, del difensore. Per l'eventuale ricorso incidentale, invece, non è sufficiente il deposito in segreteria ma occorre la notifica alle parti. (4) Per il procedimento si seguono le norme contenute nel regolamento di procedura. Ove queste non dettino prescrizioni specifiche si applicano i principi del codice di procedura civile in base al rinvio operato dall'art. 26 del codice di procedura della Corte che dispone l'applicazione, nei giudizi contabili, delle norme e dei termini della procedura civile "in quanto applicabili e non modificati dalle disposizioni del regolamento". Si è posto il problema dell'applicabilità delle innovazioni introdotte nella procedura civile che possano incidere su disposizioni del regolamento di procedura. In linea generale la giurisprudenza è favorevole all'accoglimento dello jus superveniens allorché si tratti di innovazioni modificative-aggiuntive correlate ad una migliore attuazione dei principi dell'ordinamento in materia di giudizi e di diritti dei cittadini. (*) Sintesi redazionale (1) Osserva STADERINI (La responsabilità nella pubblica amministrazione, Padova 1994 p. 216) che la norma è in contrasto con la concezione risarcitoria in senso civilistico della responsabilità amministrativa, ed anche con quella che ravvisa nel danno cagionato, e quindi legato da un rapporto di causalità con la condotta imputabile, un parametro fondamentale per addivenire ad una condanna. Si noti che l'autore è favorevole alla concezione della natura pubblicistica della responsabilità amministrativa. Nello stesso senso CORPACI (La responsabilità amministrativa tra risarcimento e sanzione, Le regioni, 1994, n. 3, 866). Il soggetto pubblico danneggiato ha interesse a richiamare il dipendente o l'amministratore a una corretta azione amministrativa piuttosto che a restaurare la propria situazione patrimoniale. Ciò trova conforto nell'officialità dell'azione del procuratore, nella separazione della responsabilità fra i coautori dell'illecito e nella possibilità del giudice di determinare il risarcimento (che è da ravvisare come sanzione) in modo da adeguarlo alle più svariate graduazioni della colpa nell'ambito della complessità dell'azione amministrativa (STADERINI, op. ult. cit. p. 133). (2) STADERINI, cit. p. 217. Peraltro la tesi non sembra accoglibile e già la giurisprudenza si evolve in senso contrario. Il fatto che l'intimando possa presentare le proprie argomentazioni al di fuori del processo dibattimentale viene proprio a dar vita ad un accertamento preliminare che, in base alla legge, il procuratore è tenuto a compiere.<br> (3) DI PASSIO, Natura giuridica, funzione, effetti dell'invito, Riv. Corte conti, 1995, 1, 440. (4) Sul procedimento ampiamente GARRI, I giudizi innanzi alla Corte dei conti, Milano, 1994, pp. 250 e 394.
------------------------------ © Servizio per le informazioni e la Sicurezza Democratica ------------------------------

Mirko VALENTI - Gli organismi d'intelligence: idee per un progetto per il futuro
1. Premessa: una nuova politica per la sicurezza Accade spesso che nell'affrontare i temi connessi all'intelligence ci si riferisca pressoché esclusivamente all'organizzazione e al funzionamento dei "Servizi". Un approccio metodologicamente più corretto richiederebbe, invero, che l'analisi muovesse dalla politica informativa e di sicurezza, che si colloca evidentemente in un momento precedente all'attività degli Organismi. In tal senso, uno dei punti di partenza per la soluzione dei diversi problemi legati alla realtà dell'intelligence va individuato proprio nella riassunzione da parte delle Istituzioni governative di una responsabilità di indirizzo politico nel settore. Ciò, beninteso, non solo e non tanto per l'immanente necessità di ridefinire gli indirizzi strategici in relazione agli scenari nuovi ed emergenti: compito, questo, già adeguatamente riassunto nella ratio dell'articolo 1 della legge n. 801/77, che affida al Presidente del Consiglio dei Ministri "l'alta direzione, la responsabilità politica generale e il coordinamento della politica informativa e di sicurezza"; quanto, piuttosto, per restituire al delicato settore un chiaro indirizzo politico, reso incerto, negli ultimi anni, dalla protratta situazione di crisi e di mutamento degli equilibri istituzionali: indirizzo che non va, ovviamente, disgiunto dal controllo politico. Tra i compiti di ogni Governo v'è certamente quello di guidare la Pubblica Amministrazione con gli strumenti propri dell'Esecutivo, in un rapporto dialettico nel quale questa trova o dovrebbe trovare un suo spazio d'imparzialità, sancito dalla Costituzione, formalmente delimitato dalle proprie attribuzioni disegnate direttamente dalla legge. Sicché, in una fase in cui, per varie ragioni, l'azione d'indirizzo tende ad attenuarsi, l'assolvimento dei compiti istituzionali trova di norma, nell'autonomia dell'Amministrazione, un discreto margine di proiezione per il futuro. Non così semplice è la trasposizione di un simile modello nel campo dei nostri apparati d'intelligence, in quanto i generali concetti esplicitati nella legge vanno riempiti, nella fattispecie, di specifico contenuto attraverso valutazioni, per loro natura, piuttosto mutevoli e spesso politicamente sensibili. È per queste ragioni che "la riassunzione da parte delle Istituzioni governative di un indirizzo politico nel settore" è necessaria, consentendo di dare impulso a un processo virtuoso che ponga le basi di una costruttiva e indispensabile identificazione di fini tra le strutture dei diversi Organismi di intelligence e il potere Esecutivo da cui esse dipendono, determinando affidamento nella Comunità sia in relazione alla fedeltà ai valori costituzionali che all'utilità e necessità dell'attività svolta. Osservando gli accadimenti degli ultimi anni può affermarsi che la carenza di un legame forte ha incrementato una crescente divaricazione tra il momento politico e quello tecnico-operativo, determinando, nell'ipotesi migliore, una situazione di disagio. Ciò ha recato senza dubbio un danno al Paese, nei termini di una sotto-utilizzazione di risorse e potenzialità, nonché ai Servizi stessi, talvolta incerti negli obiettivi da perseguire, frequentemente chiamati in causa in modo strumentale e purtroppo screditati nell'immagine anche da episodi caratterizzati da riprovevoli patologie di dipendenti infedeli. Il risultato più evidente di siffatta condizione è che oggi il sistema nel suo complesso mostra evidenti segni di incertezza. Non sufficientemente consolidato sul contenuto, l'ambito e i limiti dell'attività informativa; sugli obiettivi e sul modus operandi; non pienamente tutelato sul piano normativo, per ciò che concerne la garanzia di riservatezza, coessenziale a qualsivoglia attività di intelligence; esposto incessantemente a una subdola attività di disinformazione e di ingerenza, che va ben al di là dei princìpi di equilibrio disegnati, fin dal 1977, dalla Corte Costituzionale con la nota sentenza n. 86, che a tutt'oggi costituisce la più lucida e autorevole legittimazione della preminenza del valore della sicurezza dello Stato-comunità rispetto ad altri valori pur costituzionalmente protetti. La realtà dell'intelligence ha in sostanza risentito della crisi che ha afflitto il nostro Paese nel suo complesso. Ecco il perché della necessità - mentre il valore della sicurezza si accredita sempre più come un
------------------------------ © Servizio per le informazioni e la Sicurezza Democratica ------------------------------

bisogno diffuso - di disegnare un progetto per il futuro che consenta, in un contesto d'imparzialità, di dispiegare tutte le potenzialità del settore al servizio dello Stato democratico e della necessità di tutela della sua sicurezza. Un progetto che, richiamando la necessità di una politica, sappia cogliere e distinguere i diversi livelli e momenti di un intervento innovatore, fondandosi comunque sulla esigenza di garantire quei valori che sono in discussione e sulla profonda convinzione di sostenerne gli oneri e le scelte. Di tale necessità, il cui preliminare accertamento costituisce lo sfondo di queste considerazioni, non può, invero, dubitarsi. Nell'attuale quadro internazionale non riveste alcun fondamento, infatti, interrogarsi sul "se" lo Stato abbia o meno bisogno di un'attività informativa per la sua sicurezza. Il corretto approccio a questo tema va invece individuato in uno sforzo di progettualità che affronti, seppure con tempi e livelli d'intervento differenziati, i vari nodi da sciogliere, al fine di ottimizzare l'impiego delle risorse. Questo obiettivo può essere perseguito dotando gli Organismi di intelligence di strumenti e garanzie, investendo le necessarie risorse finanziarie, disegnando un coerente quadro di controlli, in un contesto che renda il cittadino-contribuente consapevole, attraverso documentati rapporti sui risultati, dell'impiego dei fondi pubblici e della produttività di quegli investimenti in termini di sicurezza. Occorre innovare non perché ciò rappresenti un passaggio fisiologico ovvero obbedisca a necessità d'immagine, bensì per cogliere le ragioni profonde delle difficoltà del passato, superandone i limiti, qualificando il lavoro e la funzione di apparati fondamentali per gli interessi statuali, proiettando proficue energie verso un futuro ricco di sfide.
2. La missione dei Servizi e il dibattito sulla riforma Il problema di un'auspicata riforma non può che essere sullo sfondo di un'azione innovatrice che invece fin d'ora conquista una sua rilevanza. E ciò non tanto in ragione dei tempi, necessariamente non brevissimi, di una nuova legislazione che, considerata la delicata materia, richiederà anche un ampio consenso parlamentare; quanto, piuttosto, per l'urgente necessità di definire una nuova dimensione operativa. La missione dei Servizi, infatti, concretamente individuata dalla Legge n. 801 e riassumibile nel concetto, onnicomprensivo e di rilevanza costituzionale, di "tutela della sicurezza dello Stato" è uno dei segmenti di quell'ampio campo di attribuzioni che riguardano l'intero comparto della sicurezza, di cui i Servizi stessi sono parte integrante, in relazione al quale non sono consentite pause o cadute di efficienza. In questo senso, sono almeno tre i livelli d'intervento che si offrono al Governo e al Parlamento. Il primo livello è da individuare nell'esercizio del potere di indirizzo del Presidente del Consiglio dei Ministri, di per sé sufficiente a sciogliere alcuni dei nodi fondamentali. In effetti, tale potere risulta strettamente connesso al disposto dell'articolo 1 della richiamata legge n. 801 e il suo esercizio non esclude il ricorso a organi di consulenza, come il CIIS, assai qualificati ma non adeguatamente utilizzati in passato. Il corpus delle principali disposizioni direttive risale, tranne rare eccezioni, a molti anni fa. In un settore in cui peculiare rilievo rivestono le trasformazioni politico-sociali e in cui, tra l'altro, non mancano le zone grigie d'interpretazione, un simile ritardo è certamente causa di disfunzioni. Volgendo lo sguardo all'estero, cioè alle esperienze di altri Paesi, la constatazione appena accennata risulta senz'altro confermata. Nella generalità dei Paesi europei, infatti, specifiche guidelines compendiano puntualmente l'attività dei Servizi, rivestendo un ruolo di primario rilievo in un contesto dispositivo dove le norme di legge non possono che essere di principio. La riattivazione sostanziale di tale essenziale circuito si configura, pertanto, come idonea a fornire un fondamentale contributo innovativo. Il secondo livello d'intervento è da ricercarsi nella riforma delle disposizioni di livello regolamentare che disciplinano i Servizi, contenute essenzialmente in alcuni decreti del Presidente del Consiglio e dei Ministri, dell'Interno e della Difesa, che regolano diversi aspetti relativi allo status del personale e alla gestione amministrativa. Sia le questioni che afferiscono al primo livello che quelle ricadenti nel secondo potrebbero trovare un utile riferimento nell'attività di un Sottosegretario con delega ai Servizi, alle cui valutazioni potrebbero essere canalizzate tutte le istanze di innovazione che richiedano, come nei casi di che trattasi, una decisione di livello politico. Tale posizione è stata trascurata in passato e la non favorevole valutazione di una simile opzione o dei connessi compiti, precipuamente politica, ha inciso negativamente sulla soluzione dei
------------------------------ © Servizio per le informazioni e la Sicurezza Democratica ------------------------------

molteplici problemi e sul processo di adeguamento delle posizioni statuali alle dinamiche della realtà in veloce mutazione. Il terzo livello è quello della riforma della legge n. 801 del 1977. Non è solo per i tempi che un'accurata riforma certamente richiede, che si è collocato questo passaggio per ultimo, esponendo queste considerazioni all'obiezione che potrebbe apparire singolare iniziare un processo di rinnovamento muovendo da disposizioni di livello attuativo, senza conoscere i princìpi di una riforma legislativa. E neppure per l'altra pur valida considerazione che intanto occorre garantire un sereno lavoro, non potendosi condizionare l'operato di importanti strutture dello Stato ad attese riforme i cui tempi non sono prevedibili. Posto che risulta piuttosto demagogico il principio tendente a individuare la soluzione di ogni questione nella modifica di una legge, va detto pure che la legge n. 801 deve essere considerata per la sua non trascurabile portata chiarificatrice in rapporto al periodo storico in cui fu emanata. In questa logica basti riflettere, ad esempio, sulla straordinaria novità costituita dalla istituzione, nell'ambito di un sistema binario coordinato da un organismo unitario, di un Servizio d'informazione non militare, alle dipendenze del Ministro dell'Interno. Ovvero, al progresso che questa legge ha consentito di compiere in direzione di una cultura dell'intelligence, fino ad allora quasi estranea all'esperienza nazionale, creando le premesse di un'attività informativa intesa come processo di analisi, elaborazione, e non come mera acquisizione e conservazione di notizie. Inoltre, nello svincolare gli appartenenti ai Servizi dalla qualifica di agenti o ufficiali di polizia giudiziaria, secondo un modello largamente adottato in altri Paesi, il Legislatore del 1977 ha chiaramente mostrato di comprendere la peculiarità della funzione informativa rispetto ai compiti, ben diversi, delle varie polizie. Tutti elementi che conservano assoluta validità. Ciò nonostante, nell'ampio dibattito sulla riforma - che ha visto, come non di rado accade, improvvise accelerazioni talvolta legate, a seguito di deplorevoli episodi contingenti, a singole infedeltà - convergono, da un lato, posizioni radicalmente critiche e, dall'altro, giuste istanze di cambiamento, di cui sono portavoce gli stessi Organismi di intelligence quali diretti interessati. Va da sé che la cultura della riservatezza, intrinseca a queste organizzazioni, non consente un dibattito pubblico su questi temi, che renda manifesto il punto di vista degli "addetti ai lavori", professionisti in gran parte formatisi in settori di punta dell'apparato pubblico, ingiustamente coinvolti in un processo di generalizzazione negativo e non equilibrato, che non si cura di distinguere l'Istituzione dalle posizioni soggettive. Analogamente, agli Organismi medesimi non è mai possibile controdedurre alle numerose illazioni giornalistiche che li vedono al centro di mille oscuri episodi. È pertanto importante che sia il circuito istituzionale a farsi carico di tale rappresentanza, diretta conseguenza del potere di controllo, mentre certamente, come si osserverà più avanti, i Servizi dovranno abituarsi all'idea di essere un po' meno "segreti". È questo un processo di apertura che sta ottenendo largo apprezzamento in altri Paesi, dove pure l'efficienza e la riservatezza degli apparati d'intelligence sono indiscutibili e affondano le radici in esperienze di decenni. Considerato che nel nostro Paese le nuove strutture d'intelligence, il prossimo anno, raggiungeranno il ventennale della fondazione, sarebbe assai proficuo utilizzare come una sfida quello che in termini storici si definisce "il vantaggio del ritardatario", per far crescere la cultura dell'intelligence in una dimensione fin d'ora in sintonia con l'attuale contesto sociale e le cresciute e diffuse esigenze di informazione, conoscenza, trasparenza, in un equilibrio che salvaguardi le ovvie necessità di copertura. Sarebbe veramente importante, insomma, se un tale processo fosse in grado di produrre, per i Servizi, lo stesso rilevante risultato che la legge di riforma del 1981 ha significato per la Polizia di Stato e, conseguentemente, per le altre Forze di Polizia, nel senso di avvicinamento di queste realtà alla Comunità nazionale. Tutti rammentano le difficoltà vissute, nel diverso scenario dei passati decenni, dai vari Corpi, talvolta non apprezzati e oggetto di diffidenza. Quella situazione è stata oggi largamente superata e nessuno più dubita dell'utilità e dell'efficienza di strutture dello Stato cui è conferito dalla pubblica opinione affidamento e credibilità. Ciò anche in ragione di un processo culturale che ha avvicinato la funzione istituzionale alla sensibilità della gran parte dei cittadini. Nella passata XII Legislatura, sono state circa quaranta le proposte e i disegni di legge portati all'attenzione della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica, sui temi dell'intelligence e del segreto di Stato.
------------------------------ © Servizio per le informazioni e la Sicurezza Democratica ------------------------------

Nessuno di questi ha visto un esito favorevole. È presumibile che nella presente XIII Legislatura siano reiterati molti di questi progetti. È anche auspicabile che una forma direttamente propositiva trovino pure le varie ipotesi prospettate dal Comitato parlamentare per i Servizi di informazione e sicurezza e per il segreto di Stato nelle diverse relazioni presentate al Parlamento. Sussistono, in altri termini, tutti i presupposti per un proficuo e costruttivo lavoro, nell'ambito del quale sarà opportuno che trovino uno spazio anche gli argomenti nel prosieguo descritti, certamente centrali nel contesto di cui si discorre.
3. Presupposti e ambito dell'attività informativa. Imparzialità e neutralità Qualsivoglia approfondimento sul tema dell'attività informativa, per comprenderne peculiarità e problematiche, non può prescindere da due pilastri. Da un lato, è necessario distinguere tale attività, ove posta in essere dai Servizi, da quella talvolta tipica degli organismi di polizia; relativamente, poi, ai presupposti e all'ambito delle "informazioni" dei Servizi, appare indispensabile soffermarsi su alcuni punti qualificanti, quali: i soggetti, l'oggetto, le modalità e le finalità. Muovendo dal primo profilo, va osservato che si registra, in genere, una scarsa conoscenza delle peculiarità che distinguono l'attività dei Servizi da quella delle Forze di Polizia. Le due funzioni, pur assai simili nel "modus", anche se esercitate in diversi contesti, non sono però da considerarsi fungibili. L'attività informativa tipica dei Servizi, che intanto si giustifica in quanto strettamente connessa alla tutela della sicurezza dello Stato, cioè con un preciso vincolo finalistico, non può essere in realtà confusa con l'attività di investigazione svolta dalle Forze di Polizia né, naturalmente, quando questa si sviluppa sotto la direzione dell'Autorità Giudiziaria, all'interno di un ben individuato filone d'indagine né, del resto, quando trattasi di attività investigativa preventiva d'iniziativa che comunque, per sua stessa natura, si colloca all'interno di uno scenario normalmente circoscritto ed è sempre e comunque finalizzata ad evitare il verificarsi di reati ovvero all'acquisizione di elementi conoscitivi che risulteranno poi utili durante le indagini giudiziarie. L'attività di intelligence demandata ai Servizi si radica invece in un'ottica di prevenzione ad ampio raggio, mirata alla conoscenza e all'analisi di situazioni che, pur afferenti a specifiche e ben individuate minacce alla sicurezza, si configurano come anche solo potenzialmente pericolose, e, dunque, va naturalmente collocata in un momento precedente la tradizionale attività investigativa e a questa connessa in modo eventuale e non necessario. Quest'attività informativa muove o dovrebbe muovere anche in un ambito ed entro confini in cui non sarebbe concepibile un'investigazione di polizia, neppure di carattere preventivo. Tendenzialmente, l'acquisizione di notizie su specifici fatti dovrebbe costituire, dunque, solo uno degli aspetti dell'attività. In tal senso, può anche affermarsi che l'esplorare terreni e situazioni potenzialmente immuni da investigazioni specifiche costituisce il momento più qualificante dell'attività dei Servizi, che devono essere soprattutto in grado di prevenire, attraverso l'analisi e il controllo dei fenomeni, non solo la commissione di fatti eversivi per le Istituzioni rilevanti penalmente, ma anche l'emergere di manifestazioni comunque lesive per la sicurezza dello Stato e per gli interessi nazionali, anche e forse soprattutto quando queste si manifestino in uno stato embrionale, in modo tale da consentire allo Stato di attrezzarsi per tempo di fronte alla potenziale pericolosità. Su questi fondamentali postulati concettuali già ruota l'architettura della Legge n. 801, ove si consideri l'articolo 9 che, nel sottrarre le qualifiche di polizia giudiziaria agli agenti dei Servizi, stabilisce una netta separazione tra le attività di questi ultimi e quelle investigative dirette dall'Autorità Giudiziaria e, di conseguenza, anche tra l' "informativa" dei Servizi e l'informativa di P.G., in relazione alla quale la notizia fornita dalle strutture d'intelligence costituisce solo uno degli elementi, che spetta poi agli organi di polizia riscontrare ed eventualmente fare proprio attraverso lo svolgimento della propria attività di competenza. È evidente, del pari, che tra l'attività di intelligence tipica degli Organismi informativi e l'azione di prevenzione delle Forze di polizia possono e anzi devono esserci punti di contatto, indispensabili per sviluppare sinergie vincenti. Tali punti di contatto attengono anche alle metodologie di lavoro, che in taluni casi possono essere analoghe (ad es., l'uso di informatori), e in altri costituire l'una un supporto per l'altra (ad es., l'uso di speciali
------------------------------ © Servizio per le informazioni e la Sicurezza Democratica ------------------------------

tecnologie per le indagini), in un ambito di reciproca collaborazione. Alla luce di quanto finora detto, si appalesa evidentemente come un grave errore ritenere che i Servizi possano considerarsi una sorta di ulteriore Forza di polizia. L'equivoco, che tende ciclicamente a riproporsi, è stato in verità da tempo superato dallo stesso Comitato parlamentare, che in più occasioni, nelle ultime Legislature, si è soffermato sulla diversità e inconfondibilità dei ruoli tra le strutture che svolgono attività di intelligence e quelle destinate a compiti di polizia. Ampie ed interessanti sono le problematiche legate al secondo profilo. In linea generale, va considerato che non risulta affatto agevole, dal punto di vista dispositivo, disciplinare ambito, contenuti e limiti (soggettivi e oggettivi) dell'attività informativa dei Servizi. Pochi dubbi dovrebbero invece sussistere in merito alle finalità dell'attività informativa - precedentemente illustrata - e alle modalità di questa, sulle quali ci soffermeremo più avanti. Poiché la finalità illuminante è la sicurezza dello Stato, si sarebbe portati in linea di massima a ritenere legittime tutte quelle attività che siano correlate a tale fine. Non si può sfuggire, tuttavia, all'esame preliminare di due questioni alla luce delle quali andrà valutata, nel prosieguo, la dialettica legittimità-legalità del modus operandi, avvalendosi anche del contributo desumibile dalla teoria finalistica elaborata nel diritto penale. Tali questioni acquistano, in particolare, un peso decisivo in un contesto, quale quello odierno, ove su più fronti la tutela della privacy del cittadino si caratterizza quale snodo ineludibile per ogni disposizione attinente alla gestione di informazioni e al trattamento informatico dei dati, in sede nazionale non meno che europea. La prima questione è dunque proprio la tutela della privacy, importante ostacolo con il quale misurarsi considerata l'eccezionalità, negli ordinamenti contemporanei, dei casi in cui un soggetto possa essere destinatario di controlli senza una motivata disposizione dell'Autorità Giudiziaria. La seconda ha riferimento alla circostanza che la detenzione di informazioni, comunque acquisite, costituisce di fatto un "potere", poiché potrebbe sfociare in un uso illegittimo ed essere potenzialmente fonte di pressioni o condizionamenti di varia natura. Non è semplice risolvere i problemi determinati da queste "strettoie" ordinamentali, tenuto conto che la posizione di limitazioni deve comunque confrontarsi, nella fattispecie concreta, con una "effettività" della tutela della sicurezza dello Stato, che costituisce pur sempre un valore prevalente e il cui esercizio è un diritto indiscutibile dello Stato, secondo l'insegnamento di insigni giuristi, i cui lavori sono già stati oggetto di attenzione da parte di questa Rivista (Iemolo, n. 1/95; Sandulli, n. 2/95). L'impostazione più diffusa è orientata peraltro, da un lato, a escludere la possibilità che l'attività informativa possa essere condotta su qualunque aspetto della vita privata dei cittadini; dall'altro, a enucleare, al fine di operare la medesima esclusione, alcune categorie di persone nei confronti delle quali, per il ruolo e le funzioni svolte, le informazioni potrebbero essere illegittimamente usate come forma di pressione. Un simile punto di vista è tuttavia difficilmente compatibile con i fini generali dell'attività d'intelligence, ove si faccia riferimento, a titolo esemplificativo, a un soggetto che, nell'ambito della sua vita privata, si intrattiene con pericolosi criminali; ovvero, frequenti movimenti di natura politica potenzialmente eversivi in ragione delle loro attività. O ancora, al tema di assoluta rilevanza dei rapporti tra criminalità organizzata e politica, che incidono inevitabilmente sulla sicurezza dello Stato poiché sono eversivi delle istituzioni democratiche. Tenuto conto di tali difficoltà, in un sistema sufficientemente funzionale e attento alle garanzie non pare possa comunque prescindersi da tre punti di riferimento: a) il rapporto fiduciario (tra il Governo e i responsabili dell'intelligence); b) la distinzione tra acquisizione delle informazioni e utilizzazione delle stesse nel processo di intelligence; c) il controllo. I tre momenti indicati sintetizzano un'articolata posizione secondo la quale per la gestione di una siffatta materia è indispensabile l'assoluto rapporto fiduciario tra il Governo e i responsabili dell'intelligence, i quali dovranno avere la facoltà e il dovere di eliminare tutte le informazioni ricevute, ove non utili ai fini istituzionali, e che dovranno accettare tutte le prescritte forme di controllo su questo procedimento. In questo contesto, appare a chi scrive incongrua, nei limiti di un'evidente ragionevolezza, qualunque limitazione di tipo soggettivo od oggettivo. Sarà la prudenza istituzionale a consigliare particolare attenzione e pronta informazione nei confronti del Governo e degli organi di controllo, nei casi in cui l'attività ricada su soggetti o argomenti specialmente sensibili, secondo procedure che risultano del resto
------------------------------ © Servizio per le informazioni e la Sicurezza Democratica ------------------------------

comunemente usate nei principali Paesi europei, dove non si ravvisano limitazioni allo svolgimento di siffatta attività. Questa impostazione, al medesimo tempo deontologica e normativa, consente anche di affrontare il tema dell'imparzialità dell'attività dei Servizi, assai interessante, sul quale sono già stati forniti contributi su questa Rivista (Sidoti, n. 2/1995). In particolare, il concetto di Istituzione imparziale è stato rappresentato quale indipendenza dalle partes, senza che ciò determini un riflusso nella neutralità, che non si addice allo Stato il quale, come ovvio, persegue fini ben precisi, individuati dalla Costituzione, ed è inserito in un contesto di alleanze internazionali che deve onorare. L'interessante analogia sviluppata dal citato Autore tra i Servizi e la Banca d'Italia, pur se forse non propria, per i diversi ambiti in cui le due Istituzioni si muovono, mette a fuoco il concetto di indipendenza dell'Istituzione coevo alla preminente necessità di tutela di un valore supremo (la sicurezza = la moneta) che fa parte del patrimonio della comunità nella sua interezza. Pare opportuno aggiungere che, se è nella dialettica istituzionale Governo/Organi di controllo che l'attività dei Servizi prende corpo, questa ha un riferimento e valori talmente importanti da costituire patrimonio di tutti, quindi super partes. Un ultimo problema che è necessario segnalare concerne la questione degli archivi. Molto brevemente, infatti, occorre considerare che una sensibile mutabilità di indirizzi in materia di "informazione" potrebbe avere conseguenze sulla stessa legittimità dell'acquisizione di una notizia e della relativa conservazione dei documenti. Il problema riveste apparentemente un rilievo eminentemente pratico, ove si consideri la quantità di notizie e nominativi che, variamente interconnessi, possono essere contenuti in un qualsiasi archivio, e l'estrema difficoltà cui si andrebbe incontro ove di volta in volta il patrimonio di notizie debba essere riesaminato sulla base di direttive diverse. Ma è anche questione di più ampio spessore, se si tengono presenti le polemiche che a più riprese hanno investito il Parlamento in merito al carteggio e alla documentazione di pertinenza dei Servizi.
4. La cultura dell'intelligence: trasparenza, riservatezza e segreto Un processo di innovazione profonda dovrà anche occuparsi di ricercare nuovi equilibri e bilanciamenti dei tre momenti essenziali di un rinnovato rapporto tra gli organismi di intelligence e la Comunità. Ci si riferisce, in particolare, all'esigenza di garantire effettivamente la riservatezza, anche nella sua forma più assoluta - il segreto -, in un contesto giuridico e sociale che vede invece affermarsi sempre più incisivamente il concetto di trasparenza. I Servizi certamente non sono più segreti, almeno nel senso invalso dopo la seconda guerra mondiale e che ha portato, ad esempio, per lunghi anni la Gran Bretagna a non riconoscerli neppure formalmente. Non ne è segreta l'esistenza, non ne sono segreti i fini, non devono esserne segreti i risultati. Fermo restando quanto già osservato su questo specifico tema nel precedente paragrafo, va da sé che riservato deve invece restare il "modo" dell'attività e, ovviamente, l'identità del personale che, senza la necessaria copertura, non avrebbe modo di svolgere alcuna attività. Alcune riflessioni, del resto, inducono verso l'ineluttabilità di un processo di cambiamento. Deve essere infatti considerata la dinamica che, nel più recente periodo, a tutti i livelli investe la legislazione, nel senso di rendere sempre più "trasparente" e accessibile la Pubblica Amministrazione. Nel nostro Paese, emblematico esempio ne è la Legge n. 241/90, ma nei più diversi settori la linea di tendenza dell'evoluzione normativa si muove su identici binari. È in corso cioè una vera e propria trasformazione, che attiene alla qualità della vita democratica degli Stati, tanto più necessaria in quanto le nuove tecnologie informatiche hanno posto l'informazione al centro della vita sociale. D'altro canto, la società contemporanea è anche vissuta come società dell'immagine, nel senso che la percezione dei fatti e la conoscenza avvengono sempre più attraverso il filtro mass-mediologico, dove chi non è rappresentato risulta fatalmente "perdente". È più facile dunque comprendere come mai da un po' di tempo in Gran Bretagna e in altri Stati europei circolino pubblicazioni ufficiali del Servizio di intelligence, che ne illustrano scopi e funzioni; come mai, quasi in ogni Paese, si rassegnino rapporti periodici sull'attività dei Servizi, che ricevono ampia diffusione e
------------------------------ © Servizio per le informazioni e la Sicurezza Democratica ------------------------------

pubblicità; perché, infine, sempre meno di rado, responsabili dell'intelligence compaiano in conferenze stampa o talk-show televisivi per spiegare le ragioni della loro funzione o fornire elementi su questioni specifiche. Lasciando per un attimo da parte gli aspetti sociologici, occorre far presente che nel campo giuridico-normativo un traguardo sostanziale potrà essere raggiunto solamente quando il nostro ordinamento potrà disporre di una legge unica e onnicomprensiva sui "pubblici segreti" che l'ordinamento già contempla. In altri termini, è interessante considerare come il sistema attuale esponga a due contraddittori paradossi: esistono troppi segreti e non compiutamente disciplinati, ovvero talvolta regolati in una forma che i penalisti definiscono "delle fonti occulte". Si tratta, cioè, di fonti normative che sono anch'esse classificate e che dunque non sono conoscibili dalla generalità e, dunque, di dubbia applicabilità da parte dell'Autorità Giudiziaria. Contestualmente, i segreti previsti dall'ordinamento non consentono di tutelare appieno la riservatezza, come si avrà modo di osservare nella parte relativa ai rapporti tra Organismi di intelligence e Autorità Giudiziaria. Una disciplina unitaria dei "pubblici segreti", già adottata in molti Paesi, è pertanto certamente auspicabile al fine di superare qualunque obiezione legata al potere sostanzialmente amministrativo di segretazione, per inserire a pieno titolo nel nostro ordinamento l'eccezione alla regola della pubblicità, non estranea come principio neppure al testo costituzionale. In tale ambito, sarà opportuno anche intervenire sulla disciplina del segreto di Stato. Nel nostro ordinamento, se si escludono le norme contenute nel codice penale e nel codice di procedura penale, la materia del segreto di Stato è disciplinata proprio dalla legge n. 801. Pertanto, è di tutta evidenza l'assimilazione, certamente non propria, del tema "segreto" a quello dei Servizi. Viceversa, poiché non tutto ciò che afferisce ai Servizi deve essere considerato segreto, mentre non tutto ciò che è segreto deve essere necessariamente ricondotto ai Servizi, la separazione delle due discipline appare quanto mai opportuna e coerente con le posizioni finora espresse. V'è da notare, peraltro, che la normativa sul segreto di Stato dovrà certamente essere migliorata, per rendere questo strumento un effettivo mezzo di tutela. Largo consenso esiste sull'ipotesi di temporizzazione del segreto; ulteriori modifiche sono possibili in materia di controlli; ma il vero problema che tale istituto evidenzia è connesso alla procedura, che si risolve in una decisione di livello politico, circostanza che rende tale mezzo altisonante e di difficile gestione concreta. Pertanto, sarà forse opportuno che le auspicate nuove disposizioni, nel limitare il possibile ricorso al segreto di Stato, consentano altre opportunità di difesa della riservatezza, maggiormente semplificate e più efficaci, in relazione alle quali potranno essere ampliate le facoltà di controllo del Parlamento.
5. Modus operandi e garanzie funzionali. Legittimità e legalità La questione del modus operandi, connessa all'esigenza di dotare gli appartenenti agli Organismi d'intelligence delle necessarie garanzie funzionali, costituisce probabilmente la pietra angolare di qualunque credibile progetto di riforma. Si tratta, in altri termini, di affrontare il problema di dotare i Servizi di mezzi giuridici efficaci per il perseguimento dei fini istituzionali. La necessità che si avverte è quella, cioè, di realizzare un quadro normativo che assicuri la necessaria tutela a chi opera per la sicurezza dello Stato, adeguando i mezzi a disposizione all'effettivo livello che la difesa delle Istituzioni richiede, non trascurando di collegarsi a esperienze già collaudate negli ordinamenti giuridici di altri Paesi. Per comprendere compiutamente i termini del problema, è doveroso muovere dalla considerazione che fino ad oggi una sorta di diffusa diffidenza verso l'attività degli Organismi di intelligence, nonché la difficoltà di sciogliere il nodo del rapporto con l'Autorità Giudiziaria hanno ostacolato l'inserimento a pieno titolo degli Organismi stessi in quell'importante processo che ha visto crescere le potenzialità di contrasto di tutto il comparto della pubblica sicurezza (si pensi, ad esempio, agli importanti strumenti approntati recentemente dalla legge per le finalità investigative del Servizio Centrale Antidroga e della Direzione Investigativa Antimafia). È noto infatti che il quadro normativo di cui gli appartenenti ai Servizi possono avvalersi per la copertura
------------------------------ © Servizio per le informazioni e la Sicurezza Democratica ------------------------------

giuridica di attività non convenzionali, cioè quelle consentite alle sole Forze di Polizia previa autorizzazione dell'Autorità Giudiziaria, è limitato di fatto alla sola possibilità di successiva opposizione del segreto di Stato, la cui conferma discrezionale è affidata correttamente alla responsabilità politica. Di contro, l'assenza di una specifica causa di giustificazione contemplata dal codice penale, che si muova nella direzione già indicata dell'art. 51 c.p. (adempimento di un dovere), rende oltremodo rischiosa per il personale dei Servizi quell'attività ultra legem, definita legittima dalla Corte Costituzionale nella nota sentenza n. 86 del 1977, in quanto finalizzata alla tutela del bene fondamentale della sicurezza dello Stato. Pertanto, possibilità di operare con idonei mezzi giuridici e garanzie funzionali sono due aspetti speculari di un medesimo problema, che costituisce uno snodo fondamentale sulla strada dell'ottimizzazione dell'efficienza operativa. Si pensi, ad esempio, al rilievo preminente che assume l'azione di penetrazione informativa negli ambienti tradizionalmente impermeabili e omertosi della criminalità organizzata. Stante l'attuale quadro normativo, un'azione decisa in tal senso si configura di estrema difficoltà. Osserviamone in primo luogo la reale utilità. Uno dei limiti principali, comunemente riconosciuto, della lotta alla criminalità organizzata in questi ultimi anni è consistito nel costante ritardo dello Stato nell'adeguare i propri strumenti di contrasto alle varie "rivoluzioni" che hanno segnato i principali passaggi dell'organizzazione mafiosa, dalla mafia dei feudi alla mafia imprenditrice. Tali limiti erano evidenti sia a livello normativo che investigativo. Infatti, dal punto di vista normativo il Legislatore si è visto costretto a "inseguire" l'emergenza, nonché a scontare una rapida obsolescenza delle norme dovuta alle contromisure messe in atto dalle organizzazioni criminali, fatalmente più rapide di ogni adeguamento amministrativo o legislativo. Dal punto di vista investigativo, per molto tempo la conoscenza del fenomeno, delle sue evoluzioni e delle connesse attività criminali, è stata, e per molti versi è tuttora, una conoscenza "successiva", spesso principalmente fondata sulle dichiarazioni dei collaboratori della giustizia, che nel momento in cui collaborano evidentemente sono ormai esterni al circuito criminale. Ecco dunque la novità da perseguire: superare lo scarto temporale e avvicinarsi a una conoscenza del fenomeno in tempo reale. Consente l'attuale quadro normativo un simile impegno senza difficoltà di natura giuridica e rischi per gli operatori? Inoltre, quali possono essere le modalità di un simile intervento? Si pensi ancora, a titolo esemplificativo, a tutte quelle realtà potenzialmente pericolose per la sicurezza dello Stato che non possono essere controllate con gli strumenti della polizia giudiziaria, in quanto non sussistono motivi legali che possano consentire di adottare provvedimenti giudiziari autorizzatori. Può ipotizzarsi, a mero titolo esemplificativo, il caso di un gruppo di stranieri, ideologicamente vicini ad aree del terrorismo integralista o fondamentalista, che sul territorio nazionale esercitano comunque un'attività, anche solamente propedeutica, ovvero logistica, di sostegno a una rete criminale, senza che nessuna condizione legale si appalesi per motivare un'intercettazione telefonica, o ambientale, per conoscere o prevenire gravi pericoli. Come tutelare la sicurezza nazionale in questi casi? Infine e conclusivamente, come agire in quelle circostanze nelle quali sono in causa interessi sensibili per la sicurezza e, dunque, sussiste un'esigenza rilevantissima di informazione, senza che emergano requisiti validi per un intervento giudiziario? La risposta a queste domande conduce all'essenza delle proposte che occorrerebbe esplorare per rendere effettiva la tutela della sicurezza. Si tratta, in altri termini, di dotare finalmente i Servizi di quegli strumenti minimi che consentano un adeguato dispiegarsi dell'attività informativa, come la possibilità di effettuare intercettazioni preventive telefoniche e ambientali ovvero di controllare alcuni ambienti, mediante penetrazione fisica. Inoltre, importanti strumenti sono da ritenere l'autorizzazione ad accedere agli istituti carcerari, la possibilità di rilevare ed esaminare reperti criminosi, la possibilità di emanare documenti e segni di identificazione di copertura. Queste facoltà non sono in contraddizione con la contestuale previsione di criteri di stretta legalità e con i vincoli e le garanzie del più rigoroso controllo del Parlamento. Si tratta, infatti, di rendere quantomeno possibile per i Servizi di sicurezza ciò che già è nelle possibilità della polizia di prevenzione e giudiziaria, colmando quell'incomprensibile e un po' singolare "gap" che
------------------------------ © Servizio per le informazioni e la Sicurezza Democratica ------------------------------

impedisce inspiegabilmente le operazioni degli agenti dei Servizi o talora le colloca al limite della legalità, anche quando ciò non sarebbe necessario. Di qui alla questione dell' "ombrello protettivo", su cui il Comitato parlamentare si è a suo tempo diffuso richiamando i cardini dell'attuale sistema nell'art. 202, co. 4, e 256, co. 4, del codice di procedura penale, nonché prospettando ulteriori ampliamenti inerenti al personale dei Servizi che non rivesta più tale qualifica (facoltà di opporre il segreto di Stato per fatti inerenti al periodo in cui l'interessato prestava servizio) e l'applicabilità dell'articolo 472 c.p.p. A ben vedere, le preoccupazioni intuibili di invadere una sfera di privacy al di fuori di una procedura di controllo giurisdizionale (ma non necessariamente, come si osserverà in seguito), trovano già nel diritto penale, e non solo nella più volte richiamata sentenza costituzionale - che si fonda sulla "superiorità" del valore della sicurezza dello Stato rispetto ad altri valori, pur costituzionalmente protetti - non trascurabili controdeduzioni. Nell'esaminare partitamente i comportamenti legali, in quanto aderenti a una regola normativa, e quelli legittimi, in quanto finalizzati al perseguimento di uno scopo qualificato dalla legge e ad esso coerente, si evidenzia infatti, secondo un principio di legalità sostanziale, la mancanza della violazione del bene giuridico quando il comportamento, non legale, è viceversa legittimo nelle finalità che esso realizza. La volontà del Legislatore potrebbe, dunque, spingersi per questi casi alla previsione di un'esimente di carattere generale collegata alla necessità di tutela della sicurezza dello Stato, quando, ovviamente, si operi nell'ambito di procedure regolarmente autorizzate secondo gli schemi di controllo che di seguito si illustreranno. Pressoché in tutti gli Stati europei e negli altri principali Paesi tali problematiche hanno da tempo trovato adeguata soluzione. In particolare, gli ordinamenti dei Paesi di area anglosassone (USA, Canada, Gran Bretagna, Australia) offrono sistemi efficaci e pienamente soddisfacenti sul piano delle garanzie. Come si vedrà nel successivo paragrafo è sempre prevista, in linea generale, una procedura autorizzativa preventiva, salvo i casi d'urgenza (in cui è comunque previsto un controllo successivo, quale "ratifica"), da parte dell'Autorità politica o da parte di un foro speciale della Magistratura, nonché un pregnante controllo del Comitato parlamentare. Disciplinare anche nel nostro ordinamento questi aspetti consentirà, da un lato, di disporre di Servizi più efficienti, dall'altro, di sgombrare il campo definitivamente da qualsivoglia sospetto di attività non legali.
6. I controlli Il tema del controllo riveste, nel nuovo quadro che si viene delineando, assoluto rilievo. Com'è noto, diversi sono i momenti del controllo che rifluiscono sugli Organismi di intelligence. Ponendo per ora da parte i controlli gerarchici di tipo ministeriale, che si esercitano con i tradizionali strumenti amministrativi, non esclusi quelli ispettivi e/o d'inchiesta, ciò su cui più diffusamente ci si interroga è la portata e l'intensità del controllo parlamentare, che è elemento ricorrente nei principali Paesi europei, anche se diversamente strutturato e articolato. In alcuni casi (Germania) esso è esteso, attraverso una sottocommissione del Comitato, anche ai bilanci; in altri, il Comitato è destinatario anche delle notizie coperte da segreto di Stato (Spagna); in molti casi, il controllo è particolarmente destinato anche alle c.d. attività non convenzionali, sulle quali ci si è soffermati nel precedente paragrafo, che nella gran parte degli altri Paesi europei sono consentite agli Organismi di intelligence sulla base di una autorizzazione politica o da parte di un foro speciale della Magistratura. Il Comitato per i Servizi di informazione e sicurezza e per il segreto di Stato ha reiteratamente e comprensibilmente richiesto, nelle due ultime legislature, un ampliamento dei propri poteri, ove si consideri che l'art. 11 della Legge n. 801 ne limita il potere cognitivo alle sole "linee essenziali", indicando peraltro come unici interlocutori istituzionali, per esplicare l'attività di controllo di propria competenza, esclusivamente il Presidente del Consiglio dei Ministri e il CIIS. Allo stesso Comitato può essere opposta l'esigenza di tutela del segreto in ordine alle informazioni che eccedono i citati limiti. In realtà, i poteri dell'Organismo parlamentare, in via di prassi, sono stati esercitati con maggiore ampiezza, ove si consideri, ad esempio, la circostanza ricorrente di audizioni dei responsabili dei Servizi, nonché di
------------------------------ © Servizio per le informazioni e la Sicurezza Democratica ------------------------------

funzionari di vario livello, oltre il fatto che, secondo quanto risulta dalle relazioni del Comitato, tutte le richieste di notizie da esso formulate sono state di norma soddisfatte. Tuttavia, il tema del potenziamento dei controlli parlamentari deve essere affrontato, tenendo in debito conto le altre soluzioni adottate in Europa. Sarebbe però opportuno che tale processo veda contestualmente ed equilibratamente un ampliamento dei poteri dell'intelligence, secondo un'equazione che potrebbe essere così esemplificata: maggiori poteri - maggiore controllo. Speciale menzione meritano tre aspetti e cioè la possibilità per il Comitato parlamentare di: a) acquisire documentazione dei Servizi; b) conoscere le questioni per le quali va opposto il Segreto di Stato; c) esperire forme di controllo sui bilanci. Quanto al punto sub a), si ritiene che, nei limiti di specifici accertamenti, possa ritenersi giustificata un'estensione del potere di controllo agli elementi documentali. Occorre tuttavia precisare che tale facoltà andrebbe limitata a una semplice esibizione, per evitare che la documentazione classificata dei Servizi circoli, seppure in un ambito limitato, considerata la delicatezza delle informazioni che essa può contenere, suscettibili di formare oggetto di strumentalizzazioni di parte. Diverso è il caso indicato sub b). Una corretta prospettiva istituzionale, infatti, sconsiglia forme di cogestione del segreto estranee alla corretta dialettica tra potere esecutivo e organi di controllo. Diversa appare invece la questione del controllo successivo all'utilizzazione del segreto. Opportuna sembra ancora essere l'estensione del potere di controllo del Comitato anche ai mezzi finanziari, settore nel quale deve valere la regola della massima trasparenza. Un problema non risolto, peraltro, permane: quello di garantire e rafforzare la segretezza dei lavori del Comitato e delle notizie apprese in quella sede, anche attraverso la previsione di sanzioni che penalizzino comportamenti non conformi alle regole parlamentari. Ma è bene anche tenere conto che l'esigenza del controllo ha trovato di recente forme nuove e diverse. Senza considerare il "controllo", attinente più alla sfera patologica che fisiologica, da parte dell'Autorità Giudiziaria, trovano crescente spazio nell'esperienza di altri Paesi, soluzioni diverse. Ci si riferisce a interessanti istituti che, pur collocandosi sul versante del controllo esterno, non contraddicono il principio di specialità del controllo che rappresenta il denominatore comune di tutte le legislazioni sul tema e che trae origine proprio dalla necessità di tutela della riservatezza. Realmente innovativa è, al riguardo, la figura del Commissioner, magistrato che, nell'ordinamento inglese, esercita un foro speciale competente a giudicare su tutte le istanze prodotte da cittadini che lamentano l'intrusione dell'attività dei Servizi nei loro confronti. Un altro ordinamento, quello olandese, prevede nel quadro delle competenze affidate alla figura dell'Ombudsman poteri di controllo anche nei confronti dell'attività dei Servizi rispetto ai diritti dei cittadini, anche se le risposte alle istanze rivolte a questa Autorità si limitano ad attestare se un'attività dei Servizi si sia verificata e se sia stata svolta in forma legale. Nell'ordinamento francese, poi, l'Authority che esercita il controllo sul trattamento informatico dei dati dispone di una diretta facoltà di controllo anche sui Servizi, che devono osservare, come ogni altra amministrazione pubblica, le disposizioni dettate in materia. Si può in buona sostanza affermare che in una moderna democrazia la giusta tendenza è verso una pluralità dei controlli. Il vero problema degli Organismi d'intelligence non è quello di sottrarsi ai controlli che anzi, come già precedentemente illustrato, devono essere il corrispettivo di qualsivoglia competenza. In verità, si tratta di articolare i controlli stessi in modo che il loro esercizio non comprometta esigenze vitali per gli Organismi stessi. L'esempio dell'Ombudsman olandese appare in questo senso chiarificatore. Il cittadino ha una attestazione ufficiale circa la legalità del controllo, senza tuttavia potersi spingere a verificare particolari che comprometterebbero la struttura e l'attività del Servizio. L'adozione di una simile figura anche nel nostro ordinamento, concepita come "proiezione" della portata dispositiva della legge n. 241/90, potrebbe, oltre che soddisfare esigenze di garanzia assai sentite nel campo della tutela amministrativa, contribuire a costituire, insieme con un potenziato controllo parlamentare e ministeriale, un quadro esauriente e coerente con il contesto europeo.
------------------------------ © Servizio per le informazioni e la Sicurezza Democratica ------------------------------

7. I rapporti con l'autorità giudiziaria In linea di principio e anche di fatto non può ipotizzarsi l'attività di un Servizio di intelligence che non sia anche connotata dalla massima riservatezza in ordine alle strutture e al modus operandi. Ciò nonostante, pare non agevole prescindere dalla circostanza, prevalente nell'attuale momento storico, che porta ad associare qualunque istanza di impermeabilità dell'attività, al sospetto di comportamenti non legali e dunque a una funzione della Magistratura spinta più sul versante di un controllo "sic et simpliciter" che, più propriamente, su accertati aspetti di rilevanza penale. Sul piano dei princìpi, la questione è stata già affrontata e risolta dalla richiamata sentenza costituzionale n. 86 del 1977, che ha operato un bilanciamento tra l'interesse alla sicurezza e l'interesse alla giustizia a favore del primo, secondo criteri che hanno poi trovato un'estrinsecazione normativa visibile nelle norme sul segreto di Stato e in quelle del nuovo codice di procedura penale. Sempre sul piano dei princìpi, è di tutta evidenza che il rapporto tra Autorità Giudiziaria e Servizi dovrebbe essere improntato alla totale e piena collaborazione, in quanto di norma gli interessi da tutelare coincidono, tranne possibili eccezioni che trovano nell'ordinamento una loro soluzione. Eppure, in controtendenza con tutto ciò che avviene nel resto d'Europa dove risulta che il rapporto abbia trovato un equilibrio fondato sulle funzioni istituzionali, nel nostro Paese questa relazione lascia normalmente insoddisfatti entrambi gli interlocutori. Da parte della Magistratura, sembra a volte manifestarsi una tendenza a considerare le attività dei Servizi sempre potenzialmente illegittime, ragione per cui questi ultimi sono destinatari di numerose richieste che hanno per lo più un fine indagativo piuttosto che collaborativo. Da parte dei Servizi, si esprime talvolta il disagio connesso agli effetti, in termini di destrutturazione, che la costante "ingerenza" dell'Autorità Giudiziaria può sortire sull'intero impianto di riservatezza, relativo all'identità degli appartenenti ai Servizi, alle sedi, al modus operandi, nonché al contesto delle notizie, tenuto conto che nell'ambito processuale, per definizione pubblico, non è consentito dalle norme vigenti alcuna forma di tutela della riservatezza diversa dall'opposizione del segreto di Stato, il ricorso alla quale è ovviamente circoscritto e limitato. Il problema è più facilmente comprensibile laddove si esamini nel contesto dei rapporti internazionali, considerato che in nessun altro Paese l'attività d'intelligence può essere facilmente "violata" da indagini giudiziarie e, pertanto, la sola ipotesi che documenti possano essere consegnati alla Magistratura comporta una rarefazione dei collegamenti informativi tra i Servizi. Il problema, a ben vedere, può sul piano della prassi essere ricondotto a tre specifiche tematiche: a) in primo luogo, occorre riferirsi al già richiamato tenore dell'articolo 9 della legge n. 801, che di fatto pone una barriera tra le attività dei Servizi e l'Autorità Giudiziaria, attraverso il combinato disposto di una serie di norme che seguono una linea coerente e uniforme (qualifica degli appartenenti ai Servizi; obbligo di fare rapporto in via gerarchica; facoltà di ritardo, per il direttore del Servizio, della trasmissione della notizia di reato). Le notizie e le informazioni in possesso del Servizio, trasmesse alla Polizia Giudiziaria, rivestono il valore di meri indizi o sospetti sulla cui attendibilità spetta a quest'ultima effettuare ogni utile riscontro prima di darne notizia all'Autorità Giudiziaria. Pertanto, le richieste dell'A.G. tese ad acquisire la documentazione, nella fase delle indagini, attraverso un provvedimento peraltro autoritativo (art. 256 c.p.p.) - quando non addirittura ascoltando i singoli agenti operativi quali persone informate sui fatti nell'ambito di un procedimento di cui il Servizio stesso si è occupato - da un lato sembrano contrapporsi allo spirito della legge, dall'altro alimentano, recando comunque danni alla riservatezza, una sensazione di artificiosa contrapposizione di fini; b) in secondo luogo, poiché le norme non consentono alcuna alternativa tra la consegna sic et sempliciter di tutti i documenti richiesti e l'opposizione del segreto di Stato, la situazione obiettiva che si concretizza è una compromissione degli apparati d'intelligence nel senso sopraindicato; c) in terzo luogo, problemi non minori riguardano la tutela degli appartenenti agli Organismi chiamati in un pubblico procedimento. In conclusione, occorre che la problematica trovi una sua soluzione, attraverso un riesame delle disposizioni già vigenti, che produca qualche intervento innovativo, teso a ristabilire un ordinato funzionamento delle diverse attribuzioni, secondo quei princìpi di equilibrio che si desumono dal quadro ordinamentale che si è
------------------------------ © Servizio per le informazioni e la Sicurezza Democratica ------------------------------

avuto modo di descrivere. In tal senso, il disposto dell'art. 256 c.p.p. potrebbe prevedere un'eccezione per gli Organismi informativi, consistente nella previsione di una procedura autorizzatoria del Presidente del Consiglio dei Ministri per l'acquisizione di documenti dei Servizi, ferma restando la facoltà di opposizione del segreto di Stato. Potrebbe anche ipotizzarsi che la norma preveda la contestuale possibilità, nella fase delle indagini, quando di norma vengono richiesti i documenti, di consentire al Pubblico Ministero la visione degli atti presso gli Uffici del Servizio, secondo quella procedura di "in camera inspection" che ha già dato ottimi risultati negli ordinamenti anglosassoni. Ciò consentirebbe, da un lato, una proficua collaborazione, dall'altro, la possibilità di circoscrivere le acquisizioni documentali. Inoltre, sarebbe assai utile introdurre una forma di tutela della documentazione, diversa dall'opposizione del segreto di Stato, che consenta, soprattutto in relazione alle necessità di salvaguardare i rapporti internazionali, quantomeno di non consegnare un documento nella sua integralità, ovvero di non consegnarlo affatto, previa autorizzazione del competente Ministro, sottoposta al Controllo del Comitato Parlamentare. Per ciò che infine concerne la tutela dell'identità degli appartenenti ai Servizi chiamati in pubblico dibattimento, dovrebbe trovare piena applicazione l'art. 472 c.p.p., che consente lo svolgimento del processo a porte chiuse per motivi di sicurezza dello Stato.
8. Il personale Ultime e brevi considerazioni vanno riferite al personale dei Servizi, con particolare riferimento alle modalità di reclutamento, alla formazione e allo status. La questione è di grande attualità, in quanto in molti Paesi, negli anni più recenti, i Servizi hanno adottato delle politiche mirate a diversificare le professionalità degli appartenenti agli Organismi, stabilendo un contatto in particolare con il mondo delle Università. Per rendere appetibile l'impiego nel settore dell'intelligence sono state anche diffuse pubblicazioni volte a fornire quelle necessarie informazioni sulle finalità dell'istituzione, l'iter professionale e lo status. Nel nostro Paese, il Comitato parlamentare di controllo si è in varie occasioni occupato del problema, soprattutto in relazione a due aspetti: a) le modalità di reclutamento; b) la permanenza nei Servizi, ovvero se gli organici debbano avere tendenziale carattere di stabilità o, viceversa, essere caratterizzati da una appartenenza temporanea. Quanto alla prima questione, è noto che nell'attuale sistema, ai sensi dell'art. 7 della legge n. 801, il personale dei Servizi è assunto direttamente ovvero per trasferimento temporaneo da altre Amministrazioni dello Stato. In proposito, chi scrive ritiene che le modalità di attività dei Servizi nei loro campi d'impiego richiedano l'applicazione di un principio di massima libertà nel reclutamento del personale, nel senso che si debba lasciare alla responsabilità dei vertici politici e tecnici la scelta di attingere da ogni settore della società che sia funzionale agli scopi da perseguire. Evidentemente, tra questi settori rilievo prioritario dovrà essere riconosciuto alla Pubblica Amministrazione, dove sarà possibile acquisire professionalità già formate, soprattutto già orientate all'attività operativa. In questo senso, l'attuale sistema legislativo sembra soddisfacente, tenuto conto che il problema delle modalità di reclutamento e altre questioni di carattere amministrativo ricadono nell'ambito di una normativa di livello secondario. Il rigore nel reclutamento non attiene esclusivamente al soddisfacimento dei requisiti tecnico-professionali, bensì ad altri due aspetti che costituiscono una sorta di pre-requisito per qualunque aspirante agente dei Servizi. Ci si riferisce all'affidabilità in termini di sicurezza e ai requisiti psico-attitudinali che il contesto dell'attività di intelligence richiede siano peculiari e spiccati. Quanto al secondo problema, sulla preferibilità dell'uno o dell'altro sistema si confrontano due posizioni. Chi tende a preferire un modello stabile, presta attenzione soprattutto alle necessità di formazione professionale, alla capitalizzazione dell'esperienza di lavoro, alla creazione di una forte identità degli Organismi.
------------------------------ © Servizio per le informazioni e la Sicurezza Democratica ------------------------------

Tutti questi fattori, non sarebbero realizzabili ove la permanenza fosse limitata nel tempo, tenuto conto anche della circostanza che non esistono altri settori dello Stato che svolgono omologhe attività. Coloro che, viceversa, propendono per l'ipotesi della permanenza limitata sono indotti a tali conclusioni dalla considerazione che la delicatezza delle funzioni svolte consigli di avvicendare il personale per non sedimentare pericolose incrostazioni o centri di potere. Le due posizioni, tuttavia, possono trovare un momento di conciliazione. Infatti, mentre si ritiene che per la gran parte del personale possa essere adottata più proficuamente la scelta della stabilità, poiché i vantaggi di una simile opzione sembrano prevalenti ai fini di una buona organizzazione e impiego delle risorse, i criteri di permanenza temporanea potrebbero riguardare una ristretta fascia di alti dirigenti il cui ruolo, evidentemente, ha una influenza nelle preoccupazioni manifestate sub b). Ciò che tuttavia resta assolutamente fondamentale è l'adozione di un modello elastico e non rigido per ciò che concerne l'assunzione, l'impiego e anche l'allontanamento del personale per cui venga meno il rapporto di fiducia. Tali requisiti sono irrinunciabili e caratterizzano la normativa in materia di personale di tutti i Servizi di intelligence. Per ciò che infine riguarda lo status, posto che, ovviamente, quanto ai princìpi fondamentali, si applica agli appartenenti ai Servizi la disciplina generale del pubblico impiego, non può trascurarsi la necessità che la assoluta peculiarità del lavoro nei Servizi, caratterizzato da una formale "chiusura" dei rapporti con l'esterno (si pensi alla circostanza che l'appartenente ai Servizi, anche nella sua vita privata, non può rivelare il suo reale impiego lavorativo), nonché talvolta dall'abbandono, ancorché temporaneo, delle carriere di appartenenza, siano necessariamente assistiti da una normativa che tuteli e riconosca le posizioni di status. Non si tratta, evidentemente, di riconoscere privilegi, quanto di far sì che una professione certamente "sui generis" sia ritenuta allettante dalle persone professionalmente più preparate, che dovrebbero costituire, in ragione della delicatezza e importanza del lavoro svolto, l'élite della pubblica amministrazione. In tal senso sarebbe anche auspicabile che una quota consistente del budget sia investito nella formazione permanente del personale. Mentre, infatti, può essere considerato un danno relativamente colmabile che un impiegato ministeriale non sia con metodicità aggiornato o formato ai nuovi problemi, per un operatore dell'intelligence questo costituisce sostanzialmente un paradosso che ne inficia fortemente le potenzialità lavorative. La cultura dell'intelligence, oggi patrimonio persino dei gruppi privati, deve crescere nelle Istituzioni di uno Stato moderno. E questo processo non può che nascere dall'interno degli Organismi, che sono deputati a tale ruolo.
------------------------------ © Servizio per le informazioni e la Sicurezza Democratica ------------------------------

Senato della Repubblica XIII LEGISLATURA Resoconto sommario del programma di Governo presentato il 22 maggio 1996 dal Presidente del Consiglio dei Ministri Prof. Romano PRODI
Comunicazioni del Governo Presidente. Dà la parola al Presidente del Consiglio dei ministri. Prodi, presidente del Consiglio dei ministri. Pronuncia il seguente discorso: "Onorevole signor Presidente del Senato, onorevoli senatrici, onorevoli senatori, sento, parlando oggi in quest'Aula, nella veste di Presidente del Consiglio, tutto il peso della mia personale responsabilità. È il grande peso della nostra storia, di cui questo Parlamento conserva la memoria più preziosa e di cui è l'espressione più alta. Di fronte a questo Parlamento, che è il punto di riferimento di tutte le nostre istituzioni, il Governo sente forte l'esigenza di rinnovamento espressa dal popolo italiano. Esso, per la prima volta nella storia unitaria, ha indicato in una grande, inedita coalizione popolare lo strumento per dare avvio a una nuova fase della vita della Repubblica. Sono personalmente orgoglioso di avere contribuito al successo di questa impresa politica. Ho cercato, in questa mia azione, di spendere anche il mio impegno e la mia storia personale di cristiano richiamandomi ai principi della libertà e della piena valorizzazione della persona umana. A questo indirizzo continuerò ad ispirarmi, nel rispetto di ogni fede religiosa e del principio della laicità dello Stato. Sono trascorsi quattordici mesi da quando ho preso la decisione di presentarmi nello scenario politico per realizzare un grande sogno: ricomporre il paese da una frammentazione che correva il rischio di cancellarlo per sempre dalla scena internazionale. Nel mio intenso impegno politico sono stato sostenuto da un unico sentimento: l'amore per questo Paese e da un unico ideale: mettere in una sola coalizione tutte le forze democratiche, laiche e cattoliche. Mi sono ispirato alla pagina più bella e più alta della nostra storia repubblicana. L'unità delle forze riformiste, cattoliche e laiche è infatti all'origine della nostra Repubblica. La Carta Costituzionale è nata da un bisogno che si collocava al di sopra dei partiti e delle piccole visioni: da un bisogno che ha accomunato grandi personaggi come De Gasperi, Togliatti, Parri, Einaudi, Nenni e Sturzo. Quelli sono stati uomini che, pure tra le asprezze e le difficoltà del tempo, hanno saputo mettere il bene del Paese al di sopra degli interessi immediati dei loro partiti. Dobbiamo ritrovare e dobbiamo far rivivere quello spirito. L'Esecutivo, che pure nasce da una coalizione che ha legittimamente vinto una dura ma chiara competizione elettorale, vuole essere il governo di tutti. Gli italiani hanno infatti piena consapevolezza della grande sfida che ci attende per risanare e rinnovare il nostro Paese. Non ci sono alternative. O siamo in grado di capire che occorre lo sforzo solidale di tutti per vincere la sfida del nuovo, o la nostra società, giunta dopo tanti sacrifici a un elevato livello di benessere, è destinata al declino e, infine, alla frammentazione. Non è in gioco soltanto la compattezza della nostra Nazione. È in gioco molto di più: la vita stessa della nostra società, la nostra convivenza civile, il futuro nostro e dei nostri figli. Ed è proprio pensando alle nuove generazioni, alle ragazze e ai ragazzi, ai bambini, che io sento oggi, in quest'Aula, tutto il peso della mia responsabilità. Dalle nostre decisioni dipenderà infatti gran parte del loro futuro. E un peso non minore io sento se penso agli anziani e a coloro che lo diventeranno nei prossimi anni. Anche ad essi noi abbiamo il dovere di assicurare certezza e serenità quando più forte è il bisogno di cure, di attenzioni, di solidarietà umana e sociale. A questi doveri noi non vogliamo sottrarci: non possiamo farlo per rispetto ai nostri padri e per obbligo verso i nostri figli. Aspiriamo ad essere all'altezza degli uomini migliori della nostra storia e vogliamo superare l'esame a cui un giorno ci sottoporranno i nostri figli. Sono essi che domani ci giudicheranno. Il nostro scopo è riscattare agli occhi delle giovani generazioni, con l'esempio della nostra azione pubblica, la
------------------------------ © Servizio per le informazioni e la Sicurezza Democratica ------------------------------

cattiva idea che essi si sono fatti della politica, della gestione dello Stato e, al limite, delle stesse istituzioni repubblicane, a causa dei fenomeni di corruzione e di degenerazione che hanno precipitato l'intero sistema politico in una crisi dalla quale appena ora cominciamo a risollevarci. Noi abbiamo oggi la responsabilità di guidare questo grande Paese verso il terzo millennio e non possiamo permetterci di fallire. Dopo quattro anni difficili, nel corso dei quali si sono succedute ben tre legislature e quattro governi, è tempo che l'Italia torni a progettare e a costruire il futuro. Per quattro anni l'Italia ha retto grazie alla guida sicura di un grande Presidente della Repubblica, a cui rivolgo il mio deferente saluto. Ha retto grazie al senso di responsabilità delle parti sociali e alla competenza tecnica e politica dei miei immediati predecessori e dei loro Ministri; grazie alla perseverante lotta alla criminalità organizzata e all'illegalità condotta dalla magistratura con il concorso delle forze dell'ordine; grazie alla capacità del sistema economico e produttivo di reggere la concorrenza internazionale in condizioni di oggettiva difficoltà e grazie ai cittadini rimasti fedeli ai loro principi etici più profondi e al diffuso e radicato sentimento di solidarietà nazionale. Tutto questo ha dimostrato coi fatti la grande energia morale e sociale del nostro Paese. Come in altri momenti della nostra storia nazionale, l'Italia ha trovato in se stessa e nella parte migliore della sua classe dirigente, la forza per resistere alle difficoltà. Oggi però tutto questo non basta più. Occorre cominciare ad affrontare le urgenze del Paese con una strategia di grande respiro, per collegare l'indispensabile risanamento della finanza pubblica con una credibile prospettiva di sviluppo economico, sociale e civile. In questa azione, noi dovremo essere consapevoli che non vi è urgenza maggiore di quella di approntare rapidamente la riforma dello Stato. Le condizioni politiche ed istituzionali finalmente favorevoli ci incoraggiano a cominciare subito questa impresa. Il Governo che si presenta oggi alle Camere è consapevole di avere dinanzi un Parlamento profondamente diverso da quelli delle legislature precedenti. Per la prima volta, infatti, la competizione elettorale non è stata dominata da singoli partiti o da occasionali alleanze, ma da due grandi coalizioni, portatrici entrambe di un proprio programma e di una propria proposta di governo per il Paese. La portata di questa novità è preminente rispetto alla presenza, a fianco di queste due grandi coalizioni, di altri importanti soggetti politici che hanno compiuto scelte diverse. D'altra parte, la vittoria della formazione dell'Ulivo (che compone questo Governo) non sarebbe stata altrettanto chiara senza l'alleanza elettorale con Rifondazione. Di Rifondazione, anche se ci dividono concrete e importanti scelte di politica economica ed internazionale, condividiamo la sensibilità per il mondo del lavoro, la difesa del potere d'acquisto dei salari, la priorità per l'occupazione e per i grandi temi della giustizia sociale. Valuteremo in questi campi con interesse e partecipazione proposte e suggerimenti, fermo restando che il Governo resterà fedele alla lettera e allo spirito del programma con cui si è presentato davanti agli elettori. Non a caso, il Presidente della Repubblica ha voluto sottolineare le novità politiche della competizione elettorale nelle consultazioni per la formazione del Governo, decidendo, per la prima volta nella storia repubblicana, di ricevere non i singoli partiti ma le coalizioni che si sono presentate come tali di fronte all'elettorato. Questo fatto, così nuovo per il nostro costume politico, ha un'importanza di enorme rilievo, che merita di essere sottolineata per gli effetti che determina su tutto il nostro quadro politico. Per la prima volta ha effettivamente funzionato quel sistema bipolare che molti di noi hanno tenacemente perseguito come l'approdo più auspicabile della lunga transizione italiana. Era ed è infatti mia ferma convinzione che solo in un sistema bipolare gli elettori possano scegliere non solo un partito ma anche un governo, dando vita a una legislatura stabile, in grado di assicurare, proprio grazie alla stabilità stessa del Parlamento, un'efficace continuità nella guida del Paese. Inoltre, il modo nel quale si è svolta la competizione e il fatto che gli elettori abbiano indicato con le loro scelte una maggioranza, un governo e un programma, sono un grande elemento di forza di questa nuova legislatura. Il nesso inscindibile che si è costituito tra l'elezione delle Camere e l'indicazione della coalizione vincente dimostra che anche in un sistema parlamentare puro come quello italiano è possibile che, attraverso il Parlamento, il corpo elettorale possa indicare quale coalizione, quale programma e quale proposta di governo abbia diritto di reggere il Paese. Il sistema parlamentare ritrova così tutta la sua forza ed autorevolezza come interprete fedele di una volontà popolare chiaramente espressa.
------------------------------ © Servizio per le informazioni e la Sicurezza Democratica ------------------------------

Ora tocca a noi, a tutti noi, certo con maggiori doveri per il Governo, ma con non minore responsabilità per tutto il Parlamento, dimostrare di essere all'altezza del mandato conferito dagli elettori. Il Governo è ben consapevole di dover guidare il Paese in una fase difficilissima della sua storia e sa che dai risultati che in questi anni verranno raggiunti dipende la possibilità per la nostra gente di entrare a testa alta nel nuovo secolo. Potrebbe accadere che in un clima di confusione e di scarsa operatività anche una società forte come quella italiana si sfaldi. Potrebbe accadere che legittime richieste di ammodernamento dello Stato, di sviluppo delle autonomie e delle realtà locali degradino in pericolose parole d'ordine e possano portare a risultati contrari ai fondamenti etici, culturali e storici della nostra Nazione. Ciò non accadrà. Il Governo però vuole e saprà rispondere alle legittime domande che sono state lanciate da quella parte importante del Paese che ha scelto una rappresentanza fortemente critica verso le due grandi coalizioni. In questo voto, espresso in aree fortemente produttive e che con la loro proiezione internazionale contribuiscono al generale benessere del Paese, il Governo non coglie l'affermazione di una diversa identità, ma una pressante e fondata domanda di riforma e di ammodernamento dello Stato. L'unità nazionale è fuori discussione. Ciò che invece è in discussione, e non da oggi, è la forma di Stato. La pretesa, connaturata a uno Stato fortemente centralizzato come il nostro, di legiferare su tutto, di decidere su tutto e di governare tutto dal centro del sistema, da una capitale sede di ogni centro decisionale, è sempre più in contrasto con le necessità di una società complessa, articolata e differenziata nei suoi sistemi economici, culturali e sociali. È sempre più evidente la necessità di flessibilità, di articolazione e di duttilità dei centri decisionali e degli stessi apparati amministrativi. È utile, oltre che necessario, dare voce e spessore alle differenze. Si potranno così valorizzare meglio le ricchezze e le risorse del Paese, a condizione, certo, che resti forte il sentimento di solidarietà e di comune appartenenza alla medesima Nazione. Dobbiamo perciò individuare nuovi canali istituzionali che consentano alle regioni e alle autonomie territoriali di rinnovare completamente il circuito decisionale del nostro Paese. Bisogna procedere a una forte riforma dello Stato e del ruolo stesso del Governo. La via da seguire è quella di un ampio trasferimento di funzioni amministrative dallo Stato al sistema delle regioni e delle autonomie locali. È evidente che questa filosofia di rinnovamento comporta che ad un'amministrazione centrale fondata su apparati pesanti di gestione si sostituisca un'amministrazione centrale di coordinamento e di indirizzo che collabori intensamente con le regioni e con le autonomie locali. Il Governo vuole dare immediatamente segnali chiari della sua decisione di perseguire in tempi rapidi questi obiettivi. È un primo passo in questa direzione la struttura innovativa della compagine di Governo, che accorpa alcuni Ministeri di "servizio" e che attribuisce Ministeri che sono strategici per la costruzione delle autonomie a Ministri che hanno fatto specifiche e personali scelte verso il decentramento. In questa prospettiva, il Governo, integrando decisioni già assunte dal precedente Esecutivo, intende chiedere in tempi brevissimi una delega al Parlamento, che, dopo quelle contenute nelle ultime finanziarie, consenta un immediato e profondo trasferimento di funzioni alle regioni, l'istituzione di unità amministrative elementari a livello regionale e locale, la sostanziale abolizione dell'attuale sistema dei controlli e una ampia autonomia amministrativa e contabile. Il Governo si impegna a promuovere un federalismo fiscale cooperativo, che considera il presupposto fondamentale di ogni riforma tributaria. Esso si ispira ai principi di responsabilità, di sussidiarietà e di solidarietà. Punto di partenza è un allargamento dell'autonomia tributaria degli enti decentrati, in un quadro che ha come protagoniste le regioni. Particolare attenzione e sensibilità il Governo dedicherà alla tutela delle minoranze etniche, in una visione dinamica delle autonomie speciali, con l'impegno specifico ad emanare in tempi rapidi le norme di attuazione già licenziate dalle commissioni paritetiche e ad attuare il passaggio di ulteriori funzioni e competenze. Il Governo intende inoltre promuovere il decentramento di strutture o di servizi dell'attuale sede di Roma ad altre grandi città italiane. Ci ispira l'idea di una capitale reticolare che è stata sperimentata con successo in altri Paesi. Si tratta di una prospettiva di medio periodo, che ci sembra opportuno e utile indicare fin d'ora. Si inserisce qui la questione delle riforme istituzionali e costituzionali che è stata tanto dibattuta negli scorsi anni. Aver avuto un mandato di governo non significa essere esentati dal dovere di costruire consensi, di cercare accordi con le varie realtà individuali e collettive di questo Paese. È dunque giunta davvero l'ora che si dia vita a una stagione "alta" di riforme istituzionali e costituzionali
------------------------------ © Servizio per le informazioni e la Sicurezza Democratica ------------------------------

all'insegna del dialogo e non dei monologhi. Ve ne sono le condizioni. Ve ne è la necessità per quanto riguarda il tipo di Stato e il rafforzamento reciproco del ruolo del Governo e del Parlamento. Il Governo non entra nel merito delle modalità e delle procedure più utili da adottare. Esso resta fedele all'opzione indicata nella prima tesi del programma dell'Ulivo, cioè quella di un patto da riscrivere insieme. Sulla base di questa volontà valuteremo, insieme a tutte le forze politiche di maggioranza e di opposizione, la scelta delle procedure possibili, privilegiando quella con il più elevato grado di consenso. Ciò che il Governo intende sottolineare è la convinzione che si debba giungere in tempi brevi a incisive modifiche della nostra Costituzione verso un reale federalismo cooperativo e verso una forma di Governo che rispetti il delicato equilibrio che deve esistere tra Governo e Parlamento, fra maggioranza e opposizione. Questo è il messaggio che ci ha lasciato Roberto Ruffilli e a questo dobbiamo restare fedeli. La nuova Italia che nascerà da queste riforme sarà l'Italia delle autonomie, nata per venire incontro alle reali esigenze del Paese. Noi non possiamo condividere i modi con cui queste istanze di cambiamento sono state in alcuni casi manifestate e decisamente le avversiamo nel momento in cui esprimono un desiderio di divisione, ma da lunghissimo tempo condividiamo che solo attraverso il decentramento, la sussidiarietà e la responsabilizzazione di tutti i cittadini si possono risolvere i grandi problemi dell'Italia. Ne hanno bisogno i piccoli e medi imprenditori del Nord (e soprattutto quelli del Nord-Est a cui mi lega la mia personale storia di vita), ne hanno bisogno i ragazzi del Sud, anch'essi oppressi da un centralismo che non corrisponde più al desiderio di partecipare alla costruzione del proprio personale destino. Per il Governo il risanamento della finanza pubblica e lo sviluppo sociale del Paese sono tanto importanti quanto la riforma dello Stato e delle istituzioni. La nostra coalizione si colloca nel solco della tradizione del riformismo sociale che ha caratterizzato questo secolo, ma ne riconosce i limiti e cerca nuove frontiere di solidarietà e di equità in un ambiente caratterizzato da forme nuove di concorrenza e di produzione della ricchezza. Il Governo è consapevole che tutte le conquiste sociali di cui siamo giustamente orgogliosi sono a rischio se non si saprà fare fronte all'enorme debito accumulato dallo Stato. Perciò considera una priorità ineludibile il risanamento della finanza pubblica. Ci sono ancora sacrifici da fare, ma già si intravede il punto di arrivo. Sarà preoccupazione prima del Governo che lo sforzo che ancora ci resta da compiere sia distribuito equamente. La nostra strategia economica si basa sull'abbattimento dell'inflazione, sul risanamento dei conti pubblici, sull'aumento dell'occupazione e sul rilancio del Mezzogiorno. Questi orientamenti sono sostenuti dalla precisa volontà dell'Italia di partecipare attivamente all'integrazione europea, volontà che troverà la sua massima espressione simbolica nella nuova moneta unica, l'Euro, che prenderà il via mentre saremo nella seconda parte di questa legislatura. Va dato atto ai Governi che ci hanno preceduto che la finanza pubblica italiana ha intrapreso dal 1992 un costante cammino di risanamento: al netto degli interessi, il bilancio del settore statale e quello delle pubbliche amministrazioni hanno un grande avanzo strutturale. Dal 1994 la spesa pubblica si è ridotta in proporzione del prodotto interno lordo. Il Documento di programmazione economico-finanziaria dello scorso anno prevedeva che l'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni sarebbe arrivato all'obiettivo del 3 per cento del prodotto interno lordo, richiesto dal Trattato di Maastricht, entro il 1998. La Relazione trimestrale di cassa ha messo in evidenza che gli obiettivi che il Governo uscente perseguiva non potranno essere raggiunti, a causa del maggiore onere per interessi, di una dinamica della spesa primaria più sostenuta del previsto e di entrate che subiranno l'effetto del rallentamento della crescita economica. Nel tempo trascorso dalla redazione della Relazione trimestrale di cassa, le nuove informazioni statistiche e di bilancio affluite lasciano presumere che la nostra economia, come quelle europee, stia crescendo a un ritmo ancora più basso di quanto stimato a marzo scorso e che il fabbisogno del settore statale possa superare i limiti ivi indicati. Questo Governo ha già predisposto una ricognizione sia del quadro economico di riferimento che dei conti pubblici. Al termine di tale ricognizione il Governo sarà in grado di dare una dimensione precisa agli interventi che saranno richiesti per riportare il bilancio pubblico in linea con gli obiettivi enunciati dal precedente Governo. I provvedimenti conseguenti saranno presi nel più breve tempo possibile e si accompagneranno alla anticipazione di decisioni che il Documento di programmazione economico-finanziaria per il triennio 1997-1999 indicherà come necessari per portare il bilancio pubblico al risanamento definitivo.
------------------------------ © Servizio per le informazioni e la Sicurezza Democratica ------------------------------

Se il favore con cui i mercati finanziari hanno finora accolto questo Governo si confermerà, e sarà rafforzato nel corso dei prossimi trimestri, l'opera di risanamento della finanza pubblica verrà premiata da una riduzione dei tassi di interesse sui titoli pubblici e, dunque, della spesa per interessi. La differenza tra tassi italiani e tassi tedeschi (oggi di 5 punti e un quarto) potrebbe ridursi di due o tre punti. Ricordiamo tuttavia che maggiore è lo sforzo iniziale, maggiore è il rendimento che se ne ottiene in termini di diminuzione del disavanzo e minori saranno quindi i sacrifici da compiere per raggiungere gli obiettivi prefissati. Un'eventuale riduzione degli interessi più rapida di quanto un'opportuna cautela suggerisce di mettere in conto in questo momento potrà consentire all'Esecutivo di valutare la possibilità di raggiungere obiettivi ancora più ambiziosi di quelli annunciati dal Governo che ci ha preceduto. In ogni caso, il Governo si impegna a raggiungere gli obiettivi di contenimento dell'inflazione, del fabbisogno pubblico e dei tassi di interesse prima che l'Unione monetaria prenda il via nel gennaio del 1999. Per esprimere chiaramente questa sua intenzione, il Governo, consapevole della buona situazione dei nostri conti con l'estero, non appena le Camere avranno approvato le misure di contenimento del disavanzo 1996, il Documento di programmazione economico-finanziaria per il triennio 1997-1999 e i provvedimenti di anticipazione della legge finanziaria del 1997, inizierà un dialogo con i partners europei al fine di riportare la lira di nuovo all'interno dell'accordo di cambio. In tal modo, la nostra economia recupererà l'ancora per la stabilità dei prezzi che ha perduto nel settembre del 1992. In questa situazione, il Governo si impegna a mantenere la pressione fiscale invariata rispetto ai livelli del 1995 per tutto il triennio 1996-1998; a questo fine dovranno essere presi provvedimenti per sostituire il gettito dei prelievi una tantum. Nella seconda parte della legislatura sarà possibile procedere a un sostanzioso alleggerimento dell'IRPEF e delle imposte sul reddito d'impresa, rendendo, in quest'ultimo caso, indifferenti le forme di finanziamento con debito e con capitale proprio. Il Governo si impegna inoltre a reperire risorse aggiuntive tramite l'intensificazione della lotta all'evasione fiscale e ad assicurare una ulteriore riduzione della quota della spesa pubblica sul prodotto interno lordo di due-tre punti percentuali. L'azione sulla spesa sarà la priorità che il Governo perseguirà, ma, all'interno di essa, prima della considerazione di eventuali interventi sulla spesa per prestazioni sociali, il Governo dovrà perseguire la realizzazione di tutti i risparmi possibili in termini di riduzione degli sprechi e di privilegi che ancora sussistono nei meandri della spesa pubblica. Voglio qui dichiarare che chiederò a ciascun Ministro di considerare obiettivo prioritario del suo nuovo Dicastero formulare il bilancio del proprio Ministero in modo da fornire gli stessi servizi alla collettività destinando alla spesa corrente le stesse risorse ad essa destinate nel corso del 1996. Molte aziende private hanno sopportato sacrifici ben più consistenti per risanare i propri conti. Il Paese esige che questa strada sia percorsa anche dalla pubblica amministrazione prima di essere chiamato ad affrontare ulteriori sacrifici. E questo è il nostro impegno. Ciascun Ministro di questo Governo chiede al Paese di giudicarlo già dal prossimo anno su quanto sarà stato in grado di fare a questo riguardo. Da questo vincolo non andranno esenti né la Presidenza del Consiglio, né gli organi costituzionali dello Stato. A questa azione di risanamento saranno chiamati a collaborare anche gli enti decentrati di spesa. Il vincolo del risanamento del bilancio degli enti locali e dei Ministeri si accompagnerà a una restituzione di flessibilità nella gestione delle risorse e a un alleggerimento degli adempimenti che ora intralciano la gestione degli enti locali. Al fine del successo di questa politica è essenziale un rapporto costruttivo tra il Governo e le parti sociali, rapporto che è uno dei fondamenti del nostro patto democratico. L'accordo del luglio 1993, dopo i primi sacrifici, sta dando i propri frutti in termini di salari reali, che con i recenti rinnovi contrattuali vedranno più che conservato il proprio potere di acquisto nel corso del 1996. Occorre, tuttavia, rilanciare tale accordo. Il Governo si impegna a convocare in forma solenne un incontro con tutti i firmatari dell'accordo di luglio nel quale: fare un consuntivo degli effetti prodotti da quell'accordo; annunciare e dare avvio all'applicazione delle parti dell'accordo che sono state trascurate e che sono da riproporre con le modifiche suggerite dalla realtà di oggi e dalla evoluzione in atto in tutta Europa nel campo delle relazioni fra i Governi e le parti sociali. Il confronto avverrà non appena impostato il Documento di programmazione economica e finanziaria. Noi però non consideriamo il risanamento finanziario come un fine in se stesso, ma come un mezzo per
------------------------------ © Servizio per le informazioni e la Sicurezza Democratica ------------------------------

liberare risorse da mettere al servizio dello sviluppo produttivo e quindi come una pietra angolare dell'attenzione specialissima che prestiamo al problema del lavoro e degli squilibri sociali e territoriali del Paese. Nel corso del 1995 il prodotto interno è cresciuto del 3 per cento in termini reali sotto la spinta delle esportazioni e degli investimenti. Come negli altri Paesi dell'Unione europea, l'espansione non si è tradotta in un aumento dei posti di lavoro; anzi, il tasso di disoccupazione nel Mezzogiorno è salito. Dobbiamo perciò reagire contro questa doppia tendenza di una crescita che non crea lavoro e che aggrava il dualismo tra il Nord e il Sud. Il Governo è persuaso che la valorizzazione delle risorse del Paese sia possibile soltanto se sapremo dare impulso e sviluppare con coerenza un'economia di mercato, con regole chiare e trasparenti, che permetta a tutti di partecipare liberamente alla vita della società. È questo il senso dello Stato leggero che proponiamo, uno Stato che sia arbitro e non giocatore, e che, in tutti gli ambiti, determini e faccia rispettare le regole della concorrenza. Perciò riprenderemo con determinazione la privatizzazione delle attività produttive e promuoveremo lo sviluppo di un capitalismo efficiente e civile. Le privatizzazioni appaiono uno strumento indispensabile per rafforzare le capacità concorrenziali e l'efficienza delle nostre aziende, ma dovranno essere accompagnate dalla istituzione delle autorità di controllo che i Paesi democratici prevedono in questi casi a difesa della concorrenza e dei diritti del consumatore. A questi obiettivi si deve accompagnare un crescente sforzo di modifica della nostra economia, non solo verso l'obiettivo di un allargamento dei mercati finanziari e bancari, ma verso il raggiungimento di una loro maggiore trasparenza e di una più forte concorrenza. Il nostro capitalismo vive ancora in stanze chiuse e ha perciò bisogno di aria nuova, di nuovi protagonisti, di nuove regole. Ha bisogno cioè di quella democrazia economica che è condizione essenziale per la vita della democrazia politica. Invitiamo perciò gli imprenditori, gli artigiani, i commercianti e gli imprenditori agricoli a guardare con fiducia e con rinnovato slancio alla nuova stagione politica che si sta aprendo oggi. I piccoli imprenditori saranno al centro della nostra attenzione perché solo loro sono capaci di venire incontro alla grande sfida della creazione dei nuovi posti di lavoro. Già fra poche settimane sarà pronta una serie di disposizioni per promuovere la nascita e la crescita di nuove imprese, per sostenere il loro sforzo di ricerca e innovazione e per rendere più spedito il loro accesso al credito. E soprattutto partirà immediatamente il grande processo di semplificazione necessario per un corretto funzionamento dei rapporti fra il mondo produttivo e lo Stato. La disoccupazione è oggi il problema più importante della nostra società. La mancanza di lavoro provoca esclusione, emarginazione e povertà. Con il concorso delle parti sociali, ci proponiamo di sviluppare una forte iniziativa volta alla riforma del mercato del lavoro e alla valorizzazione della formazione professionale. Dobbiamo subito operare per una migliore istruzione professionale, per ristrutturare i sussidi e gli ammortizzatori sociali, per sostituire la cassa integrazione, nel caso di crisi aziendali temporanee, con un fondo per la mobilità, per creare nuove possibilità di lavoro promuovendo i servizi alla persona nel terzo settore, per riaffermare una nuova politica ambientale, per rendere più flessibili i modelli di lavoro, per promuovere il lavoro interinale e a tempo parziale, per modificare e rendere efficienti le attuali strutture del collocamento, per rendere finalmente possibile la modulazione dei tempi di lavoro alle esigenze di vita degli individui. Con pragmatismo, sul terreno concreto della sperimentazione si possono costruire grandi novità migliorando le condizioni di vita dei lavoratori, nel rispetto della necessaria efficienza delle imprese, ormai proiettate nella concorrenza internazionale. Nella propria politica economica e sociale, il Governo non trascurerà la tutela dell'ambiente. In adempienza ai principi espressi dalla comunità internazionale a Rio de Janeiro, si intende mettere in atto politiche e strumenti operativi per perseguire l'obiettivo dello sviluppo sostenibile. A tal fine dovremo potenziare il Ministero dell'ambiente ed assicurare la piena operatività all'Agenzia nazionale per la protezione ambientale. Con lo strumento dei testi unici, in particolare in materia di rifiuti, acqua e aria, si dovrà realizzare una razionalizzazione della normativa ambientale e il recepimento delle normative comunitarie, uscendo dalle incertezze drammatiche in cui noi oggi ci troviamo in materia. Proprio nelle regioni in cui un'oculata politica ambientale potrebbe essere straordinario fattore di sviluppo è più acuta la mancanza di lavoro. In Italia, lo sappiamo bene, la questione occupazionale coincide in gran parte con la questione meridionale. Ma non dobbiamo pensare, come troppo a lungo si è fatto in passato, che quello del Mezzogiorno sia soltanto un problema economico. Il Mezzogiorno ha bisogno di acquistare
------------------------------ © Servizio per le informazioni e la Sicurezza Democratica ------------------------------

fiducia e deve avere la certezza che potrà contare anche in futuro sulla solidarietà di tutta la Nazione. Noi crediamo che il dirigismo statale, anziché stimolare iniziative locali coerenti con le risorse dei territori meridionali, abbia finito col soffocare lo sviluppo. Il primo interesse della società meridionale è, quindi, avere una classe politica nuova e responsabile, capace di produrre risultati concreti per i cittadini. Nel Mezzogiorno non possiamo ottenere i risultati che abbiamo avuto senza proseguire con tenacia la lotta contro la criminalità organizzata e promuovere ad ogni livello la cultura della legalità. È stato fatto molto negli ultimi anni e grandi sono stati i successi anche negli ultimi giorni. E di questi successi siamo grati a tutti coloro che quotidianamente si sacrificano nella lotta contro la criminalità. Non bisogna abbassare la guardia. Tutti, infatti, sappiamo che gli investimenti di cui il Mezzogiorno ha bisogno saranno favoriti dalla progressiva sconfitta della cultura mafiosa. Napoli, Palermo, Bari sono città con un inestimabile patrimonio di cultura e di bellezze storiche ed artistiche. Le naturali bellezze sono ricchezze che giacciono in gran parte inutilizzate e che una promozione intelligente del turismo e dell'agricoltura potrebbero far rifiorire e ritornare allo splendore dei secoli d'oro. Si debbono infine realizzare anche nel Mezzogiorno i grandi progetti: dalle reti di telecomunicazione per creare un ambiente favorevole all'insediamento di imprese innovative al rifornimento idrico di tutte le abitazioni; dal completamento delle reti di trasporto stradale e ferroviario a nuovi mezzi di trasporto nelle aree metropolitane. C'è moltissimo da fare. Nel quadro della riforma delle regole del mercato del lavoro e della formazione professionale, sarà inoltre necessario promuovere intese fra imprese e sindacati, col sostegno pubblico, per creare lavoro nel Mezzogiorno. Occorrerà concentrare gli sforzi su aree e settori specifici che valorizzino le particolari vocazioni del Sud. Sono certo che, con l'appoggio concreto ma non assistenziale di tutta la comunità nazionale, il Mezzogiorno ritroverà la strada dello sviluppo e riuscirà a recuperare le posizioni perdute. Siamo consapevoli che i cittadini italiani ci chiedono se davvero riusciremo a rendere l'opera di risanamento finanziario funzionale ad una nuova strategia di sviluppo economico ed occupazionale. Ci chiedono se essa sarà compatibile con un equilibrio sociale che mostra già da ora grandi segni di tensione. Ci chiedono se non dovranno rinunciare a prestazioni e servizi sociali che già ora sono troppo spesso carenti. Noi recepiamo queste preoccupazioni, le facciamo nostre, ma ci sentiamo di rassicurarli. Abbiamo già detto che manterremo invariata per due anni la pressione fiscale. E aggiungiamo che riforma dello Stato e risanamento acquistano il loro vero significato nel quadro di una grande strategia di sviluppo sociale e civile dell'intero Paese. In questa azione il Governo si ispirerà al principio di dare a tutti i cittadini uguaglianza di opportunità di fronte alla vita. Ed indispensabile sarà il rinnovamento dello stato sociale per renderlo più equo ed efficiente. Essenziale in questo caso dovrà essere la immediata riforma della scuola. A centro delle nostre preoccupazioni vi sono, infatti, i giovani. Accanto a milioni di ragazze e ragazzi che si impegnano con successo nella scuola e che dedicano parte del proprio tempo agli altri in attività di volontariato, ve ne sono troppi che perdono la fiducia e abbandonano gli studi. Troppe giovani vite appaiono sprecate. Non possiamo permettercelo. Dobbiamo investire nella scuola e in tutti i sistemi formativi, da quelli professionali alle università e agli istituti di ricerca. La scuola deve essere laboratorio di convivenza civica e sociale, un luogo dove ciascuno impara a vivere insieme agli altri, nel rispetto delle regole, con il senso del limite e, quindi, della norma. Se non funziona la scuola in un Paese, non c'è futuro. Ci impegniamo quindi a costruire un complesso di sistemi formativi in sintonia con il loro territorio e con le culture più avanzate del nostro tempo, che possano ragionevolmente esigere dai giovani il massimo impegno e che li preparino socialmente ad una competizione sana in un ambiente cooperativo. In questo senso, la nostra azione si svilupperà in un amplissimo decentramento e in un maggior coinvolgimento di regioni, province e comuni, secondo modalità che garantiscano comunque l'autonomia della scuola e dei suoi istituti; in un prolungamento dell'obbligo; nell'attribuzione al sistema scolastico di un'effettiva e generale autonomia. Anche il "governo" dei sistemi di formazione professionale verrà delegato alle regioni che provvederanno ad un ampio coinvolgimento di scuole, università, imprese, enti privati e organizzazioni non profit, come avviene nel sistema delle scuole tecniche e professionali del Nord Europa. Per l'università si provvederà a garantire e ad accentuarne l'autonomia e si punterà a una forte crescita del numero dei laureati. Verranno però diversificati i percorsi formativi e gli accessi e si punterà alla massima applicazione di efficaci strumenti di valutazione della ricerca. La scuola è per i giovani, ma non possiamo dimenticare il ruolo e la responsabilità degli insegnanti a cui non solo va la nostra gratitudine per il difficile lavoro compiuto, ma ai quali rivolgo un caldo appello perché
------------------------------ © Servizio per le informazioni e la Sicurezza Democratica ------------------------------

siano davvero il motore di questo grande rinnovamento del Paese. Grande sarà il livello di decentramento e della responsabilità nella nuova scuola italiana, ma grande deve essere il sentimento che questo è un bene prezioso per tutti. La nostra scuola deve essere quindi un grande comune sistema pubblico perché essa è al servizio dell'intera comunità. Ma, come è stato esposto nel nostro programma, essa deve prevedere spazi e libertà concrete d'azione alla scuola statale e a quella non statale, entrambe componenti essenziali di un grande sistema educativo unitario. È poi per la cultura, nel senso più ampio, che dobbiamo impegnarci di più. Nella sua struttura, e nella distribuzione delle deleghe, questo Governo ha già dato un segnale. Certo, un Governo non ha una cultura da imporre o da promuovere, mentre deve essere un catalizzatore e un garante perché le espressioni più diverse del pensiero, delle arti possano essere favorite e diffuse. È difficile da definire la cultura, ma certamente essa è ricerca di espressioni che manifestano la creatività del singolo e quella di un intero Paese. È straordinario pensare che il 60 per cento di tutte le opere artistiche del mondo siano nel nostro Paese. Occorre valorizzarle e presentarle all'Europa e al mondo intero. Mantenere un alto grado di solidarietà sociale è un imperativo di civiltà. L'ho sempre detto e lo ripeto in quest'Aula: lo Stato sociale è la conquista più grande del ventesimo secolo. È pure vero che il "patto sociale" tra gli italiani va ridisegnato, va adattato alle nuove esigenze, ai nuovi problemi e alle nuove sensibilità. È un campo vastissimo, di cui mi limiterò a enunciare le aree di interesse e i principi di intervento. La scarsità di risorse non deve andare a scapito dei diritti dei cittadini, in primo luogo nei settori della salute e della previdenza, ma spronarci a migliorare l'efficienza delle strutture e a trovare i giusti criteri di scelta per le prestazioni più strettamente assistenziali. Un'attenzione rinnovata verrà quindi dedicata a promuovere le pari opportunità tra uomo e donna con lo sguardo rivolto non solo al trattamento economico dei lavoratori, ma anche all'organizzazione del lavoro e ai tempi delle città. Grande rilievo deve essere attribuito alla politica per la famiglia, che non è soltanto la cellula elementare della società, ma è anche un soggetto economico da noi troppo penalizzato e un ammortizzatore sociale che ha consentito e consente al nostro Paese di fare fronte ai momenti più difficili e alle situazioni più scabrose. Sulla famiglia si scaricano tensioni e difficoltà che dovranno essere attenuate da politiche sociali più attente sul piano fiscale, degli assegni familiari e dell'organizzazione dei servizi. Il Governo ed io siamo ben consapevoli della centralità della famiglia, e per questo non la consideriamo come un "settore" specifico dell'azione di Governo, la cui responsabilità sia delegabile a un unico Ministro. Al Governo, e a me personalmente, pare, infatti, che la famiglia, proprio per le sue caratteristiche essenziali, sia una questione che debba interessare tutti i Ministeri, ciascuno per il suo ambito di competenze, e il Presidente del Consiglio in primo luogo. Certo, il Ministro per la solidarietà sociale ha in questo campo deleghe e responsabilità speciali. E tuttavia la famiglia sarà il soggetto fondamentale della nostra azione, intorno al quale coordinare le politiche di numerosi dicasteri. Per i servizi sociali pensiamo ad una nuova legge-quadro che assicuri la realizzazione di una adeguata rete di strutture e che sia ispirata all'idea di uno Stato sociale come "casa comune" di tutti, poveri e non poveri, che individui tuttavia un criterio e un equilibrio tra servizi per tutti e l'adozione di criteri selettivi. Forse in nessun altro settore è così importante che questa rete sia vicina ai cittadini, collegata al territorio e gestita localmente per individuare meglio bisogni, domande e linee di intervento. È opportuno che, nella gestione dei servizi sociali, uno spazio rilevante sia aperto ai privati e soprattutto alle organizzazioni del privato sociale. La nostra attenzione ai problemi della salute, alle esigenze dei più deboli, degli immigrati, degli emarginati non è un proposito astratto, ma sarà un punto di riferimento quotidiano per la nostra azione di Governo. Lo Stato inoltre non può rinunciare ad essere vicino ai cittadini e a orientarne comportamenti e a disciplinarne le scelte quando la sanità tocca i temi terribili del diritto alla vita e del diritto alla morte, del diritto alla ricerca e del diritto della specie a non essere manipolata nei suoi caratteri essenziali. Il nostro indirizzo di rinnovamento della società italiana troverà il proprio naturale coronamento nell'impegno volto ad assicurare giustizia a tutti i cittadini. È questo un compito che, prima ancora dell'impegno dei giudici e delle forze dell'ordine, richiede una generale azione civile per promuovere ad ogni livello la cultura della legalità. Questo Paese ha bisogno di legalità e di giustizia. E nel soffermarmi sui delicati temi della giustizia, aspetto fondamentale per la convivenza civile della comunità, sento il dovere di rendere omaggio alla nostra magistratura, e alle forze dell'ordine che l'hanno coadiuvata, per l'impegno e la dedizione con cui ha sempre svolto la sua funzione e, in particolare, per il grande ruolo che ha svolto in
------------------------------ © Servizio per le informazioni e la Sicurezza Democratica ------------------------------

questi ultimi difficili anni. Il Governo sa bene quanto tutto il Paese deve essere grato ai suoi giudici per l'impegno col quale hanno combattuto la criminalità organizzata e l'illegalità diffusa. Per il futuro, la linea del Governo sarà ispirata al massimo rispetto e alla più autentica deferenza per l'autonomia e l'indipendenza della magistratura. Il Governo auspica che la magistratura possa sempre più svolgere la sua naturale e doverosa funzione di tutela della legalità intesa, correttamente, come una funzione ordinaria e normale. È certo giunto il momento di invocare a gran voce, anche da questo seggio così importante, che il Paese ha bisogno insieme di legalità (la massima legalità possibile) ma anche di normalità. Per contro, il Governo, ben conscio delle gravi carenze in cui versa il sistema giudiziario italiano e le sue strutture, si impegna a garantire ogni intervento utile, idoneo e necessario a migliorare l'efficienza e l'efficacia dell'azione degli apparati giudiziari, in modo che i cittadini italiani abbiano veramente giustizia nei tempi e nei modi propri di un Paese civile. Chiederemo quindi al Parlamento di aiutarci a raggiungere una più razionale e moderna distribuzione degli uffici e delle forze sul territorio, di potenziare il sistema del giudice di pace e, più in generale, della giustizia onoraria, di razionalizzare l'impiego della magistratura ordinaria e di prevedere un sistema carcerario con circuiti differenziati per motivi sanitari e umanitari. Arrivo ora all'ultimo punto delle dichiarazioni programmatiche. Forse vi sorprenderà che tratti solo alla fine del mio intervento le questioni della politica estera e della difesa nazionale. È una scelta che nasce da una convinzione, la convinzione che mettere ordine nelle cose di casa nostra sia la condizione perché il nostro Paese possa svolgere con autorevolezza e con efficacia il ruolo che aspira ad avere nel mondo. Il principio che ci guida, nel valutare gli eventi internazionali e nell'interagire con essi, è il prevalere del valore dell'integrazione sul nazionalismo. Ci sono di monito i tragici sviluppi che la questione della ex Jugoslavia ha avuto in questi anni. È a partire da questa filosofia ed in questa prospettiva che la nostra massima priorità è data all'Europa. Ci impegniamo perché, a partire dall'Unione economica e monetaria, prenda corpo un progetto politico complessivo. Si tratta di dotare l'Unione europea di una propria politica estera e di sicurezza e di una maggiore integrazione nei settori della giustizia e degli affari interni. Solo così l'Europa sarà più credibile, più stabile e più democratica. Un'Europa politica, oltretutto, contribuirà a rendere più efficace il rapporto con gli Stati Uniti. La presenza militare americana nel continente va infatti mantenuta e lo sforzo comune sarà indirizzato a trasformare gradualmente la Nato in uno strumento militare a disposizione delle Nazioni Unite e della emergente struttura di sicurezza pan-europea. Tra i fondamentali e delicati rapporti con l'intero pianeta voglio qui infine ricordare il Grande Giubileo della Chiesa cattolica, indetto per l'anno 2000. Sono già state stanziate risorse che saranno impiegate per favorire l'accoglienza e la mobilità dei visitatori valorizzando i luoghi interessati al pellegrinaggio. Sono risorse che troveranno ampio corrispettivo per le entrate dello Stato italiano, ma che sono prima di tutto necessarie per rispondere ad un alto compito di ospitalità. Il Giubileo è per noi il massimo momento di esposizione e di visibilità: dovrà essere un elemento di identificazione e di orgoglio. Non dimenticheremo che la promozione esterna del nostro Paese non può limitarsi all'economia, ma deve anche valorizzare la nostra cultura e appoggiarsi alle numerose comunità di italiani, troppo spesso dimenticati, insediate ormai da generazioni in ogni continente. Saremmo ingenui se non vedessimo che in questo quadro di proiezione del nostro Paese nel mondo un ruolo importante debbono assolverlo le nostre Forze armate. E questo sia per garantire la difesa del territorio nazionale, per quanto possa oggi apparire remota una reale minaccia esterna, sia, invece, per dare un contributo a sostegno della pace, della stabilità e della legalità internazionale. In questa prospettiva e con questo spirito va perseguita l'attuazione del Nuovo modello di difesa, come strumento militare fortemente integrato con quello dei nostri alleati europei ed atlantici. Si definiranno i termini di un sistema di reclutamento misto che si colleghi anche al progetto di dare vita ad un nuovo tipo di servizio alla Patria, in modo che i nostri giovani siano obbligati a un periodo di impegno nei confronti della comunità, ma che possano compiere una libera scelta tra il servizio civile e il servizio militare. Rivolgo qui a tal proposito un saluto, a nome del Governo, certo anche di interpretare i sentimenti di questa Assemblea, ai nostri militari impegnati in Bosnia per la pace e al personale delle Forze armate impegnato in missioni di pace in tante altre parti del mondo.
------------------------------ © Servizio per le informazioni e la Sicurezza Democratica ------------------------------

Onorevoli senatrici, onorevoli senatori, nei limiti di tempo e con le dimenticanze proprie di una dichiarazione programmatica (dimenticanze di cui mi scuso di fronte a voi) ho esposto le linee direttive del Governo da me presieduto e che si appresta a chiedere a voi la fiducia. Voglio ora limitarmi ad alcune brevissime osservazioni conclusive. È questo un momento di grande speranza per il nostro Paese. Abbiamo di fronte a noi prospettive ed occasioni che forse mai si sono avute in passato. Di questo noi tutti dobbiamo condividerne la responsabilità: il Governo, la coalizione di maggioranza e l'opposizione. Noi vogliamo impostare nel modo più trasparente e corretto il rapporto con le opposizioni: su di noi soli grava infatti l'obbligo di Governo, ma su tutti insieme pesa la responsabilità del funzionamento delle istituzioni. Nessuno di noi può quindi sottrarsi al compito che gli spetta. Questo Governo, nel cammino che sta per intraprendere, è sostenuto da una grande speranza, quella di rafforzare l'unità del Paese, di portarlo a un più elevato livello di convivenza civile e di dotarlo di quelle strutture leggere che meglio esaltano i principi di libertà, di sana competizione economica e di giusta solidarietà. Siamo una grande Nazione di cui l'Europa e l'Occidente non possono fare a meno. La grande, vitale, ma anche confusa transizione che ha contrassegnato gli ultimi dieci anni deve finalmente approdare ad una fase di stabilità e di rilancio. Il risanamento delle finanze, l'esaltazione delle autonomie locali, la riduzione delle leggi, la semplificazione amministrativa, la riorganizzazione del fisco, la riforma della scuola, del mercato del lavoro e delle strutture finanziarie sono gli strumenti per conquistare i mercati internazionali e costruire una fase di stabilità e di rilancio della nostra società. Dovremo fare di tutto per recuperare le deficienze di comprensione che vi sono state, proprio da parte della mia generazione, verso la cultura, l'ambiente, la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio naturale, artistico e culturale. Dovremo rifare le periferie delle nostre città dove uno sviluppo convulso ha reso intollerabile il disagio dei loro abitanti. Dovremo fare i conti con le maglie strette del bilancio ma sapremo trovare le strade per investire in questi settori determinanti. L'Italia che vogliamo portare oltre il 2000 sarà pienamente europea, integrata in un'Unione che vogliamo più grande e più unita, e sarà in grado di svolgere con autorevolezza la propria missione di promozione dei diritti umani e della pace nel mondo. Sono grandi obiettivi e sono alti propositi. Chiediamo perciò la collaborazione di tutti, forze della maggioranza e di opposizione, senza che ciò comporti una confusione delle parti e dei ruoli. Chiediamo l'ausilio delle grandi istituzioni di questa democrazia, dalla Presidenza della Repubblica al Parlamento sovrano e al potere autonomo della magistratura. Ci rivolgiamo, infine, ai cittadini italiani, ai milioni di donne e uomini che sono il nostro popolo con un messaggio di speranza e di fiducia. Onorevoli senatrici e onorevoli senatori, non considerate la fiducia che io chiedo per il mio Governo un puro atto formale, un rito da consumare, automatico e freddo. Chiedo lealtà e collaborazione. Chiedo la cultura della cooperazione e non quella della contrapposizione. Da parte mia non mi voglio consumare nei corridoi del Palazzo: voglio caratterizzare il mio Governo, non per l'amore del potere, ma per la volontà di servire l'Italia. Non aspiro certo a un posto nella storia tra i grandi strateghi del potere, desidero solo aiutare il mio Paese, con semplicità, con onestà e con chiarezza. Ma nessuno pensi che ciò equivalga a debolezza. Signor Presidente del Senato, onorevoli senatrici e onorevoli senatori, chiedo la vostra fiducia perché il mio Governo possa, nei prossimi cinque anni, fare l'Italia più grande e più degna della sua storia".
------------------------------ © Servizio per le informazioni e la Sicurezza Democratica ------------------------------

Comitato Parlamentare per i Servizi di informazione e di sicurezza e per il segreto di Stato Relazione sui documenti trasmessi dalla Procura della Repubblica di Milano. Rilievi e valutazioni.
1. La recente acquisizione di un'ampia raccolta di documenti, sequestrati per disposizione dell'Autorità giudiziaria di Milano presso l'ufficio romano dell'ex Presidente del Consiglio Bettino Craxi e trasmessi al Comitato parlamentare per i Servizi di informazione e sicurezza e per il segreto di Stato, dà luogo ad alcuni rilievi e valutazioni che il Comitato intende sottoporre con immediatezza al giudizio del Parlamento. Il sequestro è avvenuto in data 8 luglio 1995, nella sede della organizzazione "Giovane Italia". È stato lo stesso on. Craxi, in un colloquio telefonico con il dottor Paolo Ielo, avvenuto nel corso della perquisizione, ad indicare come propri i locali dell'associazione e gli apparecchi esistenti presso di essa, confermando così che anche le carte là rinvenute erano a lui riconducibili. Vista la natura di esse, la Procura di Milano ha ritenuto che il Comitato fosse competente ad esercitare un proprio controllo ed ha offerto tutti gli elementi a ciò necessari, con encomiabile tempestività e con spirito di collaborazione istituzionale. 2. Nei tre faldoni che contengono 3849 pagine sono compresi materiali tra loro diversi. Si tratta in larghissima parte di informazioni: alcune tratte da documenti ufficiali o comunque custoditi in uffici pubblici, altre di incerta origine o incluse in comunicazioni private. Tra le informazioni offerte da documenti ufficiali si segnalano: a) quelle provenienti dal SISDe e relative a delitti del terrorismo rosso; b) quelle relative alla loggia massonica P2 e alle deviazioni dei Servizi di informazione e sicurezza, tratte da una serie di passi della requisitoria del dottor Libero Mancuso nel processo di primo grado per la strage del 2 agosto 1980 (la requisitoria è del 14 maggio 1986: i passi sono stati stralciati seguendo un filo logico e sottoposti all'allora Presidente del Consiglio); c) quelle, provenienti dal CESIS in data 7 marzo 1985, che si riferiscono ad un caso di apposizione del segreto di stato, nel procedimento penale per strage riguardante il terrorista nero Augusto Cauchi: la decisione, sollecitata allora dal vertice del SISMi, fu assunta da Craxi in qualità di Presidente del Consiglio (il segreto si riferiva all'identità di informatori del SISMi, vicini a Licio Gelli ed in collegamento con il capocentro di Firenze, Federigo Mannucci Benincasa; la posizione di quegli informatori e i rapporti Cauchi-Gelli non sono stati finora chiariti, sebbene il segreto sia stato tolto nel 1991; e certamente il ritardo ha nuociuto alle indagini). 3. I documenti sul terrorismo rosso riguardano la fase terminale del fenomeno brigatista. L'ex Presidente del Consiglio ha conservato, oltre a un corposo materiale propagandistico proveniente dai gruppi terroristici, anche una serie di analisi elaborate dal SISDe. In particolare sono stati rinvenuti: a) un documento SISDe e un appunto del Capo della polizia sull'omicidio del professor Tarantelli avvenuto il 27 marzo 1985, con alcune dettagliate informazioni sull'impegno politico e culturale di questo studioso (sono elencati i convegni ai quali aveva partecipato e perfino le critiche avanzate alle sue tesi nel corso di una tavola rotonda: evidentemente l'attenzione al suo lavoro che sembra, sulla base di queste note, essere stata precedente all'assassinio, non era giunta fino ad avvertire la necessità di proteggerlo); b) un documento SISDe sull'omicidio di Lando Conti, avvenuto il 10 febbraio 1986; c) un documento SISDe sull'attentato ad Antonio Da Empoli, avvenuto il 21 febbraio 1986. Assieme a queste carte, l'on. Craxi conservava il comunicato del Partito comunista combattente sulla uccisione del senatore Roberto Ruffilli, avvenuta il 16 aprile 1988; un ritaglio di stampa e una lettera personale e amichevole a lui indirizzata da Toni Negri il 10 febbraio 1982, sulle posizioni che allora emergevano all'interno delle carceri tra gli imputati di terrorismo; un opuscolo a contenuto ideologico del 1981, elaborato da un sedicente «Collettivo marxiano-comunista» e - in correlazione con questo - un
------------------------------ © Servizio per le informazioni e la Sicurezza Democratica ------------------------------

ritaglio di stampa relativo all'esistenza di «stretti legami a Rovigo tra fascisti e autonomi». 4. Per quel che riguarda le carte ufficialmente trasmesse dai Servizi, non spetta al Comitato, ma all'Autorità giudiziaria stabilire se si tratti di documenti classificati e se sia lecito averli conservati in un ufficio privato. Al Comitato compete, in ogni caso, la valutazione della rispondenza di ciascun atto ai fini istituzionali. Di natura completamente diversa sono invece le numerosissime note informative di cui era in possesso l'on. Craxi e che sono contenute in appunti privi di qualsiasi sigla o firma. Risulta anzitutto evidente che si tratta di insinuazioni, volte a gettare ombre su esponenti della vita pubblica, offrendo la possibilità di attaccarli e di delegittimare la loro azione. Siamo di fronte a notizie prive di riscontri. Di alcune di esse, pubblicizzate dallo stesso Craxi, è stato già ampiamente dimostrato il carattere calunnioso. C'è da domandarsi quale sia l'origine e quale, di volta in volta, la finalità di questi appunti anonimi, commissionati e ottenuti con lo scopo di creare veleni e per disporre, nella lotta politica, di strumenti di disinformazione e di pressione sleale sugli interlocutori e sugli avversari. A giudizio del Comitato, una parte del materiale presenta caratteristiche tali da far ritenere che esso possa provenire dall'interno dei Servizi di informazione e sicurezza. Inoltre, sono i contenuti peculiari di alcuni tra i documenti sequestrati e la tecnica espositiva adoperata a far credere legittimamente che essi non siano il frutto di occasionali collaborazioni private, ma che possano aver avuto una origine interna agli apparati di sicurezza. Su questi aspetti della documentazione occorre che si faccia piena luce. 5. Il Comitato parlamentare ha il compito di vigilare sulle attività che si svolgono nell'ambito dei Servizi e sulla loro corrispondenza alle finalità istituzionali. I criteri in base ai quali il Comitato formula le proprie valutazioni discendono dai princìpi costituzionali e dalle norme fissate nella legge n. 801 del 1977. Sotto il controllo del Comitato ricadono le attività proprie dei Servizi. Possono essere oggetto di esame, sulla base della legge, le operazioni compiute (quando esse si siano definitivamente concluse) e la relativa produzione di informazioni (fatta salva la copertura delle fonti e degli agenti). Di tutto ciò si dovrebbe conservare un'affidabile memoria negli archivi, proprio perché il controllo possa essere più tardi esercitato. In questa prospettiva, il Comitato ha uno specifico interesse ad individuare e segnalare al Parlamento, ogni volta che ne abbia notizia, le iniziative illegittime realizzate nell'ambito degli apparati di sicurezza. Il controllo è tanto più efficace quanto più è in grado di mettere a nudo le deviazioni, affinché vengano rimossi i responsabili e vengano modificate le regole che hanno reso possibili gli abusi. Tra le attività illegittime vi è certamente la composizione di appunti riservati e di dossiers, ad opera di appartenenti ai Servizi, con lo scopo di costruire strumenti di disinformazione, di pressione politica o addirittura di ricatto. Non mancano, per il passato, esempi della elaborazione e dell'uso di questo tipo di documenti. I vecchi fascicoli del SIFAR, finiti in parte nelle mani di Licio Gelli, servivano proprio alla disinformazione e al ricatto. Come il Comitato ha già rilevato nel «Primo rapporto sul sistema di informazione e sicurezza», la distorsione e la strumentalizzazione delle attività informative per scopi di parte ed extra-istituzionali erano rese possibili da una gestione arbitraria degli archivi, volutamente sottratta a ogni criterio certo e controllabile. La funzione degli archivi dovrebbe essere quella di raccogliere puntualmente tutti i documenti prodotti, in base a criteri e con modalità tali da consentirne il reperimento. Ma non si può dire che nell'arco degli ultimi decenni questa funzione si sia correttamente realizzata. Anzi, sono state frequenti le manipolazioni, i depistaggi, gli episodi di informazioni occultate, di fascicoli relativi a fatti di eversione che riapparivano a distanza di anni, dopo che ne era stata negata l'esistenza (1) . In particolare, è invalsa l'abitudine di riversare i risultati delle attività informative in appunti non protocollati né il più delle volte siglati, in modo che la loro origine non sia esattamente identificabile. Si tratta, come il Comitato ha potuto verificare in numerosi casi, di note informative accompagnate da lettere di trasmissione, ma tali da poter essere destinate autonomamente, a seconda dei casi e delle convenienze, all'uno o all'altro incartamento. Ciò evidentemente rende assai difficile ogni controllo. È opportuno ricordare che era proprio questo lo schema di composizione dei dossiers relativi a partiti e a esponenti politici, rinvenuti negli archivi dei Servizi, concernenti il periodo 1977-1981 e di cui fu ordinata la distruzione nel 1987, in seguito a una disposizione del presidente del Consiglio Goria. Alcuni di quei
------------------------------ © Servizio per le informazioni e la Sicurezza Democratica ------------------------------

fascicoli, che mostravano di avere una rilevanza penale, sono stati acquisiti dall'Autorità giudiziaria e poi da questa trasmessi al Comitato. Essi contenevano notizie, voci incontrollate e pettegolezzi sulle vicende politiche italiane, per scopi molto lontani da quelli istituzionali. Appariva chiaro che erano stati raccolti a vantaggio di gruppi interni allo schieramento di governo. Il medesimo schema - sia per quanto riguarda la disposizione formale delle carte, sia in qualche caso per i contenuti estranei ai fini istituzionali - si ritrova nei 21 fascicoli del SISDe, riguardanti esponenti politici, e impiantati nel periodo di direzione del prefetto Domenico Salazar (10 agosto 1993 - 12 luglio 1994). Ad essi il Comitato parlamentare ha dedicato un'apposita Relazione presentata alle Camere il 27 luglio 1995 (Doc. XXXIV n. 2). Anche in questo caso siamo di fronte ad appunti anonimi, conservati in uno stato di estremo disordine, tanto da non poter escludere una manipolazione dei fascicoli e una sottrazione di fogli. Almeno per due documenti anonimi conservati da Craxi - una nota sulla «Operazione Gladio» e una che contiene riferimenti cifrati, nella quale cioè si parla di persone non nominate, ma individuate con numeri e asterischi - sembra indubbia la provenienza dall'ambiente dei Servizi. È opportuno esaminare questi documenti per primi. Essi hanno comunque la stessa ispirazione e la stessa funzione di tutti gli altri: richiamano fatti che si presumono non noti, anzi segreti, e la cui divulgazione può servire a denigrare gli avversari. In generale, molti tra i documenti presentano caratteristiche di struttura e linguaggio assai simili a quelle dei dossiers illegittimi o irregolari che il Comitato ha avuto in passato occasione di conoscere. 6. L'appunto dal titolo «Operazione Gladio» si riferisce a vicende e attività del Servizio segreto militare, in gran parte ancora oggi oscure. Questa nota - al di là della rozzezza del linguaggio - rivela un duplice scopo: fornire argomenti e notizie riservate utilizzabili contro l'on. Giulio Andreotti, che aveva svelato l'esistenza della struttura Gladio, e al tempo stesso di dare di questa una visione riduttiva. «Tale presunta operazione - è scritto - che è prevista peraltro fin dal 1949, sia pure sotto il nome di codice diverso, ricorda tanto quella con cui l'on. Andreotti provvide a buttare per aria i Servizi quando voleva riassumerne il controllo completo (caso Miceli-Maletti). L'on. Andreotti sottoscrisse infatti, già all'inizio degli anni sessanta, quale Ministro della difesa, i piani segreti NATO per contrastare un'eventuale invasione da parte russa e gli uomini che hanno seguito quest'aspetto, peraltro del tutto marginale dell'attività dei Servizi, sono sempre stati uomini a lui legati, finché l'ammiraglio Martini non ha provveduto a sostituirli con persone diverse». Per sminuire la portata di Gladio si segnala inoltre l'esistenza, nel Servizio segreto militare, di una struttura simile, ma più occulta ed efficiente. «Un superservizio in realtà è sempre esistito, ma non è quello di cui si parla e aveva ed ha compiti informativi, non certo assegnati agli uomini della Gladio …». L'appunto è databile tra la fine del 1990 e gli inizi del 1991: cioè nella fase in cui per ordine dell'on. Andreotti la struttura Gladio veniva smobilitata. Proprio allora si andava acuendo la tensione tra il Presidente del Consiglio e il direttore del SISMi, ammiraglio Martini, che sfocerà nella mancata proroga del trattenimento in servizio di questi e, quindi, in pratica, nel suo allontanamento dalla Direzione del SISMi in data 26 febbraio 1991. La tesi sostenuta è che Andreotti abbia compiuto qui la stessa operazione di liquidazione di alcuni centri di comando dei Servizi, già realizzata negli anni settanta. In particolare, nel 1974, egli aveva provocato una crisi nel SID, sia attraverso un'intervista a Massimo Caprara, per il settimanale «Il Mondo», rivelando la identità del neofascista Guido Giannettini, confidente del Servizio, sia attraverso iniziative contro il generale Vito Miceli (allora Direttore del SID), in rapporto alle vicende del cosiddetto golpe Borghese e della «Rosa dei venti», sia offrendo, dal marzo 1974, come Ministro della difesa, un attivo sostegno al generale Gianadelio Maletti (allora Capo dell'Ufficio D), nello scontro interno che lo contrapponeva a Miceli. L'accenno ai piani segreti NATO, sottoscritti da Andreotti, pur nella sua genericità, deve riferirsi a due episodi, concernenti collegamenti di Gladio nel quadro NATO. Il primo è del giugno 1959: il Servizio italiano entrò allora a far parte del «Comitato di pianificazione e coordinamento», organo di SHAPE (2). Il secondo del 1964: in quell'anno il Servizio entrò a far parte del «Comitato clandestino alleato (ACC)», emanazione del suddetto Comitato di pianificazione e coordinamento e costituito tra paesi che intendevano organizzare una resistenza sul proprio territorio, in caso di aggressione dell'est e, a quanto sembra, anche nell'eventualità di «sovvertimenti interni» (3). Quando furono realizzate queste due intese con gli alleati, il Ministro della difesa era l'on. Andreotti. Dunque egli sapeva e questo è un argomento da usare contro di lui. Rispetto agli accertamenti che sono stati in varie sedi condotti, la nota contiene due notizie all'apparenza nuove:
------------------------------ © Servizio per le informazioni e la Sicurezza Democratica ------------------------------

a) la nascita di Gladio nel 1949; b) l'esistenza di un «superservizio». Sul primo punto, occorre ricordare che nel protocollo d'intesa tra il Servizio italiano e quello statunitense del 26 novembre 1956, per la costituzione di Gladio, vi era stato un esplicito riferimento ad accordi preesistenti. Nella relazione inviata dal presidente del Consiglio Andreotti alla Commissione parlamentare d'inchiesta sul terrorismo e sulle stragi il 17 ottobre 1990, verrà segnalato che con quella intesa tra SIFAR e CIA erano stati «confermati tutti i precedenti impegni intervenuti nella materia tra Italia e Stati Uniti». In base a quanto risulta dalle indagini giudiziarie è fuor di dubbio che in epoca precedente alla creazione di Gladio sia esistita un'altra organizzazione denominata «Duca», con le stesse finalità e struttura analoga, di cui sappiamo ben poco e che dovrebbe essere stata sciolta intorno al gennaio 1995 (ma in vari documenti acquisiti dall'Autorità giudiziaria si parla di organizzazione «Duca - Gladio») (4). Sul secondo punto, va sottolineato che la notizia della esistenza di un superorganismo occulto all'interno del Servizio segreto militare non poteva considerarsi nel 1990-1991 del tutto inedita, essendo già più di una volta affiorata nella tormentata vicenda delle indagini giudiziarie sui fenomeni di eversione e di deviazione degli apparati dello Stato. Alcune testimonianze a proposito di una struttura occulta operante nel SID furono raccolte nel 1974 dal giudice Giovanni Tamburino che indagava sulla organizzazione eversiva «Rosa dei venti». Il 14 dicembre 1977, il generale Vito Miceli, interrogato nel processo per il golpe Borghese, che si svolgeva davanti alla Corte d'assise di Roma, ammise esplicitamente l'esistenza di un organismo occulto nell'ambito del Servizio segreto italiano. Vi fu anche una specifica indagine giudiziaria conclusasi con l'archiviazione in data 22 febbraio 1980. Il presidente del Consiglio Andreotti aveva risposto, il 4 ottobre 1978, all'interpello della Procura della Repubblica di Roma, escludendo con una formula estremamente ambigua l'esistenza dell'organismo occulto. La questione riemerse proprio quando fu portata alla luce la struttura Gladio ed è tuttora oggetto di accertamenti da parte dell'Autorità giudiziaria. Tra l'altro, l'istruttoria condotta dal giudice istruttore di Milano Guido Salvini, relativa ad attentati collegati con la strage di piazza Fontana, ha individuato l'esistenza di una struttura clandestina predisposta ad attività di guerriglia (e denominata «Nuclei di difesa dello Stato»), che sarebbe stata coinvolta in azioni terroristiche e i cui componenti erano reclutati nell'ambiente della destra eversiva. Il giudice istruttore di Milano ha deciso la trasmissione degli atti alla Procura di Roma per i necessari approfondimenti, anche riguardo alle eventuali connessioni con Gladio. L'appunto in possesso dell'on. Craxi si riferisce a questo groviglio di situazioni non chiarite. Ed è anzi questa, ad avviso del Comitato, un'occasione per sottolineare come troppe volte nel passato sia stato assente l'impegno del Governo a conoscere la verità e sia mancata una leale collaborazione con l'Autorità giudiziaria. Perciò oggi è necessario un orientamento nuovo che rompa la continuità con quel passato. L'appunto inoltre contiene implicitamente un elogio dell'ammiraglio Martini che avrebbe contrastato il potere di Andreotti. L'autore conclude scrivendo: «… poiché raccontarle lo sviluppo di tutta questa storia comporterebbe svariate cartelle, oltre l'uso di dati classificati COSMIC, resto a sua disposizione per farlo ove ella ne avvertisse la necessità. Allo stato attuale mi bastava significarle la mia idea, peraltro condivisa nel mio ambiente, che Andreotti stia agendo unicamente per riunificare il Servizio (esigenza sempre più imprescindibile) sotto mano a lui fedele». Queste frasi inducono a credere che l'estensore dell'appunto fosse inserito (tra la fine del 1990 e gli inizi del 1991) nelle sfere più elevate del Servizio informativo militare. Peraltro l'on. Craxi, nell'audizione svoltasi davanti al Comitato il 28 novembre 1990, pur ribadendo la propria piena fiducia personale nei confronti di Martini (che aveva nominato capo del SISMi), dichiarò di non aver mai avuto, quando era Presidente del Consiglio, una effettiva conoscenza della struttura Gladio né delle sue attività e dei suoi collegamenti in ambito NATO, sottolineando la limitatezza e il carattere formale dei controlli previsti in questa materia. L'appunto esaminato dimostra come, al momento opportuno, il segretario del PSI potesse ottenere notizie più precise (anche se manipolate, in relazione alle manovre politiche a cui servivano) dall'interno del Servizio. Il Comitato ritiene che proprio in questo quadro di controlli insufficienti e di deleghe in bianco siano maturate le deviazioni più gravi nella complessiva esperienza dei Servizi e si siano determinati rapporti anomali ed extraistituzionali tra esponenti politici del sistema di governo (come era l'on. Craxi) e funzionari chiamati a dirigere questi apparati. 7. La denigrazione degli avversari è la finalità posta a base di un altro documento che contiene riferimenti cifrati.
------------------------------ © Servizio per le informazioni e la Sicurezza Democratica ------------------------------

Esso segnala incontri di dirigenti del Partito comunista italiano, tra i quali Enrico Berlinguer, con persone che vengono indicate mediante numeri. Non è chiaro se si tratti di notizie indirette, aggiustate o inventate, oppure del risultato di una vera e propria attività di pedinamento. È assai grave che, in una recente intervista a un organo di stampa, l'ammiraglio Martini abbia voluto fornire una inaccettabile giustificazione di simili attività di controllo ad opera dei Servizi, realizzate nei confronti di esponenti politici e parlamentari. Questi appunti sono ovviamente databili nella prima metà degli anni ottanta (prima della morte di Berlinguer, che è del giungo 1984, e in una fase in cui egli era nettamente schierato contro la politica craxiana). Si richiama la vicenda del prestito del Banco Ambrosiano a favore del quotidiano Paese Sera e si comunica che un ex giornalista di quella testata, rimasto senza lavoro, sarebbe pronto a parlare dei finanziamenti al PCI. Una nota cifrata e altrettanto oscura, nello stesso foglio, si riferisce a presunte informazioni utilizzabili contro il ministro del lavoro Franco Marini; e vi è infine un cenno a foto e filmini, che sarebbero nelle mani di una persona, anch'essa indicata soltanto con un numero. I termini usati e la configurazione del documento portano a ritenere che esso abbia origine all'interno di uno dei Servizi di informazione e sicurezza e che i nomi coperti da cifre siano quelli di uomini collegati con la struttura, i quali hanno collaborato alla raccolta di notizie manipolate o costruite artificialmente contro determinati obiettivi politici. L'appunto sul ministro Marini, a differenza degli altri inseriti nel documento, è di epoca recente. È sicuramente posteriore al 13 aprile 1991 (data di nomina del Ministro che rimase in carica fino al 22 aprile 1992) e può essere ancora più vicino nel tempo. È verosimile che l'onorevole Marini sia divenuto oggetto di particolare attenzione, quando ha assunto funzioni di direzione del Partito popolare, vale a dire nel 1994. 8. Vi sono poi alcuni documenti che contengono voci e affermazioni infamanti, in gran parte già emerse negli anni ottanta e in vario modo connesse con le operazioni di intossicazione informativa che si sono sviluppate attorno alla loggia massonica P2. Un dossier, costituito da quattro documenti, si riferisce al caso delle tangenti che, alla fine degli anni settanta, sarebbero state pagate a esponenti politici italiani sulle importazioni di petrolio greggio dall'Arabia Saudita. Al centro dell'affare erano l'ENI e i suoi dirigenti. Il dossier contiene anzitutto un Appunto anonimo, del 27 febbraio 1980, redatto in una forma che è consueta per i Servizi, identica a quella di altri documenti irregolari già in possesso del Comitato. Anzi, nei fascicoli illegittimi del periodo 1977-1981, sono comprese alcune note anonime dello stesso genere redatte tra l'autunno 1979 e i primi mesi del 1980, inviate al CESIS, che si riferiscono a questa vicenda, in rapporto alla politica del PSI. «Il caso delle tangenti ENI - è scritto nel testo - starebbe per tornare alla ribalta. Questa volta sarebbe corredato da elementi più particolareggiati di quanto non lo fosse prima. Colui che avrebbe in mano tutta la faccenda sarebbe il giornalista Zicari, capo ufficio stampa di Monti». La nota si riferisce a un vero e proprio conflitto che si stava svolgendo per il controllo dell'ENI. Le informazioni sui percettori delle tangenti (come quelle che sembravano in possesso di Zicari, il cui nome risulterà nelle liste della P2) servivano come armi nel conflitto. Il dossier comprende altri documenti che riguardano le vicende interne dell'ENI, in particolare l'allontanamento di Mazzanti e la nomina di Grandi come presidente e di Leonardo Di Donna come vicepresidente (altro nome incluso nelle liste P2). Craxi ha raccolto notizie o pseudo-notizie utili per intervenire in questo scontro di potere e perfino un anonimo a carico di Di Donna, del quale questi appunti segnalavano, nei primi mesi del 1980, il progressivo avvicinamento alla segreteria del PSI. 9. Tra le carte conservate fino ad oggi vi è una lettera di Francesco Pazienza. Già «collaboratore» del SISMi e tra gli «affiliati coperti» del Grande Oriente d'Italia, legato ad ambienti mafiosi e a esponenti della banda della Magliana, egli era stato al vertice di una catena di comando parallela nel Servizio segreto militare, realizzatasi ai tempi in cui questo era diretto dal generale Santovito e sostanzialmente controllato dalla P2. La lettera, piena di insinuazioni e dal tono ricattatorio, risulta inviata il 7 febbraio 1983 a Eugenio Scalfari e non può che provenire dallo stesso Pazienza. Altre affermazioni calunniose contro Scalfari sono contenute in un appunto anonimo dal titolo «Scandalo Flavio Carboni (1980-1989)», più vicino nel tempo, redatto con il medesimo stile della lettera e che può avere identica origine. 10. L'interesse ancora attuale di Craxi per le vicende della P2 è dimostrato da un promemoria, scritto di
------------------------------ © Servizio per le informazioni e la Sicurezza Democratica ------------------------------

recente per difendersi dalle accuse relative al conto «Protezione» e ai rapporti con Gelli. Egli ha inoltre conservato un lungo documento riguardante quella loggia massonica. Il testo è stato certamente redatto tra la tarda primavera e l'inizio dell'estate 1984 (5). Contiene l'annotazione a mano «Copia fu data ad Andò». L'autore intende dimostrare che Licio Gelli sia stato collegato al PCI e che sia stato un agente manovrato dai Servizi segreti sovietici. Per sostenere questa tesi, viene taciuto il fatto, documentalmente certo, che Gelli è stato, durante l'ultimo periodo della guerra, collaboratore a Pistoia del Counter Intelligence Center, organo periferico dell'OSS (Office of Strategic Services), il Servizio statunitense addetto alle informazioni, al controspionaggio e ad attività oltre le linee nemiche (6). Si ricostruiscono inoltre le vicende che hanno portato Gelli ad occupare in breve tempo il posto di primo piano nella massoneria (e precisamente nel Grande Oriente d'Italia). Si sostiene come, in tutti gli affari di cui è stato partecipe, egli abbia sempre mantenuto una propria autonomia, «senza mai dipendere direttamente da nessuno». Si approda così a un visione riduttiva e fuorviante del sistema piduista, con la quale, tra l'altro, si sdrammatizza il fatto che di quella loggia facessero parte tutti i Capi dei Servizi segreti. 11. Una testimonianza del collegamento con settori dei Servizi, che forniscono materiale informativo a Craxi, si trova in un promemoria scritto da lui stesso a proposito dello scandalo che aveva coinvolto nel 1983 alcuni amministratori socialisti di Torino. Vengono raccolte notizie sugli accusatori: Adriano Zampini, che con le sue deposizioni ha consentito ai magistrati di smascherare un complesso ed esteso sistema di tangenti, e l'ingegner De Leo, il primo a sporgere denuncia contro quegli amministratori, su consiglio del sindaco Novelli. In particolare, il promemoria contiene ragguagli sul loro passato politico e sui loro affari. Si indica espressamente che queste notizie provengono dai Servizi. Si mette insieme tutto ciò che è possibile (compresa l'insinuazione che il magistrato al quale la denuncia è consegnata sia prevenuto e di parte) allo scopo di delegittimare il processo penale. 12. Numerosi appunti, nella solita forma anonima, contengono accuse contro il PCI, fino all'inizio degli anni novanta, e poi contro il PDS e i suoi dirigenti. Si ricordano ulteriormente i prestiti effettuati dal Banco Ambrosiano, a cui si riferiva l'appunto cifrato già preso in esame. Con particolare attenzione vengono raccolti dati e notizie che possano attestare finanziamenti dall'Unione Sovietica al PCI. Inoltre, sui rapporti tra i due partiti, sono conservati documenti non recenti, provenienti dall'Unione Sovietica. Alcune note sono dedicate alle cosiddette cooperative rosse, alle quali si afferma che spetterebbe, pressoché ovunque, una quota fissa di appalti pubblici, pari al venti per cento del totale, grazie ad un accordo tra politici e imprenditori, di cui sarebbe stato parte prima il PCI e poi il PDS. Si segnala il fatto che i dirigenti del PCI e del PDS abbiano compiuto, in passato, viaggi nell'Unione Sovietica. Si descrivono numerosi affari con i paesi dell'est che avrebbero procurato vantaggi a società collegate con il PCI. Infine, si passano in rassegna le difficoltà che sarebbero state da più parti frapposte alle indagini sul «fronte rosso», condotte dalla dottoressa Tiziana Parenti. È evidente la ricerca di elementi idonei a dimostrare che la corruzione e il finanziamento illecito erano comuni a tutti i partiti. In massima parte, si tratta di documenti già noti, in relazione ai quali sono stati svolti accertamenti giudiziari. In qualche caso si è perfino proceduto per calunnia contro Craxi. 13. Altre note, in cui si descrivono pretese attività illecite, riguardano invece esponenti politici del PSI, tra i quali Claudio Martelli e Ottaviano Del Turco. Provenienti da ambienti del partito, queste informazioni servono come mezzi di lotta politica interna e sono state con ogni probabilità utilizzate (per Del Turco anche pubblicamente), tra il 1992 e il 1993, in una fase nella quale il partito esisteva ancora e Craxi cercava di neutralizzare in ogni modo i suoi possibili successori. 14. Un appunto anonimo, su un foglio senza intestazione, riguarda la Lega Nord e precisamente l'acquisto della sede di questo movimento a Milano. Lo schema è sempre quello dei fogli volanti e privi di intestazione, presenti in larga quantità, come si è detto, nei fascicoli dei Servizi e che possono facilmente sparire senza lasciar traccia.
------------------------------ © Servizio per le informazioni e la Sicurezza Democratica ------------------------------

In questo caso vengono raccolte notizie sul prezzo dell'immobile acquistato, sulle persone intervenute nella operazione, sui loro collegamenti e sui loro trascorsi, evidentemente alla ricerca di qualche elemento da usare contro la Lega. 15. Una scheda di tre pagine, senza firma né intestazione, riferisce dati informativi sul professor Romano Prodi e sulla sua gestione dell'IRI. Si valuta negativamente tale gestione e si sollevano dubbi sulla sua correttezza. 16. Due brevi dossiers sono dedicati a due associazioni milanesi: «Società civile», facente capo al professor Nando Dalla Chiesa e «Proposta nuova», facente capo all'onorevole Ombretta Fumagalli Carulli. Il primo è siglato «F.F.»: ricostruisce la storia di «Società civile» e ricorda alcuni degli aderenti, con una puntigliosa elencazione dei magistrati che hanno partecipato alle sue iniziative. Tra questi viene segnalato il dottor Antonio Di Pietro, si insiste sui suoi viaggi negli Stati Uniti (uno dei quali in compagnia del professor Dalla Chiesa), come se celassero trame misteriose, e si insinua che nelle indagini giudiziarie sulla corruzione abbiano ottenuto un trattamento di favore gli esponenti politici che avevano rapporti con l'associazione. Il secondo dossier utilizza notizie che non possono venire se non dall'interno dell'Associazione. Chi può averle raccolte? L'appunto anonimo è particolarmente dettagliato. Viene illustrato l'assetto organizzativo di «Proposta nuova» e si indica come di essa abbiano fatto parte, con la onorevole Fumagalli, il dottor Di Pietro e il consigliere comunale Radice Fossati. In entrambi i casi, appare chiara la ricerca di spunti che servano all'attacco contro i magistrati del pool milanese e soprattutto contro il dottor Di Pietro. 17. Uno speciale rilievo assume il materiale riguardante i magistrati. Esso si inquadra in un contesto di scritti e di annotazioni che definiscono l'azione condotta da varie Autorità giudiziarie contro il sistema della corruzione, come una specie di colpo di Stato: non come la riaffermazione dei diritti negati, dopo una lunga fase di illeciti commessi da esponenti politici, ma piuttosto come un cumulo di illegalità. Tale denuncia, peraltro, rimane genericamente sullo sfondo. Non viene contestato in questi scritti il merito delle azioni penali. A parte una lunga memoria, databile nel 1993, che figura in due diverse stesure, entrambe recanti all'inizio l'intestazione «Previti», ove si sostiene che il Parlamento dovrebbe programmaticamente negare tutte le autorizzazioni a procedere per ristabilire un equilibrio tra i poteri, non vi sono note che effettivamente riguardino l'esercizio della giurisdizione. Tutto l'impegno è altrove ed è volto a delegittimare i magistrati. Per fermarli si ricorre alla disinformazione, alle insinuazioni spesso inverificabili e perciò capaci di lasciare comunque un segno negativo. Il tutto alla ricerca di eventuali punti deboli (o che appaiano tali) nella vita personale di chi si vuole colpire. La posta in gioco, per chi come l'on. Craxi è incalzato da numerosi procedimenti penali, è assai alta. Proprio per questo, la fabbricazione degli strumenti informativi da usare nell'attacco presuppone un lavoro complesso e sofisticato. 18. Una nota anonima in diciotto paragrafi contiene accuse di scorrettezza, rivolte al sostituto procuratore della Repubblica di Roma dottor Vittorio Paraggio e al procuratore della Repubblica dottor Vittorio Mele per una trasferta giudiziaria in Perù che si sarebbe protratta troppo a lungo. Il dottor Paraggio è stato titolare dell'inchiesta sulla cooperazione, che concerneva tra l'altro i rapporti Italia-Perù, e in questo ambito le relazioni intercorse tra l'on. Craxi e l'ex presidente del Consiglio peruviano Alan Garcia, sottoposto nel suo paese a procedimento penale per fatti di corruzione. Vengono utilizzate e manipolate notizie provenienti dal Perù e Craxi sembra al corrente di tutti i movimenti dei due magistrati. 19. A proposito del dottor Di Pietro, occorre sottolineare che in queste carte egli è più volte indicato come un vero e proprio nemico, con il quale non si può venire a patti. Non mancano anzi gli accenni polemici alla posizione del senatore Cossiga, e alla benevolenza mostrata nei confronti del magistrato. Tuttavia, è lo stesso on. Craxi, in una lettera inviata al suo avvocato il 22 giugno 1995, ad affermare che nel 1992, con la mediazione del presidente del Consiglio Giuliano Amato e su iniziativa del capo della polizia Vincenzo Parisi, si sarebbe stabilita una sorta di intesa con il dottor Di Pietro e che ciò avrebbe indotto il Segretario
------------------------------ © Servizio per le informazioni e la Sicurezza Democratica ------------------------------

del PSI a non dire ciò che già sapeva e a non portare fino in fondo le sue critiche e le sue denunce contro gli abusi giudiziari commessi da quel magistrato. In realtà questo preteso accordo non sembra aver prodotto alcun risultato. I procedimenti penali sono anzi andati avanti, senza riguardi per Craxi e per i suoi amici. Sebbene la raccolta di elementi informativi per denigrare Di Pietro sia cominciata presto (i dossiers già circolano nel 1993), un vero e proprio attacco frontale si scatena soltanto nel 1994. Durante questo anno si preciseranno le insinuazioni e si farà ricorso ad un elemento informativo nuovo, prima usato riservatamente per esercitare pressioni sul magistrato, e solo recentemente divenuto pubblico. 20. Tra le carte di via Boezio, vi sono diversi appunti relativi al dottor Di Pietro, con notizie che si riferiscono a tre filoni di ricerca: anzitutto all'epoca in cui - prima di divenire magistrato - egli era nella polizia di Stato; in secondo luogo alle amicizie che egli aveva stretto e coltivato a Milano; in terzo luogo alle modalità con le quali, dal 1992 in avanti, egli aveva condotto le indagini sui fatti di corruzione. Per quanto concerne il periodo più lontano, le note in possesso di Craxi tentano di suggerire un collegamento tra l'attività di Di Pietro quando era in polizia e le vicende dell'autoparco, sede, come è noto, di traffici illeciti e punto di riferimento di attività mafiose nel centro-nord. Uno degli appunti - redatti in una forma che è consueta per i Servizi - afferma, tra l'altro, che il procuratore della Repubblica Borrelli «non poteva non vedere quello che avveniva all'autoparco di Milano» ed avanza dubbi sul comportamento di altri magistrati. Si tratta di affermazioni prive di riscontro e talvolta inverosimili. Il secondo filone è rappresentato dalle amicizie e dai rapporti personali del dottor Di Pietro. In particolare, gli appunti insistono sul suo rapporto con l'avvocato Lucibello che fin dall'inizio delle indagini sarebbe stato molto vicino al magistrato, con interessi economici in comune, tanto da esercitare un condizionamento su di lui. Il terzo filone comprende la denuncia di favoritismi e di un atteggiamento non equo nei confronti degli indagati: alcuni di loro avrebbero evitato il carcere o l'avrebbero subìto per pochissimo tempo, altri sarebbero stati trattati assai più duramente. Caratteristico di tutti questi appunti è il fatto che essi non siano raccolti a fini di giustizia, che non vengano usati per chiedere l'intervento della magistratura competente, ma piuttosto per spargere veleno, per cercare di intimidire il magistrato che si considera nemico, per demolirne l'immagine. Una novità interviene nel 1994. Andando al di là delle generiche denunce già note, relative ai collegamenti di Di Pietro con professionisti e imprenditori, le informazioni riguardano ora un fatto che si presenta come oggettivo. Tra il febbraio e il maggio 1992, nella fase cruciale delle indagini che hanno fatto esplodere il sistema di Tangentopoli, Di Pietro avrebbe effettuato una serie di telefonate, in particolare con gli avvocati Lucibello e D'Adamo, i quali a loro volta avrebbero avuto contatti telefonici con persone coinvolte nei reati su cui vertevano le indagini, il tutto attraverso apparecchi cellulari. Il riferimento alle telefonate è contenuto per la prima volta in una lettera dal tono intimidatorio, indirizzata dall'on. Craxi al dottor Di Pietro, il 25 febbraio 1994. Essa in particolare contesta il trattamento di favore accordato ad alcuni indagati. Ma l'elenco analitico di quelle telefonate fa parte di un dossier che ha costituito la base di avvio dell'attività ispettiva iniziata nell'autunno del 1994 a carico del dottor Di Pietro e chiusa il 7 dicembre, nel giorno successivo alle sue dimissioni. L'originale di quel dossier, mai protocollato, fu fatto distruggere dal Capo dell'ispettorato del Ministero di grazia e giustizia verso la fine di dicembre del 1994. Fotocopie di documenti in esso inclusi sono state poi trasmesse alla Procura della Repubblica di Brescia da uno degli ispettori. Mentre l'indagine della Procura di Brescia era in corso, e la vicenda del dossier era già emersa, l'on. Craxi ha reso noto pubblicamente l'elenco delle telefonate, a cui aveva già fatto cenno nella sua missiva di febbraio indirizzata a Di Pietro e che era stato trascritto per intero nel dossier riservato fornito agli ispettori. Il 22 giugno 1995, in una lunga lettera all'avvocato Del Giudice, Craxi ha affermato che i tabulati relativi alle telefonate gli erano stati forniti dal prefetto Vincenzo Parisi. Il Comitato, sulla base della documentazione in suo possesso, rileva che tra le carte conservate dall'on. Craxi e i documenti che componevano il dossier da cui è sorta l'ispezione, vi è una concordanza di ispirazione nonché la coincidenza di alcuni dati informativi. Al di là delle semplici voci e dei veleni, di cui
------------------------------ © Servizio per le informazioni e la Sicurezza Democratica ------------------------------

abbiamo già visto numerosi esempi, sembra evidente, da parte di Craxi, il perseguimento di una specifica attività di controllo nei confronti del dottor Di Pietro e di altri soggetti che avevano rapporti con lui. Si è trattato probabilmente di una raccolta di dati relativi al traffico telefonico, che, in assenza di un provvedimento dell'Autorità giudiziaria, può essersi realizzata soltanto attraverso l'attività illegittima di uno o più funzionari della Telecom. Non può escludersi una intercettazione delle telefonate. Comunque, anche la semplice acquisizione di tabulati delle telefonate, avvenute in un momento determinato e di particolare delicatezza delle indagini, è una iniziativa mirata: punta, come al solito, a sollevare sospetti e presuppone che i comportamenti e i contatti di Di Pietro fossero tenuti sotto un attento controllo. Craxi sostiene che per ottenere quei tabulati vi è stato un intervento della polizia. Getta così una pesante responsabilità sulle spalle del prefetto Parisi, scomparso alla fine del 1994. Ma le sue parole non trovano alcun riscontro. Riguardo a questa vicenda è necessario raggiungere la massima chiarezza. L'acquisizione di dati relativi alle telefonate di più persone non è cosa tanto semplice, che chiunque possa realizzare. Ma è soprattutto impegnativa la scelta del momento e degli interlocutori. È possibile che settori o singoli uomini degli apparati dello Stato abbiano lavorato per costruire informazioni riservate su Di Pietro e per tenerlo sotto controllo? Il Comitato ritiene che ciò sia verosimile. È compito dell'Autorità giudiziaria indagare, come già del resto sta facendo, su questo punto e sulla eventuale compromissione di funzionari dei Servizi di informazione e sicurezza. 21. Le carte dell'on. Craxi appaiono come un vero e proprio arsenale dei veleni. Alcuni appunti anonimi sono molto recenti e quelli che con maggiore probabilità provengono dall'interno dei Servizi si collocano nei primi anni novanta. Si tratta di un materiale fondamentalmente omogeneo. C'è una somiglianza di metodo e una continuità politica tra la disinformazione di impronta piduista dell'inizio degli anni ottanta (ad esempio le insinuazioni su Scalfari, le notizie fatte circolare sulle tangenti ENI) e i dossiers preparati, più di dieci anni dopo, contro i magistrati, in particolare contro il dottor Di Pietro. Il casuale ritrovamento di questi frammenti di archivio nelle mani di un ex Presidente del Consiglio consente di conoscere e di valutare un aspetto sotterraneo e nascosto della lotta politica. Siamo di fronte non a strumenti di conoscenza da usare per una competizione leale, ma piuttosto ad armi di offesa: pseudo-informazioni che servono a lanciare avvertimenti oscuri, a ricattare, a incutere timore, a gettare ombre e sospetti. Tutto questo ferisce la vita democratica. Le deviazioni dei Servizi di informazione e sicurezza che abbiamo conosciuto in passato dipendevano molto da questa lotta politica sotterranea. Le carte di Craxi rappresentano la conferma di un sistema. Resta da stabilire quanto di questi materiali provenga dall'interno di apparati dello Stato e di chi siano le responsabilità dei singoli comportamenti devianti. L'onorevole Craxi ha continuato a intrattenere rapporti con i Servizi, anche in anni recenti, come è dimostrato dal fatto che nelle agende sequestrate in via Boezio ricorrono più volte i nomi di funzionari di primo piano, soprattutto del SISDe, come Michele Finocchi o come il suo successore nella funzione di Capo di gabinetto, i cui nomi risultano in più annotazioni. Al riguardo il Comitato ha richiesto agli attuali Direttori del SISMi e del SISDe e al responsabile del II Reparto della Guardia di finanza se risultassero attività informative e, di conseguenza, formazione di dossiers sul conto del dottor Di Pietro, ricevendone formale risposta negativa. Il Comitato non ha oggi il potere di compiere un accertamento diretto sui rapporti tra i funzionari dei Servizi e chi ha condotto e conduce la lotta politica attraverso la disinformazione e le manovre occulte, ma si impegnerà a verificare autonomamente se sia stata svolta una attività informativa, evidentemente deviata, nei confronti del dottor Di Pietro. Su tutto ciò il Comitato potrà riferire nel contesto di una successiva relazione al Parlamento. Il Comitato può e deve chiedere all'Autorità di governo che un rigoroso controllo sia esercitato sugli archivi dei Servizi di informazione e sicurezza, per verificare se vi siano ancora tracce di attività illegittime. Alla magistratura spetta il compito di individuare chi abbia agito illecitamente e al Governo quello di cambiare strutture e uomini. Se è vero che i veleni e le calunnie non devono essere posti a base della politica, occorre perciò anzitutto garantire che nessun settore o singolo componente degli apparati dello Stato sia indirizzato alla raccolta di questi veleni. Tutta l'organizzazione degli archivi deve essere ristrutturata. La disposizione impartita dal presidente del
------------------------------ © Servizio per le informazioni e la Sicurezza Democratica ------------------------------

Consiglio Dini di bloccare la distruzione dei documenti costituisce un primo passo. Occorre prevedere tassativamente che ciascun documento o appunto informativo sia registrato e che ne sia garantita la univoca classificazione, in modo tale che sia reperibile e che non possa essere spostato né occultato. Il Comitato ribadisce l'urgenza di una riforma dei Servizi, che rafforzi da un lato la responsabilità politica dell'Autorità di governo, dall'altro il controllo parlamentare; e che si accompagni a un radicale mutamento nella composizione di questi apparati. Il cambiamento degli uomini, l'interruzione di prassi consolidate, la temporaneità della permanenza nel Servizio rappresentano fattori essenziali di innovazione. (*) Comunicata alla Presidenza il 26 ottobre 1995. (1) Si vedano in proposito i capitoli IV e VII del Primo rapporto sul sistema di informazione e sicurezza (Doc. XXXIV, n. 1). (2) SHAPE è la sigla di Superior Headquarters Allied Powers of Europe. Si tratta, praticamente, del Comando NATO in Europa. (3) Ciò è quanto risulta da un documento, datato 1 giugno 1959, rinvenuto nella documentazione di Gladio. La questione è stata trattata dalla Commissione parlamentare d'inchiesta sul terrorismo in Italia e sulle cause della mancata individuazione dei responsabili delle stragi nella seduta del 15 novembre 1990. (4) Tribunale di Bologna - Ufficio istruzione, Relazione di perizia del prof. G. De Lutiis, pp. n. 219\A\86 RGGI e n. 1329\A\84 RGGI- Allegato n. 20. (5) L'estensore si riferisce al parlamentare Giorgio Pisanò, componente della Commissione parlamentare d'inchiesta sulla loggia P2, affermando che egli ne fa parte «oggi». Inoltre, parla della Relazione Anselmi citandone vari brani. Ciò significa che la Commissione, mentre veniva scritto il documento, era in attività, anche se i suoi lavori stavano per terminare, essendo già nota la Relazione finale del Presidente. (6) V. Atti della Commissione parlamentare d'inchiesta sulla loggia massonica P2, vol. III, tomo II, pp. 23-25 e pp. 509-511.
------------------------------ © Servizio per le informazioni e la Sicurezza Democratica ------------------------------

Commissione Diocesana "Giustizia e Pace" - Diocesi di Milano Autonomie regionali e federalismo solidale
Introduzione 1. Mentre si fa più acuta l'esigenza di forme nuove di convivenza, in vista di una formazione e destinazione più equa ed efficace delle risorse in una società adulta e solidale (1), la capacità di porre mano a riforme incisive delle istituzioni non sembra rispondere all'urgenza dei problemi tenendo conto dei tempi indilazionabili che essi reclamano. Così da un lato rispuntano le propensioni al rinvio, nella sterile persuasione di un accomodamento spontaneo dei ritardi e degli scompensi, oppure si affermano le tendenze al blocco incrociato delle ipotesi risolutive, quasi che interessi e meriti di parte contino più delle cose da affrontare; d'altro lato serpeggia un senso diffuso di stanchezza o persino di sfiducia nella reale possibilità di progredire verso un assetto più adeguato delle forme di governo e di partecipazione. È invece indispensabile, proprio ora, non risparmiare sforzo alcuno in sede di riflessione sia in sede operativa, chiarendo le linee di evoluzione dei processi e offrendo uno sbocco effettivo ai disegni di più valida articolazione istituzionale. 2. Nelle pagine che seguono si considera innanzitutto la questione dei "livelli di governo" in una società che è diventata complessa e policentrica, reclamando una ridefinizione coraggiosa degli strumenti della politica. Con particolare riguardo ai processi economico-finanziari e alle dinamiche occupazionali che legano irreversibilmente le sorti dell'Italia con l'impresa dell'Unione europea, si presentano poi i motivi di carattere strutturale, che sollecitano il passaggio dall'accentramento a un sistema di autonomie regionali orientate al federalismo e alla introduzione di funzioni "reticolari". In modo specifico, la Lombardia può beneficiare di una tradizione storica che la rende matura per tale passaggio e, insieme, per fare da tramite al decollo di un nuovo sviluppo per il Paese intero. La consapevolezza di tutto ciò porta, nella quinta parte della trattazione, a suggerire una riforma del dettato costituzionale, secondo lo spirito della Costituzione stessa, volta a recepire il principio della "pari dignità" di ogni Ente di governo legittimamente riconosciuto come tale, correggendo l'attuale preminenza dello Stato sulle altre istituzioni. Nell'ultima parte, oltre a precisare i limiti della presente riflessione, si richiama l'importanza dei princìpi fondamentali - quali l'autonomia, la responsabilità, la solidarietà e la sussidiarietà - che fanno da filo conduttore dell'insieme del discorso e si incentrano sull'idea della promozione della persona umana attraverso istituzioni a essa finalizzate. 3. Se i princìpi personalistici e comunitari discendono direttamente dall'insegnamento sociale della Chiesa, così non si può certo dire della loro coniugazione in direzione di proposte come quella dell'ordinamento delle autonomie secondo una ristrutturazione delle istituzioni della convivenza in senso federale. Per il contenuto "tecnico" che le caratterizza, queste proposte hanno una inevitabile natura opzionale e sono interpretazioni non vincolanti di princìpi aperti ad altre declinazioni possibili. "La Chiesa" - ha detto Giovanni Paolo II nel suo discorso al Convegno ecclesiale di Palermo - non deve e non intende coinvolgersi con alcuna scelta di schieramento politico o di partito, come del resto non esprime preferenze per l'una o per l'altra soluzione istituzionale o costituzionale, che sia rispettosa dell'autentica democrazia (Cfr. Centesimus annus, n. 47)" (2). Allo stesso tempo il Papa ha invitato a "educarsi ai princìpi e ai metodi di un discernimento non solo personale, ma anche comunitario" (3). Con il nostro sforzo di riflessione abbiamo perciò cercato, per un verso, di proseguire un filone di pensiero che non pochi cattolici impegnati nell'azione politica hanno già sperimentato con esiti fecondi e, per altro verso, di dare una risposta concreta a bisogni storici urgenti. L'ambizione che ci anima è, infatti, di contribuire a uscire dalle secche nelle quali rischiano di incastrarsi i tentativi di ridare respiro e consistenza alla rigenerazione del tessuto democratico e partecipativo del nostro Paese, messo a dura prova dalla crescente estraneità dei cittadini alle istituzioni. Nostra convinzione è che dalla mortificazione della politica ci si possa salvare solo riqualificandola con il rigore del pensiero e dell'azione. Tale rigore ci fa dichiarare subito che l'orizzonte di solidarietà entro il quale abbiamo trattato il
------------------------------ © Servizio per le informazioni e la Sicurezza Democratica ------------------------------

tema del federalismo è per noi invalicabile e rappresenta una discriminante irrinunciabile di giudizio. "Federalismo solidale" vuol essere l'esatto contrario della contrapposizione tra le diverse parti del Paese. La prospettiva federale è valida se è capace di potenziare insieme autonomia e cooperazione, intrecciando strettamente la responsabilità per sé con la responsabilità per gli altri. Ciò significa che il fine del "federalismo solidale" è la realizzazione efficace della dignità di ogni persona nel rapporto con altre persone, senza barriere o privilegi territoriali. Sono questi i motivi che ci hanno condotto a proporre un discorso sulle buone ragioni della riforma regionale nel senso di un nuovo "regionalismo forte" o "federalismo solidale", in un contesto nel quale la vivacità della realtà lombarda si intreccia con le dinamiche nazionali e internazionali a livello di Unione europea. Per offrire innanzitutto spunti di riflessione e, poi, indicazioni per un cammino concreto, che può coinvolgere le forze presenti in tutto il Paese, a cominciare dalle regioni del Mezzogiorno, impegnate nella promozione diretta di condizioni più mature di benessere economico e civile. Non abbiamo voluto rinunciare al taglio scientifico dell'analisi e nemmeno al carattere puntuale dell'informazione. L'abbiamo ritenuto doveroso, dal momento che il nostro tema si presta a semplificazioni sloganistiche sia a favore sia contro. Lo scopo essenziale di questo documento è però di mobilitare la coscienza pratica dei credenti, e più in generale dei cittadini, verso un'azione politicamente costruttiva. Destinatari di quanto segue sono perciò tutti coloro che, nelle istituzioni o nella società civile, si sentono coinvolti nell'impresa di dare senso e contenuto alla ricerca del bene comune.
PARTE PRIMA - La questione dei livelli di governo e la sua importanza oggi
Le Istituzioni dello Stato e la crisi della politica 4. Si avverte da tempo, e pare diffondersi ogni giorno di più fra tutti i cittadini, la sensazione che le istituzioni politiche abbiano sempre maggiori difficoltà nello stare al passo con l'intensità di ritmo e l'ampiezza di trasformazione dell'economia e della società. Il fenomeno è ormai riscontrabile in vari Paesi europei: riguarda persino alcune democrazie già consolidate, ma tocca ancor più quelle che sono alla ricerca di una precisa identità. Per molti aspetti, anzi, il crescente distacco dalle istituzioni politiche e la sfiducia nella possibilità che il loro funzionamento possa essere più giusto ed efficace, rappresentano gli elementi più familiari, e anche più subdolamente pericolosi, di ciò che viene etichettato come "crisi della politica". Nel nostro Paese, sfiducia nelle istituzioni e indifferenza rispetto alla possibilità di migliorarle rischiano però di essere assai più acute che in altre democrazie dell'Europa. Il protrarsi della crisi politica è diventato tutt'uno con l'indebolimento del senso di appartenenza alla società, con lo smarrimento dei suoi valori più profondi, con l'incapacità di far crescere una cultura civica adeguata a una democrazia che intenda davvero esprimere - nella sempre più fitta rete delle interdipendenze odierne - una convivenza responsabile, solidale, confidente nella capacità di costruire il proprio futuro. Se è costretta a pagare la persistente inefficienza della macchina organizzativa del nostro Stato, la mancata fiducia nelle nostre istituzioni sconta, oltre al repentino venir meno di molte sicurezze finora offerte dallo Stato sociale, anche il corrompersi di una classe politica che ha via via abbandonato il senso autentico delle istituzioni quale strumento indispensabile per perseguire quel bene comune che aveva invece orientato il Paese nel periodo postbellico. La crisi della politica ci sta in tal modo rendendo assuefatti all'idea che sia impossibile lasciare alle spalle una tale crisi in tempi rapidi e seguendo percorsi ragionevoli e non traumatici. Eppure, uscire - finalmente e concretamente - dalla stagnazione della politica italiana è ormai una necessità non procrastinabile. E tanto più lo diventa quanto più la nostra società, per poter rispondere positivamente alla sfida delle responsabilità e dei compiti europei, deve rinsaldare le proprie peculiarità storiche e nazionali. Mentre fenomeni come la globalizzazione o la crescente necessità di democrazia internazionale rendono sempre più stretta l'interazione tra eventi e attori nazionali e su scala planetaria, il nuovo orizzonte della politica - in Italia come negli altri Paesi d'Europa - richiede con sempre maggior urgenza istituzioni che sappiano davvero articolare l'azione di governo della convivenza civile secondo i valori, gli interessi, i
------------------------------ © Servizio per le informazioni e la Sicurezza Democratica ------------------------------

bisogni reali della società.
Azione di governo e società policentrica 5. Oggi l'azione del governare si rivela risorsa più che mai indispensabile per la crescita delle società e per il buon funzionamento delle istituzioni. Ormai da tempo tutti i sistemi politici stanno sperimentando quanto sia complessa l'azione del governare sia attraverso gli schemi tradizionali dell'organizzazione dello Stato, sia con il ricorso alle più usuali procedure di acquisizione o mantenimento del consenso. La complessità attuale dell'azione di governo non è infatti un fenomeno contingente. Essa è invece il punto di convergenza delle più cruciali tra le trasformazioni politiche e sociali che hanno accompagnato l'Europa dalla fine del secolo scorso e che hanno modificato profondamente i rapporti fra l'organizzazione del potere statale e la società. L'acutizzarsi della crisi dello stato sociale rende ancora più manifeste e profonde le difficoltà del governare. Spesso assai ampie sia nei princìpi di funzionamento, sia negli effetti prodotti, le insufficienze del Welfare State sottolineano, infatti, la fragilità e precarietà dei rapporti tra società e potere statale, costringendo individui e gruppi a confrontarsi nuovamente coi vincoli, piuttosto che con le potenzialità, della politica. Mentre alcuni gruppi sociali sembrano avvertire come insostenibile il peso di qualsiasi limite imposto dalla politica, altri gruppi percepiscono con acuta intensità il rischio di essere abbandonati all'incertezza. Così, la risorsa politica e quindi la capacità di decisione si dimostrano particolarmente scarse e inefficienti proprio quando esse sarebbero determinanti per evitare che il contrasto tra le diverse parti della società, che rischiano di agire sempre più separatamente, imbocchino la strada di conflitti irreparabili. 6. Peraltro, caduta l'antica pretesa che toccasse per intero alla politica "dare un ordine alla società" attraverso un'azione generale e accentrata di governo, anche le rinate illusioni che la società possa darsi da sola un proprio ordine sufficientemente stabile e giusto sono destinate a dileguarsi rapidamente. La crisi dello Stato sociale, se ha rivelato il progressivo indebolimento della capacità organizzativa del modello di Stato accentratore, pone altresì la società di fronte alle sue primarie responsabilità nei confronti non solo di se stessa ma anche della politica. Soprattutto laddove l'accentramento istituzionale era stato reso necessario per poter procedere a forme più accelerate di unificazione politica e sociale, esso risulta ora inadeguato di fronte ai veloci mutamenti che hanno investito le sfere dell'economia e della società. La tendenziale concentrazione di pressoché tutti i livelli di governo nelle mani dello Stato, se da un lato entra in collisione con le diffuse propensioni a una tutela e a una promozione sempre più autonoma degli interessi di tipo locale, dall'altro lato risulta scarsamente coerente con quei processi che, ampliando l'area di osmosi tra ambito interno e ambito europeo, sollecitano l'azione di governo a un'incisiva ridefinizione dei propri strumenti e di alcune delle sue fondamentali finalità. La struttura del tradizionale sistema politico, organizzato gerarchicamente, si sta via via trasformando nell'intera Europa sul finire di questo secolo, in un nuovo sistema di attori politici autonomi ma interdipendenti, dando così vita a un policentrismo non solo economico e sociale, ma anche, nei fatti, già politico. La sovranità dello Stato-nazione viene sfidata e ridefinita tanto in senso ascendente (si pensi ai fenomeni della globalizzazione o del rafforzamento dell'Unione europea), quanto discendente (si pensi al fenomeno della frammentazione, di cui la forte tendenza verso il decentramento in favore di aree locali, regionali o metropolitane, rappresenta l'aspetto certo meno inquietante). E lo Stato, nella sua azione di governo, sempre meno infrequentemente è chiamato a contrattare o a cooperare di necessità con attori privati collettivi. Dalle veloci trasformazioni in atto sembra così profilarsi una nuova figura di Stato, chiamato a ridefinire le proprie aree di competenza e a coordinare orizzontalmente la sempre più robusta rete di relazioni tra attori economico-sociali interni e internazionali. Per altro verso, la struttura policentrica richiede con maggior forza una redistribuzione di poteri e di funzioni tra il governo centrale e autonome organizzazioni di settore a carattere simultaneamente pubblico e privato. Bisogna allora ritenere che questi processi siano di disegno disgregatore? Senza nasconderci che ogni passaggio al nuovo presenta difficoltà e persino rischi di regressione, noi pensiamo che quanto più le società evolvono verso configurazioni policentriche, tanto più l'azione di governo è destinata a qualificarsi, a precisarsi e ad articolarsi, così da favorire la crescita della democrazia e da impedire che si divarichino, in
------------------------------ © Servizio per le informazioni e la Sicurezza Democratica ------------------------------

modo irreparabile, democrazia e mercato.
La necessità di riarticolare i livelli di governo 7. Le società policentriche non sono affatto società anomiche, che respingano la presenza di regole o non ne avvertano la necessità. Per molti aspetti, anzi, più le società si vanno trasformando in senso policentrico, più si eleva la domanda di regole e di governo. Di fronte a tale domanda, la struttura accentrata dei tradizionali schemi organizzativi dello Stato finisce non solo con l'irrigidire e burocratizzare l'azione di governo, ma anche con il parcellizzarla, segmentandola, a favore (o contro) di questo o quel gruppo di pressione e di questa o quella organizzazione privata. L'impossibile capacità di omologazione dello Stato accentrato non di rado conduce così al paradosso che le sue attività, pur orientate a creare eguaglianza, in realtà ricalchino ed amplifichino - quando non ne producano di nuove - le fratture e le diseguaglianze già presenti nella società, con l'esito formale di renderle insormontabili e forse irreversibili. La sfida innovativa a cui sono chiamate le vecchie forme organizzative dello Stato è allora quella di realizzare il passaggio da un centralismo istituzionale, ormai impossibilitato a essere efficiente, verso un policentrismo istituzionale che, realmente aggregante, si fondi in modo autentico sui princìpi di sussidiarietà e solidarietà. Se è vero, infatti, che il governo è la componente del sistema politico che più si avvicina al concetto di centralità, altrettanto vero è che sta crescendo in misura cospicua la rilevanza da un lato dei centri locali, dall'altro di quelli sovranazionali. In sostanza, ogni azione di governo viene ad essere la risultante dell'intreccio di livelli fondamentali: quello "statale", quello "sovranazionale", quello "local-regionale" e quello "settoriale". Nasce da qui, in particolare nel nostro Paese, la necessità di procedere a una riarticolazione dei diversi livelli di governo. Con un duplice e fondamentale obiettivo: quello di dare finalmente soluzione alle principali e secolari distorsioni prodotte dall'accentramento burocratico delle istituzioni statali, e quello, soprattutto, di innovare le nostre istituzioni secondo i criteri necessari per la costruzione dell'Europa. Solo attraverso una tale indispensabile articolazione le attività di governo potranno risultare in grado di guidare le trasformazioni in atto, così rispondendo concretamente al crescente bisogno di avere uno Stato fornito di una identità precisa, riconosciuta e condivisa da tutti i cittadini, non confondibile con la figura di questo o quel partito o alleanza di partiti.
Unione Europea, Stati nazionali, Regioni 8. La precedente riflessione mette in evidenza che vi sono problemi non più affrontabili e risolvibili a livello nazionale. Questo è vero perché vi sono questioni che implicano sia livelli decisionali che superano lo Stato nazionale, sia livelli decisionali che possono essere più efficacemente impostati su scala subnazionale. La nostra riflessione dovrà quindi riferirsi da un lato alla dimensione europea e dall'altro alla dimensione regionale. Rispetto a entrambe devono essere revisionate le funzioni e formulate le proposte di riforma delle istituzioni del nostro Paese per una più ricca partecipazione dei cittadini in vista di una democrazia compiuta. I problemi da affrontare e risolvere riguardano innanzitutto gli aspetti di tipo socioeconomico che oggi, dopo cinquant'anni di esperienza nella costruzione europea, sono inscindibilmente legati a questa dimensione, si tratti delle sfide della competizione internazionale, delle richieste di occupazione, della diffusione equilibrata dei beni della convivenza, della risposta alla crisi finanziaria di alcuni stati europei. 9. D'altra parte vi sono bisogni che possono essere più efficacemente soddisfatti mediante livelli di governo subnazionale identificati nel nostro Paese soprattutto in ambiti "regionali", i quali a loro volta possono anche contribuire opportunamente alla soluzione di alcuni dei problemi socioeconomici già indicati. Infatti il dislocamento regionale è del tutto compatibile con la dimensione europea, dandole concretezza e ricevendone un quadro adeguato di orientamento. All'incrocio delle riarticolazioni tra i livelli di governo si colloca una prospettiva di cittadinanza condivisa e di protagonismo responsabile, tesa all'affermazione dei princìpi di solidarietà e sussidiarietà in un contesto
------------------------------ © Servizio per le informazioni e la Sicurezza Democratica ------------------------------

di accresciuta e irreversibile interdipendenza. In altri termini, il filo conduttore delle riflessioni successive è quello della promozione del bene della persona anche attraverso l'individuazione e il suggerimento di progetti politici, economici e istituzionali che intendono ispirarsi ai princìpi della dottrina sociale della Chiesa. Al tempo stesso siamo pienamente consapevoli che da essa non discendono soluzioni univoche, fermi restando la "trascendente dignità della persona", il "rispetto della libertà" e il compito di proporre continuamente la verità. (4) Perciò il nostro itinerario intende mettere in luce: a) i grandi problemi a dimensione europea che ci toccano direttamente e continuamente; b) la rilevanza di rinnovati livelli di governo regionale per il nostro Paese a fronte delle esigenze delineate e nel confronto con il sistema di altri Paesi europei, specialmente con il modello tedesco; c) le proposte che toccano direttamente la realtà lombarda e che appaiono coerenti con le sue tradizioni storiche e le sue potenzialità attuali nell'esercitare una influenza stimolante sulle altre entità regionali italiane nel cammino verso una integrazione a dimensione europea; d) da ultimo, una prospettiva di riforma istituzionale per il nostro Paese coerente con il perseguimento dei fini sostanziali precedentemente indicati e con precisa attinenza all'autonomia delle regioni. Tutto ciò ci condurrà a trarre la conclusione che è matura una riforma in un senso che si può definire di "regionalismo forte" o di "federalismo solidale", per la soddisfazione delle esigenze di autogoverno e nel pieno rispetto delle esigenze di unità nazionale. Il traguardo per noi più importante resta comunque quello dell'incremento della democrazia e dell'ampliamento della cittadinanza. Per tali obiettivi la riforma ipotizzata è pur sempre uno strumento, utile se ben adoperato.
PARTE SECONDA - L'unione Europea. mezzo secolo di ideali e concretezza
Una costruzione che ha progredito 10. Il 1° novembre del 1993 entrava in vigore il Trattato di Maastricht e con lo stesso prendeva avvio l'Unione Europea (UE), tappa fondamentale di una costruzione che prosegue da quasi mezzo secolo. Da quando nell'aprile del 1951 fu firmato il primo Trattato, quello della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio (CECA), che fu poi seguito da altri Trattati che hanno portato alla Comunità Economica Europea dapprima e alla Unione Europea adesso. Sono stati anni di grandi progetti e realizzazioni. Eppure ancora oggi si manifestano sia scarsa conoscenza sulla natura, gli scopi, i ruoli dell'Europa unita sia incertezze di parlamenti, di governi, di partiti, di popoli sulla "convenienza" a procedere in questo cammino. Perciò sono necessari dei richiami fondamentali tesi a dimostrare che oggi i grandi problemi di ogni singolo Paese della Unione Europea devono essere visti e possono essere risolti solo in un contesto europeo. È questa l'ottica corretta per entrare anche nel merito dei problemi italiani, ai quali questa riflessione si indirizza in modo specifico.
Ideali e concretezza 11. La costruzione europea ha marciato lungo il duplice binario degli ideali e della concretezza. Al suo patrimonio ideale ha contribuito in misura rilevante, e non da oggi, l'apporto dei cattolici e, in particolare, dei cattolici italiani. Basti ricordare che già la XXII Settimana Sociale dei Cattolici Italiani, nel 1948, affrontò il tema "La Comunità internazionale". In essa si sottolineò la necessità che l'Europa si organizzasse "ad unità tanto sul terreno politico quanto su quello economico in modo da contribuire al progresso umano e alla pace mondiale". (5) Una eguale coscienza della "responsabilità morale" verso popoli rappresentati guidò l'iniziativa dei padri fondatori dell'edificio europeo (il francese Schuman, il tedesco Adenauer, l'italiano De Gasperi, l'altro francese Monnet), con l'atto di nascita della Comunità del carbone e dell'acciaio. Il trattato che le diede avvio, firmato nel 1951, non trascurò però di menzionare anche gli "interessi essenziali" alla base dell'accordo, nella convinzione che "l'Europa potrà essere edificata solo con realizzazioni concrete, che
------------------------------ © Servizio per le informazioni e la Sicurezza Democratica ------------------------------

creino prima di tutto una solidarietà di fatto" (6). Al medesimo doppio registro degli ideali etici e della concretezza operativa si ispira pure il Trattato di Maastricht del 1993. Esso delinea una Unione Europea che promuove varie identità complementari: economica e monetaria, sociale, di politica estera con riguardo anche ai problemi della difesa delle istituzioni comunitarie. Non a caso a insistere sul profilo non semplicemente mercantile e finanziario dell'Unione Europea, aspetto importante ma non disgiungibile dalla dimensione sociale, è stata una personalità di profonda formazione cattolica quale Jacques Delors. A ciò si deve aggiungere che la XLI Settimana Sociale dei cattolici Italiani (1991) è stata dedicata al tema "I cattolici e la nuova giovinezza d'Europa", mettendo a fuoco il legame tra i princìpi di solidarietà, interdipendenza e sussidiarietà, indicati dalla dottrina sociale della Chiesa quali pilastri dell'attuale costruzione storica. Tutto ciò viene ricordato non certo per vantare meriti esclusivi all'iniziativa culturale dei cattolici. Piuttosto, si tratta di evidenziare l'importanza per tutti dei princìpi richiamati e di stimolare una loro coerente traduzione pratica. Del resto, il cammino fin qui percorso incoraggia a proseguire verso la mèta.
Dall'Euroeuforia, all'Eurodisfattismo, all'Euroresponsabilità 12. Nel 1951 furono sei i Paesi (Francia, Germania, Italia, Belgio, Olanda, Lussemburgo) firmatari del Trattato CECA. Nel 1993 furono dodici i Paesi (Francia, Germania, Italia, Belgio, Olanda, Lussemburgo, Danimarca, Gran Bretagna, Grecia, Irlanda, Portogallo, Spagna) firmatari del trattato di Maastricht. Oggi, inizio 1996, quindici sono i Paesi dell'Unione Europea essendosi aggiunti Austria, Finlandia, Svezia. Ed è questo il segno principale del successo della "idea europea" che è riuscita a superare molte fasi oscillatorie ormai note come "euroentusiasmo", europessimismo", "euroeuforia", "eurodisfattismo", che hanno attraversato il passaggio dalla CECA (1951-53) alla Comunità Economica Europea e al Mercato Comune (1957), al Sistema Monetario Europeo (1979), al Mercato Interno (1992) fino al Trattato sulla Unione Europea (1993). Non è nostro scopo ripercorrere queste fasi complesse e difficili, bensì evidenziare cos'è oggi l'Unione Europea dal punto di vista economico e sociale, e come i problemi del nostro Paese, e la loro soluzione, ne siano strettamente connessi, nella convinzione che il cammino verso l'Unione sia e debba essere irreversibile e che le linee di questo cammino siano tracciate. Non ci assoceremo perciò all'eurodisfattismo che dopo tanti anni di euroeuforia sembra oggi convincere molti, anche nel nostro Paese. Sappiamo quanto complesse siano le attuali situazioni europee in cui tutto sembra cambiare come conseguenza della fine dell'impero sovietico e della riunificazione tedesca. Sappiamo che i problemi ci sono e sono gravi. Ma siamo anche convinti che l'eurodisfattismo deve lasciare il posto all'euroresponsabilità, altrimenti i problemi non saranno risolti e i rischi di una involuzione economica e magari anche politica con un regresso al periodo prebellico si faranno ben più concreti. Nostro intendimento è contribuire a formare questo senso di euroresponsabilità con documentazioni e valutazioni su cui si possa pacatamente meditare per progettare e agire anche nel nostro Paese. I problemi economico-sociali europei sono certamente molto seri e basta a dimostrarlo un dato riassuntivo: la disoccupazione ha raggiunto i 16-17 milioni di persone, che corrispondono al 10,5-11% della popolazione attiva. Eppure l'Unione Europea è uno dei tre grandi poli sviluppati del pianeta; anzi globalmente in termini di reddito di commercio estero e di popolazione è il più grande di tutti. Gli altri due grandi poli, Stati Uniti d'America e Giappone, sembrano però situarsi in condizioni assai migliori con una disoccupazione rispettivamente pari al 6,5% e al 2%. A fronte di questa situazione i quesiti incalzano: ma allora, che ha fatto in mezzo secolo l'Europa se oggi è ancora superata da Stati Uniti e Giappone? Perché non cercare di difendersi con il protezionismo? Perché non adottare un modello economico-sociale americano o giapponese? E per il nostro Paese, quali vantaggi dello stare con un'Europa così carica di problemi? Perché non fare per conto nostro? Perché non si può fare più spesa pubblica per riassorbire la disoccupazione? E, scendendo ancora più a scala dimensionale, ci si potrebbe chiedere: che cosa importa di tutto ciò alla Lombardia, regione dove la crescita è forte, il benessere alto e la disoccupazione bassa?
Metodo per una risposta ai grandi problemi
------------------------------ © Servizio per le informazioni e la Sicurezza Democratica ------------------------------

13. Questi e altri quesiti sono legittimi, ma le risposte non devono essere sbagliate e affrettate. Ciò comporta che nel delineare i grandi problemi europei e italiani e nel cercare le risposte si stia aderenti a quattro riferimenti essenziali: il Trattato di Maastricht (1993), che rappresenta il progetto politico-istituzionale-economico della Unione Europea; il libro bianco "Crescita, competitività, occupazione. Le sfide e le vie per entrare nel XXI secolo" (1993), elaborato dalla Commissione europea presieduta da Delors; la storia di mezzo secolo e la situazione economico-sociale europea attuale; la perdurante gravità della situazione italiana. Per entrare nel XXI secolo bisogna rinnovare il modello economico-sociale europeo, che rimanendo distinto da quello americano e da quello giapponese non deve arretrare, pena una rapida decadenza, né nella capacità competitiva rispetto a questi due Paesi per ora dominanti in termini di occupazione e di presenza sui mercati mondiali né rispetto alla nuova capacità competitiva dei Paesi emergenti che positivamente escono dal sottosviluppo guadagnando spazi che l'Europa, ma non gli Stati Uniti e il Giappone, sembra perdere. 14. Il metodo europeo (ma anche italiano) per dare risposta ai grandi problemi deve basarsi su tre grandi direttrici, come in buona misura ci ricorda Delors: - ideali: aderenza a quelli che hanno forgiato l'identità e l'unità europea e in particolare consapevolezza che il risveglio può avvenire soltanto attraverso una società attivata da cittadini coscienti delle proprie responsabilità e animati da spirito di solidarietà verso coloro con i quali formano comunità locali e nazionali ricche di storia e dotate del senso di appartenenza; - lavoro e competitività: consapevolezza che la stabilità nel lavoro e la creazione di posti di lavoro che possano essere ereditati dalle generazioni future sono vincolate strettamente alla capacità dinamica di mantenere una posizione competitiva nel contesto mondiale e alla capacità di conseguire anche obiettivi sociali, in particolare il lavoro come fattore di integrazione sociale; - partecipazione e sistemi: assunzione di responsabilità a tutti i livelli di partecipazione nella consapevolezza che nelle economie e nelle società contemporanee più avanzate e fondate sui sistemi e sulle reti interconnesse e non gerarchizzate, come erano quelle della prima e seconda industrializzazione, la partecipazione non è solo espressione di cittadinanza ma anche fattore di sviluppo economico. L'Unione Europea (e l'Italia) ha molte risorse per rinnovare il suo modello e la sua crescita: quelle professionali (cultura, istruzione, innovatività, esperienza), quelle finanziarie (risparmio), quelle sociali (concertazione, solidarietà). Ma ha anche molti vincoli; tra questi una crescente "solidarietà nell'individualismo consumistico", per cui esasperati sistemi di protezione sociale ci hanno avvicinato al punto di rottura finanziaria ed economica a causa di una crescita insufficiente e allo squilibrio tra popolazione attiva e inattiva, anche per il crollo nella dinamica demografica. Il sistema attuale comporta il trasferimento dei costi ai giovani e alle generazioni future. Bisogna passare allora a una "solidarietà produttiva e intergenerazionale", che richiede anche una economia che funziona e cresce.
Due grandi problemi europei: disoccupazione e indebitamento 15. Tanti sono i problemi della Unione Europea e dei singoli Paesi che la compongono, ma due appaiono tali da sovrastare, o comunque riassumere, gli altri: quello della disoccupazione e quello delle finanze pubbliche. Sappiamo che questi problemi si collocano entro altri di ancora maggiore portata ai quali abbiamo solo accennato: quelli geopolitici, che seguono al disfacimento dell'impero sovietico e che aprono nuove competitività in Occidente e in Oriente; quelli geoeconomici, che caratterizzano una nuova rivoluzione scientifico-tecnologica centrata principalmente sulla teleinformatica e la multimedialità; quelli geodemografici, che pongono a confronto Paesi europei con dinamica demografica in vari casi (come per l'Italia) nulla e Paesi sottosviluppati confinanti con una forte spinta demografica e quindi migratoria. Occupazione e disoccupazione 16. Abbiamo già detto quanto grande e preoccupante sia la dimensione della disoccupazione in Europa: 17 milioni di persone circa pari all'11% della popolazione attiva. Questo non significa che la costruzione
------------------------------ © Servizio per le informazioni e la Sicurezza Democratica ------------------------------

europea non abbia in passato creato occupazione. Basti ricordare che il Mercato unico senza frontiere tra i Paesi europei, nei suoi progressi dal 1985 al 1992, ha generato almeno 9 milioni di nuovi posti di lavoro che diversamente non ci sarebbero stati. Dunque, senza i passi verso l'Unione Europea la situazione sarebbe stata di gran lunga peggiore. Ma questo non può bastarci. Per superare la situazione di disoccupazione attuale dobbiamo capire innanzitutto di quale tipo sia la nostra disoccupazione, per evitare risposte semplicistiche e gravemente peggiorative, come quella di dare corso a una spesa pubblica occupazionale indiscriminata o quella di impiantare fabbriche fantasma o quella di promuovere imprese obsolete tenute in vita dal pubblico denaro o infine quella del pubblico impiego come mezzo per nascondere la disoccupazione. Il punto di partenza è la constatazione che nella Unione Europea alla fine degli anni '80, dopo cinque anni di crescita molto forte, vi erano ancora 12 milioni di disoccupati pari all'8% della popolazione attiva, che pure è solo il 60% della popolazione in età lavorativa (rapporto certamente basso rispetto a quello di altri Paesi sviluppati). Dunque la crescita non ha riassorbito la disoccupazione di 12 milioni di persone, che appartengono quindi alla categoria della disoccupazione strutturale e tecnologica di lungo periodo e non congiunturale. Quali sono le cause di questa situazione? La disoccupazione strutturale è stata determinata principalmente da una infelice collocazione della economia dei Paesi europei nella divisione internazionale del lavoro. L'Unione Europea ha trovato agguerriti concorrenti in prodotti e mercati dove i Paesi di nuova industrializzazione sono adesso arrivati con costi del lavoro molto più bassi. L'Europa ha per converso subito il peso sia del costo del lavoro nelle qualifiche poco alte, che ha frenato la creazione di posti specie nel settore dei servizi, sia della scarsa flessibilità nel mercato e nella legislazione del lavoro. La disoccupazione tecnologica nasce dalla eliminazione di posti di lavoro generata dal progresso tecnico. Questo nel contempo crea altri e diversi posti di lavoro per l'attivazione di nuovi processi, per la produzione di nuovi beni e servizi. Il problema è di evitare la sfasatura tra le due dinamiche tecnologiche: quella che distrugge e quella che crea nuovi posti di lavoro; e ciò è possibile solo con una forte capacità di entrare sui mercati dei nuovi prodotti e servizi e di avere le qualifiche professionali che siano in grado di operare nella produzione e nella vendita di tali nuovi prodotti. In Europa tale sfasatura tra nuovi processi e nuovi prodotti è stata troppo ampia e perciò s'è creata della disoccupazione tecnologica. L'Unione Europea è rimasta così compressa tra due tipi di concorrenti forti su due diversi versanti della produzione e dei mercati: i nuovi Paesi industrializzati (fino a pochi anni fa denominati sottosviluppati) forti nei prodotti maturi, dove il basso costo del lavoro è cruciale; i Paesi avanzati, e in particolare USA e Giappone, forti nei nuovi processi e prodotti ad alta tecnologia, dove contano la capacità innovativa e le qualifiche professionali. Alcuni Paesi europei hanno reagito, ma nel complesso questo non è bastato. 17. Se l'Unione Europea vuole scendere a un tasso di disoccupazione accettabile, deve creare da qui a fine secolo tra i 10 e i 15 milioni di posti di lavoro e per fare questo deve seguire almeno due grandi direttrici: una nuova politica delle risorse umane e del mercato del lavoro con una formazione estesa a tutto l'arco vitale, con flessibilità interna e esterna del lavoro, con riduzione del costo del lavoro poco qualificato e con differenziali salariali legati alle qualifiche e alla produttività; una nuova politica della innovazione e delle reti infrastrutturali basata sulla certezza che il prossimo secolo sarà quello della teleinformatica e della multimedialità, le quali modificheranno completamente i sistemi economici e i modi di produrre. L'Italia non sfugge a questa situazione, anzi la soffre in pieno e basta a dimostrarlo il fatto che, dopo una svalutazione che è stata molto forte rispetto alle monete di tutti i più importanti Paesi industrializzati, la sua disoccupazione è ancora vicina al 13%: nettamente superiore alla media europea. Finanze pubbliche e indebitamento 18. Un altro versante della Unione Europea che preoccupa è quello delle finanze pubbliche e dell'indebitamento presente e potenziale delle stesse, specie in alcuni Paesi. Accade talvolta che chi si preoccupa del problema disoccupazione non consideri che dallo stesso non si può uscire durevolmente senza una oculata e rigorosa gestione finanziaria generale e del pubblico denaro in particolare. Troppo spesso in passato, specie in Italia ma non solo, il pubblico denaro è servito a nascondere la disoccupazione creando occupati fittizi. I vincoli finanziari impongono adesso una forte selettività nella spesa pubblica, la consapevolezza che la
------------------------------ © Servizio per le informazioni e la Sicurezza Democratica ------------------------------

tassazione deve pur sempre essere commisurata alla capacità contributiva e alla necessità di non sottrarre risorse agli investimenti privati, la convinzione che l'intervento pubblico deve avere corso solo laddove non possono operare le capacità e le responsabilità dei privati, la coscienza che il risparmio va tutelato perché solo così si incentiva quella parsimonia che è l'opposto del consumismo e che consente di finanziare gli investimenti di lungo periodo, dai quali dipendono l'occupazione e la crescita. In breve, l'indebitamento alto delle finanze pubbliche utilizzato per fare spese improduttive, e a fronte del quale non si trovino dei valori patrimoniali durevoli, crea l'errata convinzione che si possa spendere senza produrre e alla fine troverà come suo esito o l'inflazione e la svalutazione, che distruggono il risparmio, o il rinvio di carichi debitori alle generazioni future o drastiche misure finanziarie-tributarie (imposte patrimoniali, consolidamenti e via di seguito) che danneggerebbero la posizione italiana anche sui mercati internazionali. 19. Per questi e per altri motivi importante - anche se non certo esaustiva - è nel Trattato di Maastricht la fissazione dei criteri di convergenza monetaria e finanziaria tra i vari paesi dell'Unione, al fine di contenere il debito pubblico totale e il deficit annuale, per garantire la stabilità dei prezzi (e quindi evitare l'inflazione) e dei tassi di cambio tra le valute, per contenere i tassi d'interesse (e quindi per favorire la crescita e ridurre l'indebitamento). Alla fine, se tutti i parametri saranno soddisfatti, si giungerà alla moneta unica europea, simbolo e strumento economico fondamentale di una unione irreversibile. Ma si arrivi o meno alla moneta unica, senza il soddisfacimento graduale in un processo di convergenza - che non necessariamente dovrà verificarsi entro l'anno previsto 1999 e con i livelli quantitativi fissati dal Trattato - di queste condizioni non sarà possibile dare corso ai grandi mutamenti strutturali e tecnologici necessari per rilanciare l'occupazione; e questo perché il risparmio non andrà a finanziare gli investimenti produttivi e l'occupazione di lungo periodo ma verrà distrutto in spese improduttive, mentre gli Stati accumuleranno un debito che i creditori (o i loro figli) non vedranno mai ripagato. Negli ultimi tre anni il sistema finanziario e monetario europeo ha avuto degli sbandamenti enormi e con lui ha sbandato anche il processo di unificazione europea. Alcune valute, a causa del dissesto delle finanze pubbliche di alcuni Stati, come l'Italia, hanno subito delle svalutazioni imponenti. Altre valute, come quella tedesca, hanno avuto grandi rivalutazioni trainate dai tassi d'interesse e dalla fiducia dei mercati nella certezza del rispetto di rigorose condizioni finanziarie e produttive da parte della Germania. Eppure l'Unione Europea non si è dissolta e appare oggi nelle condizioni di una ripresa del cammino di convergenza monetaria e finanziaria e di rilancio della occupazione. (*) Contributo tratto dal volume "Autonomie Regionali e Federalismo Solidale" della Commissione Diocesana "Giustizia e Pace" - Diocesi di Milano (Centro Ambrosiano 1996). (1) Cfr. COMMISSIONE DIOCESANA "GIUSTIZIA E PACE". DIOCESI DI MILANO, Costruiamo insieme il bene comune. La destinazione delle risorse in una società adulta e solidale, Centro Ambrosiano di Documentazione e Studi religiosi, Milano, 1993. (2) GIOVANNI PAOLO II, Discorso al III Convegno ecclesiale della Chiesa italiana a Palermo, n. 10: «L'Osservatore Romano», 24 novembre 1995, pp. 4-5. (3) Ivi. (4) Cf. GIOVANNI PAOLO II, Centesimus annus, n. 46. (5) Il cammino delle settimane sociali, Dehoniane, Roma, 1988, p. 170. (6) Preambolo al Trattato.
------------------------------ © Servizio per le informazioni e la Sicurezza Democratica ------------------------------

Relazione generale sulla situazione economica del Paese (1995) L'evoluzione dell'economia nel 1995
ECONOMIA INTERNAZIONALE
1. Premessa L'area industrializzata ha conosciuto nel 1995 un rallentamento della crescita. Negli Stati Uniti il raffreddamento congiunturale si è palesato dall'inizio dell'anno, in conseguenza di pregresse restrizioni monetarie. In Europa, l'appiattimento dei profili di sviluppo è da ricollegare soprattutto con l'attenuazione delle originarie spinte propulsive, vale a dire il ciclo delle scorte e le esportazioni, in un quadro di persistente debolezza della domanda interna. Vi si sono aggiunte le oscillazioni dei cambi oltre che, in alcuni casi, incertezze politiche e tensioni sociali. La decelerazione, intervenuta nel secondo semestre, ha colpito soprattutto la Germania, la Francia e la Spagna. Il Giappone ha attraversato una fase di quasi ristagno da cui è emerso solo a fine 1995. La tendenza al miglioramento delle condizioni sul mercato del lavoro è andata attenuandosi negli Stati Uniti e nel Regno Unito. Nell'Europa continentale, ove i tentativi di introdurre elementi di flessibilità procedono con maggiori attriti, la disoccupazione ha ripreso a crescere nella seconda parte dell'anno. In Giappone l'incidenza sulla popolazione attiva delle persone in cerca di lavoro ha superato precedenti record. I fenomeni inflazionistici sono rimasti sotto controllo sia per l'esaurirsi dei rincari dei prodotti di base sia, nell'ambito dei singoli paesi, per la contenuta evoluzione dei salari, per gli aumenti di produttività, per l'azione della concorrenza internazionale e, da ultimo, per il rallentamento della crescita. In campo monetario atteggiamenti di prudenza sono prevalsi negli Stati Uniti, che hanno mantenuto invariato dal febbraio il tasso ufficiale di sconto, favorendo in seguito solo lievi ripiegamenti del costo del denaro a breve. Tendenze meno restrittive si sono profilate sia in Germania che nell'area del marco. Nei casi in cui è stato necessario difendere il cambio, si è proceduto con alternanze - come in Francia - o con ritardi. Per sospingere le attività e alleviare i problemi del settore creditizio, la banca centrale nipponica ha abbassato, in più riprese, il tasso ufficiale di sconto allo 0,5%. I successi nella lotta all'inflazione agevolano, nei sistemi dai tratti fondamentali più solidi, una flessione dei tassi di interesse a lungo termine. I cambi sono stati caratterizzati da instabilità e turbolenze: il dollaro ha perduto sino alla primavera rispetto al marco tedesco e allo yen; si è poi consolidato e rafforzato, recuperando in fine d'anno parzialmente sull'uno, totalmente sull'altro. Alla fase ribassista della moneta statunitense sono corrisposte tensioni fra le divise al di qua dell'Atlantico. Lo scenario delle economie in transizione è andato migliorando sia in Europa centro-orientale e Paesi baltici - ove il PIL ha ripreso a crescere - sia in Russia e altri membri della CSI, ove la contrazione ha assunto tratti meno gravi.
------------------------------ © Servizio per le informazioni e la Sicurezza Democratica ------------------------------

Nell'area in via di sviluppo, l'espansione dell'Asia è sfociata, per ciò che riguarda la Cina, in un soft-landing; si è invece confermata con le precedenti cadenze nel sud-est. La marcata decelerazione dell'America del centro-sud adombra la grave recessione messicana, quella Argentina e per contro lo sviluppo persistentemente elevato della Colombia, del Brasile e del Cile. La situazione del continente africano, sebbene preoccupante, ha mostrato tratti meno sfavorevoli mentre la performance mediorientale è rimasta modesta.
2. Gli andamenti nei paesi industriali La crescita statunitense è apparsa discontinua e, nel complesso, decelerata. Nella prima parte del 1995, la crisi del Messico e l'appannamento ciclico del Canada, fra i principali mercati di sbocco, hanno depresso la domanda estera; su quella interna ha inciso l'elevato grado di indebitamento delle famiglie e le restrizioni creditizie varate nel 1994 dalla Riserva federale, di cui hanno particolarmente risentito il settore automobilistico e l'edilizia abitativa. I fattori frenanti esogeni si sono però nel prosieguo attenuati e ha giovato il lieve allentamento monetario intervenuto con la primavera. In fine d'anno sono di nuovo emerse incertezze, ma i toni sono rimasti nel complesso rassicuranti, grazie alla soddisfacente progressione dei redditi delle famiglie e alla solidità delle condizioni in cui operano le imprese, sospinte anche dall'allargamento dei margini di profitto sulla via degli investimenti. In Europa, la pesantezza del mercato del lavoro, la modestia delle dinamiche retributive e lo scarso accrescimento delle disponibilità reali delle famiglie hanno compresso la domanda, appesantita altresì
------------------------------ © Servizio per le informazioni e la Sicurezza Democratica ------------------------------

dall'impostazione restrittiva delle politiche fiscali. La Germania e l'area del marco hanno subito penalizzazioni aggiuntive dall'apprezzamento esterno delle rispettive monete. A un andamento per lo più deludente dell'edilizia ha fatto da contrappeso l'accelerata espansione degli investimenti in attrezzature, soprattutto nella Scandinavia e sistemi minori del nord. Pur con irregolarità, la produzione industriale si è vistosamente allargata nella prima parte del 1995, per mostrare poi diffusi ripiegamenti. Nei consuntivi d'anno, i migliori risultati venivano colti in Scandinavia - Finlandia e Svezia in particolare con un tasso prossimo al 10% - in Austria e Spagna, col 6% circa. Regno Unito e Francia totalizzavano il 2-3%, la Germania l'1 per cento. In Giappone, eventi accidentali e in particolare il sisma di Kobe, si sono sommati a fattori strutturali - tra cui la «bolla speculativa» ancora in via di riassorbimento - nel provocare effetti recessivi. Le famiglie risentivano non solo della flessione dei valori immobiliari, ma anche del continuo appesantimento del mercato del lavoro - ove il tasso di disoccupazione ha via via superato precedenti massimi - e della scarsa progressione delle retribuzioni. Il clima di fiducia si è deteriorato ed è nel contempo cresciuta la propensione al risparmio , con un sostanziale ristagno dei consumi privati. Le aziende sono state penalizzate dall'ascesa dello yen sui mercati internazionali e su quello interno, ove vanno ridimensionandosi le barriere protettive. L'esiguità dei margini di profitto e le difficoltà di bilancio trovavano riscontro nel peggioramento del clima degli affari e nel lento riavvio degli investimenti privati. Effetti propulsivi provenivano invece dalla componente governativa, attraverso successive misure di rilancio, tra cui, in settembre, provvedimenti di spesa per 14.200 miliardi di yen - pari al 3% del PIL - in gran parte destinati a opere di pubblica utilità. Le attività di produzione industriale si sono attestate - con oscillazioni - su un livello medio del 3,2% superiore a quello del 1994. Il quadro non è rimasto privo di incertezze, dato che il miglioramento emerso a fine 1995 è essenzialmente legato agli interventi governativi e, perciò stesso, destinato a esaurirsi; la ripresa degli investimenti circoscritta alle unità di grandi dimensioni; le politiche dei paesi industrializzati, tali da esercitare contraccolpi negativi sulle esportazioni giapponesi.
3. Il mercato del lavoro Sul mercato del lavoro sono prevalse difformità e, nella seconda parte del 1995, un deterioramento, per l'arresto delle favorevoli tendenze che si erano profilate nella fase più accentuatamente espansiva del ciclo. Distorsioni accumulate nel medio-lungo periodo hanno continuato a penalizzare l'Europa ove, in base a stime del Fondo Monetario Internazionale, la disoccupazione strutturale si è ininterrottamente accresciuta negli ultimi 20 anni, sino a toccare l'8-9% della popolazione attiva. Il malessere sociale, le perdite di reddito, l'onerosità per le finanze pubbliche e i danni complessivamente da ciò derivati, hanno posto il problema fra le priorità politiche. Si è così teso a rivedere o a ridimensionare il tradizionale sostegno alla disoccupazione, per mettere l'accento su «politiche attive». In questo filone si inserisce la tendenza a rivedere la composizione delle retribuzioni per renderla più flessibile e quindi più aderente alla realtà delle aziende e a formulare programmi che prevedono la riqualificazione delle persone prive di occupazione e incentivi all'assunzione dei giovani. Nell'Unione Europea, il miglioramento ciclico del mercato del lavoro è sopravvenuto con ritardo e ha assunto dimensioni limitate, cosicché il numero dei disoccupati si è approssimato a fine 1995 ai 18 milioni, pari all'11% della popolazione attiva. Il fenomeno incide soprattutto sulle donne (il 12,6% contro il 9,6% degli uomini) e, con riferimento all'età, sulla fascia al di sotto dei 25 anni (ove si è giunti al 20,8%). Con l'«Alleanza per il lavoro», siglata in Germania il 23 gennaio 1996 dal governo e dalle parti sociali, si intendono quindi introdurre correttivi, agendo essenzialmente sul versante dell'offerta. L'accordo, articolato in 50 punti ancora da definire nei concreti aspetti applicativi, assume come obiettivo il dimezzamento in 5 anni del numero dei disoccupati, con la riduzione, tra l'altro, degli oneri sociali, il riequilibrio dei fondi pensionistici, l'accrescimento della flessibilità salariale - riferita tanto agli aspetti retributivi che all'orario di lavoro - la diffusione dell'apprendistato, incentivi alla creazione di nuove imprese e facilitazioni per l'accesso al capitale di rischio. Nel più flessibile sistema statunitense si sono colti i benefici della semionda ciclica ascendente della metà del 1992 sino alla fine del 1994, periodo in cui la disoccupazione si è ridimensionata dal 7,7% al 5,4% della
------------------------------ © Servizio per le informazioni e la Sicurezza Democratica ------------------------------

popolazione attiva. All'appannamento congiunturale intervenuto con il 1995, è corrisposta una sostanziale stabilità intorno al 5,6 per cento. Il Giappone, ove peraltro il fenomeno riveste dimensioni meno preoccupanti, ha accusato difficoltà, dato che l'incidenza delle persone in cerca di lavoro ha raggiunto a fine 1995 il massimo del 3,4 per cento.
4. La dinamica dei prezzi Dopo una breve fase di recrudescenza durante la prima parte del 1995, i fenomeni inflazionistici nell'area industrializzata riprendevano generalmente ad attenuarsi, grazie ai fattori di calmieramento di origine interna e internazionale. Al di là della variabilità stagionale, i corsi petroliferi si stabilizzavano infatti sui 17 dollari per barile, con riferimento al Brent, valore prevalente nel medio periodo. I rincari degli altri prodotti di base, in atto per tutto il 1994, si sono esauriti, come dimostra il ripiegamento dell'indice calcolato dall'HWWA in dollari. Tra gli alimentari, soltanto le quotazioni dei cereali segnavano consistenti incrementi, legati ai cattivi raccolti statunitensi, al deludente andamento dell'offerta e alla riduzione delle scorte mondiali. Sono invece ristagnati o ribassati quelli dei coloniali - come il cacao o il caffè - per lo scadere tra l'altro di precedenti accordi di cartello. Le quotazioni delle materie prime industriali - sia di origine agricola che le altre - ancora in ascesa nel primo semestre, subivano poi flessioni. Nell'ambito dei singoli paesi ha giocato la moderazione delle dinamiche salariali - nonostante qualche rialzo negli Stati Uniti, Canada e Germania - il rigore delle politiche monetarie e lo scadimento dei toni congiunturali. I prezzi alla produzione e all'ingrosso si sono mossi lungo una linea di moderata crescita nella prima parte dell'anno, per poi stabilizzarsi o addirittura ripiegare. La traslazione dell'inflazione importata - via i precedenti rincari delle materie di base o, in alcuni casi, le
------------------------------ © Servizio per le informazioni e la Sicurezza Democratica ------------------------------

perdite in cambio - ha trovato ostacoli nella debolezza della domanda delle famiglie. Negli Stati Uniti, in parte della Scandinavia, in Francia e Spagna si sono quindi confermati, nelle medie annue, i modesti aumenti al consumo registrati nel 1994; in Germania e nell'area del marco, oltre che nel Regno Unito, si sono avuti ridimensionamenti. Il Giappone ha visto cedere le quotazioni ingrosso e via via rallentare la già moderata dinamica di quelli al dettaglio che, per la prima volta dall'inizio della rilevazione (1971), accusavano un decremento annuo cifratosi nello 0,1 per cento.
5. Il commercio internazionale Il commercio mondiale ha risentito dell'appannamento congiunturale intervenuto nei paesi OCSE. Stando ai flussi in volume delle merci in entrata e uscita, l'interscambio, che nel 1994 si era allargato con un tasso prossimo al 10%, è aumentato nel 1995 di circa l'8 per cento. Alla decelerazione tanto delle esportazioni che delle importazioni dell'area industrializzata, hanno fatto riscontro risultati persistentemente favorevoli per quella in via di sviluppo, ove le une sono rimaste pressoché stazionarie e le altre si sono sensibilmente allargate. Causa verosimilmente la più sommessa evoluzione delle attività, il tasso di incremento degli acquisti dall'estero è sceso, negli Stati Uniti, dal 15% nel 1994, al 12% nel 1995; il dinamismo delle esportazioni, allargatesi di circa il 14%, sembra ascrivibile ai guadagni di competitività derivanti anche dalle flessioni del dollaro. Nell'Unione Europea, le importazioni hanno risentito dell'indebolimento della domanda e delle attività produttive; le esportazioni sono state limitate tanto dalla contrazione dei mercati di sbocco che dall'andamento dei cambi. La progressione delle vendite all'estero si è infatti sostanzialmente dimezzata sia in Germania - per l'ascesa del marco - sia nel Regno Unito, Svezia e Spagna, che hanno ormai assorbito i benefici delle massicce svalutazioni del 1992-93. In Giappone, alla debolezza della produzione interna ha fatto da contrappeso la maggiore penetrazione delle merci straniere, dovuta sia al processo di liberalizzazione sia alla sopravvalutazione dello yen. Nell'area in via di sviluppo, si sono confermate le soddisfacenti performance dei paesi est-asiatici e latino-americani. Nel complesso, le importazioni non-OCSE hanno segnato un aumento del 10% circa, che sintetizza un incremento del 3% per l'OPEC, dell'11% per gli altri paesi in via di sviluppo e dell'8% per quelli ex-Comecon.
6. Il mercato valutario I cambi sono stati caratterizzati da accentuate oscillazioni. In apertura d'anno il dollaro subiva una brusca caduta rispetto al marco tedesco e allo yen, ricollegabile con il persistente squilibrio dei conti con l'estero, con i timori di un ritorno di inflazione, ma soprattutto con le vicende del Messico, debitore e partner commerciale. Con il circoscriversi della crisi e con il rallentamento statunitense, che allontanava i rischi inflazionistici, si è tuttavia aperta una parentesi di assestamento, sfociata dall'estate in un movimento ascendente. A questo contribuiva, insieme alla composizione dei contrasti commerciali tra Stati Uniti e Giappone, l'impegno del governo nipponico nella liberalizzazione dei movimenti delle merci e dei capitali, percepita dagli operatori come efficace antidoto allo squilibrio esterno. In media d'anno, la divisa statunitense ha comunque perso l'8% sullo yen e il 12% sul marco tedesco. Le vicende del dollaro hanno interagito con quelle delle monete europee, indebolitesi, nella prima parte del 1995, rispetto al marco tedesco. Le perdite interessavano la peseta, la corona svedese, la sterlina britannica e, in minor grado, il franco francese, per la scadenza elettorale di maggio. Il consolidamento della divisa statunitense oltre che l'impegno di molti governi nel risanamento delle finanze pubbliche avviavano, dalla primavera-estate, una fase di consistenti recuperi. Nonostante alternanze, legate in autunno ai toni pessimistici assunti dal dibattito sul trattato di Maastricht, si giungeva in dicembre al parziale annullamento dei precedenti regressi o addirittura a guadagni per la corona svedese.
------------------------------ © Servizio per le informazioni e la Sicurezza Democratica ------------------------------

ECONOMIA ITALIANA
1. I principali risultati Nel corso del 1995 è proseguita la fase di espansione dell'economia italiana. Essa ha trovato riscontro in un aumento di prodotto interno lordo pari al 3%, circa un punto in più rispetto all'anno precedente. Tra i maggiori paesi industriali, il tasso di sviluppo conseguito dall'Italia è risultato uno dei più elevati. Prevalentemente concentrata nel settore industriale, la crescita economica ha continuato a essere sostenuta dalla positiva dinamica delle esportazioni. L'ampliamento dei margini unitari di profitto, e la conseguente aumentata capacità di autofinanziamento delle imprese, hanno favorito il riavvio di un robusto ciclo di investimenti in beni capitali. Il permanere di una moderata dinamica dei redditi da lavoro dipendente e una disoccupazione ancora elevata hanno contenuto il contributo alla crescita fornito dai consumi. La moderazione salariale ha frenato il propagarsi delle spinte inflazionistiche generate, nella prima parte del 1995, dai rialzi dei prezzi delle materie prime e dal deprezzamento della lira. Si è consolidato infine il riequilibrio dei conti pubblici e, dopo molti anni, si è arrestata la crescita del rapporto tra debito pubblico e prodotto interno. I nuovi guadagni di competitività indotti dal deprezzamento della lira (pari al 9,9% nella media del 1995, in termini di tasso di cambio effettivo nominale) hanno sostenuto i positivi sviluppi del commercio con l'estero. L'attivo mercantile della bilancia dei pagamenti è passato da 55.197 miliardi del 1994 a 71.687 miliardi. Tale surplus ha sottinteso un'evoluzione favorevole della bilancia reale a fronte di un peggioramento delle ragioni di scambio. Il tasso di crescita delle quantità esportate è risultato superiore al contestuale allargamento della domanda mondiale. Ne è derivato un aumento delle quote di mercato dell'Italia più consistente in confronto ai guadagni realizzati, a prezzi costanti, nel precedente biennio. Un'espansione del pari sostenuta è stata registrata dalle quantità importate. In particolare, tendenze accelerative sono state manifestate dagli approvvigionamenti esteri di beni capitali e di semilavorati in risposta alla vigorosa dinamica degli investimenti. Il parziale utilizzo, da parte degli operatori nazionali, dei margini offerti dalla variazione nominale del cambio ha trovato riscontro in un incremento dei valori medi unitari delle esportazioni inferiore a quello delle importazioni, che hanno peraltro riflesso gli impulsi negativi generati dai prezzi internazionali delle materie prime e dai movimenti del cambio. L'aumentato avanzo della bilancia commerciale e la riduzione del deficit delle partite invisibili, dovuto alla crescita degli introiti netti della voce «viaggi all'estero » e ai minori esborsi netti per trasferimenti unilaterali, hanno favorito l'emergere di un attivo delle transazioni correnti della bilancia dei pagamenti pari a 44.549 miliardi, circa 19.000 miliardi in più rispetto a un anno prima. Con riguardo all'evoluzione della domanda interna, a fronte di un aumento consistente degli investimenti, la crescita dei consumi privati è rimasta contenuta. Assecondata dalla protratta espansione della domanda estera, dalla disponibilità di ampi margini di autofinanziamento e dall'accostarsi della produzione ai livelli massimi compatibili con la capacità esistente, l'attività di investimento è risultata in forte crescita: +5,9% nella media del 1995. La dinamica decisamente sostenuta degli investimenti fissi è stata peraltro la sintesi di andamenti differenziati nei due principali comparti. La spesa in macchinari, attrezzature e mezzi di trasporto, alimentata anche dall'anticipazione dei programmi di investimento in beni strumentali indotta dalla detassazione degli utili reinvestiti, ha mostrato una spiccata vivacità portandosi su un livello superiore dell'11,5% a quello del 1994. Gli investimenti in costruzioni, nonostante il recupero manifestato nella seconda parte dell'anno, hanno invece continuato a riflettere lo scarso sostegno fornito dal settore delle opere pubbliche e dalla domanda abitativa, denunciando in media d'anno una sostanziale stabilità (+0,5%). Frenati dalla stazionarietà in termini reali del reddito disponibile delle famiglie, i consumi privati sono cresciuti dell'1,7%. In particolare, ad una dinamica relativamente accentuata della spesa per i non alimentari e servizi (+2,1%) si è accompagnato un cedimento di quella per i beni di consumo alimentare (-0,4%). L'effetto congiunto del rialzo delle quotazioni delle materie prime, del deprezzamento della lira e dello sviluppo della domanda hanno costituito le condizioni di base dell'aumento dei prezzi alla produzione dei prodotti industriali: +7,9% nella media del 1995. Le spinte lievitative, particolarmente forti nei primi mesi
------------------------------ © Servizio per le informazioni e la Sicurezza Democratica ------------------------------

dell'anno, si sono attenuate nella seconda parte del 1995 grazie al rallentamento dei prezzi dei prodotti base e al parziale recupero del cambio. Misurato dall'indice del costo della vita, l'incremento dell'inflazione al consumo è stato pari nella media del 1995 al 5,4%. Al netto delle variazioni delle imposte indirette, la crescita è stata del 4,6 per cento. La dinamica del costo della vita, dopo aver registrato una tendenza accelerativa sino a giugno, ha segnato un significativo rallentamento nel corso dell'estate e si è stabilizzata su ritmi ancora elevati negli ultimi mesi del 1995. Basato su un paniere più ampio di beni e servizi, l'indice generale dei prezzi al consumo ha peraltro presentato in media d'anno un aumento più contenuto e pari al 5,2%. Un rilevante contributo al contenimento d'inflazione è stato fornito dalla persistente moderata evoluzione del costo del lavoro. L'accordo sulla politica dei redditi ha continuato a costituire il riferimento per i rinnovi contrattuali siglati nel corso del 1995. Le retribuzioni lorde per dipendente sono aumentate del 4% nell'industria e del 5,1% nei servizi vendibili. Risentendo della diminuzione degli sgravi e della fiscalizzazione degli oneri sociali, la dinamica del costo del lavoro unitario è risultata più elevata in confronto a quella salariale. La contenuta crescita retributiva e il contestuale forte sviluppo della produttività hanno inoltre supportato un'evoluzione moderata del costo del lavoro per unità di prodotto. A due anni dall'inversione del ciclo economico, la ripresa non ha ancora dato luogo a benefici apprezzabili sull'occupazione. Le unità di lavoro hanno registrato nel complesso una nuova contrazione dello 0,4%. Tale risultato segna comunque un notevole rallentamento nel processo di riduzione della base occupazionale del biennio 1993-94. L'evoluzione negativa ha peraltro interessato il solo lavoro dipendente. Nonostante il riassorbimento della manodopera in Cassa integrazione guadagni le unità di lavoro dipendente nella trasformazione industriale sono ulteriormente diminuite (-1,4). La disoccupazione è rimasta elevata soprattutto per quanto attiene la componente femminile e le regioni meridionali. A livello globale, il tasso di disoccupazione è passato dall'11,3% del 1994 al 12 per cento. L'azione di risanamento dei conti pubblici è risultata particolarmente incisiva. Ai consistenti effetti delle manovre correttive realizzate in corso d'anno si è associato l'impulso positivo fornito dal rafforzamento dell'attività economica. Il dispiegarsi di tali fattori ha permesso il raggiungimento degli obiettivi di contenimento del fabbisogno e di stabilizzazione del debito, inizialmente stabiliti dal Documento di programmazione economico-finanziaria e successivamente confermati dalla Relazione previsionale e programmatica. Il fabbisogno del settore statale si è ridotto di oltre 25.000 miliardi rispetto al 1994 e di 2,1 punti percentuali in rapporto al PIL (dal 9,5% al 7,4%). Il miglioramento ha riflesso la notevole espansione dell'avanzo primario aumentato da 17.257 a 63.567 (dall'1,1 al 3,6 per cento del PIL) che ha più che compensato la crescita della spesa per interessi. La dinamica favorevole dei conti pubblici ha consentito, per la prima volta dal 1980, una contrazione del rapporto tra debito delle Amministrazioni Pubbliche - nella definizione prevista dal Trattato di Maastricht - e PIL: dal 125,6% del 1994 al 124,8 per cento.
2. Il mercato del lavoro A distanza di due anni dall'avvio della fase di sviluppo dell'attività economica, la caduta dell'occupazione si è considerevolmente ridimensionata. Il lento recupero della domanda di lavoro non è stato tuttavia sufficiente a produrre un restringimento della disoccupazione. La quantità di lavoro impiegata dal sistema produttivo si è ridotta di 97 mila unità standard (-0,4% in confronto al 1994). Un'evoluzione più favorevole ha caratterizzato la componente di lavoro autonomo (+29 mila unità, pari allo 0,4%); per contro, il lavoro dipendente ha evidenziato un nuovo regresso (-127 mila unità, pari -0,8%). L'emergere di una decelerazione nella tendenza riduttiva dell'occupazione globale ha d'altro canto riassunto evoluzioni settoriali differenziate. Il più confortante andamento della domanda di lavoro non ha tuttavia stimolato il restringimento della disoccupazione. Le persone in cerca di lavoro sono aumentate di circa 160 mila unità, risultando pari a 2.724 mila nella media del 1995. Il tasso di disoccupazione è salito dall'11,3% del 1994 al 12 per cento. La spinta all'allargamento della disoccupazione è stata impressa dal rientro sul mercato di molti individui che nella fase discendente del ciclo avevano abbandonato l'attività di ricerca del lavoro. Il gruppo dei disoccupati in cerca di primo impiego e quello in condizione non professionale ha infatti manifestato la crescita più elevata (+100 mila e +42 mila unità rispettivamente in confronto al 1994); il gruppo di coloro che avevano perso la precedente occupazione ha invece mostrato un aumento limitato (+18 mila unità) . A
------------------------------ © Servizio per le informazioni e la Sicurezza Democratica ------------------------------

livello territoriale, la crescita della disoccupazione ha nuovamente interessato le regioni del Sud e delle Isole. In quest'area il tasso di disoccupazione ha raggiunto nel 1995 il 21% a fronte del 7,8% registrato nel Centro-Nord. La politica di moderazione salariale è proseguita nel 1995. Anche gli accordi siglati in questo periodo hanno stabilito miglioramenti economici parametrati ai valori dell'inflazione programmata. I nuovi contratti nazionali hanno riguardato principalmente l'industria e sono stati sottoscritti in assenza di conflittualità tra le parti sociali. L'adeguamento delle misure tabellari ha assunto particolare rilievo nelle intese per il rinnovo biennale della parte economica. Si trattava infatti di stabilire l'entità del recupero motivato dalla differenza tra dinamica effettiva e programmata dei prezzi del precedente biennio di validità contrattuale. Il rischio che potessero prevalere spinte salariali non conformi all'obiettivo di contenimento dell'inflazione è risultato di fatto ridimensionato. Tutto ciò si è tradotto in una crescita dell'indice generale delle retribuzioni contrattuali per dipendente del 3,3% nella media del 1995. Tale indicatore, che non comprende i compensi a titolo di arretrati o «una tantum», ha in particolare registrato aumenti pari al 3,8% nell'industria in senso stretto e al 5% nei servizi di mercato. In questo caso, la più accentuata dinamica dell'indice ha riflesso la cadenzatura dei miglioramenti economici che, per diversi accordi nazionali dei servizi vendibili siglati negli ultimi mesi del 1994, ha avuto inizio nel 1995. Le retribuzioni di fatto sono risultate in modesta accelerazione. Per l'insieme dell'economia, le retribuzioni lorde pro capite hanno denunciato per il 1995 un aumento pari al 4,3% (3,2% nel 1994). In particolare la crescita è stata relativamente più sostenuta nei servizi destinabili alla vendita rispetto all'industria in senso stretto (nell'ordine 5,1% e 4,5%). La contenuta evoluzione salariale e la prosecuzione di un sostenuto ritmo di crescita della produttività hanno consentito di mantenere nel complesso moderata la dinamica del costo del lavoro per unità di prodotto: +1,8% in confronto al 1994. Tale risultato è peraltro sintesi di una tenue lievitazione nell'industria in senso stretto (+0,2%) e di un significativo incremento nei servizi vendibili (+4,1%).
3. La domanda interna Le risorse globali a disposizione del Paese - date dal prodotto interno lordo ai prezzi di mercato e dalle importazioni di beni e servizi - sono ammontate a 2.164.356 miliardi di lire correnti, pari ad un incremento monetario del 10,5% rispetto al 1994 e ad un tasso di sviluppo del 4,1% in termini reali. Con riguardo al loro utilizzo, nel 1995 una quota del 20,5% (18,5% nel 1994) è stata assorbita dalle esportazioni di beni e servizi e la restante parte, che si è commisurata a 1.720.752 miliardi di lire correnti, è stata destinata agli impieghi interni che hanno segnato un aumento del 2,3% nei valori a prezzi costanti, a fronte dell'incremento dell'1,6% rilevato nel 1994. L'evoluzione della domanda interna è stata sostenuta in modo particolare dagli investimenti produttivi in macchinari e attrezzature, mentre quelli in costruzioni si sono confermati pressoché stagnanti e i consumi hanno avuto dinamiche nel complesso contenute. La ripresa dei consumi delle famiglie è stata condizionata dal modesto aumento dei redditi da lavoro dipendente e dalla flessione dell'occupazione, nonché dagli effetti del processo di risanamento dei conti dello Stato. Sul tono sostanzialmente debole della domanda delle famiglie, in una fase avanzata di robusta espansione della produzione, avrebbe peraltro anche influito il peggioramento del clima di fiducia, che ha consigliato di rinviare a tempi migliori talune decisioni di spesa o quanto meno di limitare gli acquisti più importanti. Nel consuntivo del 1995 la spesa sostenuta dalle famiglie per l'acquisto di beni e servizi si è ragguagliata a 1.107.596 miliardi di lire, corrispondenti ad un aumento dell'1,7% nelle quantità e ad una crescita del deflatore del 5,7% nel confronto con il 1994. La ripartizione dei consumi privati per tipologie di beni e servizi ha evidenziato una lieve flessione della spesa alimentare (-0,4% in termini reali) e un incremento del 2,1% nei non alimentari, al cui interno sono risultati apprezzabili i consuntivi di spesa delle seguenti categorie: vestiario e calzature (+3%), mobili e articoli di arredamento (+2,1%), trasporti e comunicazioni (+3,3%), alberghi e pubblici esercizi (+3,4% rispetto all'anno precedente). I consumi collettivi, ammontati a 292.616 miliardi di lire, si sono ridotti in termini reali dello 0,5%, a riflesso delle difficoltà in cui versano i bilanci delle Amministrazioni pubbliche e del connesso blocco delle assunzioni nel pubblico impiego.
------------------------------ © Servizio per le informazioni e la Sicurezza Democratica ------------------------------

Mentre i consumi nel loro insieme sono risultati incagliati in una fase di crescita solo moderatamente evolutiva, gli investimenti in macchinari e attrezzature hanno avuto un vigoroso sviluppo assecondato dal processo di accelerata ristrutturazione dei settori manifatturieri più orientati ai mercati d'oltrefrontiera. La spesa per immobilizzi di macchinari, attrezzature e mezzi di trasporto è ammontata a 152.295 miliardi di lire segnando un incremento quantitativo dell'11,5% (nel 1994 la crescita era stata del 7,5%). Nel suo ambito, sono stati rilevati consistenti sviluppi sia per le macchine, attrezzature e prodotti vari (+12,7% in termini reali contro il +9,1% dell'anno precedente) sia per i mezzi di trasporto (+6,3% a fronte del modesto aumento dell'1% nel 1994). Al netto rafforzamento dell'attività di accumulazione in macchinari in genere si è contrapposta l'eccezionale lentezza della ripresa degli investimenti in costruzioni, che hanno scontato il mancato recupero della domanda abitativa e di quella per infrastrutture e opere pubbliche.
4. La finanza pubblica In un quadro congiunturale di robusta crescita dell'attività economica l'andamento dei conti pubblici ha registrato notevoli miglioramenti nel 1995. Il fabbisogno del Settore Statale, al netto delle regolazioni di debiti pregressi, è risultato pari a 130.249 miliardi centrando l'obiettivo (di 130.000 miliardi) posto nel Documento di programmazione economico-finanziaria del giugno 1995 e confermato nella Relazione previsionale e programmatica del settembre successivo. La contrazione di oltre 25.000 miliardi rispetto all'anno precedente (in cui il fabbisogno era stato di 155.612 miliardi) ha consentito una riduzione dell'incidenza sul prodotto interno che è passata dal 9,5% al 7,3%. L'avanzo primario, in presenza di una forte espansione della spesa per interessi, ha raggiunto i 63.567 miliardi, a fronte dei 17.257 del 1994, ed è salito dall'1,1% al 3,6% del PIL. Queste favorevoli dinamiche sono derivate, oltre che da una accelerazione dello sviluppo della fase di crescita economica, da consistenti interventi di correzione degli squilibri pubblici (risultati pari ad oltre il 3% del PIL) che hanno rafforzato il processo di risanamento, dopo il rallentamento del 1994. L'obiettivo relativo al fabbisogno del Settore Statale per il 1995 era stato inizialmente fissato a 138.600 miliardi sia nel Documento di programmazione economico-finanziaria che nella Relazione previsionale e programmatica presentati nel 1994. Per il raggiungimento del saldo programmato a fine 1994, veniva predisposta una manovra correttiva valutata ufficialmente in 48.000 miliardi. Gli interventi, suddivisi sostanzialmente in parti uguali tra maggiori entrate e risparmi di spesa, da una parte, hanno riguardato un recupero di evasione ed elusione fiscale senza aumenti delle aliquote tributarie e, dall'altra, hanno permesso un contenimento della spesa soprattutto nei settori della previdenza e della sanità. Tuttavia, l'aumento dei tassi di interesse verificatosi nella seconda metà del 1994 e protrattosi nei primi mesi del 1995 rendeva necessaria una manovra aggiuntiva. L'azione correttiva, predisposta a fine febbraio, prevedeva una riduzione del deficit pubblico di 21.000 miliardi, di cui oltre 15.000 dovuti a maggiori entrate e 5.000 a minori spese. Queste ultime hanno riguardato sostanzialmente tutte le diverse categorie di uscita; i maggiori incassi sono derivati, in larga misura, da un inasprimento dell'imposizione indiretta e da un anticipo della imposta sul patrimonio netto delle imprese. Ai primi di aprile, il fabbisogno programmato veniva ridotto a 134.000 miliardi nella Relazione trimestrale di cassa, a seguito dell'analisi dei dati di consuntivo del 1994, che indicavano una dinamica contenuta della spesa pubblica, e di aggiornamento del quadro congiunturale, con la previsione di una più intensa crescita dell'attività economica, stimata al 3% invece del precedente +2,7%. Scontando un rialzo del tasso di inflazione e l'emergere di nuovi elementi favorevoli (tra cui i maggiori dividendi previsti sugli utili dell'ENI e dell'ENEL), veniva operata una successiva e definitiva revisione verso il basso dell'obiettivo posto, come già ricordato, in 130.000 miliardi del documento di programmazione economico-finanziaria per il 1996-98. L'indebitamento netto delle Amministrazioni Pubbliche, che registra i risultati di gestione degli enti pubblici centrali e subcentrali, si è attestato a 125.505 miliardi a fronte dei 147.980 del 1994. Si è dunque verificata una notevole riduzione, dal 9% al 7,1,%, dell'incidenza sul PIL. Il rapporto tra debito delle Amministrazioni Pubbliche, - nella accezione valida per la verifica dei parametri previsti dal Trattato di Maastricht - e prodotto è diminuito dal 125,6 al 124,8 per cento.
5. La politica monetaria
------------------------------ © Servizio per le informazioni e la Sicurezza Democratica ------------------------------

Nel 1995 la politica monetaria ha accentuato l'orientamento restrittivo, mirante a moderare le aspettative d'inflazione e a invertire la tendenza all'accelerazione dei prezzi al consumo. La Banca d'Italia ha aumentato i tassi ufficiali in febbraio e alla fine di maggio: il tasso di sconto è salito complessivamente dal 7,5 al 9%; quello sulle anticipazioni a scadenza fissa dall'8,5 al 10,5%. Il cambio della lira e i corsi dei titoli di Stato, dopo aver subito un marcato indebolimento nel primo quadrimestre dell'anno, hanno recuperato nei mesi successivi. A fine anno, i rendimenti sui titoli di Stato a lungo termine erano tornati su livelli inferiori a quelli della fine del 1994. Il recupero è continuato nella prima parte del 1996. Nel corso del 1995 la politica di emissione di titoli di Stato ha tenuto conto della duplice finalità di allungare la vita media del debito e di contenere il costo dell'indebitamento, a fronte di un elevato livello dei rendimenti a lungo termine. Le emissioni nette di BOT sono state lievemente negative; l'elevato ammontare di CCT in scadenza (149.000 miliardi) è stato rinnovato soltanto in parte con titoli della stessa specie, mentre ampie sono state le emissioni nette di btp (95.900 miliardi). Nel febbraio 1995 sono stati emessi per la prima volta titoli biennali a sconto (CTZ), le cui emissioni sono proseguite su base regolare; nel corso dell'anno ne sono stati collocati 38.300 miliardi. La vita media dei titoli del settore pubblico è lievemente aumentata, a quasi tre anni.
6. Gli scambi con l'estero Nel 1995 è proseguita la fase di miglioramento dei conti con l'estero avviata nel 1993. Nel consuntivo annuo le partite correnti della bilancia dei pagamenti hanno registrato un avanzo di 44.549 miliardi di lire, superiore di 18.980 miliardi a quello del 1994 e pari al 2,5% del prodotto interno lordo. Il miglioramento è in larga parte disceso dall'ampliarsi dell'attivo mercantile, passato nella valutazione fob-fob da 57.197 a 71.687 miliardi. La crescita del surplus mercantile ha riflesso la favorevole evoluzione delle quantità scambiate che ha più che compensato la concomitante perdita accusata dalle regioni di scambio. I guadagni di competitività conseguiti negli ultimi anni dalle merci italiane hanno trovato riscontro nell'eccezionale crescita registrata dalle esportazioni in volume. In particolare, il tasso di espansione delle vendite all'estero ha toccato nel consuntivo dei primi undici mesi del 1995 e nel raffronto con il corrispondente periodo del 1994 il 15%. Tale risultato si confronta con un allargamento del commercio internazionale che dovrebbe aver di poco superato nell'intero 1995 - secondo prime stime del FMI - l'8%. Ne è pertanto derivato un guadagno di quote di mercato consistente e più rilevante rispetto a quelli conseguiti (a prezzi costanti) nel precedente biennio. Il profilo di crescita delle esportazioni è risultato tuttavia calante in corso d'anno. Il rallentamento accusato dalle vendite all'estero nel secondo semestre ha essenzialmente riflesso la perdita di tono congiunturale accusata dalle maggiori economie europee.
------------------------------ © Servizio per le informazioni e la Sicurezza Democratica ------------------------------

7. I prezzi 7. I prezzi Nel 1995 si è interrotta la discesa del tasso d'inflazione che aveva caratterizzato i quattro anni precedenti. Il sistema dei prezzi è infatti risultato sottoposto a forti tensioni inflazionistiche che hanno teso a rientrare nella seconda parte dell'anno. Nella media del 1995 l'indice generale dei prezzi al consumo ha così segnato una crescita del 5,2% a fronte del 4% con cui si era chiuso il 1994. Leggermente più contenuto, e anche esso in risalita rispetto all'anno precedente, è risultato al contempo l'aumento del deflattore del prodotto interno lordo, pari al 5% (3,5% nel 1994). L'andamento mediamente più moderato segnato dalla dinamica dei prezzi nell'area europea ha indotto un nuovo allargamento del divario inflazionistico rispetto ai principali paesi partners. Nella media del 1995 la differenza tra il tasso d'inflazione in Italia e quello in Germania e Francia è risultata pari a 3,4 punti percentuali (rispettivamente 1,3 e 2,3 punti nel 1994) mentre anche nei confronti del Regno Unito, che ha sperimentato una risalita nel tasso di crescita dei prezzi, il differenziale d'inflazione ha subito un relativo ampliamento (1,8 dopo il punto e mezzo del 1994). La distanza rispetto ai tre paesi dell'Unione europea con la dinamica dei prezzi più contenuta è ulteriormente cresciuta superando i 3 punti e mezzo. Nel corso dell'anno l'andamento dei prezzi ha comunque sperimentato due fasi differenti: la prima parte del 1995 si è infatti caratterizzata per la presenza di forti spinte inflazionistiche diffuse in tutti gli stadi di formazione dei prezzi; a partire dall'estate ha viceversa avuto luogo una graduale attenuazione del ritmo di crescita dei prezzi, particolarmente evidente a livello della produzione. L'accelerazione dell'inflazione nei primi mesi del 1995 ha trovato principale alimento nei rialzi registrati dalle quotazioni internazionali delle materie prime cui si è aggiunta l'ulteriore e consistente svalutazione della lira mentre la manovra sulle imposte indirette di inizio anno ha impresso ulteriori sollecitazioni inflazionistiche a livello della distribuzione finale. La dinamica particolarmente moderata del costo del lavoro ha comunque arginato il propagarsi delle spinte inflattive. Il recupero del cambio della lira nei mesi estivi e l'inversione di tendenza rilevata nell'andamento delle quotazioni internazionali delle materie prime hanno nel seguito consentito dinamiche dei prezzi più contenute.
------------------------------ © Servizio per le informazioni e la Sicurezza Democratica ------------------------------

(*) Documento presentato dai Ministri del Bilancio e del Tesoro il 4 aprile 1996. Stralci a cura della Redazione dal I Capitolo, L'evoluzione dell'economia nel 1995.
------------------------------ © Servizio per le informazioni e la Sicurezza Democratica ------------------------------

Camera dei Deputati XII LEGISLATURA Proposta di legge n. 842 "Norme in materia di informazione e sicurezza dello Stato, di segreto di Stato, di informazioni classificate", d'iniziativa dei deputati Dorigo, Cossutta, Bertinotti ed altri.
(*) Gli estensori della proposta di legge n. 842, pur riconoscendo il ruolo imprescindibile dei Servizi in una società democratica, ritengono tuttavia necessaria una totale revisione degli attuali organismi istituiti con la L. 801/77 e pertanto propongono: - la soppressione dei Servizi di informazione e sicurezza istituiti con la L. 801/77, e il trasferimento del personale ad altre amministrazioni dello Stato (art. 1); - la soppressione di tutti i SIOS (art. 1); - l'attribuzione, al Presidente del Consiglio, dell'alta direzione e della responsabilità della politica informativa e di sicurezza (art. 2); - l'istituzione dell'UCSI, alle dirette dipendenze del Presidente del Consiglio (art. 3); - l'istituzione, presso la Presidenza del Consiglio, del CIIS, con funzioni di consulenza e proposta sugli indirizzi generali (art. 4); - l'istituzione dell'Agenzia per l'informazione e la sicurezza dello Stato (AISS), organismo di diritto pubblico con personalità giuridica, sotto la vigilanza e l'alta direzione del Presidente del Consiglio (art. 5). I compiti assegnati a questa nuova Agenzia sono i seguenti: - ricerca, analisi e conservazione delle informazioni atte a tutelare la sovranità nazionale e trasmissione delle stesse alle autorità competenti (art. 5); - protezione delle comunicazioni elettroniche di interesse nazionale, decrittazione e decifrazione delle comunicazioni esterne, con esclusione di ogni attività di intercettazione delle comunicazioni relative al territorio nazionale (art. 5). Il personale dell'AISS può essere assunto direttamente o provenire da altra amministrazione, ma deve essere analizzato e valutato da una apposita commissione nominata dalla Presidenza del Consiglio (permangono i casi di incompatibilità per i ministri di culto, i giornalisti, i magistrati, ecc.., già previsti dalla L. 801/77). Al personale assunto, viene corrisposta l'indennità operativa prevista per gli appartenenti alle FF.AA. Non sono ammessi altri tipi di indennità (art. 6). Tutto il personale dell'Agenzia ha l'obbligo di fornire all'autorità giudiziaria le informazioni e gli elementi di prova relativi a fatti configurabili come reati (art. 7). Le pubbliche amministrazioni sono tenute a mettere a disposizione del personale dell'Agenzia ogni mezzo ed infrastruttura (art. 8). Un Comitato parlamentare di controllo, con gli stessi poteri previsti per le Commissioni parlamentari d'inchiesta, esercita il controllo sull'applicazione della presente legge (art. 9). Tutti i documenti classificati sono conservati presso l'archivio generale dei Servizi, istituito presso l'UCSI (art. 10). Con il Capo II si definiscono le norme relative al segreto di Stato e alla disciplina delle informazioni classificate (artt. 11-12-13-14-15-16-17-18-19). Con l'art. 20 si sostituisce la definizione di segreto di Stato così come stabilita dall'art. 202 del codice di procedura penale. L'art. 21 stabilisce le modalità di applicazione del controllo del Comitato parlamentare. I rimanenti articoli disciplinano le informazioni classificate. Di particolare rilievo l'art. 24 che abolisce il NOS e l'art. 25 che garantisce il diritto di accesso, per chiunque, agli atti della pubblica amministrazione. Infine, l'art. 31 che sancisce l'abrogazione degli artt. da 1 a 11 e 19 della L. 801/77.
PROPOSTA DI LEGGE d'iniziativa dei deputati DORIGO, COSSUTTA, BERTINOTTI, CRUCIANELLI, ALTEA, BARZANTI, BELLEI TRENTI, BIELLI, BOFFARDI, BOGHETTA, BOLOGNESI, BRUNETTI, CALVANESE, CARAZZI, COCCI, COMMISSO, DE ANGELIS, DE MURTAS, DILIBERTO, GALDELLI, GARAVINI, GIULIETTI, GRIMALDI, GUERRA, LENTI,
------------------------------ © Servizio per le informazioni e la Sicurezza Democratica ------------------------------

LUIGI MARINO, MORONI, MUZIO, NAPPI, NARDINI, PISTONE, MARCO RIZZO, SAIA, SCIACCA, SCOTTO di LUZIO, VALPIANA, VENDOLA, VIGNALI, VOCCOLI Norme in materia di informazione e sicurezza dello stato, di segreto di Stato, di informazioni classificate Presentata il 5 luglio 1994 Onorevoli Colleghi! - Vicende recenti e recentissime, sulle quali sono in corso indagini dell'autorità giudiziaria, rendono necessaria e urgente una riconsiderazione complessiva degli organismi preposti all'informazione e alla sicurezza dello Stato. Gli episodi di corruzione e di compromissione con organizzazioni criminali hanno rafforzato nell'opinione pubblica il convincimento, già peraltro consolidatosi negli scorsi anni, che le attività dei servizi segreti avessero come obiettivo non la salvaguardia delle istituzioni democratiche né la tutela della sovranità nazionale, ma piuttosto la difesa - anche coi mezzi e coi sistemi più spregiudicati - di interessi politici di parte (interni ed esterni al Paese) non propriamente coincidenti con quelli dell'intera collettività nazionale, ai quali soltanto deve guardare, per istituto, ogni amministrazione o settore o ufficio di uno Stato democratico. A tal punto questa autentica degenerazione ha creato allarme e sconcerto tra i cittadini da indurre molti a ritenere che l'unica soluzione credibile sia l'abolizione definitiva di tutti gli organismi preposti all'informazione e alla sicurezza dello Stato. Una soluzione certamente seducente, ma che non tiene conto di un contesto internazionale che pur profondamente mutato dopo gli avvenimenti del biennio 1989-1990, non è comunque tale da far escludere, in via generale di principio, disegni tendenti a mettere a rischio la sovranità e l'integrità dello Stato democratico, del suo territorio e delle sue istituzioni. Vanno dunque previsti strumenti di intelligence che siano in grado di prevenire o individuare eventuali disegni di tale natura. Deve tuttavia trattarsi di strumenti complessivamente nuovi, interamente ed esclusivamente destinati ai fini suddetti, del tutto estranei e neutrali nei confronti delle vicende politiche interne del Paese. Ne consegue la necessità di azzerare gli organismi istituiti con la legge 24 ottobre 1977, n. 801, di abolire i SIOS delle forze armate e delle forze di polizia, di costituire ex novo un'unica struttura alle dipendenze della Presidenza del Consiglio dei ministri che, tramite il Presidente del Consiglio dei ministri, risponda delle sue attività ad un apposito Comitato parlamentare. Il necessario coordinamento tra Presidenza del Consiglio e ministri interessati è garantito da un comitato interministeriale. È del tutto evidente che ponendo mano a una radicale trasformazione delle strutture preposte all'informazione e alla sicurezza dello Stato, occorre affrontare contestualmente una revisione delle norme riguardanti il segreto di Stato, le informazioni e i documenti classificati. Alle nuove norme in materia è dedicato l'intero capo II della presente proposta di legge. Tali norme si basano sul principio per cui al segreto si può fare ricorso esclusivamente nei casi in cui la diffusione di documenti o notizie possa arrecare danno grave all'integrità dello Stato e delle sue istituzioni. Viene abolito l'istituto dei «nulla osta di sicurezza», la cui gestione, di per sé discrezionale, ha dato luogo, in passato, ad autentiche discriminazioni. La possibilità di accesso ad atti riservati o segreti viene dunque ad essere legata esclusivamente alla funzione svolta da chi a quegli atti deve accedere per esigenze d'ufficio. Per la gestione dell'intera materia è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri l'apposito Ufficio centrale di sicurezza. quale strumento di garanzia è prevista l'istituzione di una Commissione centrale per la libertà di accesso agli atti. Con l'articolo 1 del capo I si propone la soppressione degli organismi per l'informazione e la sicurezza, istituiti con la legge n. 801 del 1977, nonché quelli delle Forze armate e delle Forze di polizia. Il personale viene trasferito ad altre amministrazioni dello Stato o può, con compiti diversi, essere impiegato nell'ambito delle stesse amministrazioni di appartenenza. Sono attribuite al Presidente del Consiglio dei ministri: l'alta direzione, la responsabilità politica generale e il coordinamento della politica informativa e di sicurezza, oltre al compito di impartire le direttive ed emanare ogni disposizione che attiene all'organizzazione e al funzionamento delle attività di cui all'articolo 2. Con l'articolo 3 si istituisce l'Ufficio centrale di Sicurezza (UCSI) alle dirette dipendenze del Presidente del Consiglio dei ministri che, sentito il Comitato di cui all'articolo 4 e il Comitato parlamentare di cui all'articolo 9, emana per decreto il regolamento dell'UCSI e ne definisce l'organico e le modalità di
------------------------------ © Servizio per le informazioni e la Sicurezza Democratica ------------------------------

assunzione e di composizione. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito il Comitato interministeriale per le informazioni e la sicurezza (CIIS), con funzioni di consulenza e di proposta sugli indirizzi generali e sugli obiettivi da perseguire per il Presidente del Consiglio dei ministri (articolo 4). È istituita l'Agenzia per l'informazione e la sicurezza dello Stato (AISS), organismo di diritto pubblico con personalità giuridica, sotto la vigilanza e la direzione del Presidente del Consiglio dei ministri (articolo 5), con i seguenti compiti: a) ricerca, analisi e conservazione delle informazioni atte a tutelare la sovranità nazionale e trasmissione delle stesse alle autorità competenti; b) protezione delle comunicazioni elettroniche di interesse nazionale, decrittazione e decifrazione delle comunicazioni esterne, con esclusione di ogni attività di intercettazione delle comunicazioni relative al territorio nazionale. La ripartizione dei fondi, tra spese ordinarie e spese riservate, è fatta all'inizio dell'esercizio finanziario dal Presidente del Consiglio dei ministri. Tale ripartizione può essere modificata nel corso dell'esercizio finanziario, con la stessa procedura. Le spese ordinarie sono soggette al controllo della Corte dei conti mentre quelle riservate sono disposte dal direttore dell'Agenzia che fornisce un rendiconto mensile al Presidente del Consiglio dei ministri. Con l'articolo 6 si stabiliscono le disposizioni relative alle assunzioni, valutazioni, incompatibilità, preclusioni e divieti del personale operante presso l'AISS. Gli articoli 7 e 8 definiscono il rapporto dell'AISS con l'autorità giudiziaria e con le pubbliche amministrazioni. Con l'articolo 9 si stabilisce il controllo parlamentare sulla politica informativa e di sicurezza, sui controlli e sui risultati ottenuti. Il Governo riferisce in materia al Parlamento con periodicità almeno semestrale. Si costituisce un Comitato parlamentare che ha gli stessi poteri previsti per le Commissioni bicamerali d'indagine, con il compito di esercitare il controllo sull'applicazione delle norme stabilite dalla presente legge. È istituito presso l'UCSI l'archivio centrale degli organi di informazione e di sicurezza per la conservazione degli atti relativi all'attività dell'AISS (articolo 10). Tutta la documentazione, protocollata, è depositata in copia presso gli uffici del Comitato parlamentare. Con il capo II si definiscono le norme relative al segreto di Stato e alla disciplina delle informazioni classificate. L'articolo 11 stabilisce che gli atti, i documenti e le attività degli organi e delle amministrazioni centrali dello Stato sono pubblici, salvo i casi in cui è richiesto il vincolo del segreto, come definiti negli articoli 12 e 13. È coperto dal segreto di Stato qualsiasi materiale o attività la cui diffusione possa arrecare danno grave all'integrità dello Stato democratico e delle sue istituzioni (articolo 12); non possono essere oggetto di segreto di Stato informazioni concernenti fatti eversivi dell'ordine costituzionale e di tutti i procedimenti penali che si riferiscono agli articoli del codice penale elencati nell'articolo 13. I trattati internazionali non possono essere sottoposti al vincolo del segreto di Stato, salvo alcune deroghe, opportunamente motivate dal Presidente del Consiglio dei ministri (articolo 14). Si escludono effetti retroattivi nell'apposizione del segreto (articolo 15). Rientrano nella definizione di segreto di Stato i documenti classificati con «segreto» e «segretissimo» (articolo 16). I documenti, per i quali può essere prevista la classifica di «riservato», non possono essere negati ai giudici di merito o al Parlamento, qualora ne richiedano visione (articolo 17). Nessun documento a contenuto puramente normativo può essere classificato (articolo 18). Il segreto di stato può essere apposto dal Presidente del Consiglio dei ministri o dai ministri facenti parte del Consiglio supremo di difesa per le materie di loro competenza (articolo 19). Con l'articolo 20 si sostituisce la definizione di «segreto di Stato» così come data dal codice di procedura penale. L'articolo 21 stabilisce le modalità di applicazione del controllo del Comitato parlamentare sulle norme stabilite della presente legge. Le classifiche che definiscono il segreto di Stato sono portate al livello inferiore ogni cinque anni e decadono dopo quindici anni, salvo decisione motivata del Presidente del Consiglio dei ministri (articolo 22).
------------------------------ © Servizio per le informazioni e la Sicurezza Democratica ------------------------------

Tutti i nominativi coperti dal segreto di Stato devono essere conservati in ordine cronologico, in uno speciale archivio presso la Presidenza del Consiglio dei ministri (articolo 23). È abolito il nulla osta di sicurezza (articolo 24). Ogni amministrazione centrale e periferica dello Stato istituisce un ufficio per la libertà di accesso ai documenti amministrativi che potranno essere ottenuti da chiunque ne faccia richiesta, fatti salvi i casi di cui al comma 3 dell'articolo 25. Entro novanta giorni l'amministrazione deve rilasciare copia del documento al richiedente o motivarne il rifiuto (articolo 26). In caso di rifiuto, il richiedente può presentare ricorso entro trenta giorni (articolo 27). L'articolo 28 stabilisce la composizione della commissione centrale per la libertà di accesso. Il capo III definisce le norme finanziarie e le disposizioni regolamentari e finali della legge. PROPOSTA DI LEGGE Capo I Norme in materia di informazione e sicurezza dello stato Art. 1 (Soppressione degli organismi per l'informazione e la sicurezza) 1. Gli organismi istituiti a norma della legge 24 ottobre 1977, n. 801, sono soppressi. Sono altresì soppressi i servizi informativi, investigativi e di sicurezza delle Forze armate e delle Forze di polizia. 2. Il personale appartenente agli organismi di cui al comma 1 viene trasferito, con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ad altre amministrazioni dello Stato. 3. Il personale appartenente ai Servizi informazioni operative speciali (SIOS) delle Forze armate e delle Forze di polizia viene assegnato, con appositi decreti dei Ministri competenti, ad altri compiti nell'ambito delle amministrazioni di appartenenza oppure trasferito, su domanda degli interessati, nelle forze e nei limiti indicati dagli articoli 3 e 6, all'Ufficio centrale di cui all'articolo 3 o all'Agenzia di cui all'articolo 5. Art. 2 (Attribuzioni del Presidente del Consiglio dei ministri) 1. Al Presidente del Consiglio dei ministri sono attribuiti l'alta direzione, la responsabilità politica generale e di coordinamento della politica informativa e di sicurezza nell'interesse e per la difesa dello Stato democratico e delle istituzioni poste dalla Costituzione a suo fondamento. 2. Il Presidente del Consiglio dei ministri impartisce le direttive ed emana ogni disposizione necessaria per l'organizzazione e il funzionamento delle attività inerenti ai fini di cui al comma 1. Art. 3 (Istituzione dell'Ufficio centrale di sicurezza) 1. Ai fini dell'applicazione di quanto previsto dal capo II è istituito, alle dirette dipendenze del Presidente del Consiglio dei ministri, l'Ufficio centrale di sicurezza (UCSI). 2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti il Comitato interministeriale di cui all'articolo 4 e il Comitato parlamentare di cui all'articolo 9, emana con proprio decreto il regolamento dell'UCSI, definendone l'organico. 3. Alla direzione dell'UCSI è preposto un dipendente dello Stato con qualifica non inferiore a dirigente generale o equiparata, nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Comitato interministeriale di cui all'articolo 4. Il mandato del direttore è revocabile, cessa in ogni caso dopo quattro anni e non è rinnovabile. 4. Il personale dell'UCSI è costituito da dipendenti delle amministrazioni civili e militari dello Stato. Il personale proveniente dalle singole amministrazioni non può eccedere il 10 per cento dell'organico dell'ufficio. Un'apposita commissione, nominata dal Presidente del Consiglio dei ministri, analizza e valuta i candidati in base a disposizioni e criteri che saranno resi pubblici dal Governo. Art. 4 (Comitato interministeriale)
------------------------------ © Servizio per le informazioni e la Sicurezza Democratica ------------------------------

1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un Comitato interministeriale per le informazioni e la sicurezza (CIIS), con funzioni di consulenza e di proposta per il Presidente del Consiglio dei ministri, sugli indirizzi generali e sugli obiettivi fondamentali da perseguire nel quadro della politica informativa e di sicurezza. 2. Il Comitato in sessione ordinaria è presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri ed è composto dai Ministri dell'interno e della difesa. Salvo che il Presidente del Consiglio dei ministri disponga diversamente in relazione a singoli affari, intervengono alle riunioni del Comitato, a titolo consultivo, il direttore dell'UCSI e il direttore dell'Agenzia di cui all'articolo 5. 3. Al Comitato in sessione plenaria partecipano altresì il Ministro degli affari esteri, il Ministro di grazia e giustizia e il Ministro delle finanze. Il Comitato si riunisce in sessione plenaria nei casi indicati dalla presente legge e in ogni altro caso in cui il Presidente del Consiglio dei ministri lo ritenga opportuno. 4. Il Presidente del Consiglio dei ministri può chiamare a partecipare alle sedute del Comitato altri ministri, autorità civili e militari ed esperti. Art. 5 (Agenzia per l'informazione e la sicurezza dello Stato) 1. È istituita l'Agenzia per l'informazione e la sicurezza dello Stato (AISS), organismo di diritto pubblico con personalità giuridica, sotto la vigilanza e l'alta direzione del Presidente del Consiglio dei ministri. 2. L'AISS cura la ricerca, l'analisi e la conservazione delle informazioni atte a tutelare la sovranità nazionale, nonché la loro trasmissione alle autorità competenti per la difesa dello Stato democratico, del suo territorio e delle sue istituzioni da ogni interferenza straniera. 3. L'AISS ha compiti di difesa elettronica, consistenti nella protezione delle comunicazioni di interesse nazionale e nella decrittazione e decifrazione delle comunicazioni esterne. È esclusa ogni attività di intercettazione delle comunicazioni interne al territorio nazionale. 4. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il CIIS in sessione plenaria e il Comitato parlamentare di cui all'articolo 9, emana con proprio decreto il regolamento dell'AISS definendone l'organico. 5. Il direttore dell'AISS è nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il CIIS in sessione plenaria, ed è scelto fra i dipendenti dello Stato con qualifica non inferiore a dirigente generale o equiparata, i magistrati delle giurisdizioni superiori ordinaria e amministrativa, gli avvocati dello Stato, i professori ordinari di università. 6. Il mandato del direttore è revocabile, cessa in ogni caso dopo quattro anni e non è rinnovabile. Il direttore è collocato di diritto fuori ruolo o nella corrispondente posizione prevista dall'ordinamento dell'amministrazione di appartenenza. Il suo stato giuridico e il suo trattamento economico sono determinati con il regolamento di cui al comma 4. 7. Il direttore esercita il suo mandato secondo le direttive del Presidente del Consiglio dei ministri e risponde a quest'ultimo dell'attività dell'AISS e dei suoi risultati. 8. Il regolamento di cui al comma 4 determina il numero e le attribuzioni dei reparti dell'AISS. Ogni reparto è retto da un funzionario che dipende dal direttore dell'AISS. Il regolamento determina altresì le modalità dei controlli contabili e delle verifiche dei costi e dei rendimenti. 9. La ripartizione dei fondi complessivamente disponibili fra spese ordinarie e spese riservate è determinata all'inizio dell'esercizio finanziario dal Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti il CIIS in sessione plenaria e il Comitato parlamentare di cui all'articolo 9. Con la stessa procedura tale ripartizione può essere modificata nel corso dell'esercizio. 10. Le spese ordinarie sono soggette al controllo della Corte dei conti. Le spese riservate sono disposte dal direttore dell'AISS, che ne fornisce rendiconto mensile al Presidente del Consiglio dei ministri. La relativa documentazione è conservata a norma dell'articolo 10. Art. 6 (Disposizioni sul personale dell'AISS) 1. Il personale in rapporto d'impiego con l'AISS è costituito da: a) dipendenti delle amministrazioni civili e militari dello Stato, collocati fuori ruolo a tempo indeterminato; b) dipendenti assunti direttamente, con i requisiti e secondo le modalità previste dal regolamento di cui al comma 4 dell'articolo 5.
------------------------------ © Servizio per le informazioni e la Sicurezza Democratica ------------------------------

2. Un'apposita commissione nominata dalla Presidenza del Consiglio dei ministri analizza e valuta i candidati in base a disposizioni e criteri che saranno resi pubblici dal Governo. 3. Il personale proveniente dalle amministrazioni dello Stato non può eccedere, per ogni amministrazione interessata, la misura del 10 per cento dell'organico dell'AISS. 4. L'ordinamento del personale e il relativo trattamento giuridico ed economico sono di tipo civile e vengono determinati dal regolamento di cui al comma 4 dell'articolo 5, con l'osservanza dei seguenti princìpi: a) il conferimento ai dipendenti di qualifiche, mansioni ed incarichi è regolato esclusivamente dall'ordinamento interno dell'AISS ed è determinato in funzione delle esigenze del servizio; b) devono essere determinate le condizioni e le modalità per il trasferimento del personale già dipendente dall'AISS nei ruoli di altre amministrazioni dello Stato. 5. Non è previsto in alcun caso il rientro del personale collocato fuori ruolo alle amministrazioni di provenienza. 6. L'AISS può avvalersi saltuariamente di collaboratori esterni per compiti d'istituto e in base a quanto previsto in merito dal regolamento di cui al comma 4 dell'articolo 5. 7. È incompatibile con ogni forma di dipendenza o di collaborazione con l'AISS la qualità di membro del Parlamento, di componente degli organi deliberativi delle regioni e degli enti locali, di magistrato, di ministro di culto, di giornalista professionista. 8. L'AISS non può avvalersi in rapporto di dipendenza, anche saltuario, di persone che, per comportamenti o azioni eversive nei confronti delle istituzioni democratiche, non diano sicuro affidamento di scrupolosa fedeltà ai valori della Costituzione e dell'ordinamento democratico. 9. Il personale dell'AISS agisce esclusivamente nell'interesse e per la difesa dello Stato democratico e delle istituzioni poste dalla Costituzione a suo fondamento. 10. Al personale dell'AISS è fatto divieto di: a) svolgere attività clandestina; b) svolgere attività armate; c) svolgere attività a favore o contro partiti o movimenti politici. 11. Al momento dell'entrata in servizio i dipendenti dell'AISS firmano una dichiarazione impegnativa con la quale garantiscono di non aver prestato altri giuramenti di fedeltà al di fuori di quello verso lo Stato e di non far parte di organizzazioni segrete o coperte. 12. Il personale che violi gli obblighi di cui ai commi 9, 10 e 11 è collocato a riposo o dimesso, con provvedimento del direttore dell'AISS. 13. Al personale dell'AISS viene corrisposta l'indennità operativa prevista per gli appartenenti alle Forze armate, aumentata, per coloro che siano impegnati in operazioni speciali, nella misura prevista per le indennità assegnate ai Corpi speciali delle Forze armate. 14. Non sono ammesse indennità né sono previsti compensi di alcun tipo al di fuori di quanto disposto dal comma 13. 15. I dipendenti dell'AISS non rivestono la qualità di ufficiali o di agenti di polizia giudiziaria; tale qualità è sospesa per tutta la durata del collocamento fuori ruolo per il personale che la rivesta in base all'ordinamento dell'amministrazione di provenienza. Art. 7 (Rapporti con l'autorità giudiziaria) 1. Tutto il personale dell'AISS ha l'obbligo di fornire all'autorità giudiziaria le informazioni e gli elementi di prova relativi a fatti configurabili come reati. 2. Tutti gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria debbono fornire la cooperazione eventualmente richiesta dal direttore dell'AISS. Art. 8 (Rapporti con le pubbliche amministrazioni) 1. Per determinazione del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto coi ministri interessati, l'AISS può avvalersi di mezzi e infrastrutture di qualsiasi amministrazione pubblica. 2. Le pubbliche amministrazioni sono tenute a corrispondere alle richieste di informazioni loro inoltrate dal direttore dell'UCSI o dal direttore dell'AISS.
------------------------------ © Servizio per le informazioni e la Sicurezza Democratica ------------------------------

Art. 9 (Controllo parlamentare) 1. Il Governo riferisce tempestivamente al Parlamento e con periodicità almeno semestrale con una relazione sulla politica informativa e della sicurezza, sui controlli e sui risultati ottenuti. 2. Un Comitato parlamentare, costituito da sette deputati e sette senatori, nominati dai Presidenti dei dure rami del Parlamento, sulla base del criterio di proporzionalità, esercita il controllo sull'applicazione della presente legge. A tal fine, il Presidente del Consiglio dei ministri, informa il Comitato sull'attività dell'AISS, dà notizia della emanazione di regolamenti e di direttive generali, comunicandone il testo e riferisce sull'assegnazione dei fondi e sui risultati della rendicontazione. Il Comitato può chiedere ulteriori informazioni e chiarimenti e formulare proposte e rilievi. 3. Il Comitato parlamentare ha gli stessi poteri previsti per le Commissioni parlamentari d'inchiesta. 4. Il Presidente del Consiglio dei ministri può richiedere al Comitato parlamentare la tutela del segreto in ordine alle informazioni che a suo giudizio eccedono i limiti di cui al comma 2. In tal caso gli atti del Comitato sono coperti dal segreto. Il segreto non è comunque previsto per gli atti regolamentari e per quelli soggetti al controllo della Corte dei conti. 5. I componenti del Comitato parlamentare sono vincolati al segreto relativamente alle informazioni di cui al comma 4. Art. 10 (Conservazione degli atti) 1. È istituito presso l'UCSI l'archivio centrale degli organismi di informazione e di sicurezza, cui è preposto un dirigente nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il CIIS. Nell'archivio centrale sono conservati tutti gli atti relativi all'attività dell'AISS, compresi quelli che si riferiscono a spese riservate. 2. Il regolamento dell'UCSI disciplina le modalità di conservazione, anche con mezzi informatici, e i criteri per l'accesso e la visione dei singoli atti, tenuto conto di quanto previsto dal capo II. 3. Tutta la documentazione deve essere protocollata e copia del protocollo è depositata presso gli uffici del Comitato parlamentare. Capo II Norme relative al segreto di Stato e disciplina delle informazioni classificate Art. 11 (Pubblicità degli atti) 1. Gli atti, i documenti, le attività degli organi delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, nonché delle regioni e degli enti locali sono pubblici, salvo che non vi sia esplicitamente e individualmente apposto il vincolo del segreto o della riservatezza secondo le norme contenute nella presente legge. Art. 12 (Presupposti del segreto di Stato) 1. È coperto da segreto di Stato qualsiasi atto, documento, notizia, materiale o attività la cui diffusione possa arrecare danno grave alla integrità dello Stato democratico, alle istituzioni della Repubblica, al libero esercizio delle funzioni degli organi costituzionali, all'indipendenza e alla difesa dello Stato. Art. 13 (Casi di inammissibilità del segreto di Stato) 1. In nessun caso possono essere oggetto di segreto di Stato informazioni concernenti fatti eversivi dell'ordine costituzionale, né il segreto può essere opposto nel corso di procedimenti penali per i delitti previsti dagli articoli 270, 270-bis, 276, 280, 283, 284, 285, 286, 289, 289-bis, 305, 306, 416-bis e 422 del codice penale, e in genere per tutti i reati aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine costituzionale. Art. 14
------------------------------ © Servizio per le informazioni e la Sicurezza Democratica ------------------------------

(Disciplina del segreto di Stato per i trattati internazionali) 1. Non possono essere sottoposti al vincolo del segreto di Stato trattati o accordi internazionali, anche se esecutivi di accordi precedentemente stipulati. 2. Singole clausole di trattati, purché non compresi tra quelli previsti dall'articolo 80 della Costituzione, possono essere dichiarate segrete. In tal caso il Presidente del Consiglio dei ministri ne comunica al Comitato parlamentare di controllo le motivazioni. Art. 15 (Esclusione di effetti retroattivi nell'apposizione del segreto) 1. Non può essere eccepito il segreto su atti, documenti, attività o materiali in genere se esso non sia stato apposto in data precedente all'eccezione, e nelle forme e secondo le modalità stabilite dalla presente legge. Art. 16 (Documenti con classifica «segreto» e «segretissimo») 1. Rientrano nella definizione di segreto di Stato le classifiche, formulate ai soli fini del trattamento dei documenti e dell'estensione della loro circolazione autorizzata, di «segretissimo», riferite a documenti o altro la cui divulgazione possa provocare un danno estremamente grave agli interessi definiti dall'articolo 12 della presente legge, e «segreto», riferita a documenti o altro la cui divulgazione possa provocare un danno grave ai medesimi interessi. Art. 17 (Documenti con classifica «riservato») 1. Ai soli fini della limitazione della circolazione e della conoscenza, l'amministrazione centrale e periferica dello Stato può utilizzare la classifica di «riservato» su quegli atti, documenti o altri materiali la cui più vasta diffusione potrebbe tradursi in un danno significativo agli interessi definiti all'ar-ticolo 12. 2. In nessun caso può essere negata al giudice di merito la conoscenza di materiali aventi la classifica di cui al comma 1, né può essere rifiutata la testimonianza da parte di persone che ne abbiano conoscenza. 3. Non possono altresì essere rifiutate al Parlamento informazioni, notizie, o materiali classificati ai sensi del comma 1. 4. Su richiesta dell'autorità che esibisce o fornisce i documenti classificati «riservato», gli stessi devono essere esaminati in dibattimento a porte chiuse o, in sede di Comitato o di Commissione parlamentare, con il vincolo della riservatezza per tutti i presenti. Art. 18 (Documenti non classificabili) 1. Nessun documento a contenuto puramente normativo può esser classificato, né possono esserlo quelle informazioni che per loro natura siano a chiunque accessibili oppure siano legittimamente a conoscenza di autorità straniere, al di fuori dei casi previsti da accordi di mutua difesa, di assistenza giudiziaria e di polizia. Art. 19 (Attribuzioni del Presidente del Consiglio dei ministri) 1. Il segreto di Stato può essere apposto dal presidente del Consiglio dei ministri e dai ministri facenti parte del Consiglio supremo di difesa per le materie di loro competenza. 2. Il Presidente del Consiglio dei ministri può delegare altri soggetti all'apposizione del segreto di Stato su materie precisamente definite. 3. La delega di cui al comma 2 ha una durata massima di due anni, rinnovabili, è individuale e intrasferibile, anche parzialmente, è revocabile in qualsiasi momento e termina in ogni caso con la cessazione del delegato dalla funzione o dalla carica che l'aveva giustificata. Art. 20 (Modifica dell'articolo 202 del codice di procedura penale) 1. L'articolo 202 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente: «Art. 202. - (Segreto di Stato). - 1. Chiunque, per ragione del suo ufficio, sia chiamato a deporre su quanto
------------------------------ © Servizio per le informazioni e la Sicurezza Democratica ------------------------------

coperto da segreto di Stato deve eccepirne l'esistenza ed astenersi dal deporre. 2. Il giudice interpella il Presidente del Consiglio dei ministri che, ove ritenga di confermarlo, deve provvedervi entro trenta giorni dalla richiesta. 3. In tal caso il Presidente del Consiglio dei ministri trasmette gli atti o i documenti coperti dal segreto che sono esaminati in camera di consiglio. 4. Ove il giudice ritenga fondata la dichiarazione di segretezza e la prova sia essenziale per la definizione del processo, dichiara non doversi procedere per l'esistenza di un segreto di Stato. In caso contrario trasmette gli atti al Comitato parlamentare di controllo. 5. Se il Presidente del Consiglio dei ministri non conferma il segreto o se il Comitato parlamentare di controllo ne dichiara la insussistenza, il giudice ordina che il testimone deponga. 6. Nel caso si proceda ai sensi del comma 5, il Presidente del Consiglio dei ministri può chiedere che la deposizione avvenga a porte chiuse». Art. 21 (Controllo parlamentare) 1. Il Presidente del Consiglio dei ministri trasmette al Comitato parlamentare l'elenco dei soggetti delegati di cui all'articolo 19; sottopone al preventivo parere gli atti normativi connessi con l'apposizione e la salvaguardia del segreto; comunica al Comitato parlamentare le richieste di conferma della sussistenza del segreto di Stato ai sensi dell'articolo 202 del codice di procedura penale e il loro esito; presenta annualmente una relazione sulla tutela del segreto. 2. Il Presidente del Consiglio dei ministri deve trasmettere entro trenta giorni dalla richiesta qualsiasi documento, atto o informazione che il Comitato parlamentare ritenga di dover esaminare. 3. Il Comitato parlamentare delibera a maggioranza assoluta, entro sessanta giorni dalla richiesta ai sensi dell'articolo 202 del codice di procedura penale, sulla legittima opposizione del segreto di Stato. Art. 22 (Validità delle classifiche) 1. Le classifiche attribuite ai sensi della presente legge sono di diritto portate al livello inferiore ogni cinque anni. 2. Con decisione motivata da comunicare al Comitato parlamentare di controllo, il Presidente del Consiglio dei ministri può deliberare di prolungare la durata del segreto di Stato su singoli atti, documenti, materiali o attività. 3. Tutte le classifiche decadono di diritto quindici anni dopo la data di apposizione della classifica originaria. Art. 23 (Registrazione dei documenti) 1. Gli atti, i documenti e, in genere, tutti i materiali coperti dal segreto di Stato devono essere annotati su registri cronologici conservati dall'autorità originante e, in copia, in uno speciale archivio istituito presso l'UCSI. Art. 24 (Abolizione del nulla osta di sicurezza) 1. L'istituto del nulla osta di sicurezza è abolito. Art. 25 (Diritto di accesso agli atti) 1. Chiunque può chiedere di ottenere in copia qualsiasi atto della pubblica amministrazione. 2. A tal fine ogni amministrazione centrale e periferica dello Stato e ogni altro ente pubblico territoriale e non territoriale istituisce, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un ufficio per la libertà di accesso ai documenti amministrativi. 3. Non possono in nessun caso essere resi noti, se non ai diretti interessati e ai soggetti pubblici che ne abbiano un legittimo interesse, gli atti che contengono informazioni di carattere personale. 4. Il cittadino ha sempre diritto di rettifica relativamente agli atti che lo riguardano.
------------------------------ © Servizio per le informazioni e la Sicurezza Democratica ------------------------------

Art. 26 (Compiti delle amministrazioni) 1. Entro novanta giorni dalla domanda, l'amministrazione di origine del documento richiesto ai sensi dell'articolo 25 deve fornirne copia al richiedente oppure motivarne il rifiuto. 2. Nello stesso termine l'amministrazione deve risponderne nel caso in cui il documento non sia esattamente individuabile oppure quando la stessa amministrazione non sia originaria del documento. 3. In ogni caso di rifiuto o di rinvio l'ufficio per la libertà di accesso ai documenti indica l'autorità alla quale il richiedente può opporre ricorso. Art. 27 (Ricorso in caso di diniego) 1. Nel caso di rifiuto all'accesso di documenti, il richiedente può proporre ricorso entro trenta giorni all'autorità indicata nella comunicazione di diniego. 2. Se, entro sessanta giorni, l'autorità appellata conferma il diniego, nel termine di trenta giorni il richiedente può ricorrere alla Commissione centrale per la libertà di accesso di cui all'articolo 28, che delibera entro novanta giorni. Le decisioni della Commissione sono definitive. Art. 28 (Commissione centrale per le libertà di accesso agli atti) 1. La Commissione centrale per la libertà di accesso, presieduta da un magistrato nominato dal Presidente della Corte di cassazione, comprende quattro membri, dei quali due nominati dai Presidenti dei due rami del Parlamento e due dal Presidente del Consiglio dei ministri. 2. Nel caso di documenti coperti dal segreto di Stato in violazione della presente legge, la Commissione dispone il riesame da parte del Presidente del Consiglio dei ministri e ne informa contestualmente il Comitato parlamentare di controllo. Capo III Disposizioni finanziarie, regolamentari e finali Art. 29 (Norme finanziarie) 1. Le spese relative all'UCSI e all'AISS sono iscritte nello stato di previsione del Ministero del tesoro. Art. 30 (Disposizioni regolamentari) 1. Le disposizioni regolamentari previste dalla presente legge sono emanate, in deroga all'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti il CIIS in sessione plenaria e il Comitato parlamentare. I suddetti decreti stabiliscono il regime della loro pubblicità anche in deroga alle norme ordinarie. 2. Nelle materie disciplinate dalle suddette disposizioni regolamentari non si applicano le norme di legge in materia di amministrazione e contabilità dello Stato, di rapporto d'impiego e di procedimento amministrativo, salvi in ogni caso i princìpi generali del diritto. Art. 31 (Abrogazione di norme) 1. Sono abrogati gli articoli da 1 a 11 e 19 della legge 24 ottobre 1977, n. 801. (*) In questo numero si esauriscono la pubblicazione e l'esame dei disegni e delle proposte di legge presentati nella XII Legislatura. (**) Sintesi redazionale.
------------------------------ © Servizio per le informazioni e la Sicurezza Democratica ------------------------------

Senato della Repubblica XII LEGISLATURA Disegno di legge n. 437 "Nuove norme in materia di istituzione e ordinamento dei servizi per le informazioni e la sicurezza e disciplina del segreto di Stato", d'iniziativa dei senatori De Notaris, Ronchi, Abramonte, Campo, Cangelosi, Carella, Di Maio, Falqui ed altri.
(*) Gli estensori del disegno di legge n. 437 mirano al superamento dei problemi connessi alla mancanza di una reale guida unitaria dei vari servizi, siano essi civili o militari. L'articolo 1 attribuisce al Presidente del Consiglio dei Ministri compiti di direzione, di responsabilità politica e di coordinamento della politica informativa, previo accordo ed approvazione del Consiglio dei Ministri. L'articolo 2 istituisce un Servizio di Informazioni Unificato (SIU) con compiti esclusivamente informativi. Conseguentemente, l'art. 11 stabilisce non solo lo scioglimento di tutti i vari servizi militari e civili, ma impone che il loro personale non possa essere riassunto nella struttura informativa. Il personale da impiegare nel SIU a norma dell'art. 4 potrà essere assunto solo mediante l'esame di un'apposita commissione e sulla base di linee guida indicate da un apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Il personale del SIU potrà permanere nell'incarico per un massimo di quattro anni, dovrà avere un altissimo profilo morale e, se proveniente dalle Forze Armate, non potrà tornare nei relativi ranghi dopo aver terminato il periodo di servizio nella struttura di intelligence. Particolare interesse riveste l'introduzione della cd. "temporizzazione" del segreto di Stato stabilendo che il medesimo può essere apposto per un periodo massimo di 15 anni, dopo il quale la documentazione diviene pubblica, consultabile presso un apposito archivio. Il controllo sulle attività del SIU viene svolto, come indica l'art. 5, da un'apposita Commissione parlamentare bicamerale, che otterrà permanentemente i poteri inquirenti.
DISEGNO DI LEGGE d'iniziativa dei senatori DE NOTARIS, RONCHI, ABRAMONTE, CAMPO, CANGELOSI, CARELLA, DI MAIO, FALQUI, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MANCUSO, PIERONI E ROCCHI Nuove norme in materia di istituzione e ordinamento dei servizi per le informazioni e la sicurezza e disciplina del segreto di Stato Comunicato alla Presidenza il 20 giugno 1994 Onorevoli Senatori - Le attività dei servizi segreti marcano in modo indelebile le vicende più oscure della storia della Repubblica. Uomini dei servizi risultano coinvolti nelle stragi che hanno insanguinato il Paese, nei traffici di droga e di armi, in attività mafiose e camorristiche, nelle associazioni segrete ed eversive, nei fenomeni terroristici di destra e di sinistra. Sono sempre uomini ed apparati dei servizi segreti che in queste settimane vengono giudicati dalla magistratura per l'utilizzo illecito di fondi pubblici, sia a scopo privato che per "aiutare" personaggi politici o correnti politiche. Il segreto di Stato, d'altra parte, nasconde ancor oggi ai cittadini fatti lontani nella storia, come la lotta al banditismo meridionale dell'Ottocento o vicende purtroppo più vicine ai nostri tempi come l'organizzazione Gladio. Occorrerebbero interi volumi per descrivere in modo soddisfacente le pagine della storia italiana rese oscure dalle attività dei servizi segreti. Ma compito del Parlamento non è, e non può essere, svolgere semplicemente un'inchiesta o un'indagine, sia essa giudiziaria oppure storica. Compito del Parlamento è quello di elaborare ed approvare leggi che
------------------------------ © Servizio per le informazioni e la Sicurezza Democratica ------------------------------

applichino nel modo migliore il dettato costituzionale e che rispecchino la volontà popolare. E per ciò che riguarda i servizi segreti ed il problema del segreto di Stato il Parlamento ormai non può ulteriormente ignorare che gli obiettivi di trasparenza e controllo democratico che stavano alla base della legge 24 ottobre 1977, n. 801, non sono stati pienamente raggiunti: i servizi segreti hanno continuato a colpire ed inquinare la vita democratica del Paese, il controllo su di essi non è stato pienamente assicurato, la trasparenza è venuta a mancare troppe volte. A ciò è da aggiungere che è venuta a mancare una reale guida unitaria dei vari servizi, siano essi civili che militari, o addirittura di forza armata, con la conseguenza di veri e propri contrasti, se non guerre, tra le varie strutture che teoricamente dovrebbero contribuire a proteggere il Paese ed i cittadini da interferenze esterne. Il nostro disegno di legge vuole intervenire su tali problematiche. L'articolo 1 attribuisce al Presidente del Consiglio dei ministri i compiti di direzione, responsabilità politica e coordinamento della politica informativa, previo accordo ed approvazione del Consiglio dei ministri. L'articolo 2 istituisce un Servizio informazioni unificato (SIU), con compiti esclusivamente informativi. Conseguentemente l'articolo 11 stabilisce non solo lo scioglimento di tutti i vari servizi, militari e civili, ma impone che il loro personale non possa essere assunto nella nuova struttura informativa. L'articolo 3 stabilisce il divieto per il SIU di compiere attività che non siano puramente informative, entrando nello specifico di compiti che negli anni passati sono stati al centro degli episodi più oscuri della storia della Repubblica, oltre a vietare l'attuazione di direttive provenienti da altri servizi stranieri. L'articolo 4 interviene sul profilo del personale da impiegare nel SIU, che potrà essere assunto solo mediante l'esame di un'apposita commissione e sulla base di linee guida indicate da un apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Il personale del SIU potrà permanere nell'incarico per un massimo di quattro anni, dovrà avere un altissimo profilo morale e, se proveniente dalle Forze armate, non potrà ritornare nei relativi ranghi dopo aver terminato il periodo di servizio nella struttura di intelligence. Il controllo sulle attività del SIU viene svolto, come indica l'articolo 5, da un'apposita Commissione parlamentare bicamerale, che deterrà permanentemente i poteri inquirenti. La seconda parte del disegno di legge interviene sulle norme che regolamentano l'opposizione del segreto di Stato, stabilendo, all'articolo 6, il divieto di opporre il segreto su fatti e documenti riguardanti i reati di terrorismo, mafia, banda armata, oltre che per quelli inerenti ad inquinamento ambientale o contro la pubblica amministrazione. Il segreto di Stato può essere opposto per un periodo massimo di quindici anni, dopo il quale la documentazione diviene pubblica e consultabile presso un apposito archivio. L'articolo 7 stabilisce rigidi criteri per le modalità di opposizione del segreto di Stato, sulla classificazione della documentazione, sul divieto di classificare a posteriori documenti in origine non segreti, oltre che sul rilascio del nulla osta di segretezza. L'articolo 8 demanda l'attività di controllo sull'opposizione del segreto di Stato alla Commissione parlamentare incaricata del controllo sul SIU, mentre l'articolo 9 stabilisce il dovere di astenersi dal testimoniare su atti e documenti coperti da segreto di Stato da parte di dipendenti pubblici. L'articolo 10 fissa il tetto di finanziamento per il SIU, riducendolo drasticamente rispetto al budget attuale. DISEGNO DI LEGGE Capo I Istituzione e ordinamento del Servizio Informazioni Unificato (SIU) Art. 1 (Dipendenza) 1. Al Presidente del Consiglio dei ministri sono attribuiti la direzione, la responsabilità politica generale ed il coordinamento della politica informativa e per la difesa dello Stato democratico e delle istituzioni. 2. Il Presidente del Consiglio dei ministri impartisce, previo esame ed approvazione da parte del Consiglio dei ministri, le direttive e le disposizioni necessarie per la organizzazione ed il funzionamento delle attività attinenti ai fini di cui al comma 1.
------------------------------ © Servizio per le informazioni e la Sicurezza Democratica ------------------------------

Art. 2 (Istituzione e compiti del Servizio informazioni unificato) 1. E' istituito, alla diretta dipendenza del Presidente del Consiglio dei ministri, il Servizio informazioni unificato (SIU). Esso assolve a compiti esclusivamente informativi a sostegno della difesa del Paese, contro ogni forma di eversione ed informandosi allo spirito democratico della Repubblica, con particolare attenzione alle attività rivolte alla prevenzione ed all'interpretazione dei fenomeni terroristici, alla protezione delle comunicazioni, alla decrittazione e decifrazione delle comunicazioni esterne, all'impedimento di interferenze da parte di potenze straniere nel Paese. 2. Il SIU comunica al Presidente del Consiglio dei ministri tutte le informazioni ricevute e comunque in suo possesso, oltre a quanto attiene alla sua attività ai sensi del comma 1. 3. L'ordinamento del SIU si informa a quello dell'amministrazione civile dello Stato, senza alcuna corrispondenza con organizzazioni e gerarchie militari, ed è stabilito con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. 4. Il direttore del SIU è nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri, su parere conforme del Consiglio dei ministri, previo parere della Commissione parlamentare di controllo di cui all'articolo 5. Art. 3 (Divieti) 1. Il SIU, nell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 1, non può condurre attività che violino i principi costituzionali ed i diritti fondamentali dei cittadini, sanciti dalla Costituzione. 2. Il SIU non può condurre attività clandestine, svolgere compiti che comportino l'uso delle armi e svolgere attività che siano favorevoli o contrarie a partiti politici. 3. Il SIU non può condurre azioni che siano in contrasto con le leggi dello Stato, in particolare per ciò che riguarda l'esportazione ed il transito di armamenti. 4. Il SIU non può attuare direttive che provengano da servizi segreti stranieri o da organismi che non siano nazionali né mantenere rapporti diretti con la magistratura e le Forze armate. 5. E' fatto divieto di attribuire al SIU le funzioni della guerra psicologica, dell'azione psicologica e delle forme non convenzionali di guerra, che dovranno comunque essere svolte e pianificate dagli organismi competenti secondo i principi dell'ordinamento giuridico interno ed internazionale. Art. 4 (Personale) 1. Gli appartenenti al SIU non rivestono la qualità di ufficiali o di agenti di polizia giudiziaria; tale qualità è sospesa durante il periodo di appartenenza al SIU per coloro che la rivestono in base agli ordinamenti dell'amministrazione di provenienza. 2. L'arruolamento del personale nel SIU avviene mediante esame di un'apposita commissione nominata dal Presidente del Consiglio dei ministri. La valutazione dei candidati è condotta in base a disposizioni emanate con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. 3. La durata massima della permanenza negli incarichi di cui al presente articolo è di quattro anni. Per il personale che abbia dimostrato eccezionali capacità e per il quale si richieda un prolungamento di permanenza è necessario che la conferma sia espressamente autorizzata dal Presidente del Consiglio dei ministri. 4. Il personale del SIU firma, al momento dell'entrata in servizio, una dichiarazione di impegno in cui assicura di non aver prestato altri giuramenti di fedeltà al di fuori di quello verso lo Stato e di non far parte di organizzazioni segrete. La falsa dichiarazione è punita con la reclusione fino a dieci anni. 5. Il personale del SIU ha l'obbligo di dichiarare, al momento dell'entrata in servizio, l'eventuale appartenenza, anche passata, a partiti politici, associazioni, comitati e società aventi qualsivoglia finalità. Il Presidente del Consiglio dei ministri decide, su parere della commissione di cui al comma 2, in merito all'incompatibilità con l'appartenenza al SIU. 6. Non possono appartenere in modo organico o saltuario al SIU persone che, per comportamenti od azioni eversive nei confronti delle istituzioni democratiche, non diano garanzie di affidabilità e di scrupolosa fedeltà ai valori della Costituzione repubblicana. 7. Al personale del SIU è fatto divieto di assumere incarichi dirigenziali o di consulenza presso imprese interessate alla produzione o al commercio di armi per un periodo di cinque anni dopo la cessazione dal
------------------------------ © Servizio per le informazioni e la Sicurezza Democratica ------------------------------

servizio. 8. Il personale proveniente dalle Forze armate, quando sia cessato il periodo di servizio nel SIU, può transitare esclusivamente verso amministrazioni civili. 9. Ai dipendenti del SIU è assegnato un trattamento economico pari a quello degli appartenenti alle Forze armate, comprensivo dell'indennità operativa. E' vietata la corresponsione di qualsiasi altra forma di indennizzo o indennità. Art. 5 (Commissione parlamentare di controllo) 1. È istituita una Commissione parlamentare di controllo sulle attività del SIU, di seguito denominata "Commissione", composta da dieci deputati e da dieci senatori, nominati in modo che la sua composizione rispecchi la proporzione dei Gruppi parlamentari. 2. La Commissione esercita il controllo sull'applicazione dei principi stabiliti dalla presente legge e presenta al Parlamento una relazione semestrale sull'attività svolta. 3. La Commissione ha i medesimi poteri e le medesime limitazioni previste per le Commissioni parlamentari d'inchiesta limitatamente alle attività ed ai fatti connessi al SIU. 4. Il Presidente del Consiglio dei ministri trasmette ogni documento ed informazione richiesti dalla Commissione in merito alle attività ed alle operazioni del SIU. 5. Nel caso in cui i documenti e le informazioni trasmessi ai sensi del comma 4 siano tutelati dal segreto di Stato o professionale, i componenti della Commissione sono vincolati al segreto stesso. 6. La Commissione, ove ritenga, a maggioranza assoluta dei suoi membri, che l'opposizione del segreto, ai sensi del comma 5, non sia fondata, ne riferisce al Parlamento per le conseguenti valutazioni. 7. Gli atti ed i lavori della Commissione sono pubblici, con l'eccezione dei casi in cui debba essere garantito il segreto di Stato. Capo II Segreto di Stato Art. 6 (Limitazione del segreto di Stato) 1. Sono coperti dal segreto di Stato gli atti, i documenti, le notizie, le attività ed ogni altra circostanza la cui diffusione sia idonea a recar danno alla integrità dello Stato democratico, alla difesa delle istituzioni poste dalla Costituzione a suo fondamento, al libero esercizio delle funzioni degli organi costituzionali, alla indipendenza dello Stato italiano rispetto agli altri Stati e alle relazioni con essi, nonché alla preparazione e alla difesa da aggressioni militari. 2. In nessun caso possono essere coperte da segreto di Stato notizie relative a fatti eversivi dell'ordine costituzionale, alle associazioni di cui all'articolo 416-bis del codice penale e all'articolo 1 della legge 25 gennaio 1982, n. 17, nonché al traffico illegale di armi, munizioni e materie esplodenti, a fatti che riguardino reati di terrorismo, mafia, costituzione di banda armata, costituzione di apparati ed associazioni clandestine, reati contro la pubblica amministrazione o contro enti pubblici economici o reati commessi al fine di occultare le attività criminose suddette, gravi inquinamenti ambientali, accordi internazionali. 3. L'opposizione del segreto di Stato per gli atti ed attività di cui al comma 1 non può in nessun caso avere una durata superiore a quindici anni. Dopo detto periodo i documenti possono essere portati a conoscenza del pubblico e sono conservati per la consultazione presso un apposito archivio del SIU. 4. Presso l'archivio di cui al comma 3 sono depositati tutti i documenti coperti da segreto di Stato da oltre quindici anni e su cui sussista il divieto di presa di conoscenza, tenuti, sino alla data di entrata in vigore della presente legge, presso altri archivi ed uffici storici. 5. E' fatto obbligo al SIU di protocollare tutta la sua documentazione e di metterla a disposizione del Presidente del Consiglio dei ministri e della Commissione. 6. E' vietata la distruzione di ogni documento del SIU o comunque sottoposto a segreto di Stato in mancanza di autorizzazione scritta rilasciata dal Presidente del Consiglio dei ministri, sentita la Commissione.
------------------------------ © Servizio per le informazioni e la Sicurezza Democratica ------------------------------

Art. 7 (Modalità di opposizione del segreto di Stato) 1. Il Presidente del Consiglio dei ministri ha la responsabilità dell'opposizione del segreto di Stato, ai sensi dell'articolo 6, previa consultazione del Consiglio dei ministri, sulle richieste scritte che gli pervengono in merito. 2. Il Presidente del Consiglio dei ministri dà comunicazione scritta al Presidente della Repubblica, ai Presidenti delle Camere ed ai componenti della Commissione delle motivazioni che giustifichino la richiesta dell'opposizione del segreto di Stato. 3. Il Presidente del Consiglio dei ministri stabilisce, con apposito decreto da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e previo parere della Commissione, i criteri relativi alle materie oggetto del segreto di Stato, con riguardo agli aspetti politici, militari, economico-industriali ed amministrativi. 4. Le categorie di classificazione, già esistenti, dei documenti "segretissimo" e "segreto" sono unificate nella categoria "segreto"; le categorie "riservatissimo" e "riservato" non hanno alcuna rilevanza ai fini penali; la categoria "vietata divulgazione" ha rilevanza esclusivamente amministrativa. 5. Gli enti da cui provengono i documenti classificati ai sensi del comma 4 devono conservare su apposito registro la documentazione attestante e motivante la classificazione stessa. Entro il mese di gennaio di ogni anno il responsabile dell'ente da cui provengono i documenti classificati valuta la possibilità di abbassare la classifica dei documenti o di declassificarli. 6. Nessun documento originariamente non classificato può venire sottoposto successivamente alla sua emissione a procedura di classificazione ai sensi del comma 4. 7. Con il decreto di cui al comma 3 sono altresì stabiliti i criteri per la concessione del nulla osta di segretezza (NOS). Il diniego del nulla osta di segretezza deve essere motivato per iscritto. L'interessato può ricorrere avverso la suddetta decisione presso il giudice ordinario entro novanta giorni dalla comunicazione del diniego. 8. L'illegale, irregolare o non autorizzata opposizione del segreto di Stato è punita con la reclusione sino a cinque anni e con l'interdizione perpetua dai pubblici uffici. Art. 8 (Attività di controllo) 1. La Commissione esercita, oltre alle competenze indicate all'articolo 5, le attività di controllo sull'opposizione del segreto di Stato ai sensi dell'articolo 7. 2. Le attività di cui al comma 1 sono finalizzate: a) alla verifica sulla gestione del segreto di Stato da parte degli organismi a tale compito preposti; b) alla vigilanza sui requisiti di liceità, attualità ed effettività del segreto di Stato; c) alla richiesta di informazioni al Governo ed alla verifica sull'adeguatezza delle risposte ad atti di sindacato ispettivo parlamentare relativi alla materia del segreto di Stato ed al SIU; d) alla valutazione delle metodologie utilizzate per la concessione del NOS di cui al comma 7 dell'articolo 7. Art. 9 (Dovere di astenersi dal testimoniare e divieto di esame determinati dal segreto di Stato) 1. I pubblici ufficiali, i pubblici impiegati e gli incaricati di pubblico servizio hanno l'obbligo di astenersi dal deporre e non possono essere interrogati su quanto coperto da segreto di Stato. 2. Qualora l'autorità giurisdizionale non ritenga fondata la dichiarazione fatta dai soggetti di cui al comma 1, in ordine alla segretezza, interpella il Presidente del Consiglio dei ministri che, ove ritenga di confermarla, deve provvedervi entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta. In tal caso non si procede per il delitto di cui all'articolo 372 del codice penale e, qualora la conoscenza di quanto coperto dal segreto di Stato sia ritenuta essenziale al procedimento, l'autorità giurisdizionale dichiara di non doversi procedere nell'azione penale per l'esistenza di un segreto di Stato. Art. 10 (Norme finanziarie) 1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede mediante istituzione, a decorrere
------------------------------ © Servizio per le informazioni e la Sicurezza Democratica ------------------------------

dall'esercizio finanziario 1995, di un apposito capitolo nello stato di previsione del Ministero del tesoro destinato a finanziare le attività del SIU. 2. La dotazione del capitolo di cui al comma 1 è stabilita, per il triennio 1995-1997, in 300 miliardi di lire annui. Art. 11 (Norme transitorie) 1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge cessano di operare il Servizio per le informazioni e la sicurezza militare (SISMi) e il Servizio per le informazioni e la sicurezza democratica (SISDe). 2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge è sciolto il Comitato esecutivo per i servizi di informazione e di sicurezza (CESIS). 3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge cessano di operare i reparti e gli uffici addetti alla informazione, sicurezza e situazione esistenti presso ciascuna Forza armata o Corpo armato. 4. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Comitato parlamentare di cui all'articolo 11 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, è sostituito dalla Commissione parlamentare di controllo di cui all'articolo 5 della presente legge. 5. Tutti i mezzi, la documentazione e le strutture tecniche degli organismi di cui ai commi 1, 2 e 3 confluiscono nel SIU. 6. Il personale degli organismi di cui ai commi 1, 2 e 3 non può in nessun caso entrare a far parte del SIU ed è assorbito dagli uffici dell'amministrazione civile. 7. La commissione di cui al comma 2 dell'articolo 4 determina i criteri per la valutazione degli anni di impiego del personale di cui al comma 6 del presente articolo, presso gli organismi di cui ai commi 1, 2 e 3 ai fini della carriera. Art. 12 (Abrogazione di norme) 1. La legge 24 ottobre 1977, n. 801, è abrogata. 2. Alla data di entrata in vigore della presente legge sono declassificati gli accordi internazionali riguardanti la concessione della base navale di Sigonella e la base navale de La Maddalena e l'accordo sull'installazione di missili a testata nucleare Jupiter. 3. A decorrere dalla medesima data di cui al comma 2 è declassificata la pubblicazione PCM ANS 1/R. (*) Sintesi redazionale.
------------------------------ © Servizio per le informazioni e la Sicurezza Democratica ------------------------------

Senato della Repubblica XII LEGISLATURA Disegno di legge n. 812 "Nuovo ordinamento dei servizi di informazione per la sicurezza e disciplina del segreto di Stato", d'iniziativa del senatore Ramponi
(*) La proposta di legge presentata dal Sen. Ramponi muove dalla necessità di una più incisiva attività di controllo da parte del Parlamento, e di una chiara definizione dei rapporti tra personale e attività dei servizi segreti e la magistratura, di una più chiara e precisa indicazione delle responsabilità di gestione economica e di spese, di una migliore definizione di competenza dei due Servizi, di una organizzazione che ne assicuri il controllo ed il coordinamento e infine di una maggiore chiarezza, sicurezza e tutela dell'operato degli appartenenti agli enti informativi. Inoltre, la proposta in esame: a) lascia invariata l'attribuzione al Presidente del Consiglio dei Ministri dell'alta direzione, della responsabilità politica generale e della titolarità della tutela e dell'apposizione del segreto di Stato; b) individua nel Consiglio dei Ministri la struttura di Governo che costituisce organo di consulenza e proposta per il Presidente del Consiglio dei Ministri, per gli indirizzi generali e per gli obiettivi fondamentali della politica informativa per la sicurezza e la sede di informazione per tutti i Ministri sull'evoluzione della situazione generale; c) rispetto alla legge precedente sposta nell'ambito del Consiglio dei Ministri quanto prima era attribuito ad un organo particolare, il CIIS (Comitato interministeriale per le informazioni e per la sicurezza), del quale facevano parte solo alcuni Ministri. Viene pertanto istituito nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri un Dipartimento dell'informazione per la sicurezza, con la finalità di realizzare l'unitarietà della struttura; attribuisce la guida ed il coordinamento ed il controllo ad una autorità politica (Sottosegretario alle informazioni per la sicurezza ); d) basa la sua articolazione operativa su due organismi di intelligence competenti ed operanti per l'attività di informazione nei confronti delle minacce, uno all'interno ed uno all'esterno del territorio nazionale (soluzione verticale).
DISEGNO DI LEGGE d'iniziativa del senatore RAMPONI Nuovo ordinamento dei servizi di informazione per la sicurezza e disciplina del segreto di Stato Comunicato alla Presidenza l'8 settembre 1994 Onorevoli Senatori - Le competenze, l'organizzazione e le modalità operative dell'attività informativa per la sicurezza in Italia sono regolate dalla legge 24 ottobre 1977, n. 801. Il mutato quadro di situazione interno ed internazionale, obiettivamente impone una nuova scrittura della legge che, emanata nel 1977, vede oggi completamente cambiato il contesto che ne aveva ispirato i fondamentali concetti di base, dai quali derivano logicamente lo spirito e la struttura normativa. Il quadro degli equilibri internazionali è oggi sostanzialmente diverso, ed è completamente diversa anche la situazione interna dello Stato. Mentre alcune minacce si sono attenuate o hanno mutato la loro possibilità di esplicazione, altre completamente nuove appaiono all'orizzonte o sono già pesantemente attive. Quella portata dalla criminalità organizzata nazionale e internazionale nel traffico e vendita di stupefacenti, di armi di materiale fissile e di quant'altro possa portare grave danno alla pace ed alla stabilità internazionale, o al sicuro progresso delle Società. Quella della proliferazione di materiali, mezzi e conoscenze in campo nucleare chimico, batteriologico ed in quello vettoriale per il lancio degli ordigni, che può mettere nelle mani di organizzazioni o di Governi a rischio mezzi tremendi di distruzione o anche di semplice ricatto.
------------------------------ © Servizio per le informazioni e la Sicurezza Democratica ------------------------------

Quelle nel settore economico e finanziario che, grazie al reimpiego delle enormi disponibilità finanziarie da parte della malavita organizzata, possono finire per inquinare e controllare il sistema ponendolo in mani irresponsabili e criminali. Quelle nel settore dell'informazione multimediale, della sicurezza ecologica e altre. Nel contempo sono rimaste immanenti minacce già esistenti, come quella del terrorismo ma con connotazioni completamente diverse, anche per il progressivo aumento della cosmopoliticità della società italiana, quella dello spionaggio, anche lei mutata e orientata al campo tecnologico d'avanguardia di tutti i settori, più che concentrata su quello militare, che ha assunto altro tipo di possibile eventualità. Inoltre nel periodo di giurisdizione della legge in vigore è emersa la necessità di una migliore e più incisiva attività di controllo da parte del Parlamento, e di una chiara definizione dei rapporti tra personale e attività dei Servizi segreti e la Magistratura, di una più chiara e precisa indicazione delle responsabilità di gestione economica e di spesa, di una migliore definizione di competenza dei due Servizi, di una organizzazione che ne assicuri il controllo ed il coordinamento e infine di una maggiore chiarezza, sicurezza e tutela dell'operato degli appartenenti agli enti informativi. Queste sono in stretta sintesi le ragioni che inducono alla messa a punto di un disegno di legge sui Servizi di informazione, naturalmente aperto ad eventuali integrazioni o correzioni migliorative. Esso: a) attribuisce al Presidente del Consiglio dei ministri l'alta direzione, la responsabilità politica generale e la titolarità della tutela e dell'apposizione del segreto di Stato. Non innova rispetto a quanto stabilito in precedenza; b) individua nel Consiglio dei ministri la struttura di Governo che costituisce organo di consulenza e proposta per il Presidente del Consiglio dei ministri, per gli indirizzi generali e per gli obiettivi fondamentali della politica informativa per la sicurezza e la sede di informazione per tutti i Ministri sull'evoluzione della situazione generale; c) rispetto alla legge precedente sposta nell'ambito del Consiglio dei Ministri quanto prima era attribuito ad un organo particolare, il CIIS (Comitato interministeriale per le informazioni e la sicurezza), del quale facevano parte solo alcuni Ministri. L'innovazione deriva dalla considerazione che il nuovo quadro di situazione nazionale e internazionale presenta una globalità in termini di potenziali minacce, tali da poter interessare nel loro sviluppo tutto lo scibile dei diversi settori di attività dello Stato, con connessioni ed interazioni continue. Pare quindi corretto individuare nel Consiglio dei ministri, la sede d'origine del processo di impostazione delle linee fondamentali della politica di informazione e di arrivo dei principali elementi di sintesi dell'attività di ricerca. Ritengo inoltre opportuno richiamare l'attenzione sul fatto che nella legge precedente si è sempre parlato di informazione e sicurezza, unendo in un tutt'uno le due entità quasi che la competenza di entrambe risalisse ai Servizi segreti. In questo modo si è commesso un errore concettuale che ha finito per dar luogo nella cultura e nella conoscenza dell'opinione pubblica generale, alla errata convinzione che la responsabilità e l'attività di ricerca informativa e la responsabilità e attività di mantenimento della sicurezza si identificassero. Esiste indubbiamente, ed è assolutamente necessaria, una strettissima interrelazione tra le due attività, operando la prima per fornire tutti gli elementi necessari e indispensabili all'azione della seconda, ma azioni, procedimenti e responsabilità e strutture interessate sono distinti e diversi e trovano il loro luogo dei punti unitario in termini di responsabilità indirizzo, guida e controllo nel Presidente del Consiglio dei ministri. Ecco perché nel disegno di legge all'articolo 1 al Presidente del consiglio dei ministri si attribuisce l'alta direzione e la responsabilità politica dell'informazione e della sicurezza, mentre a partire dall'articolo 2 nel trattare di responsabilità, competenze, ordinamento e procedimenti riferiti all'attività di intelligence, si parla sempre di informazione per la sicurezza e non di informazione e sicurezza, a differenza di quanto detto nella legge in vigore. Istituisce un Dipartimento dell'informazione per la sicurezza nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri, realizzando l'unitarietà della struttura, ne affida la guida, il coordinamento e il controllo ad una autorità politica (Sottosegretario all'informazione per la sicurezza) che assolve alla sua funzione con l'ausilio di un Comitato Esecutivo per l'attività di guida, coordinamento e controllo e di una Unità Centrale per la conoscenza in tempo reale dell'evolversi della situazione informativa.
------------------------------ © Servizio per le informazioni e la Sicurezza Democratica ------------------------------

Basa la sua articolazione operativa su due servizi organismi di intelligence competenti e operanti per l'attività di informazione nei confronti delle minacce, uno all'interno ed uno all'esterno del territorio nazionale. Per la ripartizione delle competenze tra i due Servizi: tra una soluzione di ripartizione verticale (assegnazione a ciascuno di diversi tipi di minaccia: terroristica, criminale, militare, ambientale, economica eccetera) o una soluzione di ripartizione areale (interna, esterna), si è preferita la seconda, in questo modo allineandosi alla soluzione adottata da quasi tutti gli Stati omologhi per livello ed organizzazione politico sociale. La interrelazione sia sul piano verticale sia su quello orizzontale tra le diverse minacce e le aree di loro sviluppo è comunque stata presa in seria considerazione ed al Comitato Esecutivo è stato affidato il compito del coordinamento delle iniziative e delle competenze contingenti in funzione della situazione e del suo evolversi. Inoltre, la ripartizione per area presenta il vantaggio di una maggiore elasticità, consentendo di affidare, senza problemi normativi, a ciascun servizio, per l'area di competenza, qualsiasi nuova minaccia dovesse emergere in futuro. A questo proposito il disegno di legge: a) innova, rispetto alla legge in atto istituendo presso la Corte di cassazione un gruppo di tre magistrati competenti a concedere le autorizzazioni su richiesta del Sottosegretario all'informazione all'attuazione - in sede di attività di ricerca informativa - di intercettazioni, apertura di corrispondenza, sequestro temporaneo di documentazione, perquisizioni, eccetera nei confronti di cittadini italiani. E' questa una novità, ritenuta quanto mai opportuna che, per talune procedure particolari, necessarie per lo svolgimento di azioni incisive e penetranti, assicura garanzia ai cittadini e corretta copertura agli operatori dell'intelligence; b) istituisce un Comitato di controllo per i Servizi (peraltro già esistente). Rispetto alla precedente configurazione innova stabilendo per legge che la presidenza del Comitato compete alla componente politica all'opposizione e include tra le funzioni del Comitato anche il parere sui bilanci preventivi e consultivi di spesa, e sui regolamenti attuativi dell'ordinamento della struttura e della tutela del segreto. Le due novità paiono molto opportune e significative. Una consente un controllo puntuale del Parlamento nei confronti degli elementi di base: organizzativi, operativi e finanziari dell'attività di intelligence, l'altra, affidando all'opposizione la presidenza della Commissione di controllo, consente, nel modo a mio parere più corretto in termini democratici, il controllo preciso e responsabile nei confronti dell'attività della maggioranza di Governo, da parte dell'opposizione. Inoltre il disegno di legge: a) definisce con chiarezza i procedimenti d'azione degli agenti, le modalità di autorizzazione e copertura e le responsabilità; b) assicura il coordinamento e il controllo della attività di intelligence svolta per scopi particolari di settore da qualsiasi altro ente dell'Amministrazione statale; c) stabilisce con chiarezza: competenza e responsabilità per la definizione dei bilanci preventivi e consuntivi, per le autorizzazioni di spesa, la gestione e la conservazione della documentazione. Come detto nel corso della presentazione il disegno di legge si propone di mettere a punto una legislazione di base per l'attività dei Servizi Segreti italiani, adeguata alla nuova realtà e capace di mantenere buona validità nei confronti degli sviluppi di situazione del prevedibile futuro. Si propone inoltre di recepire sul piano normativo tutti i miglioramenti e gli adeguamenti suggeriti dall'esperienza degli ultimi anni. Rimane aperta ogni possibilità di integrazione che porti ad un complessivo miglioramento della propria funzione. DISEGNO DI LEGGE Art. 1 (Attribuzione del Presidente del Consiglio dei ministri) 1. Al Presidente del Consiglio dei ministri sono attribuiti l'alta direzione, la responsabilità politica generale e il coordinamento della politica informativa e di sicurezza nell'interesse e per la difesa dello Stato democratico e delle istituzioni poste dalla Costituzione a suo fondamento.
------------------------------ © Servizio per le informazioni e la Sicurezza Democratica ------------------------------

2. Il Presidente del Consiglio dei ministri impartisce le direttive ed emana ogni disposizione necessaria per l'organizzazione e il funzionamento delle attività attinenti ai fini di cui al comma 1; stabilisce i criteri relativi all'apposizione del segreto di Stato, ne controlla l'applicazione e individua gli organi a ciò competenti; esercita la tutela del segreto di Stato. Art. 2 (Attribuzione del Consiglio dei ministri) 1. Il Consiglio dei ministri: a) costituisce organo di consulenza e proposta per il Presidente del Consiglio dei ministri, sugli indirizzi generali e sugli obiettivi fondamentali da perseguire nel quadro della politica informativa per la sicurezza. Deve essere costantemente informato dell'evoluzione della situazione generale; b) esprime il proprio parere sulla nomina del Sottosegretario all'informazione per la sicurezza, dei direttori generali dei due servizi e dell'Unità Centrale; c) esamina e formula proposte sui bilanci preventivi e consuntivi del Dipartimento di cui all'articolo 3. Art. 3 (Dipartimento dell'informazione per la sicurezza) 1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un Dipartimento dell'informazione per la sicurezza dello Stato, retto da un Sottosegretario, con il compito di assicurare l'organizzazione, il funzionamento ed il coordinamento dell'attività d'informazione per la sicurezza dello Stato. 2. Il Dipartimento è costituito da: a) un Comitato Esecutivo di guida e coordinamento; b) una Unità Centrale; c) un Servizio informativo per l'interno; d) un Servizio informativo per l'estero. 3. L'ordinamento del Dipartimento e le eventuali successive variazioni sono definiti con regolamento del Governo, emanato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Comitato parlamentare di controllo di cui all'articolo 13. Art. 4 (Compiti e attribuzioni del Sottosegretario all'informazione) 1. Il Sottosegretario all'informazione per la sicurezza dello Stato: a) è nominato e revocato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio dei ministri; b) guida e coordina l'attività del dipartimento secondo le direttive del Presidente del Consiglio dei ministri; c) presiede il Comitato Esecutivo; d) tiene costantemente informato il Presidente del Consiglio dei ministri sull'evolversi della situazione informativa; e) garantisce il flusso delle informazioni di specifico interesse ai responsabili dei Ministeri competenti; f) presenta al Presidente del Consiglio dei ministri il bilancio di previsione e il consuntivo di spesa; g) trasmette al Comitato parlamentare di controllo dei servizi i documenti di cui alla lettera f) una volta approvati. Art. 5 (Compiti, attribuzione e composizione del Comitato Esecutivo) 1. Il Comitato Esecutivo è la sede di definizione: a) del quadro di situazione generale e del suo controllo; b) delle linee di programma dell'attività operativa in funzione degli sviluppi della situazione generale; c) dei bilanci preventivi e consuntivi di spesa; d) delle direttive operative e di gestione del Dipartimento riferite al personale, alle risorse finanziarie, alle infrastrutture; e) del coordinamento con gli altri organi dello Stato; f) del coordinamento con i servizi di informazione e sicurezza degli altri Stati;
------------------------------ © Servizio per le informazioni e la Sicurezza Democratica ------------------------------

g) delle operazioni di rilievo condotte dai due Servizi di cui all'articolo 3. 2. Il Comitato Esecutivo è presieduto dal Sottosegretario all'informazione ed è composto dai direttori dei due Servizi e dal direttore dell'Unità Centrale con funzione di membro e segretario. Art. 6 (Compiti, attribuzioni dell'Unità Centrale) 1. L'Unità centrale (UC): a) è l'organo di supporto alla attività del Comitato Esecutivo di guida e controllo; b) mantiene aggiornato il quadro della situazione in funzione del flusso informativo prodotto dai servizi di informazione; c) assicura la diramazione ai Ministeri competenti delle informazioni di specifico interesse; d) costituisce ente di guida, coordinamento e controllo delle attività relative al personale, alla gestione logistica ed alla gestione amministrativa di carattere comune per tutto il Dipartimento; e) cura la messa a punto del progetto di bilancio preventivo e consuntivo di spesa del Dipartimento, e gestisce la parte di propria competenza; f) è l'organo centrale di sicurezza per la tutela del Segreto di Stato. 2. L'UC è retta da un direttore nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio dei ministri su proposta del Sottosegretario all'informazione per la sicurezza che assume anche l'incarico di Autorità nazionale per la sicurezza. Art. 7 (Compiti e attribuzione del servizio informativo per l'interno) 1. Il Servizio informativo per l'interno (SII) assolve all'interno del territorio nazionale a tutti i compiti informativi per la difesa della stabilità e dell'integrità dello Stato da ogni pericolo o minaccia. Quando ce ne sia la necessità, riconosciuta in sede di Comitato Esecutivo, il Servizio può svolgere di volta in volta attività all'esterno del territorio nazionale sempre in concorso con il Servizio informativo per l'estero. 2. Il direttore del Servizio è nominato e revocato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sentito il consiglio dei ministri su proposta del Sottosegretario all'informazione per la sicurezza. Gli altri funzionari del Servizio indicati nelle disposizioni sull'ordinamento, sono nominati dal Sottosegretario all'informazione per la sicurezza su proposta del Comitato Esecutivo. 3. Il direttore è responsabile del funzionamento e della gestione del Servizio secondo le direttive definite in sede di Comitato Esecutivo. Mantiene costantemente informato il Sottosegretario all'informazione per la sicurezza sugli avvenimenti di rilievo informativo ed assicura la trasmissione di tutte le informazioni in suo possesso, le analisi, le situazioni elaborate e lo sviluppo delle operazioni alla UC. Assicura il collegamento con il Servizio per l'estero in tutti i diversi settori di minaccia. Art. 8 (Compiti e attribuzioni del Servizio informativo per l'estero) 1. Il Servizio informativo per l'estero (SIE) assolve, fuori dai confini nazionali, a tutti i compiti informativi per la difesa della indipendenza e della integrità dello Stato da ogni pericolo, minaccia o aggressione. Quando ve ne sia la necessità, riconosciuta in sede di Comitato Esecutivo, il Servizio può svolgere di volta in volta anche attività all'interno del territorio nazionale, sempre in concorso con il SII. 2. Il direttore del Servizio è nominato e revocato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio dei ministri su proposta del Sottosegretario all'informazione per la sicurezza. Gli altri funzionari del Servizio, indicati nelle disposizioni sull'ordinamento, sono nominati dal Sottosegretario all'informazione per la sicurezza su proposta del Comitato Esecutivo. 3. Il direttore è responsabile del funzionamento e della gestione del Servizio secondo le direttive definite in sede di Comitato Esecutivo. Mantiene costantemente informato il Sottosegretario all'informazione per la sicurezza ed assicura la trasmissione di tutte le informazioni in suo possesso, le analisi, le situazioni elaborate e lo sviluppo delle operazioni alla UC. Assicura il collegamento con il SII in tutti i diversi settori di minaccia. Art. 9 (Assunzione, stato, compiti e attribuzioni del personale)
------------------------------ © Servizio per le informazioni e la Sicurezza Democratica ------------------------------

1. Il personale di ciascuno dei Servizi istituiti dagli articoli 7 e 8 e dell'Unità Centrale di cui all'articolo 6, è costituito da dipendenti civili e militari dello Stato che vengono trasferiti, con il loro consenso, alle esclusive dipendenze dei Servizi stessi, nonché da personale assunto direttamente. 2. Il SII e il SIE possono altresì avvalersi, anche in forma non continuativa, di collaboratori esterni. In nessun caso i Servizi possono avere alle loro dipendenze, in modo organico o saltuario, membri del Parlamento, consiglieri regionali, provinciali, comunali, magistrati, ministri di culto e giornalisti professionisti. 3. Non possono appartenere in modo organico e saltuario all'Unità Centrale e ai Servizi persone che, per comportamenti od azioni eversive nei confronti delle istituzioni democratiche, non diano sicuro affidamento di scrupolosa fedeltà ai valori della Costituzione. 4. La consistenza dell'organico dell'Unità Centrale e di ciascun Servizio, i casi e le modalità relativi all'assunzione del personale e rientro dei dipendenti pubblici nelle amministrazioni di originaria appartenenza, il trattamento giuridico-economico e i casi e le modalità di trasferimento ad altra amministrazione dello Stato del personale assunto direttamente, sono stabiliti, anche in deroga ad ogni disposizione vigente, dal Presidente del consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il Consiglio dei ministri, su proposta del Comitato Esecutivo. Il trattamento giuridico ed economico del personale dell'Unità Centrale e dei Servizi non può comunque essere inferiore a quello delle qualifiche corrispondenti del pubblico impiego. Art. 10 (Modalità operative e rapporti con l'autorità giudiziaria) 1. Gli appartenenti all'Unità Centrale e ai Servizi non rivestono la qualità di ufficiali o di agenti di polizia giudiziaria; tale qualità è sospesa durante il periodo di appartenenza all'Unità Centrale e ai Servizi per coloro che la rivestono in base agli ordinamenti dell'amministrazione di provenienza. 2. In caso di necessità per l'assolvimento dei loro compiti, ad agenti dei Servizi, su richiesta del Sottosegretario all'informazione e con il consenso del Presidente del Consiglio dei ministri, in via temporanea possono essere conferite la qualifica e le attribuzioni di agenti o ufficiali di pubblica sicurezza. 3. I direttori dei Servizi, previa autorizzazione del Sottosegretario all'informazione per la sicurezza e della Corte di cassazione possono disporre che i rispettivi agenti operino in modo occulto o coperto o anche sotto identità diverse da quelle reali. 4. Gli appartenenti ai Servizi di cui agli articoli 7 e 8 possono, nell'espletamento delle attività d'istituto, chiedere informazioni a qualunque persona e invitarla a produrre documenti o altre cose in suo possesso con il consenso dell'interessato. 5. Nei confronti di cittadini italiani, gli appartenenti ai Servizi Segreti possono procedere a: a) intercettazioni di conversazioni o comunicazioni telefoniche e di altre forme di telecomunicazione; b) sequestro temporaneo e apertura di corrispondenza; c) sequestro temporaneo di atti presso enti finanziari per acquisizione di documentazione o copia; d) perquisizioni personali, locali o domiciliari, anche in deroga alle disposizioni generali, per acquisire qualunque forma di documentazione utile ai fini della informazione per la sicurezza; dalla procura generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, su richiesta del Sottosegretario all'informazione per la sicurezza approvata dal Presidente del Consiglio dei ministri. 6. In relazione alle attività di cui al comma 5, nell'ambito della procura generale della Repubblica presso la Corte di cassazione è costituito un gruppo di tre magistrati per le autorizzazioni di cui ai commi 3 e 5. In caso di emergenza e di contingente assenza di collegamento con l'autorità giudiziaria il Sottosegretario all'informazione per la sicurezza può dare l'autorizzazione, dandone comunicazione entro ventiquattro ore alla stessa autorità. 7. I direttori dei Servizi hanno l'obbligo di fornire ai competenti organi di polizia giudiziaria le informazioni e gli elementi di prova relativi a fatti configurabili come reati. L'adempimento dell'obbligo di cui sopra può essere ritardato, su disposizione del Sottosegretario all'informazione per la sicurezza, con l'esplicito consenso del Presidente del Consiglio dei ministri, quando ciò sia strettamente necessario per il proseguimento delle finalità istituzionali dei Servizi. 8. In deroga alle ordinarie disposizioni, gli appartenenti ai Servizi hanno l'obbligo di fare rapporto, tramite i loro superiori, esclusivamente ai direttori dei Servizi, che ne riferiscono, contestualmente al Sottosegretario
------------------------------ © Servizio per le informazioni e la Sicurezza Democratica ------------------------------

all'informazione per la sicurezza. 9. Gli agenti dei Servizi possono essere chiamati a testimoniare davanti all'autorità giudiziaria, previa autorizzazione del Presidente del Consiglio dei ministri e non possono essere destinatari diretti di ordini o incarichi da parte di essa. 10. Tutti gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria debbono favorire ogni possibile cooperazione agli agenti dei servizi. 11. L'Unità Centrale, il SII e il SIE possono utilizzare, per determinazione del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Sottosegretario all'informazione per la sicurezza, i Ministri interessati, mezzi e infrastrutture di qualsiasi amministrazione dello Stato. 12. Il SIE e il SII, debbono prestarsi reciproca collaborazione e assistenza, regolata e coordinata in sede di Comitato Esecutivo. 13. Nessuna attività comunque idonea all'acquisizione d'informazioni per la sicurezza può essere svolta al di fuori degli strumenti, delle modalità, delle competenze e dei fini previsti dalla presente legge. 14. Chiunque sia informato delle operazioni indicate nel presente articolo è tenuto al segreto di Stato. Art. 11 (Norme finanziarie) 1. Le spese relative al Dipartimento all'informazione per la sicurezza sono iscritte in apposita rubrica, denominata: "Spese per l'informazione per la sicurezza" nello Stato di previsione del Ministero del tesoro. 2. Il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Sottosegretario per la sicurezza all'informazione, sentito il parere del Consiglio dei ministri, determina l'entità dell'assegnazione complessiva e la sua ripartizione tra fondi ordinari e fondi riservati e nell'ambito di ciascuno la ripartizione delle risorse tra le diverse categorie di spesa sulla base del bilancio preventivo predisposto dal Comitato Esecutivo. Richiede il parere del Comitato parlamentare di controllo. 3. L'ammontare dell'assegnazione, una volta definito, viene iscritto, nella previsione di spesa della Presidenza del Consiglio dei ministri, ripartito tra l'Unità Centrale ed i due Servizi. 4. Il Ministro del tesoro, sulla base dei provvedimenti anzidetti, provvede, con propri decreti, ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio. Le spese riservate sono iscritte in appositi capitoli e non sono soggette a rendicontazione. 5. Per la gestione dei fondi ordinari, il criterio informatore delle spese si ispira ai principi fissati dal regio-decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, e dal relativo regolamento approvato con regio-decreto del 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni. I limiti di somma dei funzionari del Dipartimento, per autorizzare impegni di spesa, sono quelli fissati per i dirigenti dello Stato, purché delegati a tali funzioni; per importi superiori è competente il Sottosegretario all'informazione per la sicurezza. 6. Per la gestione dei fondi riservati: a) per le spese effettuate in attuazione dei programmi di potenziamento o di mantenimento e funzionamento del Dipartimento già indicate nel bilancio preventivo di spesa, valgono i limiti fissati per la gestione dei fondi ordinari; b) per le spese riferite ad attività operativa, ogni spesa di importo eccedente la cifra di 50 milioni deve essere approvata dal Sottosegretario all'informazione per la sicurezza. 7. Tutta la documentazione deve comunque essere conservata ed allegata a ciascuna pratica di sviluppo e attuazione del programma o di sviluppo e compimento dell'atto operativo cui si riferisce. Art. 12 (Tutela del segreto di Stato) 1. Al Presidente del Consiglio dei ministri compete l'alta direzione e la responsabilità politica della tutela del segreto di Stato. 2. Egli presiede l'Organizzazione nazionale per la sicurezza, emana le direttive per la sua organizzazione e in particolare per la tutela del segreto, controlla l'applicazione delle direttive e dei regolamenti di cui al comma 5. 3. L'Organizzazione nazionale per la sicurezza comprende: a) l'Autorità nazionale per la sicurezza che è il direttore dell'Unità Centrale; b) l'Ufficio centrale per la sicurezza nell'ambito dell'Unità Centrale. 4. Gli Uffici per la sicurezza presso le amministrazioni pubbliche e, quando necessario, anche presso enti
------------------------------ © Servizio per le informazioni e la Sicurezza Democratica ------------------------------

privati, che esercitano attività interessate alla tutela del segreto. 5. L'ordinamento dell'Organizzazione nazionale per la sicurezza e la disciplina delle sue attività sono stabilite con uno o più regolamenti emanati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri. Art. 13 (Comitato parlamentare di controllo) 1. E' istituito un Comitato parlamentare per il controllo dei servizi di informazione per la sicurezza. 2. Il Comitato è costituito da un presidente che deve essere espresso dalla componente politica all'opposizione e da cinque deputati e da cinque senatori nominati dai Presidenti dei due rami del Parlamento sulla base del criterio di proporzionalità. 3. Il Comitato: a) esercita il controllo sulla applicazione della presente legge; b) è informato dal Presidente del Consiglio dei ministri sugli indirizzi delle politiche per l'informazione e sulla loro attuazione; c) esprime parere preventivo sull'emanazione del regolamento per l'ordinamento del Dipartimento di cui all'articolo 3; d) esprime parere preventivo sui bilanci, preventivi e consuntivi di spesa. 4. Il Comitato può richiedere informazioni e chiarimenti e formulare proposte. 5. Il Comitato può richiedere di ascoltare il Presidente del Consiglio dei ministri, il Sottosegretario all'informazione per la sicurezza e, su sua autorizzazione, i direttori dei Servizi. 6. Il Presidente del Consiglio dei ministri può opporre al Comitato parlamentare, indicandone le ragioni essenziali, l'esigenza di tutela del segreto in ordine alle informazioni che a suo giudizio eccedono i limiti di cui ai commi precedenti. 7. Nel caso di cui al comma 6, il Comitato parlamentare ritenga, a maggioranza di due terzi dei suoi componenti, che l'apposizione del segreto non sia fondata, ne riferisce a ciascuna delle Camere per le conseguenti valutazioni politiche. 8. I componenti del Comitato parlamentare sono vincolati al segreto relativamente alle informazioni acquisite, nonché alle proposte ed ai rilievi formulati qualora riguardino materie tutelate dal segreto di Stato. 9. Gli atti del Comitato, anche se riguardino materie normalmente non tutelate dal segreto di Stato, sono coperti dal segreto di Stato, salvo che il Comitato non disponga altrimenti a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, tra i quali deve essere compreso il presidente del Comitato stesso. Art. 14 (Coordinamento dell'attività informativa) 1. Al fine di consentire che il Dipartimento dell'informazione per la sicurezza assicuri il coordinamento dell'intera attività informativa dello Stato, ogni organo od istituzione dello Stato destinato a svolgere, per fini istituzionali di settore, attività informativa, deve: a) comunicare al Dipartimento compito e struttura e modalità operativa della propria organizzazione; b) mantenere costante collegamento con interlocutori del Dipartimento all'uopo designati. Art. 15 (Applicazione della legge e disposizioni transitorie) 1. Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge si procede alla nomina del Sottosegretario all'informazione per la sicurezza e alla nomina dei direttori dell'Unità Centrale e dei due Servizi. 2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo della Repubblica emana il regolamento per la sua attuazione con decreto del Presidente della Repubblica previa deliberazione del Consiglio dei ministri su proposta del Presidente del Consiglio sentito il Comitato parla-mentare di cui all'articolo 13. 3. Sono abrogati gli articoli da 1 a 11 e gli articoli 18 e 19 della legge 24 ottobre 1977, n. 801. 4. Sono abrogate tutte le disposizioni interne e regolamentari in contrasto o comunque non compatibili con la presente legge. Le nuove disposizioni dovranno essere tempestivamente emanate dagli organi competenti.
------------------------------ © Servizio per le informazioni e la Sicurezza Democratica ------------------------------

5. La transizione dall'ordinamento attuale a quello previsto dalla presente legge e dal regolamento di attuazione, avverrà progressivamente sotto la responsabilità, la guida ed il coordinamento del Sottosegretario all'informazione per la sicurezza. Tale trasformazione deve concludersi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. 6. Sino alla data di emanazione di una nuova legge organica relativa alla materia del segreto, le fattispecie previste e punite dal libro II, titolo I, capi primo e quinto del codice penale, concernenti il segreto politico interno e internazionale, debbono essere riferite alla definizione di segreto di cui all'articolo 1 della presente legge e all'articolo 12 della legge 24 ottobre 1977, n. 801. Art. 16 (Entrata in vigore) 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. (*) Sintesi redazionale.
------------------------------ © Servizio per le informazioni e la Sicurezza Democratica ------------------------------

DECRETO LEGISLATIVO 12 febbraio 1993, n. 39 Norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 2, comma 1, lettera mm), della legge 23 ottobre 1992, n. 421
20-02-1993 Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Serie Generale LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI DECRETO LEGISLATIVO 12 febbraio 1993, n. 39 (1) "Norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 2, comma 1, lettera mm), della legge 23 ottobre 1992, n. 421" (2) IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Visto l'art. 2, comma 1, lettera mm), della legge 23 ottobre 1992, n. 421; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 dicembre 1992; Acquisito il parere delle commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 gennaio 1993; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica; Emana il seguente decreto legislativo: Art. 1 1. Le disposizioni del presente decreto disciplinano la progettazione, lo sviluppo e la gestione dei sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni dello Stato, anche a ordinamento autonomo, e degli enti pubblici non economici nazionali, denominate amministrazioni ai fini del decreto medesimo. 2. L'utilizzazione dei sistemi informativi automatizzati di cui al comma 1 risponde alle seguenti finalità: a) miglioramento dei servizi; b) trasparenza dell'azione amministrativa; c) potenziamento dei supporti conoscitivi per le decisioni pubbliche; d) contenimento dei costi dell'azione amministrativa. 3. Lo sviluppo dei sistemi informativi automatizzati di cui al comma 1 risponde ai seguenti criteri: a) integrazione ed interconnessione dei sistemi medesimi; b) rispetto degli standard definiti anche in armonia con le normative comunitarie; c) collegamento con il sistema statistico nazionale. 4. Allo scopo di conseguire l'integrazione e l'interconnessione dei sistemi informativi di tutte le amministrazioni pubbliche, le regioni, gli enti locali, i concessionari di pubblici servizi sono destinatari di atti di indirizzo e di raccomandazioni, nei modi previsti dall'art. 7. Art. 2 1. Le amministrazioni provvedono di norma con proprio personale alla progettazione, allo sviluppo e alla
------------------------------ © Servizio per le informazioni e la Sicurezza Democratica ------------------------------

gestione dei propri sistemi informativi automatizzati. 2. Ove sussistano particolari necessità di natura tecnica, adeguatamente motivate, le amministrazioni possono conferire affidamenti a terzi, anche tramite concessione, qualora la relativa proposta sia accolta nel piano triennale di cui all'art. 9. 3. In ogni caso le amministrazioni sono responsabili dei progetti di informatizzazione e del controllo dei risultati, salvi i poteri dell'Autorità prevista all'art. 4, e conservano la titolarità dei programmi applicativi. Art. 3 1. Gli atti amministrativi adottati da tutte le pubbliche amministrazioni sono di norma predisposti tramite i sistemi informativi automatizzati. 2. Nell'ambito delle pubbliche amministrazioni l'immissione, la riproduzione su qualunque supporto e la trasmissione di dati, informazioni e documenti mediante sistemi informatici o telematici, nonché l'emanazione di atti amministrativi attraverso i medesimi sistemi, devono essere accompagnate dall'indicazione della fonte e del responsabile dell'immissione, riproduzione, trasmissione o emanazione. Se per la validità di tali operazioni e degli atti emessi sia prevista l'apposizione di firma autografa, la stessa è sostituita dall'indicazione a stampa, sul documento prodotto dal sistema automatizzato, del nominativo del soggetto responsabile. Art. 4 1. È istituita l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione, denominata ai fini del presente decreto Autorità, la quale opera presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri con autonomia tecnica e funzionale e con indipendenza di giudizio. 2. L'Autorità è organo collegiale costituito dal presidente e da quattro membri, scelti tra persone dotate di alta e riconosciuta competenza e professionalità e di indiscussa moralità e indipendenza. Il presidente è nominato con decreto del presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri. Entro quindici giorni dalla nomina del presidente, su proposta di quest'ultimo, il Presidente del Consiglio dei Ministri nomina con proprio decreto, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, gli altri quattro membri. L'autorevolezza e l'esperienza del presidente e di ciascuno dei quattro membri dell'Autorità sono comprovate dal relativo curriculum di cui è disposta la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, in allegato ai suddetti decreti. 3. Il presidente e i quattro membri durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta. Per l'intera durata dell'incarico essi non possono esercitare, a pena di decadenza, alcuna attività professionale e di consulenza, ricoprire uffici pubblici di qualsiasi natura, essere imprenditori o dirigenti d'azienda; nei due anni successivi alla cessazione dell'incarico non possono altresì operare nei settori produttivi dell'informatica. I dipendenti statali e i docenti universitari, per l'intera durata dell'incarico, sono collocati, rispettivamente, nella posizione di fuori ruolo e di aspettativa. 4. Al funzionamento degli uffici e dei servizi dell'Autorità, al fine della corretta esecuzione delle deliberazioni adottate dall'Autorità medesima, sovrintende un direttore generale, che ne risponde al presidente dell'Autorità ed è nominato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su designazione del presidente dell'Autorità. Il direttore generale dura in carica tre anni, può essere confermato, anche più di una volta, ed è soggetto alle disposizioni di cui al comma 3. 5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del tesoro, sono determinate le indennità da corrispondere al Presidente, ai quattro membri e al direttore generale. Art. 5 1. L'Autorità propone al Presidente del Consiglio dei Ministri l'adozione di regolamenti concernenti la sua organizzazione, il suo funzionamento, l'amministrazione del personale, l'ordinamento delle carriere, nonché la gestione delle spese nei limiti previsti dal presente decreto. 2. L'Autorità provvede all'autonoma gestione delle spese per il proprio funzionamento e per la realizzazione dei progetti innovativi da essa direttamente gestiti, nei limiti dei fondi da iscriversi in due distinti capitoli dello stato di previsione della spesa della Presidenza del Consiglio dei Ministri. I fondi sono iscritti mediante variazione compensativa disposta con decreto del Ministro del tesoro. Detti capitoli sono destinati, rispettivamente, alle spese di funzionamento e alla realizzazione dei citati progetti innovativi. La gestione finanziaria è sottoposta al controllo consuntivo della Corte dei conti.
------------------------------ © Servizio per le informazioni e la Sicurezza Democratica ------------------------------

Art. 6 1. Nella fase di prima attuazione del presente decreto, l'Autorità si avvale, per lo svolgimento dei propri compiti, di personale dipendente da amministrazioni o enti pubblici, da società od organismi a prevalente partecipazione pubblica, in posizione di comando, di distacco o, nel limite massimo del contingente previsto dalle tabelle A e B allegate alla legge 23 agosto 1988, n. 400 (3), di fuori ruolo, in conformità ai rispettivi ordinamenti, nonché di personale con contratti a tempo determinato, disciplinati dalle norme di diritto privato, fino a un limite massimo complessivo di centocinquanta unità. L'Autorità può avvalersi di consulenti o di società di consulenza. 2. Entro il 30 giugno 1994 il presidente dell'Autorità riferisce al Parlamento sullo stato di attuazione del presente decreto e formula proposte al Presidente del Consiglio dei Ministri in ordine all'istituzione di un apposito ruolo del personale dell'Autorità. Art. 7 1. Spetta all'Autorità: a) dettare norme tecniche e criteri in tema di pianificazione, progettazione, realizzazione, gestione, mantenimento dei sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni e delle loro interconnessioni, nonché della loro qualità e relativi aspetti organizzativi; dettare criteri tecnici riguardanti la sicurezza dei sistemi; b) coordinare, attraverso la redazione di un piano triennale annualmente riveduto, i progetti e i principali interventi di sviluppo e gestione dei sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni; c) promuovere, d'intesa e con la partecipazione anche finanziaria delle amministrazioni interessate, progetti intersettoriali e di infrastruttura informatica e telematica previsti dal piano triennale e sovrintendere alla realizzazione dei medesimi anche quando coinvolgano apparati amministrativi non statali, mediante procedimenti fondati su intese da raggiungere tramite conferenze di servizi, ai sensi della normativa vigente; d) verificare periodicamente, d'intesa con le amministrazioni interessate, i risultati conseguiti nelle singole amministrazioni, con particolare riguardo ai costi e benefici dei sistemi informativi automatizzati, anche mediante l'adozione di metriche di valutazione dell'efficacia, dell'efficienza e della qualità; e) definire indirizzi e direttive per la predisposizione dei piani di formazione del personale in materia di sistemi informativi automatizzati e di programmi per il reclutamento di specialisti, nonché orientare i progetti generali di formazione del personale della pubblica amministrazione verso l'utilizzo di tecnologie informatiche, d'intesa con la Scuola superiore della pubblica amministrazione; f) fornire consulenza al Presidente del Consiglio dei Ministri per la valutazione di progetti di legge in materia di sistemi informativi automatizzati; g) nelle materie di propria competenza e per gli aspetti tecnico-operativi, curare i rapporti con gli organi delle Comunità europee e partecipare a organismi comunitari e internazionali, in base a designazione del Presidente del Consiglio dei Ministri; h) proporre al Presidente del Consiglio dei Ministri l'adozione di raccomandazioni e di atti d'indirizzo alle regioni, agli enti locali e ai rispettivi enti strumentali o vigilati e ai concessionari di pubblici servizi; i) comporre e risolvere contrasti operativi tra le amministrazioni concernenti i sistemi informativi automatizzati; l) esercitare ogni altra funzione utile ad ottenere il più razionale impiego dei sistemi informativi, anche al fine di eliminare duplicazioni e sovrapposizioni di realizzazioni informatiche. 2. Anche nell'attuazione di quanto disposto dal comma 1, lettera h), l'Autorità può proporre al Presidente del Consiglio dei Ministri la stipulazione di protocolli di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di cui all'art. 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (4), con l'Unione delle province italiane (UPI), con l'Associazione nazionale dei comuni d'Italia (ANCI), con l'Unione nazionale comuni, comunità ed enti della montagna (UNCEM), con l'Unione delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (Unioncamere), nonché con enti e società concessionari di pubblici servizi in materia di pianificazione degli investimenti, di linee di normalizzazione e di criteri di progettazione di sistemi informativi. 3. Spettano inoltre all'Autorità le funzioni ad essa riferibili in base al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (5).
------------------------------ © Servizio per le informazioni e la Sicurezza Democratica ------------------------------

4. L'Autorità può corrispondere con tutte le amministrazioni e chiedere ad esse notizie e informazioni utili allo svolgimento dei propri compiti. Art. 8 1. L'Autorità esprime parere obbligatorio sugli schemi dei contratti concernenti l'acquisizione di beni e servizi relativi ai sistemi informativi automatizzati per quanto concerne la congruità tecnico-economica, qualora il valore lordo di detti contratti sia superiore al doppio dei limiti di somma previsti dagli articoli 5, 6, 8 e 9 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, come rivalutati da successive disposizioni. La richiesta di parere al Consiglio di Stato è obbligatoria oltre detti limiti ed è in tali casi formulata direttamente dall'Autorità. La richiesta di parere al Consiglio di Stato sospende i termini previsti per il parere rilasciato dall'Autorità. 2. Il parere dell'Autorità è reso entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della relativa richiesta. Si applicano le disposizioni dell'art. 16 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (6). Art. 9 1. L'Autorità fissa contenuti, termini e procedure per la predisposizione del piano triennale e delle successive revisioni annuali di cui all'art. 7, comma 1, lettera b). 2. Ai fini della predisposizione del piano triennale e delle successive revisioni annuali: a) l'autorità elabora le linee strategiche per il conseguimento degli obiettivi di cui all'art. 1, comma 2; b) le amministrazioni propongono una bozza di piano triennale relativamente alle aree di propria competenza, con la specificazione, per quanto attiene al primo anno del triennio, degli studi di fattibilità e dei progetti di sviluppo, mantenimento e gestione dei sistemi informativi automatizzati da avviare e dei relativi obiettivi, implicazioni organizzative, tempi e costi di realizzazione e modalità di affidamento; c) l'Autorità redige il piano triennale sulla base delle proposte delle amministrazioni, verificandone la coerenza con le linee strategiche di cui alla lettera a), integrandole con iniziative tese al soddisfacimento dei fondamentali bisogni informativi e determinando i contratti di grande rilievo. 3. Il piano triennale e i relativi aggiornamenti annuali predisposti dall'Autorità sono approvati dal Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro del bilancio e della programmazione economica, entro il 30 giugno di ogni anno; essi costituiscono documento preliminare per la predisposizione dei provvedimenti che compongono la manovra di finanza pubblica. 4. L'Autorità presenta al Presidente del Consiglio dei Ministri, entro il 30 aprile di ogni anno, una relazione che dia conto dell'attività svolta nell'anno precedente e dello stato dell'informatizzazione nelle amministrazioni, con particolare riferimento al livello di utilizzazione effettiva delle tecnologie e ai relativi costi e benefici. Il Presidente del Consiglio dei Ministri trasmette entro trenta giorni la relazione al Parlamento. Art. 10 1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ogni amministrazione, nell'ambito delle proprie dotazioni organiche, individua, sulla base di specifiche competenze ed esperienze professionali, un dirigente generale o equiparato, ovvero, se tale qualifica non sia prevista, un dirigente di qualifica immediatamente inferiore, quale responsabile per i sistemi informativi automatizzati. 2. Il dirigente responsabile di cui al comma 1 cura i rapporti dell'amministrazione di appartenenza con l'Autorità e assume la responsabilità per i risultati conseguiti nella medesima amministrazione con l'impiego delle tecnologie informatiche, verificati ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettera d). Ai fini della verifica dei risultati, i compiti del nucleo di valutazione di cui all'art. 20, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (7), sono attribuiti all'Autorità. 3. In relazione all'amministrazione di appartenenza, il dirigente responsabile per i sistemi informativi automatizzati, oltre a contribuire alla definizione della bozza del piano triennale, trasmette all'Autorità entro il mese di febbraio di ogni anno una relazione sullo stato dell'automazione a consuntivo dell'anno precedente, con l'indicazione delle tecnologie impiegate, delle spese sostenute, delle risorse umane utilizzate e dei benefici conseguiti. Art. 11 1. Le amministrazioni, d'intesa con l'Autorità, riservano una quota dei posti di dirigente della dotazione
------------------------------ © Servizio per le informazioni e la Sicurezza Democratica ------------------------------

complessiva della medesima qualifica per l'inquadramento del personale specificamente qualificato nello svolgimento di attività relative ai sistemi informativi automatizzati, purché in possesso dei requisiti richiesti per l'accesso a tale qualifica. 2. I dirigenti di cui al comma 1 coordinano i sistemi informativi impiegati nell'amministrazione in cui operano, sotto la direzione del dirigente generale di cui all'art. 10, comma 1, e si avvalgono del personale dipendente specificamente adibito allo sviluppo, gestione e manutenzione dei sistemi informativi automatizzati. 3. Il personale addetto alle attività relative ai sistemi informativi automatizzati può essere tenuto alle prestazioni lavorative anche in ore notturne e durante i giorni festivi, con i trattamenti retributivi e i turni previsti dai contratti collettivi. Art. 12 1. Le clausole generali dei contratti che le singole amministrazioni stipulano in materia di sistemi informativi automatizzati sono contenute in capitolati approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, su proposta dell'Autorità. 2. I capitolati prevedono in ogni caso: a) le modalità di scelta del contraente, secondo le disposizioni della normativa comunitaria; b) i criteri per la vigilanza in corso d'opera, per i collaudi parziali e per il collaudo definitivo; c) i criteri di individuazione delle singole componenti di costo e del costo complessivo; d) le penali per i ritardi, per la scarsa qualità dei risultati, per il mancato raggiungimento degli obiettivi, nonché i poteri amministrativi di decadenza, risoluzione, sostituzione; e) le modalità per la consegna o l'acquisizione dei beni e servizi forniti; f) i criteri e le modalità di eventuali anticipazioni; g) i requisiti di idoneità del personale impiegato dal soggetto contraente; h) le ipotesi e i limiti dell'affidamento da parte dell'aggiudicatario a terzi dell'esecuzione di prestazioni contrattuali; i) il rilievo degli studi di fattibilità ai fini dell'aggiudicazione dei contratti di progettazione, realizzazione, manutenzione, gestione e conduzione operativa; l) la dichiarazione che i titolari dei programmi applicativi sviluppati nell'ambito dei contratti di fornitura siano le amministrazioni. 2-bis. L'Autorità, nel rispetto della vigente normativa in materia di scelta del contraente, può stipulare convenzioni con le quali l'impresa prescelta si impegna ad accettare, sino a concorrenza della quantità massima complessiva stabilita dalla convenzione e ai prezzi e condizioni ivi previsti, ordinativi di fornitura deliberati dalle amministrazioni di cui all'articolo 1. I contratti conclusi con l'accettazione di tali ordinativi non sono sottoposti al prescritto parere di congruità economica (8). 3. In sede di prima applicazione del presente decreto, le amministrazioni possono richiedere la revisione dei contratti in corso di esecuzione o di singole clausole, per adeguarli alle finalità e ai princìpi del presente decreto sulla base di indirizzi e criteri definiti dall'Autorità. Art. 13 1. La stipulazione da parte delle amministrazioni di contratti per la progettazione, realizzazione, manutenzione, gestione e conduzione operativa di sistemi informativi automatizzati, determinati come contratti di grande rilievo ai sensi dell'art. 9 e dell'art. 17, è preceduta dall'esecuzione di studi di fattibilità volti alla definizione degli obiettivi organizzativi e funzionali dell'amministrazione interessata. Qualora lo studio di fattibilità sia affidato ad impresa specializzata, questa non ha facoltà di partecipare alle procedure per l'aggiudicazione dei contratti sopra menzionati. 2. L'esecuzione dei contratti di cui al comma 1 è oggetto di periodico monitoraggio, secondo criteri e modalità stabiliti dall'Autorità. Il monitoraggio è avviato immediatamente a seguito della stipulazione dei contratti di cui al comma 1, ovvero entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto se i contratti siano già stati stipulati. Al monitoraggio provvede l'amministrazione interessata ovvero, su sua richiesta, l'Autorità. In entrambi i casi l'esecuzione del monitoraggio può essere affidata a società specializzata inclusa in un elenco predisposto dall'Autorità e che non risulti collegata, ai sensi dell'art. 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287 (9), con le imprese parti dei contratti. In caso d'inerzia dell'amministrazione, l'Autorità si sostituisce ad essa. Le spese di esecuzione del monitoraggio sono a carico
------------------------------ © Servizio per le informazioni e la Sicurezza Democratica ------------------------------

dell'Autorità, salve le ipotesi in cui l'amministrazione provveda alla predetta esecuzione direttamente o tramite società specializzata. 3. Non è consentito il rinnovo alla medesima impresa contraente dei contratti di cui al comma 1 ove non sia stata dapprima effettuata la verifica dei risultati conseguiti in precedenza, nei modi previsti dall'art. 7, comma 1, lettera d). Qualora motivi di continuità del servizio imponessero il rinnovo, questo è disposto per il solo periodo necessario a far compiere la verifica. L'impresa contraente è tenuta ad offrire piena collaborazione all'Autorità durante lo svolgimento della verifica dei risultati, pena l'esclusione dalla partecipazione all'aggiudicazione successiva. Art. 14 1. I contratti e i relativi atti di esecuzione in materia di sistemi informativi automatizzati stipulati dalle amministrazioni statali sono sottoposti al controllo successivo della Corte dei conti. 2. La Corte riceve entro trenta giorni dalla stipulazione i contratti e successive periodiche informazioni sulla gestione dei medesimi, anche sulla base di proprie specifiche richieste. 3. La Corte comunica all'Autorità gli eventuali rilievi formulati alle amministrazioni. 4. L'Autorità è tenuta a conformarsi, nella propria attività, alla pronuncia della Corte. In caso di motivato dissenso, l'Autorità può chiedere al Consiglio dei Ministri di rappresentare alla Corte i motivi del dissenso. La Corte riferisce annualmente al Parlamento sui risultati del controllo. Art. 15 1. Le amministrazioni e le imprese contraenti sono tenute a fornire all'Autorità ogni informazione richiesta. Ove l'Autorità ravvisi atti o comportamenti che possano ingenerare dubbi sulla loro conformità alle regole della concorrenza, ne riferisce tempestivamente al presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato. 2. Ove risultino gravi inadempienze delle imprese nei confronti delle amministrazioni, l'Autorità invita le amministrazioni competenti ad assumere i conseguenti provvedimenti, ivi compresa l'esclusione delle imprese inadempienti dalla partecipazione a procedure di aggiudicazione di contratti di fornitura con le amministrazioni. Art. 16 1. Entro il 31 dicembre 1993 sono adottati, su proposta dei Ministri competenti, d'intesa con l'Autorità, uno o più regolamenti governativi emanati ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (10), al fine di coordinare le disposizioni del presente decreto con le esigenze di gestione dei sistemi informativi automatizzati concernenti la sicurezza dello Stato, la difesa nazionale, l'ordine e la sicurezza pubblica, lo svolgimento di consultazioni elettorali nazionali ed europee (11). 2. Le disposizioni del presente decreto si applicano ai sistemi informativi automatizzati di cui al comma 1, contestualmente ai regolamenti ivi previsti, a decorrere dal 1° gennaio 1994. Restano comunque ferme le disposizioni di cui agli articoli da 6 a 12 della legge 1° aprile 1981, n. 121 (12), e dei relativi provvedimenti di attuazione concernenti il funzionamento del centro elaborazione dati di cui all'art. 8 della stessa legge. 3. Per ragioni di assoluta urgenza, le amministrazioni di cui al comma 1 hanno facoltà di procedere indipendentemente dal parere dell'Autorità di cui all'art. 8, dandone comunicazione all'Autorità medesima. In tali casi le amministrazioni richiedono direttamente al Consiglio di Stato il parere di competenza, che viene espresso nei termini di cui all'art. 8, comma 4, ridotti della metà. 4. Le comunicazioni all'Autorità concernenti la progettazione, lo sviluppo e la gestione dei sistemi informativi automatizzati di cui al comma 1 sono coperte dal segreto d'ufficio o dal segreto di Stato, secondo l'indicazione dell'amministrazione interessata. 5. Dall'applicazione del presente decreto sono esclusi gli enti che svolgono la loro attività nelle materie di cui all'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691 (13). 6. Sono fatte salve le disposizioni di legge relative al trattamento di dati personali. 7. Ai fini dell'integrazione e dell'interconnessione dei sistemi informativi automatizzati resta fermo quanto previsto dall'art. 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (14). 8. Con i regolamenti di cui al comma 1 sono altresì individuate particolari modalità di applicazione del presente decreto in relazione all'Amministrazione della giustizia.
------------------------------ © Servizio per le informazioni e la Sicurezza Democratica ------------------------------

Art. 17 1. Al fine di non ostacolare i processi di automazione in atto, in fase di prima attuazione del presente decreto l'Autorità propone al Presidente del Consiglio dei Ministri una procedura semplificata per l'approvazione degli studi di fattibilità e dei progetti di sviluppo, gestione e mantenimento dei sistemi informativi automatizzati da avviare nel corso degli anni 1993 e 1994 (15). 2. In attesa dell'approvazione del primo piano triennale, l'Autorità determina caso per caso i contratti di grande rilievo, previa comunicazione da parte delle amministrazioni di tutti i contratti in via di stipulazione. 3. In deroga a quanto previsto dal presente decreto, per i contratti in corso di rinnovo o che vengano a scadenza entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto è in facoltà delle amministrazioni di prorogare i rapporti contrattuali per un periodo non superiore a tre anni, oppure di far ricorso ad apposito atto di concessione di durata non superiore al triennio, qualora il contratto da rinnovare intercorra con società specializzata avente comprovata esperienza pluriennale nella realizzazione e conduzione tecnica di sistemi informativi complessi. Agli atti relativi si applicano le disposizioni di cui all'art. 14. 4. In sede di prima applicazione del presente decreto e comunque non oltre il 31 dicembre 1993, il commissario straordinario del Governo, nominato con decreto del Presidente della Repubblica 13 novembre 1992, è presidente dell'Autorità. Durante tale periodo non si applica il regime di incompatibilità previsto, per il presidente, dall'art. 4, comma 3. Art. 18 1. Alle materie regolate dal presente decreto non si applicano le disposizioni contenute negli articoli 2 e 3 del regio decreto legislativo 18 gennaio 1923, n. 94 (16), e nell'art. 14 della legge 28 settembre 1942, n. 1140. 2. Sono abrogate le disposizioni contenute nell'art. 27, comma primo, n. 9) e, limitatamente ai riferimenti all'informatica, n. 3), della legge 29 marzo 1983, n. 93 (17). (1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 20 febbraio 1993, n. 42 (2) Princìpi e modalità per la realizzazione della Rete unitaria della pubblica amministrazione sono stati stabiliti con Dir. P.C.M. 5 settembre 1995, riportata al n. LXXX. (3) Riportata al n. XXX. (4) Riportata al n. XXX. (5) Riportato alla voce Impiegati civili dello Stato. (6) Così sostituito dall'art. 4-ter, D.L. 12 maggio 1995, n. 163, riportato al n. LXXVI. (7) Riportato alla voce Impiegati civili dello Stato. (8) Comma aggiunto dall'art. 6, L. 24 dicembre 1993, n. 537, riportata alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato, nel testo sostituito dall'art. 44, L. 23 dicembre 1994, n. 724, riportata alla stessa voce. (9) Riportata alla voce Società commerciali. (10) Riportata al n. XXX. (11) Limitatamente alle strutture informatiche dell'Amministrazione dell'Interno e delle forze di polizia, il termine di cui al presente comma è prorogato al 30 ottobre 1995 dall'art. 3, D.L. 28 agosto 1995, n. 361, riportato alla voce Impiegati civili dello Stato. (12) Riportata alla voce Sicurezza pubblica. (13) Riportata alla voce Istituti di credito. (14) Riportata al n. XLI. (15) L'art. 4-bis, D.L. 12 maggio 1995, n. 163, riportato al n. LXXVI, ha disposto che la procedura semplificata di cui al presente comma si applichi anche ai progetti da avviare nel corso degli anni 1995 e 1996. (16) Riportato alla voce Provveditorato generale dello Stato. (17) Riportata alla voce Impiegati civili dello Stato.
------------------------------ © Servizio per le informazioni e la Sicurezza Democratica ------------------------------

Tribunale di Madrid (Spagna) Sentenza n. 43, con la quale il giudice ha archiviato il procedimento sulle intercettazioni telefoniche operate dal CESID
ORDINANZA A Madrid, 6 febbraio 1996 I - ATTI Primo - Questo Tribunale segue i procedimenti 4297/95 contro Emilio Alonso Manglano, Manuel Navarro Benavente, Juan Miguel Nieto Rodriguez, Juan Antonio Perote Pello, Visitacion Reyes Patino-Galan, Francisco Vallejo Leon e Jose Maria Vida Molino, per i presunti reati di intercettazione telefonica, peculato e prevaricazione. Secondo - Il Procuratore Sig. Pozas Granero, a nome e per conto del sig. Jaime Cammany y Diez de Revenga, in data 28 novembre 1995, ha richiesto con istanza scritta la pratica relativa agli atti probatori ampliati mediante istanza ricevuta ieri. Terzo - Il giorno 23 gennaio questo Tribunale ha ricevuto una querela proveniente dal Secondo Tribunale della Corte suprema di Cassazione formulata dal Procuratore Sig. Lorente Zurdo, a nome e per conto del Sig. Jose Maria Ruiz Mateos, per un presunto reato di intercettazione di comunicazioni telefoniche e peculato, perché sia inserita nel presente procedimento. II - FONDAMENTI GIURIDICI Primo - Per ragioni di economia processuale, tutte le questioni sollevate fino a questo momento si risolveranno nello stesso procedimento. Riguardo l'istanza processuale del Sig. Campmaay: a) si presenti una richiesta al Tribunale Militare n. 1, affinché consegni a questo Tribunale testimonianza di un rapporto dell'attuale Direttore del CESID, di cui al sommario 01/02/95, al fine di stabilire se il Sig. Alonso Manglano fosse a conoscenza delle intercettazioni telefoniche. Dalla dichiarazione di questi resa alla Procura (foglio 57 e seguenti), e da quella resa a questo Tribunale (foglio 143 e seguenti), non si deduce affatto che egli ignorasse i fatti, al contrario egli stesso dichiara che nell'adempimento dei compiti del centro che dirigeva, già nel 1984 aveva acquisito una squadra di professionisti per migliorare le possibilità d'analisi dello spettro radio-elettronico per le frequenze comprese tra i 20 ed i 1000 MHZ, che tale squadra era stata dotata di mezzi tecnici adeguati, e che era al corrente, tra l'altro, che le registrazioni erano effettuate su nastri. Si respingono dunque queste richieste e quella avente carattere sussidiario perché ritenute non necessarie ai sensi dell'art. 311 del Codice Penale spagnolo. b) Si interessi della compagnia telefonica nazionale spagnola, verificando l'elenco degli abbonati al servizio telefonico mobile nell'anno 1984. Al foglio 1438 degli atti risulta il numero di abbonati al sistema telefonico mobile (479) ma l'identità di ciascun titolare non fornisce indicazioni utili alla causa. c) Si raccolgano le dichiarazioni di: Juan Alberto Perote Pellon Juan Miguel Nieto Rodriguez Visitacion Reyes Patino-Galan Jose Manuel Navarro Benavente Emilio Alonso Manglano Enrique Conde Sanchez. I primi cinque come imputati e l'ultimo come testimone. Ad eccezione di Juan Alberto Perote Pellon, che avvalendosi del diritto sancito dall'art. 24.2 della Costituzione spagnola, si è rifiutato di deporre innanzi a questo Tribunale; gli altri, come ben dice il richiedente, sono già comparsi e hanno rilasciato dichiarazioni, alcuni, come il Sig. Navarro Benavente, addirittura in due occasioni.
------------------------------ © Servizio per le informazioni e la Sicurezza Democratica ------------------------------

Per questa ragione e per quelle di seguito esposte, non sono ammesse agli atti le prove richieste. d) Allo stesso modo si respinge la richiesta di prova riportata nell'ultima istanza presentata dal Procuratore Sig. Pozas Granero e relativa: 1) alla presentazione di un resoconto documentato al Sig. Ministro della Difesa affinché questi lo trasmetta all'organismo competente, il Consiglio dei Ministri, perché valuti gli interessi in gioco, principalmente quello relativo alla sicurezza dello Stato, ne stabilisca la declassifica e la sua conseguente ritrasmissione a questo tribunale che provvederà a produrre gli effetti legali in questo procedimento; 2) alla consegna delle registrazioni di conversazioni del querelante Sig. Jaime Campmany y Diez de Revenga, che hanno dato luogo all'avvio delle indagini (all'istruzione delle pratiche) per le ragioni più avanti esposte. Secondo - Unita alle pratiche una seconda querela presentata al Procuratore Sig. Lorente Zardo, a nome e per conto del Sig. Jose Maria Ruis Mateos che ha come oggetto l'ampliamento di quella ora inviata dal Secondo Tribunale Supremo al Sig. Narciso Sarra y Sarra e al Sig. Julian Garcia Varges, senza che sia pertinente l'ammissione di tale ampliamento in base al risultato delle prove fino ad ora acquisite. Dovendo respingere anche la richiesta delle prove richieste ad eccezione di quella segnalata al numero 3 sempre per le ragioni che si riportano nel paragrafo quattro e seguenti qui di seguito riportati. Numero 2: "Richiesta di comparizione in qualità di testimoni dei signori: Juan Alberto Perote Jose Manuel Navarro Benavente Enrique Conde Andres Fernandez Baena Juan Miguel Nieto Rodriguez Manuel Lopez Sergente Montes senza che, anche dopo la deposizione, possano essere modificate le loro situazioni personali" Per gli argomenti già esposti nel paragrafo precedente. Numero 4: "Documentazione consistente nell'incaricare d'ufficio la polizia giudiziaria, nazionale o Guardia Civil, affinché si costituisca un'unità alle dirette dipendenze di sua Eccellenza il Giudice Istruttore affinché porti a termine le indagini relative ai fatti oggetto di questa denuncia, dovendo il Cesid, organismo attualmente oggetto di indagine, ritirarsi immediatamente dalla stessa, non essendo possibile far coincidere i ruoli di inquirente ed indagato". Quindi il Cesid non può essere l'organo inquirente in questo procedimento, ed essendo d'altra parte facoltà dell'istruttore l'attribuire o meno a membri della Polizia Giudiziaria determinati incarichi, senza che tale misura abbia in alcun caso carattere di prova documentale. Numeri 5 e 6: "Relativi rispettivamente all'ordine di verifica e sequestro nella sede del Cesid dei 93 nastri enumerati nell'articolo pubblicato sul quotidiano "El Mundo" in data 13.6.1995, come di quelli che potrebbero emergere dalle presenti indagini e dai rapporti periodici elaborati in relazione alle suddette intercettazioni". Poiché tali richieste sono già state evase negli atti datati 6 novembre 1995 e 15 gennaio 1996. Paragrafo 7: "Relativo all'intimazione d'ufficio al Cesid, affinché consegni una memoria nella quale si dichiari se esista un mandato giudiziario di autorizzazione per i controlli telefonici riportati nell'articolo precedentemente menzionato". Poiché è ovvio che le intercettazioni delle comunicazioni, e non i controlli telefonici, che hanno originato questo procedimento, non erano autorizzati dal giudice. Ciò è stato anche riconosciuto dal Sig. Alonso Manglano nella sua dichiarazione. Paragrafi 8 e 9: "Relativi all'intimazione d'ufficio al Cesid affinché consegni la nota di tutte le spese relative agli apparati utilizzati per le suddette intercettazioni, nonché delle risorse materiali ed umane impiegate; che ugualmente sia intimato a detto Centro di consegnare una relazione completa relativa alle persone e/o funzionari incaricati delle intercettazioni..." Perché interessano materie protette dalla classifica "riservato". Paragrafo 11: "Relativo all'esortazione al Tribunale Togato Militare n. 1 e/o Tribunale Centrale Militare dal quale dipende questo Organismo Militare affinché invii tutte le pratiche avviate". Poiché i fatti istruiti dal Tribunale Togato Centrale Militare n.1 non hanno nulla a che vedere con quelli trattati da questo Tribunale. Terzo - Da quanto risulta fino a questo momento si deduce che dalla data non meglio precisata del 1982, il centro di intercettazione integrato nel Dipartimento Operativo del Centro Superiore di Informazioni della Difesa, ha analizzato lo spettro radio-elettrico utilizzando apparecchiature che inizialmente non erano
------------------------------ © Servizio per le informazioni e la Sicurezza Democratica ------------------------------

professionali. Nell'anno 1984 e successivamente nel 1989 si è ampliata la possibilità "di raccolta", delle frequenze, fino ad arrivare a quelle comprese tra i 20 ed i 1.350 MHZ. Gli apparati tecnici assegnati a tale ufficio erano corredati di riceventi e registratori a cassette, alcuni si occupavano di ricercare i canali o le frequenze ed altri, una volta sintonizzata la frequenza, registravano il contenuto dell'emissione sul corrispondente nastro. Sono state quindi intercettate e registrate conversazioni utilizzando il sistema di telefonia mobile automatica per almeno uno degli interlocutori. Le informazioni raccolte venivano analizzate e, in alcuni casi, distrutte, in altri, qualora non risultassero di interesse per il Cesid dal punto di vista operativo, messe da parte ed archiviate. Il risultato delle indagini svolte mostra che la percentuale del margine di frequenze comprese tra i 20 ed i 1.350 MHz, che spettava alla telefonia mobile, non supera il 5,63%. Dalla stessa indagine risulta che non è possibile conoscere a priori la frequenza che viene assegnata ad un telefono mobile per intrattenere una conversazione, poiché essa viene attribuita dallo stesso sistema, ed è possibile che durante una conversazione intrattenuta con il sistema T.M.A. la comunicazione possa transitare su un'altra frequenza. Infatti è impossibile preselezionare un telefono mobile con gli apparati di ricezione in dotazione al Cesid e dunque una ricerca delle conversazioni con tali apparati risulta aleatoria. Direttore del Cesid al momento dei fatti contestati era l'imputato, Sig. Alonso Manglano. Direttore del Dipartimento Operativo era il Sig. Perote Pellon e Direttore del Gabinetto per le Intercettazioni in esso integrato il Sig. Navarro Benavente, il cui superiore gerarchico era il Sig. Lopez Borrego. In questo Gabinetto di Intercettazioni prestavano servizio, come personale tecnico, tra gli altri, la Sig.ra Visitacion Reyes Patino-Galan, il Sig. Francisco Vallejo Leon, il Sig. Jose Vida Molina ed il Sig. Juan Miguel Nieto Rodriguez. Quarto - Risulta evidente che in uno stato moderno, se si desidera proteggere interessi vitali, è necessario dotarsi di Servizi di Informazione, qualunque sia il loro nome, strutturati in modo tale da consentire loro di allertare le massime autorità circa i pericoli che incombono sulla Nazione prima che essi si concretizzino. Per questo motivo, non bisognerà meravigliarsi se i poteri pubblici decideranno, al momento opportuno, di dotare il nostro Paese di una struttura organizzativa incaricata di svolgere le funzioni sopra menzionate. In tal senso già una norma precostituzionale, il Regio Decreto 2723/1977 del 2 dicembre modificato dal Regio Decreto 726/1981 del 27 marzo, ha disposto l'articolazione del cosiddetto Centro Superiore di Indagini della Difesa, così come stabilito da un ordine specifico; e la L.O. 6/1980 del 1° luglio - modificata dalla L.O. 1/1984 del 5 gennaio - con la quale, agli art. 10 e 13, si incaricava il Ministro della Difesa di emanare le disposizioni necessarie per il compimento di quelle finalità. In conseguenza di tali mandati di autorizzazione, il Ministro della Difesa ha emanato il decreto 135/1982 del 30 settembre, con il quale si regolano la struttura e le relazioni che il Centro Superiore di Informazione della Difesa deve seguire. Successivamente alle disposizioni citate, altre norme hanno inciso sia sulla struttura organica del Ministero della Difesa che sul Cesid ed in tal senso bisogna riportare le seguenti: Regio Decreto 135/1984 del 25 gennaio con il quale si ristruttura il Ministero della Difesa, indicando il Cesid come l'organismo di Informazione del Capo del Governo e del Ministro della Difesa; R.D. 1/1987 del 1° gennaio dal quale deriva l'attuale struttura del suddetto Ministero, modificato dai RR.DD. 498/1984 del 29 aprile, 619/1990 del 18 maggio, 764/1992 del 26 giugno; R.D. 2632/1985 del 27 dicembre, con il quale si regolano la struttura interna e le relazioni del Centro Superiore di Informazione della Difesa; R.D. 1169/1995 del 7 luglio, con il quale si modifica la struttura Organica del Cesid ed il R.D. 1324/1995 del 28 luglio con il quale si stabilisce lo statuto del personale del Cesid. Le funzioni specifiche di un servizio di informazione con le caratteristiche del Cesid riguardano la realizzazione di attività che in nessun caso somigliano a quelle svolte in altri organismi dell'Amministrazione Pubblica. Che ciò sia e debba essere così si deduce dallo studio di alcuni compiti che il già citato decreto 135/1982 attribuisce al Cesid; in tal senso risulta paradigmatico il riferimento al paragrafo 3 dell'art. 3 della norma sopracitata: "Contrastare lo spionaggio e le attività dei Servizi di Intelligence Esteri che attentano alla sicurezza o agli interessi nazionali, mediante la prevenzione, l'identificazione e la neutralizzazione all'interno ed al di fuori del Territorio Nazionale". Secondo la norma riportata si prescrive l'osservanza di una condotta senza stabilire quali debbano essere i mezzi utilizzati per conseguirla ed inoltre si impone anche la realizzazione di una condotta all'estero; tutto ciò tramite l'utilizzazione di termini quali "neutralizzazione" ed altri dal contenuto preciso. Naturalmente, se si confronta la legislazione relativa a questo punto in vigore nel nostro Paese con quella di
------------------------------ © Servizio per le informazioni e la Sicurezza Democratica ------------------------------

altri Paesi a noi vicini -confronto necessario soprattutto se si considerano tutti gli accordi internazionali raggiunti dalla Spagna e l'integrazione del nostro Paese in importanti strutture sovranazionali - vedremo che la somiglianza è notevole. Nonostante l'importanza delle funzioni che il Cesid è chiamato a svolgere e la difficoltà che comporta il precisare maggiormente i suoi compiti, risulta evidente che le azioni dei funzionari al servizio di quell'Organismo sono limitate dalle frontiere segnate dal nostro ordinamento giuridico applicabile sia alle azioni sviluppate nell'ambito del Territorio Nazionale che alle peculiarità che devono essere osservate nello svolgimento delle azioni al di fuori di esso, considerando che, nelle relazioni internazionali, non sono prese in considerazione quelle dottrine che predicano un atteggiamento diverso di fronte ai Diritti Umani che dipendono dalla territorialità, dalla extraterritorialità o dalla nazionalità degli interessati. E, ancora più importante, l'affermazione che anche i funzionari del Cesid come gli altri funzionari dell'Amministrazione Pubblica - art. 103 della Costituzione Spagnola - sono soggetti alla Legge e al Diritto, in quanto ogni azione da essi realizzata potrebbe interessare, anche solo indirettamente, materie che godono di particolare tutela nel nostro Ordinamento o riservate. Quinto - Il Codice Penale all'art. 192 bis prevede la punibilità per l'Autorità, i funzionari o gli agenti pubblici che, senza autorizzazione giudiziaria, ed a margine di quanto previsto all'art. 55.2 della Costituzione Spagnola, intercettino le comunicazioni telefoniche, non fa altro che dare copertura penale al diritto fondamentale previsto dall'art. 18.3 della Costituzione Spagnola. Diritto questo al segreto delle comunicazioni già previsto dall'art. 8.1 della Convenzione Europea per la tutela dei Diritti Umani e delle Libertà Fondamentali del 1950 (oggetto di ratifica del 26.9.1970) che acquista particolare importanza per il nostro ordinamento giuridico visto il tenore degli artt. 10.2 e 96 della Costituzione Spagnola e per il riconoscimento ricevuto dalla Giurisdizione del Tribunale Europeo per i Diritti Umani cosa che suppone anche il riconoscimento della validità delle sue sentenze, affermata peraltro dal T.C. con le sue prime decisioni (SS. 13/2/81; 10/4/81; 18/5/81; 2/7/81 e 14/7/81). Nonostante quanto stabilito dall'art. 18.3 della Costituzione Spagnola costituisca un Diritto Fondamentale, il Tribunale Costituzionale ha dichiarato in numerose occasioni, e con esso concorda la Dottrina, che "il diritto alla privacy non è assoluto, come non lo è alcuno dei diritti fondamentali, in quanto superabili da interessi costituzionalmente rilevanti, sempre che la motivazione si riveli necessaria per raggiungere il fine legittimo previsto" (Sentenza 143/1994 del 4 maggio). Questa idea di limitazione del diritto è espressamente prevista nel testo dell'art. 8 della Convenzione Europea precedentemente nominata, ed in applicazione di quanto lo stesso Tribunale Europeo ha suggerito nel "caso Klass" (A. 8/978) "le società democratiche sono minacciate, ai nostri giorni, da forme molto complesse di spionaggio e dal terrorismo, e lo Stato deve essere capace, per combattere efficacemente queste minacce, di vigilare in segreto gli elementi sovversivi che operano sul suo territorio. Il Tribunale deve quindi ammettere che l'esistenza di disposizioni legislative che autorizzino i poteri di vigilanza segreta della corrispondenza, degli invii postali e delle comunicazioni risultano, di fronte ad una situazione eccezionale, necessari per una società democratica, onde salvaguardare la sicurezza nazionale e/o la difesa dell'ordine nonché la prevenzione di reati. Naturalmente, queste "ragioni" che possono interessare il diritto fondamentale devono essere accompagnate da garanzie sufficienti, infatti proprio questo è richiesto dall'art. 18.3 della Costituzione Spagnola quando richiede una risoluzione giudiziale (artt. 579 e seguenti del Codice Penale spagnolo). Sesto - nonostante quanto appena detto, non sempre si producono intromissioni nella sfera personale in relazione all'esercizio di un diritto fondamentale ed è quindi necessario che questa intrusione sia effettuata, per essere considerata legittima, secondo quanto previsto, nel caso specifico dall'art. 18.3 della C.S. e dagli artt. 579 e seguenti del Codice Penale spagnolo. Così, in relazione all'art. 17 della C.S., sia il Tribunale Costituzionale (vedasi tra le altre le Sentenze 103/1983 e 107/1988 del 4 e 7 ottobre rispettivamente) che il Tribunale Supremo (Sentenza 1/2/1995 e quelle ivi citate) hanno più volte affermato che le misure presunte come tali, quali il fermo per procedere all'identificazione, le perquisizioni occasionali, i controlli preventivi, gli spostamenti presso commissariati per l'effettuazione di determinate indagini, ecc., non possono essere paragonate alla privazione della libertà cui si riferisce l'art. 17 C.S.. La verifica di queste prove costituisce per l'interessato una sottomissione non illegittima dal punto di vista costituzionale, alle norme di polizia, sottomissione che può anche essere obbligata senza la previa esistenza di indizi di infrazione, nel corso di controlli preventivi realizzati da incaricati dei controlli in materia di sicurezza (Sentenza del T.S. 15.4.1993 e nello stesso senso quella del 20 dicembre dello stesso anno).
------------------------------ © Servizio per le informazioni e la Sicurezza Democratica ------------------------------

Settimo - I progressi tecnologici ottenuti in questo ultimo secolo hanno aperto nuovi orizzonti ove le attività pericolose per gli interessi della Sicurezza Nazionale hanno trovato un terreno fertile, così i servizi di Informazione dello Stato si sono visti obbligati a muoversi, oltre che nel tradizionale campo che implicava un contatto quasi fisico con i potenziali nemici, anche in un altro campo dominato dalle diverse tecnologie relative alla comunicazione. Tuttavia, si tratta di un terreno necessariamente suddiviso tra molteplici utenti, che ne hanno bisogno per le loro costanti comunicazioni realizzate sia per ragioni puramente personali che imprenditoriali o professionali. Ma si tratta anche di un ambito che, per le sue enormi possibilità, è di per sé utilizzabile o suscettibile di utilizzo da parte di persone o gruppi che realizzano attività contrarie agli interessi nazionali. Di qui, l'attuazione delle normative che disciplinano l'attività dei Servizi di informazione che esercitano una vigilanza tipo "pulizia" dello spettro radio-elettrico. Pulizia delle comunicazioni, questa, che non era destinata all'intercettazione, nel senso previsto dall'art. 192 bis C.P., di una comunicazione in particolare, né alla sorveglianza dello sviluppo della comunicazione intrattenuta da un soggetto o da un gruppo di persone determinate o determinabili, ma al controllo sull'uso dello spettro da parte di persone che potrebbero svolgere attività potenzialmente pericolose per la sicurezza dello Stato. Per questo motivo, la condotta descritta non colpisce il bene giuridico protetto nella fattispecie penale. Si tratta, infatti, di una sottomissione non illegittima dal punto di vista costituzionale a norme di polizia e questo sempre che la suddetta vigilanza osservi i necessari presupposti di aleatorietà e riservatezza. Nel caso in cui si volesse procedere all'intercettazione delle comunicazioni mantenute da soggetti determinati, gli interessati dovranno, fatto salvo quanto previsto dall'art. 55 C.S., ottenere la risoluzione indicata nell'art. 18.3. C.S., conformemente a quanto stabilito dagli artt. 579 e seguenti del Codice Penale spagnolo. Dalle risultanze peritali operanti nella causa, alle quali ci siamo precedentemente riferiti, che nessuna delle parti ha impugnato e le cui conclusioni sono assunte da questa istruttoria come proprie, si deduce chiaramente che le disposizioni adottate dai responsabili del CESID, ora imputati, non erano dirette tanto all'intercettazione di una comunicazione telefonica, quanto al controllo di uno spazio radio-elettrico, nel quale si produceva un'ampia gamma di segnali, il cui controllo preventivo costituiva precisa competenza dei servizi di sicurezza del suddetto Centro. In tal senso, l'intercettazione casuale di una comunicazione telefonica, come quelle che sono oggetto del presente procedimento, rimarrebbe a margine della tutela penale di cui all'art. 192 bis del nostro Codice, il quale prevede - dato il carattere prevalentemente doloso del reato - una volontà decisa di intervenire ed osservare concretamente le conversazioni realizzate attraverso gli apparecchi telefonici; in senso analogo si è espresso il Tribunale Supremo nella sua sentenza dell'8.7.1992 circa l'atipicità del mero od occasionale ascolto attraverso apparecchi telefonici. Quindi, non ricorrono gli elementi della fattispecie di cui all'art. 192 bis del C.P., così come alcuna rilevanza giudiziaria presenta la condotta del Cesid di conservazione ed archiviazione dell'informazione priva di interesse dal punto di vista operativo, non essendo essa oggetto di questo procedimento, nonché quella di sottrazione del materiale che conteneva detta informazione, come la sua successiva riproduzione e divulgazione. Vengono pertanto a cadere le imputazioni di prevaricazione e peculato di fondi pubblici, data la conformità al diritto della condotta in questione. Per tutto ciò, ed ai sensi degli artt. 789.5 comma 1 e 637.2 del Codice Penale spagnolo, si dichiara conclusa la presente istruttoria. In relazione a quanto esposto, DISPONGO Si dichiara conclusa la presente istruttoria e si stabilisce l'archiviazione dei presenti atti. Si notifichi quanto sopra alle parti ed al Pubblico Ministero. Si sottoscriva questa risoluzione e si restituisca la cauzione versata dall'imputato Sig. Emilio Alonso Manglano. La presente risoluzione non è definitiva e può essere impugnata innanzi a questo Tribunale entro tre giorni. Così è deciso, disposto e sottoscritto
------------------------------ © Servizio per le informazioni e la Sicurezza Democratica ------------------------------

Dott.ssa ANA MERCEDES DEL MOLINO ROMERA, MAGISTRATO del Tribunale di Istruzione numero 43 di Madrid. Si dia corso a quanto disposto, certifico. (*) Traduzione dallo spagnolo a cura della Redazione.
------------------------------ © Servizio per le informazioni e la Sicurezza Democratica ------------------------------

Stati Uniti:Central Intelligence Agency
La Central Intelligence Agency (CIA) è un'organizzazione di intelligence senza alcuna funzione di polizia o sicurezza interna. Le sue attività vengono regolamentate da vari statuti e decreti presidenziali, sotto il controllo di Comitati Congressuali e altri organi dell'Esecutivo. La CIA venne istituita, unitamente al Consiglio Nazionale per la Sicurezza (NSC) con la legge sulla sicurezza nazionale del 1947. Molti dei compiti specifici affidati alla CIA derivavano dal progetto concepito nel 1944 da William J. Donovan, avvocato newyorchese, su incarico del Presidente Franklin D. Roosevelt, che desiderava riformare il sistema di intelligence. Donovan proponeva "una organizzazione che raccogliesse intelligence con metodi clandestini e non, che fornisse direttive in materia di intelligence, ne fissasse gli obiettivi nazionali e mettesse in correlazione il materiale informativo raccolto da tutti gli enti governativi". Il sistema di coordinamento venne perfezionato con la Legge del 1949 che affidava alla CIA il compito di mettere in correlazione, valutare e diramare i contributi informativi attinenti alla sicurezza nazionale. La legge indicava altresì il Direttore della Central Intelligence quale responsabile della protezione dei metodi e delle fonti informative. Lo statuto del 1949, che può essere considerato alla stregua di un regolamento per la segretezza del bilancio dell'Agenzia, consentiva all'Organismo di intelligence di poter ricorrere a procedure fiscali e amministrative riservate, esentandolo dalle numerose limitazioni previste sulla spesa dei fondi federali. Al fine di proteggere le fonti e i metodi di intelligence da qualsiasi divulgazione, la legge del 1949 ha altresì esentato la CIA dal rendere noti dati sulla sua organizzazione, funzioni, sigle, funzionari, incarichi, stipendi o sul numero del personale impiegato. Tuttavia, solo il Presidente può ordinare all'Agenzia di condurre un'operazione segreta. Queste azioni vengono solitamente proposte dal Consiglio Nazionale per la Sicurezza. Le operazioni segrete sono prese in considerazione nel momento in cui l'NSC reputa che gli obiettivi di politica estera degli USA non possono essere conseguiti per le normali vie diplomatiche e quando l'azione militare sia giudicata come estrema opzione. Pertanto l'Agenzia può ricevere dal Presidente ordine di condurre una speciale attività all'estero, per fini di sostegno alla politica estera, in modo che non sia riconducibile al Governo statunitense o resa di pubblico dominio. Ricevuto tale ordine il Direttore della Central Intelligence dovrà darne comunicazione ai Comitati di Controllo del Congresso. Il Decreto Presidenziale n.1233, però, proibisce espressamente alla CIA di ricorrere, sia in modo diretto, che indiretto, all'omicidio. L'osservanza di tale direttiva è garantita da strumenti di controllo interno e dalle procedure di supervisione congressuali. Particolare rilievo riveste, in base alle disposizioni emanate, il ruolo del Direttore della Central Intelligence Agency, che funge da principale consigliere del Presidente e del NSC in tutte le questioni riguardanti l'intelligence all'estero e inerenti la sicurezza nazionale. Il DCI è anche il principale consigliere del Presidente e del Consiglio Nazionale per la Sicurezza su questioni di intelligence estera. Oltre ad essere capo della Central Intelligence Agency, il DCI dirige altri organismi che rientrano nelle sue competenze in seno alla Comunità di intelligence. La Comunità di Intelligence La Comunità di Intelligence si identifica in quell'insieme di agenzie e di organizzazioni dell'Esecutivo che conducono svariate attività informative abbracciando l'intero arco dell'impegno nazionale statunitense nel settore dell'intelligence. La Comunità è composta da: Central Intelligence Agency, Agenzia per la sicurezza nazionale, Agenzia per l'Intelligence e la Difesa, Uffici del Dipartimento della Difesa incaricati della raccolta di intelligence estera
------------------------------ © Servizio per le informazioni e la Sicurezza Democratica ------------------------------

specializzata attraverso programmi di ricognizione, Bureau di intelligence e Ricerca del Dipartimento di Stato, i SIOS di Esercito, Marina e Aeronautica, FBI, Dipartimento del Tesoro e Dipartimento dell'Energia. I membri della Comunità informano il Direttore della Central Intelligence Agency attraverso relazioni presentate ai diversi comitati specializzati che trattano materie di intelligence di comune interesse. Controllo legislativo sull'intelligence Il congresso statunitense ha avuto compiti di controllo sulla CIA sin dalla sua costituzione nel 1947. Tuttavia, prima della metà degli anni '70, i poteri di controllo venivano affidati ai Comitati sui Servizi Armati di ambedue le Camere ed erano meno formali rispetto alla situazione odierna. All'epoca il DCI e i suoi rappresentanti interagivano direttamente con i rispettivi Presidenti dei Comitati Congressuali, e raramente avevano testimonianze e udienze formali. Dopo le affermazioni riguardanti gli illeciti compiuti da agenzie di intelligence statunitensi come la CIA, il 19 maggio 1976 il Senato ha costituito il Comitato ristretto del Senato sull'intelligence (SSCI). La Camera dei Deputati in data 14 luglio 1977 ha invece costituito il Comitato Ristretto Permanente della Camera sull'Intelligence (HPSCI). Questi Comitati, unitamente a quelli sui Servizi Armati e sulle Relazioni e Affari Esteri, sono stati incaricati di autorizzare i programmi delle agenzie di intelligence e controllare le loro attività. L'Ufficio per gli Affari congressuali della CIA si occupa direttamente delle questioni connesse ai controlli. SSCI e HPSCI ricevono tutti i prodotti di intelligence dell'Agenzia. In aggiunta, funzionari e analisti della CIA forniscono ogni anno più di mille rapporti ai membri del Congresso e ai suoi Comitati. Oggi la CIA riferisce regolarmente ai Comitati di Intelligence del Senato e a quello permanente del Congresso, così come disposto dalla legge del 1980 sul controllo sui Servizi e da altri decreti dell'Esecutivo. Controllo dell'Esecutivo sull'intelligence Il controllo dell'Esecutivo è espletato dai seguenti organi: Consiglio per la sicurezza Nazionale Il National Security Council (NSC) è stato costituito in base alla Legge sulla Sicurezza Nazionale del 1947 al fine di fornire al Presidente uno strumento di integrazione tra le politiche interne, estera e militare con riguardo alla sicurezza nazionale. L'NSC è il supremo organo dell'Esecutivo preposto alla revisione e alla definizione dell'indirizzo di tutte le attività di intelligence estera e di controspionaggio. Membri statutari dell'NSC sono: il Presidente degli Stati Uniti, il Vice Presidente, il Segretario di Stato e il Segretario alla Difesa. Il Direttore della Central Intelligence Agency e il Capo di Stato Maggiore partecipano in veste di consiglieri. Organo Consultivo di Intelligence estera del Presidente (PFIAB) Il PFIAB si colloca nell'ambito dell'Ufficio esecutivo del Presidente. I suoi diversi membri prestano servizio su richiesta del Presidente e vengono scelti tra cittadini leali e meritevoli, che non ricoprono incarichi governativi, qualificati in ragione della loro posizione, esperienza e indipendenza. La loro prestazione non è remunerata. L'Organo controlla sistematicamente l'operato di tutte le agenzie governative impegnate nella raccolta, valutazione o produzione di intelligence o nell'applicazione delle politiche di intelligence. Valuta inoltre l'efficienza dell'Amministrazione, del personale e della organizzazione delle agenzie di intelligence, informando il Presidente su obiettivi, conduzione e coordinamento delle attività di dette Agenzie. Il PFIAB ha specifiche funzioni propositive ai fini del miglioramento e incremento degli sforzi informativi degli Stati Uniti. Le proposte possono essere direttamente presentate al Direttore della Central Intelligence, alla CIA o ad altre agenzie operanti nel settore. Organo di Controllo sull'Intelligence del Presidente (PIOB) Il PIOB è istituito nell'ambito della Casa Bianca. È composto di tre membri non appartenenti al Governo,
------------------------------ © Servizio per le informazioni e la Sicurezza Democratica ------------------------------

nominati dal Presidente. Uno di essi, che funge da Presidente è altresì membro del PFIAB. L'Organo ha la funzione di individuare e riferire al Presidente ogni attività di intelligence suscettibile di indagine in ordine a questioni di legalità rispetto alla costituzione, alle leggi statunitensi o ai decreti esecutivi presidenziali. L'Organo, permanente e indipendente, è anche incaricato del controllo sulle direttive interne e sulla direzione della Comunità di Intelligence. Le risorse umane e finanziarie La CIA compie accurate selezioni fra persone altamente qualificate in quasi ogni settore di studio. Scienziati, ingegneri, economisti, linguisti, matematici, segretari e operatori di apparati elettronici sono soltanto alcune delle specializzazioni più richieste. Alcuni sono degli specialisti - scienziati in fisica e sociologia, dottori in medicina, avvocati - ma vi sono anche molti altri dipendenti che hanno dimostrato grande capacità nel gestire gli incarichi affidati. L'Agenzia promuove un programma di equa occupazione per tutti gli impiegati, inclusi donne, esponenti di minoranze e handicappati. Il numero dei dipendenti o le dimensioni del budget dell'Agenzia non possono essere divulgati. Sebbene il budget e le dimensioni della CIA costituiscano notizie classificate, essi vengono ugualmente e dettagliatamente controllati dall'Ufficio Programmazione e Bilancio e dai sottocomitati Controllo e Difesa dei Comitati sugli stanziamenti dei fondi in ambedue le Camere. Le risorse destinate all'intelligence sono altresì sottoposte a rigorosi esami e processi di approvazione, come per ogni altro organo governativo del Paese. Le pubblicazioni La CIA occasionalmente divulga pubblicazioni non classificate per contribuire alle attività di ricerca di comunità accademiche e finanziarie. La maggior parte di questi rapporti contiene informazioni estere e internazionali nei settori economico e politico, nonché di funzionari stranieri. Sono reperibili presso l'Ufficio Stampa del Governo, il Servizio Nazionale per le Informazioni Tecniche e la Biblioteca del Congresso. La CIA non può, in ogni caso, divulgare molti altri suoi rapporti acquisiti da fonti riservate.
------------------------------ © Servizio per le informazioni e la Sicurezza Democratica ------------------------------

------------------------------ © Servizio per le informazioni e la Sicurezza Democratica ------------------------------

Enciclopedia delle spie Giorgio Boatti - (Edizione "Rizzoli", Milano, 1989)
Il testo costituisce un approccio originale al tema "spionaggio", in cui risuonano echi vagamente illuministici e sentori di conversazioni amabili ma per nulla distratte. È godibile la trattazione per argomenti separati, per "voci" appunto, in cui nomi di oggetti si mescolano a nomi di persone, di luoghi, di organismi politici, di ognuno dei quali si scrive, seppur assai brevemente, con dovizia di particolari spesso curiosi e con citazioni di cultura e di storia. Il tocco "magico" è la spiritosa "legenda" in cui ad ogni simbolo, rigorosamente "spionistico", corrisponde una fine dicitura esplicativa. È un'attrattiva per il lettore, in quanto garbata metafora del mondo oscuro e doppio dello spionaggio, stemperato nella decifrabilità piana del simbolo spiegato e ampiamente sparso per tutta la trattazione delle "voci".
------------------------------ © Servizio per le informazioni e la Sicurezza Democratica ------------------------------

La mia vita nella CIA William Colby e Peter Forbath - (Edizione "Mursia", Milano, 1981)
È un testo che unisce la forza della testimonianza diretta a uno stile narrativo sciolto e piacevole, nel quale verità politiche interessanti compaiono accanto ad aspetti quotidiani dell'esistenza. William Colby narra, con un'ottica senz'altro personale, le vicende nazionali e internazionali della CIA, sin dalla sua costituzione, in tutti gli anni in cui egli vi ha lavorato come addetto o come funzionario prima, come direttore dal 1973 al 1976, poi. Raccontando le sue esperienze e la storia della struttura, riferisce dei rapporti con l'Italia al tempo della guerra fredda, confermando il ruolo di sostegno che gli Stati Uniti ebbero, in quegli anni, nelle vicende politiche del nostro paese e degli avvenimenti del Vietnam, ove ha lavorato per alcuni anni, sfiora la crisi dei missili cubani nell'ottobre 1962 e la guerra nel Laos, la crisi in Cile al tempo della morte di Allende e il problema di Castro. Di particolare interesse la ricostruzione dei rapporti interni della CIA con il Congresso, passati anche attraverso momenti di tensione per le accuse di un giornalista sulla sua attività antipacifista. Nel 1974, infatti, un servizio apparso sul New York Times, a firma di Seymour Hersh, denunciava una "massiccia operazione illegale di spionaggio interno", intrapresa dall'agenzia negli anni di Nixon. Un'imponente campagna stampa si abbatté sull'apparato e il sensazionalismo degli articoli contenenti le presunte mostruosità compiute dall'Agenzia accese l'opinione pubblica americana, già resa inquieta dagli episodi relativi al Vietnam, al Watergate, al Cile. Si diede inizio alle indagini: il Presidente Ford nominò una Commissione presidenziale speciale e Commissioni speciali furono nominate anche dal Senato e dalla Camera dei Rappresentanti. Il siluramento di Colby, giunto al termine di mesi che egli stesso ricorda turbolenti e intensi, è attribuibile, a suo giudizio, non solo al desiderio del Presidente Ford di segnare una svolta netta nella vita dei servizi, tramite la nomina di un nuovo direttore, ma soprattutto al modo con cui egli aveva affrontato la crisi della CIA. L'atteggiamento di Colby, infatti, "pragmaticamente e filosoficamente, era in contrasto con quello del Presidente e dei suoi principali consiglieri": ispirarsi cioè "alla costituzione e applicarne i princìpi… collaborare alle inchieste e cercare di spiegare al Congresso, alla stampa e all'opinione pubblica i servizi segreti, la loro importanza, i loro successi e i loro insuccessi". La visione personale di Colby sui servizi segreti, vale a dire il convincimento, che emerge chiaramente dalle pagine del suo libro, era che essendo essi utili e indispensabile il loro contributo alla sicurezza della nazione, andasse fatta la giusta pubblicità perché la gente ne conoscesse le funzioni, i limiti e i prodotti, con giuste informazioni relative alla loro natura e alla loro attività.
------------------------------ © Servizio per le informazioni e la Sicurezza Democratica ------------------------------

Discorso sul federalismo Emilio Raffaele Papa - (Edizioni Giuffrè, Milano, 1995)
L'agile volumetto raccoglie le considerazioni sulle "radici storiche fondamentali, e certe ragioni ideali, politico-costituzionali autentiche del federalismo" come afferma nella premessa lo stesso autore, Emilio Raffaele Papa, professore ordinario di storia moderna e contemporanea nell'Università di Bergamo. La lettura del lavoro, articolato in nove capitoli, costituisce pertanto un'occasione di ulteriore riflessione su un tema che, seppur mai attenuatosi in una certa corrente ideale e culturale, è riemerso prepotentemente negli ultimi anni, costituendo la rivendicazione del federalismo il punto di forza della battaglia radicale condotta dalla Lega. Meritorio, pertanto, il contributo e utile a un dibattito vitale che, troppo spesso infirmato da equivoci e contraddizioni, dovrebbe in realtà condurre alla serena formulazione di proposte concrete per una transizione ad un assetto federalista dello Stato italiano. Il discorso si snoda lungo l'esame dei tre grandi modelli di federalismo, il tedesco, l'americano e quello svizzero; delineati i due concetti di confederalismo e federalismo, partendo dall'analisi della natura del foedus al fine di chiarire le loro differenze; richiamati brevemente Altusio, dotto giurista tedesco, autore di una interessante formulazione politico-dottrinaria sull'ideale federalistico, Proudhon, Hugo; definito il principio di sussidiarietà e le necessità espresse dalla sua formulazione, vengono fornite alcune valutazioni sui sistemi elettorali e l'istituto referendario "la cui funzione di sensibilizzazione dell'opinione pubblica e di stimolo alla partecipazione", pur nella valutazione degli inevitabili contrappesi, viene giudicata indiscutibile. Vengono svolte poi considerazioni interessanti sul tema costituzionale del capo dello Stato e del capo del Governo, ritenendo l'Autore che il modello cui riferirsi, sebbene imperfetto, sia quello tedesco e particolarmente efficace, in tale ambito, viene ritenuta la formula del "konstruktive Misstrauensvotum: la sfiducia costruttiva". Ricordata la visione che del federalismo ebbero Cattaneo, Ferrari e altri studiosi e politici, pervenendo ai tempi attuali, vengono giudicate "molto felici" alcune riflessioni di Miglio sulle macro regioni europee mentre sul piano della costituzione di una federazione italiana, il pensiero dello studioso appare all'autore "condizionato da una visione separatista di fondo". Si considera positivamente uno studio "senz'altro apprezzabile", condotto dalla Fondazione Agnelli sulle autonomie regionali, con una valutazione attenta e critica delle proposte contenute nel lavoro. Papa è convinto che l'Italia possa "trovare nel federalismo la sua vocazione vincente. Attraverso un graduale passaggio all'ordinamento federalistico sul piano legislativo, fiscale e del bilancio, nel contesto di un rinnovamento del quadro costituzionale in tempi politici progressivi e solleciti".
------------------------------ © Servizio per le informazioni e la Sicurezza Democratica ------------------------------

L'uso della realtà virtuale e dei sistemi multimediali nel processo penale Carlo Sarzana di S. Ippolito - (in "Il diritto dell'informazione e dell'informatica", n. 1, 1996, pp. 21-29)
L'autore, un illustre magistrato e uno tra i più autorevoli studiosi del settore, introduce il concetto di realtà virtuale come "un universo grafico tridimensionale, creato dal computer e interattivo, che consente una totale partecipazione-immersione in una rappresentazione audiovisiva del mondo, nel quale gli oggetti possono essere maneggiati e manipolati in tempo e spazio reali". Viene poi ad essere posto l'accento sull'efficacia dell'uso della realtà virtuale negli USA, in modo particolare nel settore giudiziario, per la ricostruzione di eventi e accertamenti di responsabilità, pur nella considerazione della necessità di adottare adeguate precauzioni. Riferendosi alle applicazioni della realtà virtuale al processo penale italiano, Sarzana ne valuta positivamente la validità, sostenendo che le forme di ricostruzione statiche di situazioni ed eventi andrebbero "senz'altro ammesse ai sensi dell'art. 187 cod. proc. pen. (eventualmente facendo ricorso anche all'art. 189)" e ricordando l'uso delle tecnologie informatiche multimediali, con una loro breve illustrazione, nei processi di Milano, a carico degli imputati di Tangentopoli, e in quello celebrato presso la Corte di Assise di Caltanissetta per la strage di Capaci.
------------------------------ © Servizio per le informazioni e la Sicurezza Democratica ------------------------------

Riforma non traumatica dell'intelligence USA "Le Monde du Reinsegnement", 7 marzo 1996
L'articolo riferisce i risultati raggiunti dalla Commissione istituita, sotto la presidenza dell'ex Segretario della Difesa Harold Brown, al fine di valutare i ruoli e le capacità della comunità di intelligence degli Stati Uniti. La Commissione ha, tra l'altro, approvato la proposta del Direttore della CIA, John Deutch, di creare una National Imagery and mapping Agency (NIMA), raggruppando il Central Imagery Office (CIO), il National Photographic Interpretation Center (NPIC) e la Defence Mapping Agency (DMA), rifiutando nel contempo lo smantellamento del National Reconnaissance Office e il trasferimento delle relative competenze all'U.S. Space Command, proposti da alcuni. Lo studio Brown fornirebbe, inoltre, una serie di indicazioni riguardanti una migliore gestione dell'Intelligence con "la creazione di nuovi posti dirigenziali e il trasferimento delle competenze" oltre a suggerimenti specifici relativi a nomine, assegnazioni di responsabilità, operazioni clandestine, definizioni dei ruoli, eventuali trasformazioni di particolari uffici. L'articolo riporta notizie anche relativamente al rapporto che, sempre in tema di riforma dell'intelligence, è stato presentato dal repubblicano Larry Combest, presidente della Commissione della Camera dei rappresentanti incaricati di redigerlo e che conterrebbe modifiche più radicali di quelle della Commissione Brown. Infatti alla CIA "verrebbero sottratte le attività clandestine condotte dalla sua Direzione delle operazioni e il suo ruolo verrebbe limitato alle analisi delle informazioni". Sarebbe inoltre prevista la soppressione della National Security Agency (NSA) e del National Reconnaissance Organization con l'attribuzione delle attività di ascolto e di raccolta delle informazioni satellitari alla Technical Collection Agency (TCA), una nuova agenzia che curerebbe anche l'attività di sorveglianza dei tests degli armamenti dei Paesi stranieri, condotti dal Central Management Office. La ricerca e lo sviluppo dei satelliti spie e di altri sistemi di spionaggio sarebbero affidati ad un nuovo Technology Development Office.
------------------------------ © Servizio per le informazioni e la Sicurezza Democratica ------------------------------

Le riforme dell'Intelligence "International Herald Tribune", 2 aprile 1996
Apparso su "The Washington Post" e pubblicato successivamente dall'International Herald Tribune, il 2 aprile, l'articolo affronta il tema assai dibattuto della riforma dei servizi segreti americani. Gli scandali più recenti che, in questo Paese, hanno colpito il mondo dell'intelligence sembrano infatti aver solamente impresso un moto di accelerazione a un processo di rinnovamento già avviato e ormai non più procrastinabile. Infatti, comunque constatata la necessità dei servizi di intelligence, se ne auspica un riassetto teso al loro miglioramento: "un riordino non una rivoluzione". Nell'articolo si fa cenno allo studio commissionato dal Congresso Democratico, nel 1994, a un gruppo di lavoro composto da membri designati dallo stesso Congresso e guidato da Harold Brown, ex Segretario alla Difesa e da Warren Rudman, ex senatore repubblicano, definendolo come una "direttiva amministrativa, che si propone di consolidare i poteri e i controlli politici, nonché il ruolo del direttore dell'Intelligence Centrale, quale primo consigliere del Presidente in materia di intelligence". Il rapporto, sempre secondo l'articolista, conterrebbe indicazioni efficaci, volte alla strutturazione di una intelligence più "utile agli 'utenti' della politica, della diplomazia e dell'Esercito", garantendo, allo stesso tempo, la possibilità di realizzazione delle operazioni clandestine. Viene giudicata poco misurata la protezione del bilancio dell'intelligence prospettata dallo studio Brown che, al fine di riassorbire il personale impegnato nella lotta all'ex blocco sovietico, suggerirebbe anche un blocco delle assunzioni per un anno.
------------------------------ © Servizio per le informazioni e la Sicurezza Democratica ------------------------------

USA: Informazione economica e competitiva "Le Monde du Reinsegnement", 4 aprile 1996
L'articolo segnala il successo ottenuto dalla conferenza annuale della Society of Competitive Intelligence Professional (SCIP), svoltasi ad Arlington, vicino a Washington, dal 27 al 30 marzo. L'associazione, di cui fanno parte molti dei professionisti americani dell'Intelligence Economica e Competitiva (IEC) è ora guidata da Tracey Scott, che si è prefisso, tra gli altri, l'obiettivo di "rafforzare la posizione strategica dell'intelligence competitiva ed economica all'interno dell'impresa". In tale ambito, infatti, sono da considerarsi ormai indispensabili lo "sfruttamento sistematico delle fonti aperte, l'osservazione costante della concorrenza, la veglia tecnologica, la raccolta intelligente delle informazioni all'interno stesso della società". Alcuni teorici dell'IEC, tuttavia, ritengono che il concetto di intelligence non sia sovrapponibile a quello di informazione e Ben Gilard, ex responsabile dell'Unità di Intelligence della polizia israeliana, oggi professore associato di management presso la Rutgers University, sottolinea il ruolo sostanziale svolto in una azienda da una vera cellula di intelligence rispetto ai dati offerti da un pur eccellente centro di documentazione. Tuttavia può ritenersi che tale concetto non esprima una contraddizione, ma che sia necessario studiare i presupposti per una coesistenza delle due funzioni di "documentazione avanzata" e di "visione strategica".
------------------------------ © Servizio per le informazioni e la Sicurezza Democratica ------------------------------

Hanno collaborato a questo numero: Anna FERRI e Silvana LOTTI Esperte di Diritto Comunitario Leonardo MAZZA Ordinario di Diritto Penale presso l'Università di Siena Onorato SEPE Presidente di Sezione della Corte dei Conti Mirko VALENTI Giurista
------------------------------ © Servizio per le informazioni e la Sicurezza Democratica ------------------------------