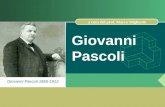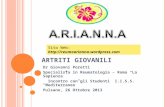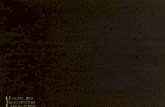Giovanni Pascoli 1855-1912 Giovanni Pascoli a cura del prof. Marco Migliardi.
GLI „ESERCIZI” GIOVANILI DI GIOVANNI PASCOLI
-
Upload
antonio-di-pietro -
Category
Documents
-
view
219 -
download
6
Transcript of GLI „ESERCIZI” GIOVANILI DI GIOVANNI PASCOLI
GLI „ESERCIZI” GIOVANILI DI GIOVANNI PASCOLIAuthor(s): ANTONIO DI PIETROSource: Aevum, Anno 27, Fasc. 4 (LUGLIO - AGOSTO 1953), pp. 332-358Published by: Vita e Pensiero – Pubblicazioni dell’Università Cattolica del Sacro CuoreStable URL: http://www.jstor.org/stable/25820474 .
Accessed: 16/06/2014 13:01
Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at .http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp
.JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range ofcontent in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new formsof scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected].
.
Vita e Pensiero – Pubblicazioni dell’Università Cattolica del Sacro Cuore is collaborating with JSTOR todigitize, preserve and extend access to Aevum.
http://www.jstor.org
This content downloaded from 185.2.32.106 on Mon, 16 Jun 2014 13:01:36 PMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions
ANTONIO DI PIETRO
GLI "ESERCIZI,, GIOVANILI DI GIOVANNI PASCOLI
A chi voglia iniziare da capo e puntualmente una storia del farsi
della poesia pascoliana, i primi testi che si offrono sono quelli del poe ta ancora studente liceale, o addirittura ginnasiale, dagli Scolopi ad
Urbino. Versi di un adolescente, non differiscono gran che dalle prime prove di ogni ragazzo che, innamorato delle lettere, si illuda, a quell'e ta, di essere chiamato alia poesia: sono tuttavia degni di considerazione, non solo perche costituiscono comunque la prima testimonianza di una
vocazione che si mostro poi autentica; ma anche perche di quella voca
zione ci danno indicazioni non del tutto generiche. Pur senza supervalu tarli, infatti, (ma si supervaluta un fanciullo solo se si pretende di conside
rarlo uomo, non se si cercano in lui i segni immancabili dell'uomo futuro) risultano essi, ad un* attenta lettura, documenti non trascurabili delle
prime inconscie simpatie letterarie del poeta, che si trasformeranno piu tardi nella scelta cosciente di una via, fra le innumerevoli possibili, che
lo condurra alia scoperta di se.
II testo piu antico da noi conosciuto (che, per essere stato pubbli cato, presuppone certo altre private esercitazioni) e // pianto dei com
pagni> stampato a Urbino nel 1869 (1), quando Tautore aveva cioe soltanto
quattordici anni. Non si pud certo parlare di poesia per questo compo nimento d'occasione, vero compito in rima, in cui il provinciale studen
tello di ginnasio, ignaro di movimenti letterari contemporanei, cerca di
imitare i classici italiani conosciuti sui banchi, sotto la guida dei suoi
maestri: e utile tuttavia osservare, oltre alia sua precoce perizia di ver
seggiatore, come egli fra i poeti letti tenga soprattutto presenti quelli che, dal Petrarca al Tasso e ai romantici, meglio rappresentano il filone
idillico-elegiaco della nostra letteratura, e come fra le metafore tradizio
nali, utilizzabili per un compianto, preferisca sviluppare quella dell'albero
(1) Nell'opuscolo Solenni esequie di Pirro Vivjani nel giorno XXX della sua morte, Urbino, Roccetti-Ricci, 1869: lo ha ripubblicato recentemente G. PETROCCHI in La forma zione ietteraria di G. P., Firenze, Le Monnier, 1953, pp. 53-54.
This content downloaded from 185.2.32.106 on Mon, 16 Jun 2014 13:01:36 PMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions
OLI "ESERCIZI,, OIOVANILI DI GIOVANNI PASCOLI 353
divelto dal turbine, che gli permette di spostare la sua attenzione dal T inconsistente immagine del compagno morto ad una sia pur genericissi* ma e ingenuamente letteraria scena di natura:
Quale arboscel, che di novelle fronde lieto s'adorna, e di piacevol rezzo
del rio conforta le ridenti sponde, e il puro aere intorno
de' fiori allegra col soave olezzo, crescea il garzon, quando dal suol natio
il turbin della morte ahil lo rapio. A noi il sorriso tornera d'aprile
e al prato torneran Terbelte e i fiori, e gli augelletti ne Fusato stile con grata melodia
saluteran del giorno i primi albori; la rondinella dall'estranio lido
fia pur che torni a rivedere il nido.
Ma tu non tornerai, o giovinetto (1);
ne si pud non sottolineare come gia affiori, pur nella sua grezza mate
rialita, il tema del ?suol natio? e del ?nido? (a cui torna con umana
nostalgia la rondine), che sara poi dominante nella poesia pascoliana; e val la pena anche di notare come la facile musicalita di questi incon diti versi gia tenda a divenire meno superficial quando subentra il te ma del rimpianto:
Ahi! quel felice tempo che tra noi fostj, qual vision gradita o qual sogno passo, ed or soltanto a noi rimane la memoria e il pianto.
Di poesia non si pud, egualmente, parlare a proposito della compo sizione Come studio Raffaello, scritta dall'alunno degli Scolopi l'anno
dopo, e anch'essa subito pubblicata (2). E gia pero meno acerba, e ri velatrice di atteggiamenti meno generici e piu pregni di futuro del gio vinetto esordiente. Dal Petrarca ( ue i fiori e Verbe, e il bel tempo rime
na, I e s'ode Filomena... ?) al Tasso (u I alba intanto / infioraua di rose / // ciel...?), dal Parini arcadico ("Ape industre all'albore / oola a' prati irrorati, e si riposa / su 7 giglio o su la rosa ?) a quello civile ("... lonor, che al vero merito concede / la tua patria dellarte inclita sede,,), dal
(1) Pianto antico del Carducci, in cui e sviluppato lo stesso tema di questi ultimi versi, non pote suggerire nulla al Pascoli, perche fu scritto due anni dopo, nel 1871.
(2) Nell'opuscolo Alia memoria di Raffaello, Fossombrone, Tip. Monacelli, 1870. Cfr. PETROCCHI, op. cit., pp. 54-57.
This content downloaded from 185.2.32.106 on Mon, 16 Jun 2014 13:01:36 PMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions
354 A. DI PIETRO
Monti ("per te della pittura / ebbe I' Ausonia il oanto, / e fu natura ointa ?) al Foscolo ("e d'altisensi albergo fe il tuo seno?), dal Manzoni ("OA
quante volte al so/o...?) al Leopardi ("si diffondea per le piagge odo
rose I e crescea a poco a poco...?), il componimento e tutto un intarsio
di echi indiscriminati di classici: quasi Tautore quindicenne si preoccupi solo di mostrarsi ai maestri, che lo hanno probabilmente incaricato di com
porre l'ode, studiosissimo discepolo. E tuttavia evidente che sui temi di
natura egli indugia piu a lungo e con maggior compiacenza: Raffaello e
celebrato solo come T insuperabile pittore di paesaggi:
Se riede il vago Aprile
al giocondo spettacolo rapita Talma a dipinger la tua mano invita.
Se avvien che minaccioso
di mesto, negro, oscurissimo velo
tutto si cuopra il cielo
mentre tuona per l'aere il fragoroso
fulmine; o se del monte
sibila il vento sulla bianca fronte, di quella scena che porge natura
tu scolpisci neH'alma la paura;
e, a levitare la sua ispirazione, si levano intorno a lui solo spettacoli e
voci della natura:
Oh quante volte al solo raggiare in ciel di cheta arnica luna
per qualche selva bruna
ascoltavi d'augello il flebil duolo! Pensavi: e ti rapia
quel pensiero in gentile melanconia.
Pinger pensavi e luna e augello . ..;
e se pure quegli spettacoli e quelle voci sono libreschi, e se libresca
e anche la ?gentil melanconia ? che di fronte ad essi invade l'artista, e
pur sempre vero che tutto denuncia, nel chiaro sottinteso autobiografico, una predilezione e un atteggiamento che non saranno smentiti dal futuro
poeta: il quale, del resto, gia ora utilizza la reminiscenza scolastica con
una infedelta talvolta significativa, come quando rinchiude T arioso pae
saggio leopardiano in una piu angusta cornice villereccia:
Allor lene sussurro
si diffondea per le piagge odorose e crescea a poco a poco
misto di canti agresti in ogni loco;
This content downloaded from 185.2.32.106 on Mon, 16 Jun 2014 13:01:36 PMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions
OLI "ESERCIZI,, GIOVANILI DI GIOVANNI PASCOLl 335
e gia, attrihuendo a Raffaello un'emozione particolarmente profonda della sua vita, isola quel tema del "nido?, su cui fugacemente, e come per caso, si e pur fermato nel componimento precedente:
.gia al tuo nido natio
piangendo dici addio.
E che i temi d'un naturalismo idillico, inumiditi appena per ora da
un'intermittente vena di romantica malinconia, siano i piu congeniali
all'aspirante poeta, confermano le altre due composizioni storico-cele
brative da lui scritte alTincirca negli stessi mesi: Napoleone a Sanf E
lena e Ferruccio a Gaoinana (1). La prima, che, dopo essersi soffermata
per tutta la prima strofa sulla descrizione dell'?isoletta? minacciata dal
F ? onda atlantica?, e dopo aver tentato, inopportunamente e invano, di
appoggiarsi ancora a temi arcadici folti di echi tassiani (qualcuno evi
dentissimo: " L'aure spiraoan gia nunzie d'Aurora ?), cade interamente,
nonostante il soccorso del Cinque maggio manzoniano e della leopardiana canzone Air Italia; e la seconda, che dissolve il drammatico episodio di
Ferruccio in un seguito di scene di natura. Scene letterarie, al solito, intessute di generici petrarchismi e di piu precise e non dissimulate re
miniscenze illustri, del Poliziano (uEra il mattin... e la civetta esce dal cauo tufo ?), e, soprattutto, del Tasso (" Di rose colte in Paradiso infio ra?; "i pastori / fuggon de' boschi tra i seloaggi orrori ?), intrecciate a
meno lontane memorie romantiche del Berchet (uper aspri gioghi / erro
la notte oscura ?) ; scene, tuttavia, in cui si nota gia, nel soverchiante
contrappunto di cartacee armonie (" or piange Flora e... per questi colli sua voce si sente... ?; apiangera mesto da quei colli l'Eco...?; t( deh! tacete, o ocque ed 6re...?;
u di agresti canti e boscherecce aue
ne I un suon misto si leva?), il ravvivarsi di un'attenzione piu minuta alle voci delle cose:
Tutto s'apre al sorriso; cresce il canto
basso in pria degli augelli . . .
solo s'udiva il basso mormorio
(1) Composte ambedue prima che il Pascoli, nel 1871, lasciasse Urbino, per andare
a frequentare la seconda liceale a Rimini (v. G. lesca, Urbino e gli albori poetici di
G. P. in ?Romagna?, aprile-maggio, 1913, pp. 135-140; e cfr. Petrocchi, op. c/7., pp.
57-62), furono, si direbbe, lasciate allo stato di abbozzi. Le attuali edizioni, infatti, non
persuadono: in piu di un luogo non hanno senso o sono evidentemente lacunose: non
solo i vv. 25-26 (come ha notato il Petrocchi), ma anche i vv. 28-30 di Napoleone a
Sant'Elena non si legano fra loro; e, sia sintatticamente sia metricamente, incoerenti sono
anche i vv. 2-4 di Ferruccio a Gauinana; ne mancano altri luoghi molto dubbi.
This content downloaded from 185.2.32.106 on Mon, 16 Jun 2014 13:01:36 PMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions
336 A. DI PIETRO
di solitario fonte e un tremolar di fronde . . .
Si unisce intanto alTindistinto suono
una dolce armonia: e d'una cetra
il tintinnire arguto . . . ;
e in cui gia il ricordo storico si inserisce, non come evocazione di una
concreta presenza umana, ma come fantasiosa visione che, fermata per un attimo, in una immagine di un impressionismo ancor piu tassiano
(chi non ricorda Clorinda?) che romantico (1):
Appare intanto la sovra quel colic
un cccelso guerriero:
candido, monta candido destriero, e il brando ignudo estolle:
si dissolve poi nel paesaggio, in un gioco d' echi, per caricarlo, con in
genuo artificio, di arcane suggestioni. Ne la fondamentale tendenza alFidillio, osservata nei primissimi ver
si scritti dal Pascoli a Urbino, e smentita da quelli che qualche anno
dopo, ancora studente liceale, compose Nelle nozze della principessa Anna Maria Torlonia col principe Giulio Borghese (2). Questa canzone
nuziale, infatti, che suona del tutto a vuoto finche ripete, senza alcuna
partecipazione, i temi morali tolti di peso al Parini, assume una qualche consistenza quando descrive ?Fonda morta? e ?le pigre acque? delle
paludi; e attinge un minimo di vita fantastica quando l'ampia e imper sonate descrizione, a cui presta tutti i colori la tavolozza pariniana, si
restringe nel triste quadretto dei familiari del ?viator?, morto per ?ma
cerante febbre?, che attendono il loro caro invano:
Ma la cara consorte e il fanciulletto, cui grave il dubbio preme
Talma fedele, ognora
esploravan da tacito poggetto
Pgiu per Taspra discesa ogni sentiero:
(1) II Tasso fu, evidentemente, uno degli autori che piu senti a se consonante il Pa
scoli adolescente. Concorse forse una lettura particolarmente assidua, probabilissima in una scuola di religiosi dell' Ottocento, e soprattutto in una scuola di Urbino, cosi legata a ricordi tassiani. Ma non e facile, anche, distinguere fin dove quella consonanza fu sua e fin dove dell'aria stessa ch'egli respirava: che innumerevoli sono (e non tutte ancora
scoperte) le linfe tassiane che alimentano la cultura e il gusto dei romantici.
(2) V. Poesie varie, nel volume Poesie di G. P., Milano, Mondadori, 1944 (3a edi
zione), pp. 1143-1146. La canzone porta la datar del 24 otlobre 1872: ma e, pensiamo, la data delle nozze: fu scritta quindi poco prima nelle vacanze estive, cioe, quando, termina ta la seconda liceale a Rimini, il Pascoli si preparava a frequentare la terza a Firenze.
This content downloaded from 185.2.32.106 on Mon, 16 Jun 2014 13:01:36 PMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions
Oil ''ESERCIZl,, CIOVANILI DI GIOVANNI PASCOLI $37
e spesso un licto canto in suit'aurora
fingea pietoso inganno al sollecito affanno:
dove, dielro i grezzi leopardismi, si nasconde la dolente memoria di
un'altra attesa incoscia epresaga: quella del poeta ancora fanciullo, che
aspetto invano, con la mamma e i fratelli, il padre ucciso lungo la
strada (1). Memoria dei propri morti e della fanciullezza, che, balenata appena
in questi poveri versi d'occasione, inondera piu tardi Tidillio pascoliano, come la sorgente piu copiosa e profonda della sua poesia. E gia ora
comincia a pullulare fra il cumulo dei residui scolastici e dei nuovi ap
porti culturalistici che la nascondono, nei versi, anch'essi d'occasione,
scritti, non molto dopo, per una fanciulla morta e intitolati Epikedeia (2): in cui, fra i tetri sentimentalismi e gli aridi intellettualismi di derivazione
basso-romantica, si fa strada, sollecitato da un personale ricordo (3), un piu mite e dolce sentimento di rimpianto:
(1) Ruggero Pascoli fu assassinato da ignoti il 10 agosto del 1867, quando il poeta aveva poco piu di dodici anni. E un'eco dell'attesa angosciosa della sua famiglia, redenta
in poesia, e intrecciata ai temi della ?rondine? e del ?nido? gia presenti in questi pri missimi versi giovanili, riaffiora nell'elegia della maturita X agosto (v. Myricae in Poesie
di G. P.t ed. cit., p. 72).
(2) V. Studi Pascoliani, Bologna, 1927, pp. 3-5; e cfr. PETROCCHI, op. cit., pp. 67
70. E una composizione del Pascoli ancora studente, come si deduce dalla scherzosa let
terina in versi che la precede, in cui dice all' amico Marcovigi che, per non respingere
la sua preghiera di scrivere qualcosa per la fanciulla morta, ha dovuto trascurare, ?/'/7o
lico e it latino / componimento ?: e la data piu probabile ci sembra il 1873, quando cioe,
il Pascoli, frequentando la terza liceale non piu in una citta di provincia ma a Firenze,
aveva gia avuto modo di accostarsi a qualche autore contemporaneo, di cui in questi versi si sente, per la prima volta, l'imitazione.
(3) Fanciulla, a diciotto anni, era morta pochi anni prima, nel 1868, anche la sorella
del poeta, Margherita: e la memoria della cara scomparsa lo visita certo mentre scrive.
Piu di un'immagine di questa composizione giovanile ritornera, infatti, nel Giorno dei
morti, che il Pascoli premise (ideale prefazione) alia seconda edizione di Myricae del
1892 (v. ora Poesie di G. P., ed. cit., pp. 3-11). Come la ?fanciulla impaurita? di Epi
kedeia appunto, Margherita,
la pia fanciulla che sotterra, al verno,
si risveglio dal sogno della vita,
e ?trema nella bara sola?; e come sul cimitero di Epikedeia si ab
stroscio di pioggia ed ululi di vento,
. . . scroscia l'acqua: un impeto di vento
squassa il cipresso e corre il camposanto.
Aevum - Anno XXVII - 22
invoca i suoi cari
battono
cosi, a S. Mauro,
This content downloaded from 185.2.32.106 on Mon, 16 Jun 2014 13:01:36 PMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions
338 A. DI PIETRO
Volse clla addietro la smarrita faccia? Chiamo la madre? Tesc a noi le braccia? Ed or che fa? dorme nel buio, o suole pensare a* giuochi ed^all'amore, e al sole?
e una piu tenera e caritatevole pena<:
Da lungo tempo ella cammina: il gelo le sue tenere piante inlividiva:
ella chiamava per Tignoto cielo
la madre, e la sua madre, ahl non l'udiva!
E tu, buon sacerdote, a cui si crede,
dille che la sua madre un di vedra; diglielo ancor se ti fuggi la fede, perche, buon sacerdote, e carital
e un piu sommesso tremore:
Mi trema il cuore, se a quel mondo io penso, di la, misterioso, eterno, immensol
e un piu rassegnato interrogare il mistero, che e ricondotto anch'esso nei termini delT idillio:
In qual lontana sponda a quale ignota gronda, ti piacque il nido pendere che non ne torni ancor?
ma che, nakcondendosi nell' idillio, lo pervade di un accoramento nuovo, in cui e gia il primo seme della sua dissoluzione e del suo riscatto.
* * *
Compiuti gli studi liceali e trasferitosi il Pascoli a Bologna, si apre innanzi a lui il vasto mondo della cultura contemporanea: un mondo in
cui sempre maggior rilievo viene acquistando [la prepotente figura del
Carducci; ma che, non ancora interamente soggetto alia sua dittatura, e
ricco di fermenti e aperto ai richiami piu vari (sui quali non vale la pe na, dopo tanti altri (1), di insistere genericamente qui; anche perche, presi in se stessi, interessano il Pascoli non meno e non piu che
(1) Vedi soprattutto: N. Benedetti, La formazione della poesia pascoliana, Firen
ze, Sansoni, 1934; G. A. Peritore, La poesia di Giovanni Pascoli, Modena, Soc. Ed.
Modenese, 1942; A. Galletti, Pascoli (3a ed.), Milano, Sonzogno, 1945; G. Petrocchi, La formazione letteraria di Giovanni Pascoli, gia citata.
This content downloaded from 185.2.32.106 on Mon, 16 Jun 2014 13:01:36 PMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions
OLI "ESERCIZI,, GlOVANILl DI GIOVANNI PASCOL1 339
ogni altro uomo di cultura del secondo Oitocento italiano). A questi disparati e spesso confusi richiami, di cui solo qualche fievole eco era a lui giunla fra le tranquille pareti del liceo, porge egli attento l'orec
chio; e, dimentico e igrtaro della sua puerile vena idillica rampollata al
l'ombra dei classici, accorre, indifeso, ad ogni invito, in cerca di una
sua strada.
Di questa irrequieta ricerca sono evidenti le tracce nella piu vasta
produzione poetica dei suoi anni universitari. Tracce talora divergenti, che dicono le sue perplessita e i suoi pentimenti; ma che piu contrad
dittorie troppo spesso appaiono, perche solo pochi dei versi da lui allora
composti si possono con sicurezza disporre in una puntuale successione
cronologica, che faccia apparire intera Tintima coerenza del suo pur sinuoso cammino (1). Quei pochi versi tuttavia, anche se non ci per mettono di ripercorrerlo passo passo, non sono del tutto insufficienti a
suggerirci di quel cammino le tappe piu probabili. A seguire le loro indicazioni, non sembra che Tincontro del giovane
studente universitario col suo maestro, Carducci, sia stato subito fecon
do. Nessun segno rilevante di influssi carducciani si trova infatti nei
versi, composti nel 1875, In morte di Angelo Morri (2), che rimodulano
i temi basso-romantici gia presenti in Epikedeia, con una piu fluida e
molle cadenza, in cui gia si annunzia quel gusto della parola ricantata
che diverra poi una delle caratteristiche della poesia Pascoliana. 11 di
stico che apre la composizione:
Chi sa dov'or si trovi il pellegrino che s'e pariito e non ritorna piu?
ritorna come un' eco, infatti, nelF ultima strofa, con un accento impercet tibilmente mutato:
Chi sa dov'or si trovi il pellegrino che s'e partito e non ritorna piu!
Gusto del riecheggiamento della parola che, anch' esso gia avvertibile in
Epikedeia (uella chiamaoa... / la madre, e la sua madre, ah! non V udi
(1) Maria Pascoli ha raccolto, nelle Poesie oarie, i primi versi del fratello, non solo
indiscriminatamente, ma in maniera che lascia piu di un dubbio sull'esattezza delle sue
indicazioni cronologiche: fra i componimenti da lei posti tra il 1872 e il 1880 si trova in
fatti, per esempio, tutto il ciclo dei Miti, di cui almeno Y ultima parte (Crepuscolo) non
fu pubblicata prima del 1886. Ne i versi giovanili editi dallo Schinetti sono, di solito, dalati o cronologicamente ordinati. Fatta quindi qualche rara eccezione, possiamo con certezza
assegnare una data solo ai pochi testi che furono pubblicati dal poeta, man mano che li
componeva, sulle riviste del tempo.
(2) V/Poesie oarie, ed. cit. pp. 1146-47: in calce e segnata la data: 1875.
This content downloaded from 185.2.32.106 on Mon, 16 Jun 2014 13:01:36 PMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions
346 A. DI PIETRO
valry), ritroviamo nella breve lirica Ritornal (1), sospesa al reiterato
richiamo:
se a te giungono umane parole,
ritorna, ritorna, ritorna!
e nel dialoghetto Jago (2), affidato tutto al controcanto dell* ultimo verso
d' ogni strofetta: inconsistent poesiole ambedue, che, per il loro troppo facile romanticismo, ci sembra siano da assegnarsi appunto, all'incirca, allo stesso periodo.
I primi segni dell'innesto della robusta poesia carducciana sul mojle tronco del romanticismo di maniera del Pascoli ventenne appaiono evi
denti nei martelliani di Fantasmagoria (3), pubblicati il 6 maggio 1876, come programma del giornale ?Color del tempo ?:
Color del tempo! il mondo sta sotto il ciel pesante qual sotto il manto eterno gli ipocriti di Dante; vengono per incerte vie coi cappucci bassi,
quasi ladri notturni, gli uomini a lenti passi. E la sui monli come su lugubri manieri
si disegnano in fosco cavalli e cavalieri.
E noi ferisce in fronte la brezza deH'ignoto; e noi fascia di tedio l'afa del terremoto.
Tedio e non pace! II bufalo ritto sul colle aprico
fiuta, mugghiando, il soffio del turbine inimico; tali accasciati aH'ombra d'antiche are e di troni
i lunghi ozi tentiamo con memori canzoni.
Un innesto che e, ancora, piuttosto una commistione, da cui solo per un
attimo sembra levarsi la voce del Pascoli, annunciante un altro dei temi
prediletti della sua poesia: quello delle campane:
..... a un tratto squillaron le campane come se interrogassero le nuvole lontane.
La stessa commistione che troviamo nelle quartine La morte del ricco (4), comparse sul periodico riminese ?IlNettuno? nel febbraio del 1878, do ve perd prevalgono gli elementi basso - romantici e tutto sommerge una
altisonante quanto inespressiva retorica da comizio, da cui si pud solo
salvare quell'attenzione non simulata del giovane autore ai miseri e agli
oppressi, che, mentre da un lato si riallaccia a qualche atteggiamento di
(1) Ibidem, p. 1168.
(2) Ibidem, pp. 1165-6.
(3) Ibidem, pp. 1154-5.
(4) Ibidem, pp. 1155-6.
This content downloaded from 185.2.32.106 on Mon, 16 Jun 2014 13:01:36 PMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions
GLI "ESERCIZI,, GIOVANILI DI GIOVANNI PASCOLI 341
moralismo pariniano della sua adolescenza, precorre, dalTaltro, alia lon
tana, quel senso di umana compassione per gli umili, che sara una delle
costanti deir opera sua nella maturita.
Ma non e sul terreno, a lui straniero, della musa politica e sociale
che l'innesto fra il realismo carducciano e i vaporosi o cerebrali senti
mentalismi degli epigoni romantici pud divenire, per il Pascoli, fecondo. I primi frutti di quell* innesto si trovano infatti nelle liriche che piu lon
tane nascono dal tumulto delle contese civili, in cui pure egli, iscritto
air ?Internazionale?, fervidamente si getta: nelle liriche che scrive, sen
za alcun pubblico impegno, per se, quando rimedita, in solitudine, la
lezione del Carducci e ascolta le voci dei grandi romantici d' ohV alpe o d'oltre oceano, e, corroborato da quella lezione e aperto a nuove
sensazioni da quelle voci, torna a guardare il mondo della natura, che e il suo, e lo pervade delle sue emozioni e lo popola dei suoi ricordi e dei suoi sogni.
E sono frutti che spuntano a stento, come appare da quasi tutte le
composizioni che con piu probability si possono porre in questo perio do (fra il 1875 e il 1877 cioe). Mattino (1), per esempio, in cui alle cantanti sdolcinature dei primi versi fa brusco riscontro il ?forte odor
selvaggio ?
degli ultimi. O Voci misteriose (2), in cui, viceversa, il qua dretto iniziale, carduccianamente concreto e arioso, ma gia pascoliana mente attento alle piu piccole cose e alle piu sottili percezioni:
La nebbia gemica, tira una buffa
ch' empie di foglie stridule il fosso; lieve nell'arida sicpe si tuffa
il pettirosso;
sotto la nebbia vibra il vocale
canneto un brivido quasi febbrile;
sopra la nebbia lontano sale
il campanile;
passo, e precedemi sul limo un gaio stormo di passed quasi irridendo,
si disperde nella tetra vacuita del
. faticato
di pensier torbido cielo d'inverno,
in cui forse Eschilo medito il fato, Dante, 1' inferno,
(1) Ibidem, pp. 1164-5.
(2) Ibidem, pp. 1147-8.
This content downloaded from 185.2.32.106 on Mon, 16 Jun 2014 13:01:36 PMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions
342 A. DI PIETRO
e in cui, poi, repentino e clamoroso, dilaga il ?grido fervido, lungo,
echeggiante? di
Pan per le cedue boscaglie errante
Dio vincitore.
O 11 vento (1), in cui il senso ansioso di indefinito, che il poeta ? non
immemore delle sospese angosce del Poe, da lui letto e tradotto pro
prio in questi anni (2) ? ricava dalF? onda di lamento ? del vento del
Nord ch' ?uria alia porta?, resta circoscritto dalle solide' immagini della ?macchia irta e contorta? e dei ?neri stormi? migranti. E altre
composizioni si potrebbero citare, da Nel bosco (3), a Va Varabo er
rante (4), alia ballata intitolata a Sandor Petofi (5), dove V oscillazio ne del Pascoli, fra una effusa sensibilita romantica e un carducciano senso di eoncretezza delle cose, e evidente e determina spesso una
stridente discontinuity stilistica. Una discontinuity che e anche piu ap
pariscente se si considera, invece del singolo componimento, Tinsieme
della produzione di questi anni, in cui, accanto a liriche pedissequa mente fedeli airesempio carducciano, come // Rubicone (6) e Primavera e poesia (7), si trovano liriche come // vento, appunto, di prevalence derivazione romantica, e Alia luna (8), in cui, Timmagine appena accen
nata di un idillio lunare vapora in inconsistent fantasticherie:
Tutta notte i raggi tuoi
mi seguiro amicamente, le memorie degli eroi
potei legger nel torrente.
Ne' lor gorghi sonnolenti
son sepolte arcane istorie.
(1) -Ibidem, pp. 1159-60.
(2) Come dimostra il tentativo di rifacimento del Corvo del poeta americano, intitolato
dal Pascoli Tenebre, dove compare proprio il tema del misterioso picchio alia porta.
(3) Ibidem, pp. 1149-50. Quattro quartine di questa lirica furono pubblicate nel 1877, col titolo di Rimembranze, in ?Nuovi Goliardi? (vol. I, p. 260).
(4) V. Schinetti, op. cit., p. 388; e cfr. Petrocchi, op. cit., pp. 66-7.
(5) Fu pubblicata nel 1877, in ? Pagine sparse* (serie II, p. 97), e ripubblicata ora dal PETROCCHft op. cit., pp. 62-3.
(6) Poesie varie, ed. cit., p. 1166.
(7) Ibidem, p. 1165; dove e pero intitolata solo Primavera, che e il titolo con cui
comparve il 16 giugno 1882 (il giorno prima che il Pascoli si laureasse) in ?Cronaca bizantina?; ma era gia stata pubblicata nel 1877 su ? Pagine sparse ? col titolo appunto di Primavera e poesia (v. PETROCCHI, op. cit., p. 12).
(8) V, Schinetti, op. cit., pp. 384-5; e cfn Petrocchi, op. cit., p. 65,
This content downloaded from 185.2.32.106 on Mon, 16 Jun 2014 13:01:36 PMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions
GLI "ESERCIZI,, GIOVANILI DI GIOVANNI PASCOLI 343
Quali cose ascolteresti
se tu stessi ad ascoltarl ...
Ma gia una maniera cT incontro piu felice, fra i decisi modi carduc ciani e quelli suggestivamente evasivi dei romantici, e raggiunta in //
Maniero, dove il mondo degli svagati giochi della fantasia, ancorato a un
ricordo non letterario dell'immaginosa adolescenza, e chiuso nei sicuri
confini di un luogo familiare, trova un equilibrio durevole col mondo della realta. Equilibrio che si risolve in un mutuo scambio: per cui, mentre piu ferme diventano le labili immagini delle memorie e dei sogni, meno fisicamente grevi appaiono i profili delle cose:
Te sovente fra i boschi ardui, maniero,
popolai di baroni e di vassalli, e le mie strofe come falchi ai gialli merli strideano e sul terrazzo nero.
Lungo i veiri correa tenue mr leggiero
lume, nitriano fervidi i cavalli, e a uno squillo che uscia giu dalle valli,
apria le imposte il maggiordomo austero;
e sul fosso scendea la fragorosa saracinesca ... Or dove sei, divino
carme, pensato fra Y ombre cadenti?
Sovra i tuoi gioghi la forse, Apennino, in faccia alle solenni albe, pensosa
qualch'elce nera lo ripete ai venti.
E questo sonetto, pubblicato neir aprile del 1877 (1), il primo approdo a cui giunge il tirocinio poetico del Pascoli ormai ventunenne: e ne
ebbe certo coscienza il poeta, se e la prima appunto delle sue com
posizioni che salvo dalla severa condanna con cui respinse quasi tutti
i suoi versi giovanili, e la rielaboro per introdurla nella raccolta di
Myricae. Se, infatti, i temi (dal u maniero ? air
" elce nera?), il metro,
la sonorita deiraccento e la stessa nostalgia dell' evocazione ricordano
insistentemente il Carducci, ad avvertirci che una nuova e piu vibratile
sensibilita si insinua nelle forme carducciane basterebbe quel ?leggie ro / lume? che ?Lungo i vetri correa tenue?, d'una levita incorporea
gia schiettamente pascoliana, e lo sciogliersi del concluso ritmo della
(1) Vedi ?I Nuovi Goliardi? (vol. I, fasc. 3?, p. 124), da cui citiamo; e vcdi quanto differente e questa prima cdizionc dall'ultima quale si legge in Myricae (v. Poesie di G. P., cd. cit. p. 25), neirAPPENDiCE, che, per comodita del lettore, abbiamo posto in fondo a
questo studio.
This content downloaded from 185.2.32.106 on Mon, 16 Jun 2014 13:01:36 PMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions
344 A. DI PIETRO
strofa in piu molli cadenze, reso cvidente dalla frattura improvvisa del
decimo verso (" saracinesca... Or dove sei divino ?) e, ancor piu, dal
susseguirsi degli enjambements, che, appoggiando sempre il peso della
loro inarcatura sugli aggettivi (" leggiero / lume,,, " fragorosa / saraci
nesca^, " divino / carme ?,
" pensosa I... elce?), rivelano, al di la della
piu libera soluzione prosodica, la fondamentale tendenza del poeta a
dissolvere la sostanza delle cose evocate nelle loro qualita acustiche e
visive piu cariche di suggestioni. Tendenza che gia piu chiara si manifesta nel sonetto Lo so..., pub
blicato solo qualche mese piu tardi (1), in cui il ricordo, divenuto, da
spunto, unica fonte dell'ispirazione, immerge le cose sognate e le cose
vedute in un'onda sola di intima dolcezza, e cancella cosi le nitide pro
spettive fra reale e ideale dei pur presenti modelli carducciani, spostan do sempre piu V attenzione del poeta dalle immagini e dalle voci della
realta oggettiva aU'ombra e alPeco che esse hanno lasciato nel cuore:
Lo so, non era nella valle fonda,
suon, quel ch'io udia, di palafreni andanti; era l'acqua che giu dalle stillanti
tegole, in fretta, percotea le gronde.
Pur io vedeva correre giganti in file immense, via, lungo la sponda, ne vedea T ombre galoppar nell'onda, ne vedea le corazze luccicanti.
Cessato il vento poi, non di galoppi suono udia, ne vedea fughe remote
piu, ma voi soli rivedevo, o pioppi;
le grandi teste infondere nel lume
rorido, e ragionar di storie ignote,
lungo la riva del mio dolce fiume.
Processo di riduzione della realta a occasione di liriche emozioni
che, iniziato sotto il segno della memoria della prima eta, gia diventa una caratteristica permanente ed ess^nziale della poesia del Pascoli, se
appare evidente anche quando, abbandonati i suoi personali ricordi, egli tenta, suH'orma del Carducci, la rievocazione storica. Come appunto nel
le quartine su Ghino di Tacco, pubblicate a principio del 1878 (2), dove
(1) Nel fascicolo giugno-luglio 1877 de ?I Nuovi Goliardi? (vol. I, fasc. 5-6, p. 259). II sonetto fu anch'esso rielaborato e introdotto nella raccolta di Myricae, col titolo di
Rio Sa/to: vedi in appendicc, mcssi a fronte, i testi, notevolmente diversi, della prima e
dell'ultima edizione.
(2) Vedi ?Pagine sparse* del marzo 1878; e Poesie varie, ed. cit., pp. 1168-9.
This content downloaded from 185.2.32.106 on Mon, 16 Jun 2014 13:01:36 PMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions
GLI "ESERCIZI,, GIOVANILI DI GIOVANNI PASCOLI 345
il poeta, dimenticata la concreta immagine umana del conte predone, si
indugia sulle cose che lo circondano, trasformandole quasi in simboli della sua presenza leggendaria, con una tecnica che chiaramente prelu de a quella che sara poi codificata nelle pagine sul ?fanciullino?: rive
lando, cosi, come la memoria delFeta puerile, tema prediletto fin dall'a
dolescenza (il tema del ?nido?!) dal poeta, si e ormai cosi affondata
nella sua sensibilita da diventarne la misura costantemente sottintesa, e
la matrice profonda, quindi, della sua poesia. Solo piu tardi in quelle
pagine, il Pascoli dira, infatti, che la poesia e appunto, neiruomo, ?la sua medesima fanciullezza, conservata in cuore attraverso la vita, e
risorta a ricordare e a cantare?: e dira che ?Non sono gli amori... che
premono ai fanciulli; si le aste bronzee e i earn di guerra e i lunghi
viaggi e le grandi traversie? e che dei guerrieri essi ammirano i ?caschi? e le grandi ?aste? che fanno ?una lunga ombra?; ma quella sensibilita
di fanciullo, attratta dagli oggetti piu che dalle passioni degli uomini
adulti, e gia tutta nelle quartine di Ghino di Tacco
Ghino di Tacco usci di Radicofani; l'asta gittava un'ombra lunga al suolo.
Guarda un villan di tra le stoppie e mormora:
quella e l'asta di Tacco e il suo figliuolo.
Dall'antica badia tra i lecci rosea
T abate il vide per la via passare,
Gli nitri sotto il palafren; latrarono nella corte i molossi ed i limieri;
Soffio allor nel gran corno. Ardeva al vespro
la punta della lancia e la celata.
E la meraviglia che levita l'attenzione alle cose propria del fanciullo,
pur senza impegni teoretici, gia prende coscienza di se: ?Vedere e udi
re, altro non deve il poeta?, ?tu sei il fanciullo eterno, che scopre tutto
con meraviglia?, dira ancora nelle pagine sul ? fanciullino ? il Pascoli; ma gia in Primo ciclo (1), composto presumibilmente nello stesso pe riodo di Ghino di Tacco, canta:
Tutto: le stelle e il sole, il piano e i neri monti,
de' venti le parole, il sussurar de' fonti,
(1) V. Poesie varie, ed. cit., pp. 1157-9,
This content downloaded from 185.2.32.106 on Mon, 16 Jun 2014 13:01:36 PMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions
346 A. DI PIETRO
tutto il mio cuore intende, tutto il cuor vede e ascolta
or per la prima volta;
e meraviglia prende a questo cuor, io sento, del suo commovimento.
e questa stupita attenzione, non piu ignara di se, gia si prova a cogliere nelle cose voci impercettibili e nuove:
Tra l'albaspina e il bosso
odo un tinnir leggero come d'un riso...
e da quelle voci gia trae lo spunto per magiche trasfigurazioni:
Dal pioppo anche si scosse
un plauso senza fine
di non so che manine (1).
Trasfigurazioni in tanta parte simili ai recentissimi incantesimi di
Azzarellina (Iside, del Prati, e proprio del 1878) e alle contemporanee fantasie del Graf (Medusa e del 1880); ma da quegli incantesimi e da
quelle fantasie gia tuttavia nettamente distinte per un piu rigoroso con
trollo stilistico, che, attraverso la ricerca della parola piu propria, co
stringe il poeta ad una piu esatta individuazione delle cose e delle
emozioni, difendendolo dalle astrazioni intellettualistiche e dagli ondeg
giamenti di una sensibilita proclive agli abbandoni. E il freno dell'arte
che conservano, come eredita inalienabile del Maestro, tutti i discepoli del Carducci, anche quando, superata la prima pedissequa imitazione, si allontanano da lui per percorrere la loro via, e che nel Pascoli e
reso piu saldo dalla sua ininterrotta consuetudine con gli autori greci e latini. Un freno che a volte contiene la meraviglia del ?fanciullino?
fino a deviarla verso le forme, troppo accorte, di un estetismo predan nunziano (Canto novo, del 1882, e ancora da venire, ma imminente): come in Patuit Dea (2), dove il prodigio della divina apparizione
(1) Questi ultimi versi concludono la parte III del Primo ciclo: parte che il Pascoli stacco dalle altre, per inserirla, come composizione autonoma, nella raccoltina di nove
poesie che pubblico su ?Vita Nuova? del 10 agosto 1890 (A. II, n. 32), col titolo, usato
per la prima volta, di Myricae; non la incluse piu pero nelle successive raccolte di Myricae,
(2) V. Poesie oarie ed. cit., pp. 1151-2.
This content downloaded from 185.2.32.106 on Mon, 16 Jun 2014 13:01:36 PMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions
ULI "ESERCIZI,, GIOVANILI DI GIOVANNI PASCOL1 347
serve solo a orchestrare le voci della natura e a farle risuonare in
un'atmosfera piu tesa:
NeH'aulente pineta le cicale
frinivano. Correa per il terreno
un non so qual baleno
d'orme guizzanti al suon del maestrale.
Ma quando ella v'apparve, ecco il rumore
e il tornear ristette:
molleggio sulle vette sospeso degli arguti pini il vento. Ne ronzar api alle purpuree more, ne zillar cavallette,
ne, simili a saette, schizzar ramazzi nel silenzio intento; s'udi sol l'affannato empito lento
delle ondate alia spiaggia cianciuglianti e su da* palpitanti
vepri un lieve pel cielo frullar d'ale (1)
Ma piu spesso Timpegno stilistico, sotto la suggestione del Carducci minore e dietro l'esempio del condiscepolo e amico fraterno Severino
Ferrari, si fa capacita di cesellare con amorosa cura oggetti consueti e
scenette familiari, come neirEpistola (a Ridwerde) (2), indirizzata appunto al Ferrari, in cui splendono e risuonano, vive, tutte le piccole cose di un nido umano, caldo di affetti:
desti la casa, e un canzoncino spicchi tra l'assiduo fruscio della granata e l'argentino acciottolio dei bricchi;
mentre s'odono intorno le voci di quel nido piu grande che e il proprio
paesello:
L'angelus suona e il sole ai vetri batte
.Vanno a sciami contadine
al mercato cinguettando per via, e chiocciano dalle aie le galline.
(1) II compiacimento estetico, che in Patuit Dea e arginato dal concrete* senso della
natura, si avvia invece verso le forme, solo occasionalmente sperimentate, di uno sterile
parnassianismo del mito Le lacrime di Bacco, composto nell'ottobre del 1878 (v. schi
netti, op. city p. 391; e cfr. Petrocchi, op. cif., pp. 63-4), e nel componimento Dagli
stagni gialli, probabilmente posteriore (fu pubblicato nella ?Cronaca bizantina? del 1?
agosto 1882, ma fu forse scritto qualche anno prima): a provare una volta di piu come
la natura sia sempre V humus piu fertile della prima poesia pascoliana.
(2) V. Poesie varie, ed, cit., pp. 1160-1,
This content downloaded from 185.2.32.106 on Mon, 16 Jun 2014 13:01:36 PMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions
348 A. DI PIETRO
Ma intorno a questi disegni finemente miniati, di scuola carducciana, gia si allargano spazi piu ampi:
II molin romba; e strisciano zirlando
le rondinelle sulle bianche ghiaie. Sul greto, piu lontano, a quando a quando sciabordano in cadenza lavandaie (1).
Spazi interminati che, incurvandosi sulle piccole cose accarezzate dal
poeta, le fanno piu piccole, determinando una doppia prospettiva, dell'in
finitamente grande e delPinfinitamente piccolo, che di per se crea un'at
mosfera di stupore: sia che, in Alba dolorosa (2), il trillo dell'usignolo risuoni piu gracile e, appunto percio, piu magicamente nitido sotto il
cielo dilatato dagli ?estremi albori? lunari:
La luna cala: gli umidi arboscelli scossano lunghi grappoli di fiori, e l'usignolo di tra' pioppi snelli
-tio tio- trilla agli estremi albori;
sia che, nel primo dei Sonetti eterocliti dedicati al Ferrari (3), lo scherzo
letterario delle bestiole grottescamente canore si interrompa improvvisa mente di fronte airimmensita della notte, in cui i canti di quelle minu
scole creature, recuperata per un attimo la loro voce vera, si disperdono, e risuonano insieme piu acuti, e nella loro naturalezza, piu ricchi d'incanto:
Era tutto, da presso e da lontano, uno zillare sotto le rugiade nellMnfinita chiarita del piano.
E lo stupore, che naturalmente nasce dalla simultanea sensazione fisica
di due dimensioni abnormi, si carica di spirituali suggestioni quando,
(1) II tema di questi ultimi versi sara poi ripreso in una delle myricae riunite dal poeta sotto il titolo L'ultima passeggiata (v. Myricae, ed. cit., p. 47): Lavandare; dove
sul cadenzato sciabordio si alza una malinconica cantilena popolare, che si perde, con
echi prolungati, in un paesaggio autunnale:
E cadanzato dalla gora viene
lo sciabordare delle lavandare
con tonfi spessi e lunghe cantilene:
(2) Ibidem, pp. 1167.
(3) Ibidem, pp. 1169-70. Questi sonetti furono scritti intorno al 1878: il primo di essi fu composto infatti, come il poeta stesso avverte Leggendo il "Mago? di Severino Fer
rari e a II Mago? apparve appunto nel 1878.
This content downloaded from 185.2.32.106 on Mon, 16 Jun 2014 13:01:36 PMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions
GLI "ESERCIZI,, GIOVANILI DI GIOVANNI PASCOLI 349
nella prima delle Elegie (1) per esempio, tra i confini immensi del cielo
e quelli, minimi, di un riposto angolo di terra, palpita, memore o sognan te, il cuore del poeta:
nel breve campo ove dormono i miei, ove canta, tra i pioppi, il Lui
udro la guazza con vasto brusio
sulle acacie odorose crosciar,
E sognero nella notte serena
che mi vengono amici a veder;
che fruscia e stride il trifoglio e l'avena
per migliaia di passi legger.
Cosi che si ha talvolta, in questi esercizi giovanili, il chiaro presenti mento di quello che sara il fascino della piii originale poesia pascoliana:
poesia di un mondo di piccole cose, intorno a cui alitano, levitandolo, le ombre di un mondo infinitamente piii grande, popolato di presenze
misteriose.
Ma queste ombre, che' piu tardi tenteranno di allungarsi oltre gli estremi limiti delPuniverso fisico, restano per ora chiuse entro il visibi
le arco del cielo; e le arcane presenze che le abitano, e che vorranno
poi diventare simboli di metafisici messaggi, sono ancora, soltanto, i cari
morti che vengono, in punta di piedi, incontro al poeta, e i fantasmi che
si levano dalle pagine dei suoi libri prediletti, e
... i bei sogni affoltati alia memoria
come al nido le rondini... (2).
E ancora infatti la memoria della prima eta il fulcro della poesia giova nile del Pascoli: e non una memoria remota, quasi interamente dissolta nella prodigiosa sensibilita del ?fanciullo eterno ?, ma una memoria an cora saldamente stretta al nido natio e al chiuso cerchio delle concrete cose che lo compongono, e che costituiscono tutto il mondo, sia pur
trasfigurato da occhi stupiti, d' ogni fanciullo. E se da quel nido il poeta si parte, e sempre per tornarvi, con una tenerezza nuova che fa ognuna di quelle cose piii sua, e sempre per un breve viaggio. Che, quando
troppo si dilunga, gli stessi sogni che insegue si disperdono, quasi privi di meta, innanzi al suo sguardo, come in Echi di cavalleria (3), e crolla
(1) V. Poesie varie, ed. cit., pp. 1152-4.
(2) V. Scoramento, in Poesie varie, ed. cit., p. 1167.
(3) V. Poesie varie, ed. cit., pp. 1170-2.
This content downloaded from 185.2.32.106 on Mon, 16 Jun 2014 13:01:36 PMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions
350 A. DI PIETRO
no vani al primo riapparire delle cose amate, come il poeta stesso con
fessa nella lunga e inconclusa fantasia di Astolfo (1):
Oh patria! o casa piena di bisbigli e d'ombre rosee! In faccia
lieti le stanno i sicomori e i tigli e il gelsomin l'abbraccia;
oh! le aurate fantasime di gloria cadono, nebbie vane;
s'io ne vedo apparir nella memoria
le verdi persiane.
Ed e in questo costante, inevitabile ritorno della memoria alia terra e
alia casa natie il nucleo poetico di Colascionata prima a Seuerino Fer
rari-Ridiuerde, che, composta intorno air'80, ? o giu di li? (2) (e proba bilmente poco dopo), e pubblicata alia fine del 1882 (3), pud conside rarsi la lirica che piu compiutamente riassume i temi e i modi della
giovane poesia pascoliana. I ricordi storici di sapore carducciano, i campi, gli animali che li
popolano, il villaggio, le campane, i pioppi, le rondini, i sogni della fan
ciullezza, il cimitero: tutti i motivi ricorrenti nei versi fin qui scritti dal Pascoli si ritrovano, infatti, nelle quartine di Colascionata prima; e tutti si intrecciano intorno al motivo centrale del ?nido?, e ad esso gradual mente si stringono, con un moto necessario e concorde, in cui e appun to Tintima unita poetica della composizione.
Le briose allusioni all'arte di Severino, con cui la lirica si apre
(Dehl Ridiverde, come io lo vorrei quel ribechino che hi scarabilli, e suvvi tesser fila di trochei, fila d'argento che squilli e scintillil),
lontanissime dal tema dominante (e furono percid poi soppresse), pur
valgono a segnare, evocando il giovanile sodalizio letterario bolognese, la distanza che separa il poeta dalla meta a cui tende il suo pellegri naggio sentimentale. E lentamente, poi, egli sembra avviarsi, lungo la
(1) Ibidem, pp. 1172-9.
(2) Vedi le Note apposte dal poeta a Myricae (ed. cit., p. 1315), dove questa lirica si ritrova, profondamente rielaborata (come puoi osservare sui testi riportati in appendice) e col titolo di Romagna.
(3) In ?Cronaca bizantina? del 1? dicembre 1882 (A. II, vol. Ill, n. 12, p. 92), da cui citiamo.
This content downloaded from 185.2.32.106 on Mon, 16 Jun 2014 13:01:36 PMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions
OLI "ESERCIZI,, OIOVANILI DI OIOVANNI PASCOLl 351
traccia dei suoi ricordi, verso il suo ?bel paese?, che annuncia aH'ami
co, quasi a invogliarlo al viaggio, prima ancora che si veda:
Vorrei menarti nel rnio bel paese cui regno Sigismondo Malatesta;
lo tenne pure il Passator cortese, re della strada, re della foresta.
Ma presto il ?bel paese ? si spalanca ai suoi occhi in una distesa visio ne di terre assolate (in cui tuttavia 1q sguardo si posa qua e la a spiare, con T infantile curiosita di una volta, le piu piccole creature che vi abitano):
Te nelle stoppie, tra cui va chiocciando
con altrui polli la tacchina dotta; te dagli stagni verdegialli, quando vi guazzan lMridate anatre in frotta;
te vorrei convenire, o Ridiverde, e tra foschi olmi, nido alle ghiandaie, vociar Y old / che lungo, alto, si perde dentro il silenzio meridian dell'aje:
una visione che si restringe, man mano che egli avanza (con un rapido
gioco di prospettive, in cui ad aperture solari si alternano ombrosi in
terni), prima intorno ai casali disseminati pei campi:
mentre il villan depone dalle spalle gobbe la ronca, e afferra la scodella, ed il bue ruma nell'opache stalle
la sua laboriosa lupinella;
e poi, sempre piu, alle case del suo borgo natio, raccolte intorno al
campanile:
Da* borghi sparsi Y angelus in tanto si rincorron co' lor gridi argentini; chiamano al rezzo, alia quiete, al santo
desco fiorito d'occhi di bambini;
e infine alia sua casa, e al cantuccio piu appartato di quella casa, che
e il nido piu suo:
Gia m' accoglieva, in quell* ore bruciate,
sotto il trinato ombrello Una mimosa
che fioria la mia casa ai di d'estate
co' suoi pennacchi del color di rosa;
This content downloaded from 185.2.32.106 on Mon, 16 Jun 2014 13:01:36 PMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions
352 A. DI PIETRO
e s' intrecciavan per lo sgretolato muro un folto rosajo e un gelsomino;
guardava il tutto un pioppo alto e slanciato vocale a giorni come un birichino:
nido; da cui volano i sogni, e a cui giungono, ormai di lontano, e biz
zarramente suggestive, le voci della grande pianura assolata:
Io la dentro annidiato crogiolavo le tue stanze, Ariosto, e le tue, Lippi; o alia fatal Sant'Elena esulavo, o rinnegavo la virtu a Filippi;
e udia del grillo in mezzo al pien maggese Targuto quilio sopra i ritornelli, e apprendea de' ranocchi le riprese
strepitanti sul fin'degli stornelli!
Ma, giunto ormai al termine del suo viaggio, il poeta improvvisamente si arresta, e sembra che si interrompa e si capovolga il movimento lirico
della poesia: chePimmagine gioconda del ?nido?, finora amorosamente
inseguita e finalmente raggiunta, bruscamente si disperde nella deserta
vastita di un mondo straniero, e al suo posto rimane soltanto Pangolo buio del cimitero:
Ma da quel nido, rondini tardive,
tutti, tutti sfrattammo un giorno nero:
io, la mia patria or e dove si vive;
gli altri, son poco lungi - in cimitero.
In realta pero P iniziale movimento lirico sotterraneamente continua, per riaffiorare piu intenso, e approdare al suo termine ultimo: al nido delle
memorie e dei sogni che vive indistruttibile, rifugio estremo, nel cuore
del poeta, in cui Paltro nido, quello di terra e di pietre e di fiori di
San Mauro, tutto si raccoglie, e piu luminoso risorge dalP ombra del
?giorno nero?: non piu, ormai, svanita Pillusione del ritorno, ? bel pae se? da riscoprire festosamente con Pamico fraterno, ma ? dolce paese?, tanto piu dolce quanto piu vietato, che Panima porta con se, e in cui, anche se duole come una ferita inguaribile il pensiero degli intrusi, ad
ogni ora, con gioia sempre nuova, si ritrova:
Cosi piu non verro per la calura
tra que' tuoi polverosi biancospini, ch'io non ritrovi nella mia verzura
del cuculo ozioso i piccolini,
This content downloaded from 185.2.32.106 on Mon, 16 Jun 2014 13:01:36 PMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions
On "esercizi,, CioVanili di Giovanni pascoli 353
Romagna solatia, dolce paese cui regnd Sigismondo e Malatesta; cui tenne pure il Passator cortese, re della strada, re della foresta.
II tema del ?suol natio? o del ?nido?, che continuamente ricorre
neir opera giovanile del Pascoli fin dai versi urbinati per Pirro Viviani
e per Raffaello, raggiunge in questa commossa evocazione di San Maurd
la sua prima compiuta espressione: e l'itinerario lirico che, in Colascio
nata, conduce il poeta dal ? bel paese ?, descritto a Severino, al ? dolce
paese ?, che demerge come un canto dal cuore, e quasi simbolo del cam
mino che egli ha compiuto dalle idilliche descrizioni dei suoi primi esercizi alle sue prove piu mature, in cui gli elementi descrittivi comin
ciano a dissolversi in un impressionismo musicalmente suggestivo, che
gia chiaramente addita la piu lunga via che innanzi a lui si apre. La via
che porta per esempio, appunto, a Romagna (1), dove il respiro lirico, che solo verso la fine solleva e trasfigura le immagini paesistiche di
Colascionata, investe, fin dall'inizio, tutta la composizione:
Sempre un villaggio, sempre una campagna mi ride al cuore (o piange) Severino...;
e la via che giunge (per seguire sempre la traccia del grande tema del
?nido?) fino a Ritorno (2), dove Odisseo, in un'assorta atmosfera di
mito, mentre cerca il suo ?nido sospeso alia rupe?, si scopre, ? grigi i ca
pelli e pieni d'ombra gli occhi?, nella fonte Aretusa, e vede in se, e in
se con muto stupore compiange,
la sua lontana fanciullezza estinta.
E Colascionata prima, meglio di ogni altra lirica del Pascoli, pud
porsi a segnare il limite che separa la strada del suo tirocinio, fin qui
(1) La prima redazione di Romagna, che e, come si e detto il rifacimento di Cola
scionata, compare, dieci anni dopo Colascionata, nella seconda edizione di Myricae,
(Livorno, Giusti, 1892, pp. 127-132). Ma molte delle acerbita di Colascionata rimangono in questa prima redazione, che solo piu tardi saranno eliminate dal poeta. Rimangono
infatti immutate le quartine "/o la dentro annidiato crogiolavo...,, e "Ma da quel nido,
rondini tardioe...,,; manca ancora, rispetto all'edizione definitiva, la quartina "E mentre
aereo mi ponevo in via...,,; e, per non dire di minori varianti, la terza quartina si legge cosi:
La nelle stoppie, tra cui va chiocciando
con gli altrui polli la tacchina dotta, la, dagli stagni lustreggianti, quando vi guazzan iridate anatre in frotta.
(2) V. Odi e inni, in Poesie di G. P. ed. cit., pp. 436-446.
Aevum - Anno XXVII - 23
This content downloaded from 185.2.32.106 on Mon, 16 Jun 2014 13:01:36 PMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions
354 A. DI PIETRO
percorsa, da quella delle sue definitive testimonianze poetiche. Compo sta e pubblicata nel periodo in cui egli concludeva, in ritardo, i suoi
studi universitari (1), e Y ultima delle sue composizioni, infatti, che inte
ramente meriti 1'attribute di ?giovanile?, e Y ultima anche, per la radica
le trasformazione a cui sara sottoposta piu tardi, che possa ancora chia marsi ?esercizio?. Iniziata poi la sua vita di professore e ricostruito in
qualche modo, a Massa (2), il suo nido, il poeta si porra con consape volezza e serenita nuove al suo lavoro: e comporra le liriche de L ulti ma passeggiata, che, apparse poco piu di tre anni dopo Colascionata e rimaste quasi del tutto immutate nelle successive edizioni (3), aprono evidentemente un diverso e piu importante capitolo della sua storia
d'uomo e di artista.
APPENDICE
Per comodita del lettore, come si e avvertito, riportiamo qui inte
gralmente, a fronte, i testi di // Maniero, Lo so ... (poi Rio Salto) e
Colascionata prima (poi Romagna), quali sono nella prima edizione
(difficilmente reperibile, ~e di solito trascurata o ignorata anche dai cri
tici) e neirultima: i testi cioe dei versi giovanili che, soli fra tanti, il Pascoli non ripudio e inseri, profondamente rielaborati, nel capitolo Ri cordi di Myricae. Non e qui il luogo per un commento alle varianti, che,
(1) Si laured, ormai nel suo ventisettesimo anno di eta, il 17 giugno del 1882, con
una tesi sulla poesia di Alceo.
(2) Nominato nel settembre del 1882 professore di lettere latine e greche al liceo di Matera, il Pascoli fu trasferito nel 1884 a Massa, dove presto lo raggiunsero le sorelle
Ida e Maria.
(3) Pubblicate la prima volta, in opuscolo, nel settembre del 1886, per le nozze di Severino Ferrari, costituirono poi uno dei gruppi di Myricae (ed. cit., pp. 45-53).
Oltre a quelle de L'ultima passeggiata, ci restano altre liriche scritte dal Pascoli fra il 1882 e il 1886 (v. Poesie uarie, ed. cit., pp. 1181-1196), che non possono conside rarsi tuttavia, per la mancanza d'ogni impegno artistico, ne tentativi, ne, ancor meno, do cument di poesia: sono, la gran maggioranza, piuttosto, delle sentimentali letterine in ver si alle sorelle, che egli non pubblico mai e non ebbe mai intenzione di pubblicare. E se
alcune fanno eccezione (come: Massa, I sepolcri, Scherzo, La gatta, L'amoroso gior nata, Maggio), per il fatto che son tutte non anteriori al 1885, e non sono quindi antici
pazioni delle liriche de I'ultima passeggiata ma composizioni meno felici ad esse con
temporanee, non interessano, sia per i loro limiti cronologici sia per la loro natura, la nostra indagine.
This content downloaded from 185.2.32.106 on Mon, 16 Jun 2014 13:01:36 PMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions
GLI "ESERCIZI,, GIOVANILI Dl OlOVANNI f>ASCOLI 555
apportate in un tempo posteriore a quello da noi assegnato agli * eser
cizi? giovanili, non riguardano la nostra attuale indagine: le sottolineiamo
soltanto, perche, dair immediato confronto piu chiara risalti Tacerbita
delle prime stesure; e ci limitiamo a sottolinearle per quel tanto che
esse sono fisicamente evidenti (tralasciando, per ragioni tipografiche, di segnalare i semplici spostamenti di versi o di parole) perche una di
versa sottolineatura, oltre a sembrarci meno perspicua, implicherebbe
appunto quell* ulteriore discorso critico sugli sviluppi della poesia pa scoliana che esorbita dai limiti del nostro lavoro.
IL MANIERO (1)
Te sovente fra i boschi ardui, maniero,
popolai di baroni e di vassalli, c le mic strofe come falchi ai gialli merli strideano e sul terrazzo nero.
Lungo i vetri correa tenue un leggiero
lume nitriano fervidi i cavalli,
e a uno squillo che uscia giu dalle valli, apria le imposte il maggiordomo austero;
e sul fosso scendea la fragorosa
saracinesca... Or dove sei, divino
carme, pensato fra T ombre cadenti?
Sovra i tuoi gioghi la forse, Apennino,
in faccia alle solenni albe, pensosa,
qualch'elce nera lo ripete ai venti.
LO SO... (3)
Lo so, non era nella valle fonda,
suon, quel ch'io udia, di palafreni andanti;
era l'acqua che giu dalle stillanti
tegole, in fretta, percotea la gronda.
Pur io vedeva correre giganti in file immense, via, lungo la sponda,
IL MANIERO (2)
Te sovente, o /ra boschi arduo maniero,
popolai di baroni e di vassalli, mentre i ialchetti udia squittir su' gialli merli e radendo il baluardo nero.
Pei veiri un lume /rascorrea leggiero, e nitriwano fervidi i cavalli:
a uno squillo che uscia giu dalle valli, apria le imposte il maggiordomo austero;
e nel fosso stridea la fragorosa
saracinesca. Or tu canto divino,
sceso con Y ombre nel mio cuor cadenti,
dove sei? Di tramonti, ora, pensosa
la sur un torvo giogo d'Appennino
qualch'elce nera lo ripete ai venti.
RIO SALTO (4)
Lo so; non era nella valle fonda
suon che s'udia di palafreni andanti;
era l'acqua che giu dalle stillanti
tegole a furta percotea la gronda.
Pur via e via per 1* infinita sponda passar vedevo / cavalieri erranti;
(1) Da "I Nuovi Goliardi?, vol. I, fasc. 3, p. 124.
(2) Da Myricae, in Poesie di G. P., Milano, 1974, p. 25.
(3) Da "I nuovi Goliardi,,, vol. I, fasc. 5-6, p. 259.
(4) Da Myricae, ed. cit., p. 24.
This content downloaded from 185.2.32.106 on Mon, 16 Jun 2014 13:01:36 PMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions
356* A. DI PIETRO
ne yedea Y ombre galoppar nell' onda,
ne vedea le corazze luccicanti.
Cessato il vento poi, non di galoppi suono udia, ne vedea fughe remote
piu, ma voi soli rivedevo, o pioppi;
le grandi teste infondere nel lume
rorido, e ragionar di storie ignote,
lungo la riva del mio dolce fiume.
COLASCIONATA Ia (1) A Seven no Ferrari
Ridiverde
Deh! Ridiverde, come io lo vorrei
quel ribechino che tu scarabilli,
e suvvi tesser fila di trochei,
fila d'argento che squilli e scintilli!
Vorrei menarti nel mio bel paese
cui regno Sigismondo Malatesta;
lo tenne pure il Passator cortese,
re della strada, re della foresta.
Te nelle stoppie, tra cui va chiocciando
con altrui polli la tacchina dotta;
te dagli stagni verdegialli, quando vi guazzan l'iridate anatre in frotta;
te vorrei convenire, o Ridiverde, e tra foschi olmi, nido alle ghindaie, vociar Yolal che lungo, alto, si perde dentro il silenzio meridian dell'aje:
mentre il villan depone dalle spalle gobbe la ronca, e afferra la scodella, ed il bue ruma nell'opache stalle la sua laboriosa lupinella.
scorgeoo le corazze luccicanti,
scorgeuo l'ombra galoppar su//'onda.
Cessato il vento poi, non di galoppi il suono udiuo, ne vedea fremando
fughe remote at dubitoso lume;
ma voi solo vedevo, amici pioppi/ Brusivano soave tentennando
lungo la sponda del mio dolce fiume.
ROMAGNA (2) a Severino
Sempre un villaggio, sempre una cam
pagna mi ride a I cuore (o piange), Severino: il paese ovef andandot ci accompagna
Vazzurra vision di San Marino:
sempre mi torna al cuore il mio paese cui regnarono Guidi e Malatesta, cui tenne pure il Passator cortese, re della strada, re della foresta.
La nelle stoppie dove singhiozzando va la tacchina con /'altrui covata,
presso gli stagni lustreggianti, quando lenta vi guazza /'anatra iridata,
oh I fossi io ieco; e perderci nel verdet e di tra gli olmi, nido alle ghiandaie, gettarci Vurlo che lung/ si perde dentro il merid'iano ozio deira/e;
mentre il villano pone dalle spalle gobbe la ronca a afferra la scodella,
e '1 bue rum/Vza nelle opache stalle
la sua laboriosa lupinella.
(1) Da "Cronaca bizantina,,, A. II, vol. Ill, p. 92.
(2) Da Myricae, ed. cit., pp. 21-23.
This content downloaded from 185.2.32.106 on Mon, 16 Jun 2014 13:01:36 PMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions
GLI "ESERCIZI,, GIOVANILI DI GIOVANNI PASCOLI 357
Da' borghi sparsi gli angelus in tanto si rincorron (*) co* lor gridi argentini; chiamano al rezzo, alia quiete, al santo
desco fiorito d'occhi di bambini.
Gia m' accoglieva, in quell'ore bruciate,
sotto il trinato ombrello una mimosa
che fioria la mia casa ai di d' estate co' suoi pennacchi del color di rosa;
e s' intrecciavan per lo sgretolato
muro un folto rosajo e un gelsomino;
guardava il tutto un pioppo alto e slan
ciato (**) vocale a giorni come un birichino.
lo la dentro annidiato crogiolavo le tue stanze, Ariosto, e le tue, Lippi; o alia fatal Sanf Elena esulavo, o rinnegavo la virtu a Filippi;
e udia del grillo in mezzo al pien maggese
Targuto quilio sopra i ritornelli,
e apprendea da* ranocchi le riprese
strepitanti sul fin degli stornellil
Ma da quel nido, rondini tardive, tutti, tutti sfrattammo un giorno nero:
io, la mia patria or e dove si vive;
gli altri, son poco lungi - in cimitero.
Da* borghi sparsi le campane in tanto
si rincorron coi lor gridi argentini; chiamano al rezzo, alia quiete, al santo
desco fiorito d'occhi di bambini.
Gia m'accoglieva in quelle ore bruciate
sotto Tombrello di trine una mimosa,
che fioria la mia casa ai di d'estate co' suoi pennacchi di color di rosa;
e s* abbracciava per lo sgretolato muro un folto rosa/o a un gelsomino;
guardava il tutto un pioppo alto e slan
ciato
chiassoso a giorni come un biricchino.
Era il mio nido; dove, immobilmente,
io galoppava con Guidon Selvaggio e con Astolfo; o mi vedea presente
V imperatore nelV eremitaggio.
E mentre aereo mi poneva in via
con Tippogrifo pel sognato alone, o risonavan nella stanza mia
muta il dettare di Napoleone;
udia tra i fieni allor allor falciati de' grill/ // verso che perpetuo trema,
udiva dalle rane dei fossati un lungo interminabile poema.
E lunghi, e interminati, erano quelli
ch'io meditai, mirabili a sognare:
stormir di frondi, cinguettio d'uccelli,
risa di donne, strepito di mare.
Ma da quel nido, rondini tardive, tutti tutti migrammo un giorno nero;
io, la mia patria or e dove si vive;
gli altri son poco lungi; in cimitero.
(*) E stampato: ricorron.
(**) E stampato: lanciato.
This content downloaded from 185.2.32.106 on Mon, 16 Jun 2014 13:01:36 PMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions
358 A. DI PIETRO
Cosi piu non verrd per la calura
tra que' tuoi polverosi biancospini,
ch'io non ritrovi nella mia verzura
del cuculo ozioso i piccolini,
Romagna solatia, dolce paese
cui regno Sigismondo Malatesta;
cui tenne pure il Passator cortese,
re della strada, re della foresta.
Cosi piu non verro per la calura
tra quei tuoi polverosi biancospini,
ch'io non ritrovi nella mia verzura
del cuculo ozioso i piccolini,
Romagna solatia, dolce paese,
cui regnarono Guidi e Malatesta,
cui tenne pure il Passator cortese,
re della strada, re della foresta.
This content downloaded from 185.2.32.106 on Mon, 16 Jun 2014 13:01:36 PMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions