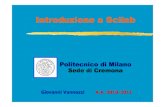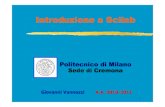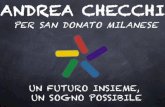Francesca Vannozzi Sez. Storia della Medicina Università … sdm/files/u_arte_empirica.pdf ·...
-
Upload
nguyenkhanh -
Category
Documents
-
view
219 -
download
6
Transcript of Francesca Vannozzi Sez. Storia della Medicina Università … sdm/files/u_arte_empirica.pdf ·...

1
Francesca Vannozzi Sez. Storia della Medicina Università degli Studi di Siena “ Dall’arte empirica alla sperimentazione sistematica: il ‘nuovo’ medico del Settecento riformatore”
Nel Settecento, le povere condizioni di gran parte della popolazione e la diffusione di gravi malattie endemiche o epidemiche insieme a nuove patologie non meno temibili, sono ancora le due condizioni principali di sollecito ad interventi di carità, beneficenza e assistenza ospedaliera, già quest’ultima inquadrabile nell’ambito di una organizzazione sanitaria deputata alla cura. Medico fisico e chirurgo vi ricoprono infatti ruoli sanitari ben codificati dagli statuti ospedalieri, pur riservando loro anche un sotteso compito di vigilanza, specie verso quegli ‘indesiderabili’, quali gravide occulte, tignosi e pazzi, accuratamente confinati in zone ghettizzate rispetto alla benpensante collettività. Pur rimanendo forte l’intervento assistenziale, in esso si intravede oltre al momento del controllo, quello del tentativo di rimuovere le cause del disagio sociale e sanitario, in rapporto ad una scienza medica nuova che si va formando.
Del resto, ai medici non possono sfuggire i fattori favorenti la malattia, insiti nelle condizioni di lavoro improbo e nella vita miserabile, che cominciano ad esser visti come problemi di rilevanza sociale.
La medicina del XVIII secolo, risente dei fermenti e delle riforme politiche, sociali ed intellettuali che caratterizzano il periodo fino agli anni della Rivoluzione Francese. Fatti storici di grande importanza, scoperte e invenzioni scientifiche, pratica di cura intesa modernamente, “fanno” la scienza medica del Settecento, che in tutta Europa porterà alla critica illuministica della medicina della tradizione.
Esempio di questa maggior sensibilità al disagio sociale è, in Toscana, il medico Vincenzo Chiarugi (1759-1820), che ricopre a Firenze, prima in modo provvisorio poi definitivo nel 1817, la carica di Soprintendente degli Ospedali Riuniti di S. Maria Nuova e Bonifazio, sostituendo Pasquale Bolli, deceduto nella tragica epidemia di tifo petecchiale che, preceduta da una grave carestia in concomitanza alle più generali condizioni di miseria, aveva determinato nel periodo primaverile una grande quantità di decessi nella campagna fiorentina e nella stessa città (1).
Ma l’importante ruolo di massimo referente dell’autorità sanitaria fiorentina, gli viene dalla pregressa sua esperienza maturata presso l’Ospedale di Bonifazio dove, oltre a questioni di cura, si era occupato anche di organizzazione sanitaria nell’ambito dell’assistenza al malato di mente, che gli consentiranno di pubblicare a fine Settecento i due famosi trattati Della pazzia in genere e in specie (1793) e il Saggio teorico-pratico sulle malattie cutanee sordide (1799). Professore di Medicina e Chirurgia nel Regio Spedale di Bonifazio, egli aveva osservato scrupolosamente i pazienti ivi ricoverati onde poter far chiarezza non solo sulle origini della malattia di mente, ma anche sulla grande vastità di patologie cutanee che “vennero poco osservate, e furono in conseguenza descritte con oscurità, e confusione” (2).
Tale esperienza gli consente così di delinearne “la Genesi, la Natura, le Cause, il Trattenimento Generale e particolare colla scorta soltanto dell’Osservazione” (3).
Sono i “fatti osservati” che in Chiarugi sostituiscono le inutili “ipotesi ed ogni congettura”, a indirizzare verso la corretta diagnosi. Ma le modalità del suo innovativo essere medico vanno anche riferite alla formazione, teorica e clinica, ricevuta in quel vasto ambito culturale della medicina toscana in epoca lorenese. Non a caso, Chiarugi vive quale giovane medico appena venticinquenne le conseguenze del Regolamento del 1784 che reimposterà integralmente l’assetto amministrativo del Santa Maria Nuova. Ed è in tale vivacità riorganizzativa, sia nei confronti della struttura, che del personale sanitario e dell’assistito, che va interpretato il suo innovativo approccio verso il malato di

2
mente, che lo porterà ad assumere l’incarico granducale per lo studio del riassetto strutturale del Bonifazio, quale luogo idoneo al ricovero del pazzo e dell’affetto da patologia cutanea.
E da una più attenta considerazione del malato deriva anche la necessità dell’introduzione di norme igieniche, inquadrabili in una strategia sanitario-organizzativa finalizzata anche ai malati ‘cronici’, i dementi, un tempo destinati ad essere solo emarginati in un “reclusorio”, come quello fiorentino di Santa Dorotea, utilizzato fino al 1788 e poi soppiantato dal Bonifazio.
Della pazzia in genere ed in specie è certamente scritto da Chiarugi per avallare, sempre sull’esperienza di personali osservazioni, una moderna e diversa impostazione nei confronti della malattia mentale, che ben si inserisce nel panorama di cambiamento economico e di riforma sociale fortemente sostenuto dalla politica del Granduca Pietro Leopoldo. E Chiarugi è solo uno dei tanti esempi di ciò che ha significato la medicina e l’essere medico nel Settecento in Toscana.
Il medico dunque dell’ospedale non è il curante di ricchi, nobili e sovrani, perché l’ospite abituale dell’ospedale rimane comunque l’indigente, che vi approda essenzialmente per bisogno di cibo, ricovero, accoglienza, dalle cui privazioni derivano le stesse sue malattie. Vitto e alloggio valgono di più dei farmaci per una popolazione giunta al ricovero da una infermità comunque sempre associata a cronica miseria.
In tale realtà, va inserita anche l’attività del medico condotto o medico ‘comunale’, già disciplinata in Toscana dagli inizi del secolo. Una medicina anch’essa rivolta al povero e probabilmente ‘fatta’ anche di cose povere, ma non aliena da innovazioni scientifiche, quali la pratica dell’innesto del vajuolo che nella seconda metà del XVIII secolo è largamente diffusa nel senese tanto da costituire il tema del primo tomo degli Atti dell’Accademia delle Scienze detta de’ Fisiocritici di Siena (1761), raccolta di scritti medici su “una delle più utili scoperte che si sieno mai fatte in prò della Umanità” (4).
Persino l’ospedale cittadino di Siena, il Santa Maria della Scala, sceglie per i propri ‘gittatelli’ di avvalersi di esperti ‘chirurghi d’innesto’, per una sorta di inoculazione sperimentale che inizia il 1° ottobre del 1755 su tre esposti. Tale decisione istituzionale induce a molteplici riflessioni: sull’importanza di una pratica medica condotta a livello personale e maturata nel tempo, che porta ad una riconosciuta perizia, quasi ad una sorta di specializzazione, quella appunto di ‘medico innestatore’; ma anche sull’attenzione del Governo stesso a quelle condizioni sanitarie della città che, compromettendo gravemente la salute dei cittadini, richiedono l’intervento del medico per la loro risoluzione.
L’esperienza medica delle condotte rurali, a contatto con il mondo dei lavoratori delle campagne, nel quale lasso è il confine tra miseria ed indigenza, certamente è di stimolo a quel passaggio del concetto di malattia da condizione ineluttabile a patologia curabile, dipendente da uno specifico ambiente sociale, che sia il lavoro stagionale nelle zone malsane della Maremma o l’infortunio riportato nella bottega artigiana o nell’attività estrattiva in miniera, il tutto da inquadrare in una politica della salute che nel Settecento va sempre più delineandosi e che si basa essenzialmente sul dato della ripetuta osservazione medica.
Sempre più frequente diventa infatti per il medico rilevare quei fattori sociali che causano malattia, per la quale diventa più facile prevedere l’adeguato intervento terapeutico. Da tale cambiamento, che vede sempre più il medico quale soggetto di una pratica clinica, in un contesto quindi empirico della medicina, ma avvalorato dall’osservazione, che scaturisce anche l’esigenza di migliori ambienti ospedalieri, rinnovati per condizioni di aria, luce, spazio, igiene concesse dalle ristrutturazioni dei grandi ospedali europei nel Settecento.
E questa sensibilità al sociale da parte del medico, può anche spiegare una sua maggiore coscienza politica, riscontrabile in molti medici specie dalla seconda metà del XVIII secolo, con una personale partecipazione alle vicende politiche del momento. Valga di esempio l’anatomista Paolo Mascagni (1755–1815), figura ricca e completa di uomo di scienza tra Sette e Ottocento, con una vita fortemente connotata anche dall’impegno politico, che gli costò duri mesi di carcere. Le malattie degli strati più deboli della popolazione suggeriscono infatti alla classe dirigente problemi che solo l’impegno congiunto del medico e del politico potrebbero risolvere.

3
Ma la figura di Mascagni ben si presta a spiegare anche quella che comincerà ad essere una diversa modalità nell’esercizio della professione, che richiede, per essere ben svolta, l’obbligata scelta tra attività didattica, ricerca e cura del paziente. Il “principe degli anatomici” rinuncia infatti “di applicarsi alla Clinica” per dedicarsi esclusivamente a “soddisfare i doveri sia della Cattedra che della ricerca della Scienza Anatomica”: è il primo anatomico a non dedicarsi all’esercizio della professione medica in nome della ricerca e dell’insegnamento (5). E per meglio formare il medico, essenziale è il cambiamento nel suo percorso formativo, che prevede non solo la pratica al letto del malato, ma anche frequenti esercitazioni in aula con modelli, manichini, tavole didattiche. Per far fronte a tali nuove esigenze didattiche, i grandi atenei si arricchiscono di sussidi ormai indispensabili all’insegnamento e apprendimento, specie per l’anatomia e l’ostetricia. Così, come Paolo Mascagni a Firenze appronta le 44 tavole a grandezza naturale del fastoso atlante di anatomia, l’Anatomia Universa; così a Bologna Giovan Antonio Galli fa costruire “le macchine de’ parti”, utili per una ‘ostetricia sperimentale’ da insegnare a studenti di medicina e allieve ostetriche e che sarà di modello per molte altre collezioni ostetriche settecentesche, in cera e terracotta, oggi presenti in molti musei universitari italiani. L’insegnamento medico-chirurgico fa così ingresso nelle corsie, scuole, accademie, e cattedre sono istituite in Italia ed Europa a partire soprattutto dalla seconda metà del secolo. La nuova prospettiva scientifica accantona progressivamente la fede nei precetti, a favore degli esperimenti condotti in laboratorio, nella sala anatomica e nell’orto botanico.
L’iconografia scientifica da elemento di abbellimento dei testi medici diventa loro corredo essenziale, strumento insostituibile per l’apprendimento della disciplina. Non a caso, il grande Mascagni, per il suo Vasorum Lymphaticorum (1787) (6), si premura perché Ciro Santi, scelto dal docente per l’alta sua precisione nella raffigurazione e che curerà la parte iconografica dell’opera, predisponga particolareggiatissime incisioni su lastre di rame non solo degli organi iniettati con il mercurio per evidenziare i linfatici, ma anche dei preparati istologici del tessuto linfatico, che Mascagni aveva approntato e osservato al suo microscopio di manifattura inglese tipo Dollond (7). Le recenti elaborazioni dottrinarie non possono infatti fare più a meno della ricerca e della sperimentazione e degli strumenti che la consentono.
La stessa figura dell’ anatomista non è più ritratta lontano dal tavolo dell’autopsia, sul quale in precedenza operava solo il ‘tagliatore’, spesso sotto le direttive di un ‘indicatore’, tramite tra docente ed esecutore della dissezione. Il “principe degli anatomici” Paolo Mascagni, per la sua Grande Anatomia (1823-1831) (8), sezionerà personalmente centinaia di cadaveri e studierà i tessuti del corpo umano avvalendosi di lenti semplici e microscopi portatili, che consentiranno ai disegnatori di realizzare le mirabili 44 tavole a dimensioni naturali dell’opera (9).
Ma il mondo culturale del giovane Lettore di anatomia nel periodo del suo insegnamento nell’Ateneo senese non è solo quello della didattica, ma spazia in un complesso panorama di interessi scientifici che non escludono anche il forte impegno politico. L’albero della libertà issato al centro di Piazza del Campo a Siena nei pochi giorni di dominio francese della città, appartiene ad un cerimoniale pubblico che lo stesso Mascagni promuove quale membro del governo di Municipalità, al quale partecipa in qualità di Delegato alla Vigilanza degli Istituti di Istruzione e di Pubblica Beneficenza. Il 18 aprile 1799, è infatti istituito il Comitato d’Istruzione che “avrà per oggetto l’esaminare e proporre i mezzi che crederà più espedienti e efficaci per animare, proteggere e propagare l’Agricoltura, le Arti, il Commercio, le Scienze ed altri stabilimenti tendenti all’utilità pubblica” (10).
Ed è il Mascagni docente, ma anche agronomo, scienziato, sperimentatore, che è chiamato a sovrintendere tale Comitato, nell’intento di promuovere un rinnovamento nell’intera società. È l’uomo di scienza al servizio dell’utilità pubblica che si impegna a sconfiggere le arretratezze, la povertà, l’ignoranza ancora così presenti nella società civile di fine secolo.
All’ambiente ospedaliero nel quale il medico è inserito in un sistema di cura pur sempre in ambito benefico-assistenziale, all’accademico dove l’insegnamento sempre più si avvale della esercitazione e della sperimentazione, alla condotta rurale dove alla prestazione sanitaria si

4
aggiunge l’attenzione anche alle condizioni igienico-sanitarie, si offrono al medico del Settecento anche le nuove discipline dell’arte, prime tra tutte l’ostetricia.
A fine secolo, la ‘medicina delle donne’ va infatti a trasformarsi completamente, strutturandosi progressivamente in ‘arte medica’ che come tale richiede una adeguata istruzione, diventando di competenza maschile: dalle mani della comare al forcipe del ‘maestro de’ parti’.
Così, mentre il primo incarico dell’insegnamento dell’ostetricia nell’ateneo senese è conferito nel 1774 a Giacomo Bartolomei, già docente di Medicina Pratica, i successivi Lettori saranno per oltre un secolo scelti nell’ambito chirurgico, perché all’ostetrico è richiesta innanzitutto ‘abilità di mano’. Il successore del Bartolomei nel 1776 sarà infatti il chirurgo Alessandro Felici, già settore anatomico, al quale lo Studio consegnerà ufficialmente lo strumentario utile al suo esercizio all’Ospedale Santa Maria della Scala: tirateste, tenaglie, leve, uncini, siringhe, nonché una serie di figure di ‘creta cotta’ per la didattica ostetrica.
La costante presenza di una strumentazione ostetrica all’interno di quella chirurgica settecentesca è un buon tramite per capire l’estensione della competenza del chirurgo al settore dell’assistenza al parto. Lo strumento di elezione dell’ostetricia, il forcipe, insieme a dilatatori, pinze, uncini e altri ferri embriotomici, compare infatti obbligatoriamente nella strumentazione medica quasi a rafforzare l’obbligatorietà del ricorrere al ‘medico ostetricante’ nei casi di parti ‘difficili’. Con l’intenzione di regolamentare la professione della levatrice, conferendole l’adeguata istruzione e togliendo dalle mani della ‘mammana’ la puerpera e il nascituro, l’istituzione delle prime scuole pubbliche di ostetricia diventano anche l’occasione per ben delimitare l’operato della levatrice rispetto a quello del medico, in una totale subordinarietà della prima rispetto al secondo, posizione che diventerà nei secoli definitiva. Adducendo infatti la maggiore istruzione e quindi competenza del medico e la non facile manipolazione degli strumenti ostetrici, spesso pesanti e ingombranti, la figura maschile del chirurgo avoca a sé il diritto all’assistenza al parto ‘laborioso’, al quale sarà poi chiamato solo il ‘maestro de’ parti’ o chirurgo ostetrico o medico ostetricante.
La “Aedibus parturientium”, ospizio o ricovero o asilo o casa di maternità, dove sono accolte la ‘gravide occulte’, diventa dal Settecento la ‘palestra’ ostetrica e quindi la scuola per una didattica per giovani studenti di medicina e allieve levatrici, fatta anche su modelli ostetrici in terracotta o cera, marchingegni in legno che simulano il bacino muliere con utero in cristallo e fantoccino di pezza, ma senza disdegnare le esercitazioni sul cadavere della donna e del feto (11).
L’ostetricia, bisognosa di tante nozioni teoriche quanto di tirocinio, trova nelle scuole di ostetricia che fioriscono in Italia dalla prima metà del XVIII secolo, un corpo docente medico specialistico, pur ancora pienamente di formazione chirurgica (12).
Anche in Firenze, presso il Conservatorio di Orbatello, ricovero per le povere vecchie e per le ‘disgraziate pericolate’ o gravide occulte, è fondata una scuola per l’istruzione ostetrica per chirurghi e levatrici, istituita a seguito del Motuproprio del 23 maggio 1763 promulgato per far fronte alle condizioni deplorevoli in cui versava l’ostetricia sotto il Governo Mediceo. La Scuola era infatti necessaria “allo studio dell’arte dell’allevatrice” e a quello dell’ostetricia per i “giovani di medicheria e di Camposanto, convittori in Santa Maria Nuova” (13).
Solo pochi anni dopo, con decreto granducale del 1773, viene allestita presso lo stesso Arcispedale di Santa Maria Nuova un apposito locale per le partorienti povere, utile per “l’istruzione pratica delle ostetriche del Granducato”, chiamata camera di S. Filippo, con l’assegnazione di un posto di ostetrico che dal 1783 sarà Francesco Valle, Lettore di Ostetricia nell’Arcispedale e maestro di ostetricia pratica.
Dal 1815, la sala diventa Ospizio di Maternità, con il fine: “di provvedere tutte le comunità della Toscana di abili ed oneste levatrici onde affidino e tutelino così il proprio servizio ostetrico” (14).
Da segnalare inoltre come dal 1776 fosse operante anche la condotta ostetrica in ogni quartiere di Firenze, fatta da una levatrice e da un chirurgo aiutato dal migliore dei suoi studenti di chirurgia (15).

5
È comunque quale branca della chirurgia che l’ostetricia si avvia verso il lungo cammino dell’autonomia disciplinare, tanto che per più di un secolo il Lettore di ostetricia sarà scelto tra i chirurghi più esperti.
Anche la stessa chirurgia nel Settecento trova una diversa apertura, che porterà l’arte verso il cammino di una sua progressiva qualificazione, fortemente e a lungo ostacolata dai medici-fisici, che rivendicano la propria supremazia scientifica sull’esercizio pratico, ritenuto carente di quel retroterra culturale che affonda le proprie radici nei testi classici. In realtà, già dalla fine del XVII secolo si era assistito “ad una inversione di quelle tendenze che fin dal medioevo avevano garantito il predominio della medicina teorica e il disprezzo per la pratica chirurgica” (16).
La richiesta di una preparazione più impegnativa per il riconoscimento del nuovo ‘status’ professionale del chirurgo che lo avrebbe sempre più distanziato dal barbiere, sollecita in Europa la nascita delle grandi scuole di chirurgia: dalla famosa Acadèmie Royale de Chirurgie di Parigi alla Scuola di Würzburg e alle cattedre e scuole italiane, come la chirurgica dell’Ospedale Santa Maria Nuova di Firenze con Antonio Cocchi (1695–1758) e Angelo Nannoni (1715-1790).
Come il Lettore di Medicina, raffigurato nei frontespizi dei testi del passato assiso su uno scranno, coinvolto nell’attenta lettura dei testi aristotelico-galenici, ben distante dal bisognoso di cure, ‘scende’ al livello del malato per assisterlo, attento alla narrazione della sua malattia, alla descrizione dei sintomi, all’osservazione dei segni; così il chirurgo si dota di un personale armamentario, sempre più ricco di nuovi ferri, meglio forgiati, raffinati, fatti di materiali scelti, di tipologia quanto mai varia perché specifici di un intervento. Si tratta di una cultura operatoria che si forma sui progressi della medicina meccanica, chimica, di microscopia applicata alla ricerca e all’anatomia, che pertanto richiedono per la didattica di testi moderni, tavole aggiornate, strumentazione varia e maneggevole.
I nuovi termini del linguaggio chirurgico dell’Encyclopédie (17) si avvalgono di illustrazioni che con sempre più frequenza compariranno nei correnti volumi della disciplina. Le cassette chirurgiche sono organizzate e suddivise per tipologia di strumenti specifici di un unico intervento operatorio o per interventi d’organo. La chirurgia professionale settecentesca si avvale dell’insegnamento in Scuole apposite, create per impartire le modalità dell’intervento alla luce delle innovazioni della medicina operatoria, che soprattutto grazie alle conoscenze di anatomia e fisiologia, ad una maggior abilità manuale dovuta all’esercizio, ad una migliore strumentazione è disciplina regolata da precise regole di insegnamento.
Il chirurgo settecentesco, non più barbiere o flebotomo, è uomo di scienza, d’arte e di mestiere e assume in sé i tre ruoli perché in possesso di precisi requisiti: cultura, padronanza di nuove tecnologie d’intervento, strumenti chirurgici quanto mai raffinati (18).
È in tale nuova configurazione della disciplina operatoria che si inserisce pienamente l’opera del medico personale dell’Imperatore Giuseppe II a Vienna, il chirurgo pavese Giovanni Alessandro Brambilla (1728–1800), che lascia un volume, Instrumentarium Chirurgicum militare Austriacum (1780, 1° ed., 1782 2° ed.) e una raccolta di cassette didattiche di chirurgia. A dimensione naturale sono gli strumenti delle sessantacinque tavole del volume, corredate dal testo con la descrizione di ogni singolo ferro, quale sussidio didattico chiaro ed essenziale per lo studio dell’arte chirurgica. Ma non solo, perché Brambilla, sempre per favorire l’apprendimento, fa costruire anche tre armamentari didattici, compendio essenziale per gli studenti di medicina che, come affermerà nel 1850 Malgaigne nella Prefazione del suo Manuale di medicina operatoria, devono impratichirsi di quella “chirurgia che deriva dall’opera della mano e dall’applicazione degli strumenti” (19).
La raccolta madre è predisposta per l’Accademia medico-chirurgica militare di Vienna, scuola in cui insegnava Brambilla, dal 1783 professore di Operazioni Chirurgiche, Ostetricia e Chirurgia legale, e che rilasciava il diploma di maestro o dottore in chirurgia, necessario per esercitare la libera pratica “in ogni luogo, così nel civile, come nel militare” (20).
Brambilla, sempre nell’intento di una riqualificazione della professione, è convinto sostenitore di una “chirurgie-mèdecine”, secondo cui ogni medico deve saper passare dalla teoria alla pratica non solo descrivendo, ma eseguendo operazioni chirurgiche, con la conseguente

6
obbligatorietà per la chirurgia di far parte dei programmi didattici di ogni studente di medicina, impostazione che egli con tenacia contribuirà a diffondere nella cultura medica viennese (21). Ancor più a ragione, nel suo “Discours sur la prèminence et l’utilitè de la chirurgie” (1768), Brambilla non si esime nel sostenere con forza la priorità della chirurgia sulla medicina, rifuggendo la pratica dei barbieri.
Oltre che di cere anatomiche, giunte a Vienna nel 1786 da Firenze dove aveva sovrinteso la loro fattura Felice Fontana (1730–1805), il Gabinetto dell’Accademia Chirurgica è pertanto provvisto di cassette di chirurgia riservate sia ad una serie di strumenti specifici (“cucurbitae et scalpella”, “catheteres et syringa”, “trapanum”…), sia ad un set utile ad una tipologia di intervento d’organo (“pro cataracta”, “pro fractura crani”…), sia infine a tutta la strumentazione necessaria per uno specifico intervento (“pro partu”, “pro iniectione”, “enterenchytae”…). Analoga la collezione fiorentina, meno ricca di strumenti della viennese, ma completa per l’esecuzione della chirurgia dell’epoca praticata al Santa Maria Nuova. Sicuramente imputabile alla straordinarietà della collezione, l’attenzione che lo stesso Chiarugi presta nel 1818 nel predisporre il relativo catalogo a stampa, provvisto delle piante dei 30 + 5 ripiani delle cassette della raccolta, dove ogni pezzo è contraddistinto da un numero per poter risalire alla “di lui natura, e spesso ancora secondo il di lui uso, ed Autore”, quale spiegazione del disegno dell’annessa tavola dell’edizione latina dell’Instrumentarium (22).
La raffinatezza della collezione e l’ampia tipologia negli strumenti ben testimoniano il livello raggiunto nell’intervento chirurgico: - nella modalità e tecnica delle nuove operazioni; - nel perfezionamento degli interventi già da tempo praticati, quali la litotomia o l’operazione
della cataratta con estrazione del cristallino; - nell’estensione della chirurgia a settori di nuova competenza, come l’assistenza al parto con
l’uso del forcipe; - nella evoluzione tecnologica della strumentazione chirurgica, con la scelta di materiali
innovativi, quali la ‘resina elastica’ o caucciù, già utilizzato dal Brambilla, o argento e altri metalli per evitare che il ferro si arrugginisca nel tempo. Nonostante i grandi progressi compiuti dall’arte operatoria, nel Settecento non è però ancora
superato appieno il conflitto tra chirurgo e medico, tra un lavoro prettamente manuale e quello teorico del medico-fisico. A fine secolo, ancora i chirurghi dovranno insistere per riscattare la propria professione da un perdurante stato di inferiorità, avallato dall’antico tabù religioso della sacralità del corpo insieme al disprezzo per l’intervento medico solo manuale. Ma, la di là dei conflitti corporativi, certamente forte è la spinta verso una sempre maggiore apertura nei confronti del nuovo sapere, che va dall’anatomia alla fisiologia, dalla medicina chimica a quella meccanica, con conseguenti ripercussioni sulle scelte terapeutiche del passato e più in generale sull’incontestabile rinnovamento della medicina. L’influenza dell’anatomia patologica e della sperimentazione elevano il campo operatorio, ormai lontano dall’empirismo. In tale panorama si configura anche l’esigenza di una diversa formazione e organizzazione per una moderna classe medica, “contro la chiusura e la routine delle èlites di consiglio e di collegio” (23).
Con il fine di dare uno ‘status’ preciso alla professione, anche l’Ospedale di S. Maria Nuova a Firenze avvia con Cocchi e Nannoni la già citata scuola di chirurgia e l’apprendistato chirurgico nel Regio Spedale entra a far parte delle scuole cittadine della Facoltà di Arti, che, distinta dalla Facoltà superiore di Medicina dello Studio, integrano e duplicano le scuole propedeutiche della Facoltà filosofica pisana. Cocchi, colta figura ricca di esperienze acquisite in lunghi viaggi all’estero, tiene lezioni di anatomia nell’ospedale fiorentino per gli studenti interni ospedalieri e dimostrazioni pubbliche sul cadavere “per la maggior soddisfazione di chiunque si diletta di questo studio" (24).
In realtà, i suoi esercizi anatomici sono più dissertazioni scientifiche rivolte ad un pubblico accademico, che sperimentazione vera e propria e risultano avere una forte azione di propaganda nei confronti della propria attività medica, consentendogli di incrementare notorietà e

7
conseguentemente sia clientela che discepoli. La figura di Antonio Cocchi ben rappresenta quindi quella del medico che, nonostante gli impegni politici e didattici, non trascura la pratica privata della professione, attento al proprio ruolo all’interno della società e quindi interessato alla promozione della propria immagine: un “dovere di convenienza” l’essere professore privato di medicina e pubblico di anatomia, nonché esperto e quindi consulente di questioni di sanità pubblica, come l’igiene ospedaliera o la medicina termale. Rilevante è comunque per Cocchi l’aspetto dell’esperienza anatomica nella formazione del medico. È infatti con il confronto tra dati autoptici e sintomi nel vivente, con la ricerca del rapporto causale tra lesioni anatomiche degli organi affetti e malattie, che l’autopsia diventa strumento essenziale per riconoscere le patologie. Sul tavolo anatomico sono messi in evidenza i quadri morbosi, identificati da precise lesioni d’organo: è il connubio tra anatomia e pratica clinica.
Il chirurgo ospedaliero al tavolo anatomico non solo insegna l’anatomia del corpo umano, ma offre anche l’opportunità allo studente di constatare la corrispondenza tra sintomo e lesione anatomo-patologica, nonchè di impratichirsi dei più complessi interventi operatori.
Secondo tale emergente orientamento di apprendistato chirurgico in accademie mediche o nelle scuole chirurgiche ospedaliere sorte attorno a figure di rilievo, si inquadra anche il metodo di insegnare l’arte ostetrica non tanto con modelli didattici, quanto tramite esercitazioni sul cadavere di donna e di feto.
Che ormai sia imperante una nuova tipologia di medico, nata dall’arricchimento delle teorie con la pratica, è ben evidente anche dagli insegnamenti accademici che, ad esempio per l’Università di Siena, erano di Medicina Teorica, Medicina Pratica, Anatomia, da inizi secolo al 1743, anno nel quale a seguito della nuova riforma degli studi universitari, si aggiunge l’insegnamento della Chirurgia. Con l’insegnamento dell’ostetricia dal 1774 e la regolamentazione a seguito del Motuproprio del 4 aprile 1780, le cattedre rimarranno invariate per tutto il secolo: Medicina Teorica insegnata nella sede dell’Università, cioè la Sapienza, mentre Istituzioni Chirurgiche, Ostetricia, Anatomia, Medicina Pratica presso l’Ospedale Santa Maria della Scala per favorire “i Giovani Studenti perché possano più facilmente combinare i Precetti con le osservazioni” (25).
In particolare, con la Medicina Teorica e Pratica, l’insegnamento della patologia si arricchisce di esercitazioni diagnostico-terapeutiche e anatomo-patologiche. La storia anamnestica al letto del malato, l’esame degli infermi, la ricerca dei sintomi delle malattie e la diagnosi differenziale, insieme alle esercitazioni nell’anfiteatro anatomico della dissezione dei malati giunti a morte, inducono lo studente di medicina ad una frequentazione assidua dell’ambiente ospedaliero, allontanandolo sempre più dalla figura del medico fisico-filosofo per un nuovo ruolo di medico-chirurgo che si avvale di una preparazione sistematica, fatta di teoria e pratica, sintesi delle discipline mediche dell’epoca.
Pur rimanendo invariato il numero delle cattedre, molte sono le novità in fatto di materie di insegnamento, che nell’ultimo ventennio del secolo si estendono alla Fisiologia, Igiene, Patologia, Botanica, Chimica e Operazioni Chirurgiche. Il docente di medicina sceglie se tenere le proprie lezioni in lingua latina o toscana e se “dettare gli scritti propri o prevalersi di opere già stampate”, quali testi di studio per lo studente. Il conseguimento della Laurea Dottorale, regolamentato dal Motuproprio dell’11 dicembre 1786, avviene dopo quattro anni di frequenza dello Studio e l’aver sostenuto sei esami: - Logica Metafisica Etica - Fisica - Anatomia - Medicina Teorica - Medicina Pratica - Geometria e Chimica alle quali si aggiunge nel 1787 la Storia Naturale e Botanica e dal 1797 la Clinica. I cambiamenti nella prassi della medicina, il dibattito scientifico garantito dal fiorire delle accademie e dal nascente fenomeno delle pubblicazioni periodiche che diffondono le novità

8
scientifiche sono di impulso anche al rinnovamento che nelle università si va attuando su schemi didattici validi per il richiesto aggiornamento scientifico. Le nuove dottrine, le nuove tecniche, le nuove metodologie d’indagine fondate su osservazione ed esperimento, i nuovi metodi di divulgazione sono pertanto tra i maggiori fattori che influiscono sulle riforme degli studi universitari e quindi sulla formazione e definizione di competenze disciplinari. Le cosiddette “scienze di base”, chimica, fisica, matematica, compaiono nei programmi didattici perchè ormai la medicina è in un rapporto obbligato di scambio e di impulso reciproco con le conoscenze di molte altre materie.

9
NOTE: 1. L. Marri Malacrida, E. Panconesi, Vincenzo Chiarugi. I suoi tempi, il suo libro sulle malattie
cutanee sordide, Firenze, Ediz. Riviste Scientifiche, 1989, p. 26; 2. V. Chiarugi, Saggio teorico-pratico sulle malattie cutanee sordide, Firenze, Allegrini, 1799, p.
VI; 3. V. Chiarugi, cit., p. VII; 4. A. Bacci, D. Parrini, F. Vannozzi, I documenti dell’Accademia I. Verbali, memorie, epistole ed
atti dalla fondazione al secolo XVIII, “Memorie n. 5” – Siena, Cantagalli, 1994; 5. P. Mascagni, Autobiografia, in: “Archivio della Famiglia Mascagni”, Accademia dei
Fisiocritici, Siena; 6. P. Mascagni, Vasorum Lymphaticorum Corporis Humani Historia et Ichonographia, Siena,
Pazzini Carli, 1787; 7. Museo di Storia Naturale dell’Accademia dei Fisiocritici, Sala Paolo Mascagni, (a cura di F.
Vannozzi), Siena, Protagon Editori Toscani, 1998, pp. 36–40; 8. P. Mascagni, Anatomiae Universae, Pisa, Nicola Capurro, 1823–1831; 9. sulla figura di Paolo Mascagni v. La Scienza Illuminata. Paolo Mascagni nel suo tempo (1755–
1815), (a cura di F. Vannozzi), Siena, Nuova Immagine, 1996; 10. Manifesto bilingue del 29 germile anno 7°, in “Archivio Accademia dei Fisiocritici di Siena”; 11. F. Vannozzi, L’insegnamento nello Studio senese dell’ostetricia e della ginecologia, in: “La
collezione degli strumenti di ginecologia, ostetricia e pediatria”, Siena, Nuova Immagine, 2002, pp. 11–25;
12. G. Cosmacini, Storia dell’ostetricia. Stato dell’arte dal Cinquecento all’Ottocento, Milano-Roma-New York 1989;
13. Betti, P., Studi di Medicina Pubblici, Firenze, Tip. delle Murate, 1861, p. 327; 14. Betti P., cit., p. 325; 15. L. Marri Malacrida, Nascita e sviluppo dell’ostetricia. Modelli didattici e ceroplastica, in:
“Museo di Storia della Scienza. Catalogo”, cit., pp. 310–317; 16. N.E. Vanzan Marchini, La chirurgia europea e gli ‘Atti’ dei Collegi veneziani, in: “Dalla
scienza medica alla pratica dei corpi”, Padova, Neri Pozza, 1993, p. 45; 17. Encyclopédie ou dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers par une société de
gens de lettres, curata da Denis Diderot (1713-1784) e Jean Baptiste Le Rond d’Alembert (1717-1783) è in 35 volumi che escono tra il 1751 e il 1780;
18. F. Vannozzi, Strumentaria chirurgica e modelli didattici. Da ferro a strumento di professionalità. L’armamentario chirurgico di Giovanni Alessandro Brambilla, in: “Museo di Storia della Scienza. Catalogo (a cura di M. Miniati)”, Firenze, Giunti, 1991, pp. 302–309;
19. Dei tre armamentari, oggi uno è conservato presso l’Istituto e Museo di Storia della Scienza di Firenze, uno all’Istituto di Storia della Medicina dell’Università di Vienna, il terzo al Museo dell’Ateneo di Pavia;
20. L. Belloni, Lo strumentario chirurgico di Giovanni Alessandro Brambilla, Firenze, Moretti, 1971, p. 13;
21. L. Bellone, Giovanni Alessandro Brambilla e l’equiparazione della chirurgia alla medicina, in: “Giovanni Alessandro Brambilla nella cultura medica del Settecento europeo”, Milano, 1980, pp. 15–19;
22. V. Chiarugi, Spiegazione delle piante esprimenti le cassette componenti l’Armamentario chirurgico dell’I. e R. Arcispedale di S. Maria Nuova di Firenze, Firenze 1818;
23. E. Brambilla, La medicina del Settecento: dal monopolio dogmatico alla professione scientifica, in: “Storia d’Italia. Annali 7, Malattia e Medicina”, (a cura di F. Della Peruta), Torino, Einaudi, 1984, pp. 35;
24. E. Brambilla, cit., p. 78;

10
25. F. Vannozzi, L’insegnamento della medicina in Siena dal XVII secolo ai giorni nostri, in: “L’Università di Siena. 750 anni di storia”, Milano, Pizzi, 1991, pp. 159-173.

11
9