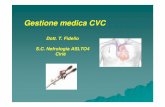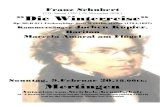Fidelio
-
Upload
portale-ragazzi -
Category
Documents
-
view
214 -
download
1
description
Transcript of Fidelio
FIDELIO, IL VOLTO DELLA LIBERTA’
PremessaLe note che qui sono scritte sono rivolte in primo luogo agli insegnanti. La costruzione di uno spettacolo è per sua natura un percorso potenzialmente didattico. Ogni insegnante che conosce bene i propri alunni può quindi approfittare di questa edizione del progetto all’opera per approfondire in classe (o magari per se stesso) alcuni spunti che troverà sul Portale. Possiamo dire che quello che segue è una sorta di ragionamento (a voce alta) che ogni regista, ogni operatore culturale fa nella sua testa al momento di affrontare un’opera. Ogni volta un testo diventa pretesto per domande e approfondimenti che in primo luogo ci servono per avvicinarsi a quel nucleo di temi e sentimenti che si affacciano alla nostra sensibilità e trasformano in esperienza personale ed originale il rapporto con un classico. Fidelio è un’opera difficile e quindi non è detto che l’insieme dei nostri suggerimenti possa tradursi in una diretta attività in classe, ma ogni insegnante, se vorrà, potrà approfittarne per coltivare quella sua visione originale dell’opera che sicuramente, anche se non subito, si tradurrà in un’offerta migliore peri suoi ragazzi. Senza contare che prendersi un po’ di tempo per sé (anche solo quello che potrete concedervi per la lettura di queste brevi note) non è un tempo da disprezzare.
Fidelio. Le fonti, l’accoglienza dell’opera.
Fidelio è l’unica opera lirica di Ludwig van Beethoven, musicista famosissimo e popolare soprattutto per le sue sinfonie, in particolare la Terza, detta Eroica, la Quinta, il cui inizio è forse uno dei brani musicali più noti al mondo, e la Nona, della quale probabilmente tutti conoscono la melodia del finale (Inno alla gioia).
L’opera debuttò a Vienna il 20 novembre 1805, ma fu rivista e corretta dall’autore in vista di una seconda esibizione nel 1806 e ancora per una terza edizione che andò in scena il 21 maggio 1816. Il soggetto al quale s’ispirò è un dramma francese, Léonor, di Jean-Nicolas Bouilly, andato in scena nel 1798 con grande successo: a questo lavoro attinsero altri musicisti: Ferdinando Paer e Giovanni Simone Mayr (pare che Beethoven conoscesse l’opera di Paer, di cui era amico e che incontrò a Vienna alla fine del 1803; non solo, fra le carte del grande compositore tedesco è stata trovata una copia della Leonor di Paer).
La storia si ispira ad un fatto vero: Bouilly, infatti, racconta nelle sue memorie un fatto che sembra un vero e propr io romanzo d’avventura. Siamo in piena rivoluzione francese, nella città di Tours e lo scrittore scopre che un suo vecchio amico, il conte de Semblancy, viene tenuto in carcere. Avverte la mog l i e che , t raves t i t a da contadino entra nel carcere e tenta inutilmente di far scappare
il marito. Fra coloro che vogliono ad ogni costo la morte del conte c’è Jean Baptiste Carrier che è un uomo crudele, tanto crudele che lo stesso Robespierre, capo indiscusso dei rivoluzionari, lo convoca a Parigi perché si discolpi dell’accusa di usare metodi inumani e spietati. Un gruppo di soldati prende in consegna Carrier che fugge per tornare a Tours e uccidere il conte de Semblancy: la moglie, che gli spara, e l’inviato del governo francese però riescono a salvare il prigioniero e a portare Carrier a Parigi (per la cronaca, dopo aver contribuito alla rovina di Robespierre viene a sua volta giustiziato nel 1794). Per motivi di opportunità (i fatti narrati erano troppo recenti e potevano scatenare nel pubblico reazioni anche molto violente) Bouilly decise di spostare l’azione nella Spagna del Seicento e di camuffare i veri attori del dramma con nomi inventati, ovviamente spagnoli.
Lo spettacolo ebbe un grande successo. Perché? Questo genere di dramma, che in francese si chiama pièce à sauvetage, entusiasmava il pubblico perché i suoi protagonisti, che potevano essere ricchi o poveri, non importa, si salvavano (vincevano) perché erano buoni e superavano i mille trabocchetti dei cattivi, un po’ come i supereroi.
Beethoven lavorò oltre un anno e mezzo alla scrittura del Fidelio e riempì un quaderno di 250 pagine!!!!! Non si decideva mai: aveva appena scritto la sinfonia Eroica e lavorava molto. Ma non era mai contento: si era impegnato in un genere per lui nuovo
e voleva comunicare la forza dei suoi ideali di libertà e giustizia, ma anche rinnovare il modo di fare il melodramma.
L’opera fu un insuccesso: il motivo principale è da ricercare nel fatto che nel 1805 Vienna era occupata dalle truppe francesi e molti amici ed estimatori di Beethoven erano scappati di fronte all’invasione delle truppe di Napoleone.
La trama
L'azione si svolge in una prigione in Spagna, nel XVII secolo.
Atto I
Don Pizarro è il governatore della prigione in cui egli stesso ha fatto imprigionare ingiustamente il suo nemico personale Florestan. La moglie di questi, Leonore, vuole ritrovarlo e, travestitasi da uomo e preso il nome di Fidelio, lo cerca. Le informazioni la indirizzano proprio verso il carcere di don Pizarro. Qui, per scoprire se Florestan è tra i prigionieri, fa in modo di entrare nelle grazie di Rocco, il carceriere, e, involontariamente, entra anche in quelle di Marzelline, la figlia di lui, che se ne innamora sdegnando le attenzioni di Jaquino, il giovane portiere della prigione.
Nel frattempo una lettera informa don Pizarro dell'imminente arrivo del ministro di stato don Fernando e teme che questi possa scoprire l'ingiustizia commessa con l'arresto illegale di Florestan, che è amico di don Fernando. Dà ordine, dunque, a Rocco di uccidere il prigioniero, ma quest’ultimo si rifiuta. Costretto a dover commettere personalmente il delitto ottiene, però, che Rocco prepari la fossa. Fidelio assiste al colloquio e sospetta che il prigioniero di cui parla don Pizarro sia proprio Florestan. Per scoprirlo convince Rocco a far uscire in cortile tutti i prigionieri, ma Florestan non si trova tra questi e Fidelio, rassegnato, non può far altro che seguire Rocco nelle segrete per aiutarlo a scavare la fossa.
Atto II
Florestan giace incatenato nel buio della segreta e si lamenta della perduta libertà. Entrano Rocco e Fidelio, che si era deciso a salvare comunque il prigioniero chiunque egli fosse. Non appena ne ode la voce invocare il nome "Leonore", però, riconosce subito in lui il marito. Quando don Pizarro arriva per ucciderlo, Fidelio lo affronta e gli rivela la sua identità, ma il governatore è ben deciso a uccidere entrambi.
Uno squillo di tromba annuncia l'arrivo del ministro e fa frettolosamente uscire don Pizarro dalle segrete, mentre Leonore e Florestan si abbracciano esultanti. Nella piazza del castello il ministro dà ordine che i prigionieri siano liberati e ascolta da Rocco il resoconto dei fatti. Leonore toglie personalmente le catene al marito e, mentre i crimini di don Pizarro vengono smascherati, si leva un coro in lode dell'eroina.
Beethoven e Napoleone
Già Napoleone. Il compositore era stato un grande ammiratore del generale e aveva sperato che gli ideali di Libertà, Fratellanza e Uguaglianza che avevano guidato la Rivoluzione Francese avrebbero migliorato la vita di tutti gli europei. In questa speranza non era solo, perché moltissimi scrittori, pittori e musicisti si erano illusi che Napoleone avrebbe regalato loro la libertà (non si deve dimenticare che in molte zone d’Europa i re governavano in modo dispotico ) e rimasero delusi quando il grande condottiero si era autoproclamato “Imperatore” dei Francesi e aveva invaso l’Europa comportandosi come un sovrano qualsiasi, uccidendo, rubando e costringendo alla sottomissione i nuovi sudditi del suo impero. Beethoven intitolò
inizialmente la sua Terza sinfonia “Bonaparte”, ma poi cambiò idea e la chiamò più genericamente “Eroica”. D’altra parte il compositore per un po’ di tempo sperò anche di abbandonare Vienna, magari per andare proprio a Parigi e, ossessionato com’era di non avere mai un lavoro sicuro, cercava di capire come comportarsi con i potenti di Francia.
Alcuni cenni sulla personalità di Beethoven
Nel Fidelio, sin dall’Ouverture, si percepisce l’amore del musicista per la libertà, per raggiungere la quale bisogna agire, lottare. La musica ci fa sentire il carattere di Beethoven, irruento , convinto della propria missione; il musicista infatti non considerava la musica come qualcosa di bello e decorativo, ma come qualcosa di essenziale per la sua vita, anzi la sua ragione stessa di vivere, alla quale affidava il compito di parlare al futuro (dirà “…. E una seconda, e una avanzante terza generazione mi ricompenserà duplicemente, triplicemente dei torti che ho dovuto sopportare da parte dei miei contemporanei”). Il compositore, che aveva iniziato a suonare sin da giovanissimo ed era figlio di un musicista, in realtà piuttosto modesto, viveva nella convinzione che nessuno capisse la grandezza del suo genio. Non era facile perché a Vienna tutti lo paragonavano a Mozart (un vero ragazzino prodigio) e ritenevano il carattere di Ludwig veramente infernale. Non solo. Come dice Massimo Mila, un grande critico musicale (e non solo), “Beethoven si pone come il primo artista moderno (e quindi incompreso ai suoi tempi) anche per il senso di responsabilità ch’egli pose in ognuna delle sue opere. Le sue sinfonie non furono più 104 come per Haydn, o 49 come per Mozart; ma 9. Era passato il tempo di quella grandiosa disinvoltura, in cui il mestiere teneva indubbiamente tanta parte. Ogni composizione impegna ora a fondo la personalità dell’autore, secondo una concezione nuova dell’originalità dell’artista”.
Sicuramente non era un uomo facile: oggi saremmo più indulgenti sapendo che aveva trascorso un’infanzia molto difficile (la madre era morta giovane e il padre amava molto bere e spesso malmenava il piccolo Ludwig) e, soprattutto, soffriva di una malattia che molto presto lo portò ad essere … sordo. Per un compositore così vitale fu un dramma e in una lettera ai fratelli, mai spedita, si confessava con toni veramente struggenti:
O voi uomini che mi reputate o definite astioso, scontroso o addirittura misantropo, come mi fate torto ! Voi non conoscete la causa segreta di ciò che mi fa apparire a voi così. Il mio cuore e il mio animo fin dall’infanzia erano inclini al delicato sentimento di benevolenza e sono stato sempre disposto a compiere azioni generose.
Considerate, però, che da sei anni mi ha colpito un grave malanno peggiorato per colpa di medici incompetenti. Di anno in anno le mie speranze di guarire sono state gradualmente frustrate, e alla fine sono stato costretto ad accettare la prospettiva di una malattia cronica (la cui guarigione richiederà forse degli anni o sarà del tutto impossibile). Pur essendo dotato di un temperamento ardente, vivace, e anzi sensibile alle attrattive della società, sono stato presto obbligato ad appartarmi, a trascorrere la mia vita in solitudine. E se talvolta ho deciso di non dare peso alla mia infermità, ahimè, con quanta crudeltà sono stato allora ricacciato indietro dalla triste, rinnovata esperienza delle debolezza del mio udito. Tuttavia non mi riusciva di dire alla gente: «Parlate più forte, gridate perché sono sordo».
“Come potevo, ahimè, confessare la debolezza di un senso, che in me dovrebbe essere più raffinato che negli altri uomini e che in me un tempo raggiungeva un grado di perfezione massima, un grado tale di perfezione quale pochi nella mia professione sicuramente posseggono, o hanno mai posseduto. – No, non posso farlo; perdonatemi perciò se talora mi vedrete stare in disparte dalla vostra compagnia, che un tempo invece mi era caro ricercare. La mia sventura mi fa doppiamente soffrire perché mi porta a essere frainteso. Per me non può esservi sollievo nella compagnia degli uomini, non possono esservi conversazioni elevate, né confidenze reciproche. Costretto a vivere completamente solo, posso entrare furtivamente in società solo quando lo richiedono le necessità più impellenti; debbo vivere come un proscritto. Se sto in compagnia vengo sopraffatto da un’ansietà cocente, dalla paura di correre il rischio che si noti il mio stato. – E così è stato anche in questi sei mesi che ho trascorso in campagna. Invitandomi a risparmiare il più possibile il mio udito, quell’assennata persona del mio medico ha più o meno incoraggiato la mia attuale disposizione naturale, sebbene talvolta, sedotto dal desiderio di compagnia, mi sia lasciato tentare a ricercarla. Ma quale umiliazione ho provato quando qualcuno, vicino a me, udiva il suono di un flauto in lontananza e io non udivo niente, o udiva il canto di un pastore e ancora io nulla udivo. – Tali esperienze mi hanno portato sull’orlo della disperazione e poco è mancato che non ponessi fine alla mia vita. – La mia arte, soltanto essa mi ha trattenuto. Ah, mi sembrava impossibile abbandonare questo mondo, prima di aver creato tutte quelle opere che sentivo l’imperioso bisogno di comporre; e così ho trascinato avanti questa misera esistenza – davvero misera, dal momento che il mio fisico tanto sensibile può, da un istante all’altro precipitarmi dalle migliori condizioni di spirito nella più angosciosa disperazione. Pazienza – mi dicono che questa è la virtù che adesso debbo scegliermi come guida; e adesso io la posseggo. – Duratura deve essere, io spero, la mia risoluzione di resistere fino alla fine, finché alle Parche inesorabili piacerà spezzare il filo; forse il mio stato migliorerà, forse no, a ogni modo io, ora, sono rassegnato. – Essere costretti a diventare filosofi ad appena 28 anni non è davvero una cosa facile e per l’artista è più difficile che per chiunque altro. – Dio Onnipotente, che mi guardi fino in fondo all’anima, che vedi nel mio cuore e sai che esso è colmo di amore per l’umanità e del desiderio di bene operare. O uomini, se un giorno leggerete queste mie parole, ricordate che mi avete fatto torto; e l’infelice tragga conforto dal pensiero di aver trovato un altro infelice che, nonostante tutti gli ostacoli imposti dalla natura, ha fatto quanto era in suo potere per elevarsi al rango degli artisti nobili e degli uomini degni.
Questo “testamento”, scritto appena qualche tempo prima che iniziasse a lavorare al Fidelio, contiene tutte la caratteristiche del carattere di Beethoven, che i contemporanei giudicavano rude, goffo, maleducato e indisponente.
I temi del Fidelio: libertà, giustizia.
Ma torniamo a Fidelio: il desiderio di libertà e di giustizia da un lato e l’amore matrimoniale sono i due elementi portanti dell’idea dell’opera. Beethoven cresce in un momento storico nel quale si dibatte in tutta Europa il tema della Libertà. C’erano stati gli intellettuali dell’Illuminismo che ritenevano che la ragione dovesse per forza portarci a essere tolleranti con chi la pensa in modo diverso da noi e verso un modo di governare giusto. Molti avevano cercato di capire come si potesse vivere in un mondo di persone felici e avevano discusso anche in modo feroce su quale fosse il regime politico migliore,
il modo di governare ed essere governati che garantisse a tutti di non subire torti, insomma in una parola di essere liberi.
Poi la Rivoluzione francese aveva dimostrato che quegli ideali potevano guidare il popolo contro il privilegio dei nobili e dei re, ma anche che la realizzazione concreta di quegli stessi ideali era molto complessa. Molto sangue era stato versato; molte ingiustizie erano state commesse … in nome della Giustizia.
Ovviamente molti rimasero delusi, ma altri pensarono che la Rivoluzione aveva pur mostrato almeno una strada per arrivare all’Uguaglianza, alla Fraternità e alla Libertà e che anche l’arrivo di Napoleone e del suo esercito di conquistatori non era stato soltanto un male. Con le sue truppe, infatti aveva esportato o aveva fatto nascere in Europa il desiderio di essere liberi. Non solo. Se dobbiamo (o possiamo) prestare fede a quello che Napoleone scrive quando ormai sconfitto vive in esilio nell’Isola di Sant’Elena, lui stesso aveva un’idea pacificatrice delle sue imprese. Il brano che segue è citato nel meraviglioso romanzo Guerra e pace di Lev Tolstoj, opera centrata sulla fallimentare invasione della Russia da parte di Napoleone .
"La guerra di Russia avrebbe dovuto essere la più popolare dei tempi moderni: era la guerra del buon senso e degli interessi reali,la guerra del riposo e della sicurezza per tutti; era unicamente pacifica e conservatrice. E' stata combattuta per la grande causa, per porre fine ai rischi e per dare inizio a un periodo di sicurezza. Un nuovo orizzonte si sarebbe dischiuso, nuovi lavori colmi di benessere e di prosperità per tutti. Poiché il sistema europeo era stato fondato, non restava più che organizzarlo. Soddisfatto su questi punti essenziali e tranquillo dovunque, avrei avuto anch'io il mio "congresso" e la mia "santa alleanza". Ma queste idee mi sono state rubate. In questa riunione di grandi sovrani, noi avremmo discusso familiarmente sui nostri interessi e trattato con i popoli, come lo scrivano con il suo padrone. L'Europa avrebbe così ben presto formato un popolo solo e chiunque, viaggiando ovunque, si sarebbe trovato sempre nella patria comune. Avrei chiesto che tutti i fiumi fossero navigabili per tutti, avrei
chiesto la comunità dei mari e che i grandi eserciti fossero ormai ridotti alla sola guardia dei sovrani. Di ritorno in Francia, in seno alla grande patria, forte, magnifica,tranquilla, gloriosa, avrei proclamato immutabili i suoi confini, ogni guerra futura soltanto difensiva, ogni ulteriore ingrandimento territoriale antinazionale. Avrei associato mio figlio all'impero; la mia dittatura sarebbe finita e avrebbe avuto inizio il suo regno costituzionale... Parigi sarebbe stata la capitale del mondo, e i Francesi l'invidia di tutte le nazioni! In seguito i miei ozi e i miei ultimi giorni sarebbero stati consacrati, in compagnia dell'imperatrice e durante il tirocinio regale di mio figlio, a visitare lentamente, come una vera coppia di campagnoli, con i nostri cavalli, tutti gli angoli più remoti dell'impero, ascoltando le lagnanze, riparando i torti, spargendo ovunque i monumenti e i benefici".
Parrebbe una specie di Europa unita (a parte il dettaglio che su tutto il continente avrebbe dovuto comandare uno solo ….).
Dei delitti e delle pene: 250 anni fa
Ma riprendiamo la questione Giustizia e Libertà. Il dibattito sui diritti dei cittadini iniziato nel Settecento non era stato inutile. Basti pensare, tornando proprio al nostro Fidelio, che fra i frutti della discussione di quei tempi possiamo trovare un libro fondamentale e bellissimo, scritto 250 anni fa (1764), precisi, precisi , da un italiano: Dei delitti e delle pene di Cesare Beccaria. Il testo è bellissimo, perché in modo semplice e logico contesta molte idee che circolavano a quei tempi sulla giustizia (e alcune le potete sentire anche oggi, di solito dopo che si viene a conoscenza di qualche fatto di cronaca o dell’arresto di qualche criminale). L’autore non intende difendere i delinquenti, ma puntualizzare che le leggi devono essere chiare, non manipolabili, certe ed essere applicate con rigore: ma contesta per esempio l’idea che servano a far rispettare la legge sia la tortura sia la pena di morte. Non lo spettacolo della morte, ma il timore di essere privati della libertà che distoglie le persone da commettere i reati. Rispetto alla tortura nega che possa servire a scoprire la verità su un delitto, semplicemente perché l’accusato (notare bene non il condannato) può resistere alle sevizie semplicemente perché è forte, non innocente. Anzi l’autore si permette anche di ironizzare sull’argomento, dicendo che non un giudice, ma un matematico serve a capire l’utilità della tortura, sotto la seguente forma: “data la forza dei muscoli e la sensibilità delle fibre d’un innocente, trovare il grado di dolore che lo farà confessar reo di un dato delitto”.
Ecco alcuni passi che parlano delle pene (condanne), della pena di morte e della prevenzione dei reati.
“Dalla semplice considerazione delle verità fin qui esposte egli è evidente che il fine delle pene non è di tormentare ed affliggere un essere sensibile, né di disfare un delitto già commesso. Può egli in un corpo politico, che, ben lungi di agire per passione, è il tranquillo moderatore delle passioni particolari, può egli albergare questa inutile crudeltà strumento del furore e del fanatismo o dei deboli tiranni? Le strida di un infelice richiamano forse dal tempo che non ritorna le azioni già consumate? Il fine dunque non è altro che d’impedire il reo dal far nuovi danni ai suoi cittadini e di rimuovere gli altri dal farne uguali. Quelle pene dunque e quel metodo d’infliggerle deve esser prescelto che, serbata la proporzione, farà una impressione più efficace e più durevole sugli animi degli uomini, e la meno tormentosa sul corpo del reo.”
“La certezza di un castigo, benché moderato, farà sempre una maggiore impressione che non il timore di un altro più terribile, unito colla speranza dell’impunità; perché i mali, anche minimi, quando son certi, spaventano sempre gli animi umani, e la speranza, dono celeste, che sovente ci tien luogo di tutto, ne allontana sempre l’idea dei maggiori, massimamente quando l’impunità, che l’avarizia e la debolezza spesso accordano, ne aumenti la forza. L’atrocità stessa della pena fa che si ardisca tanto di più per schivarla, quanto è grande il male a cui si va incontro; fa che si commettano più delitti, per fuggir la pena di un solo. I paesi e i tempi dei più atroci supplizi furono sempre quelli delle più sanguinose ed inumane azioni, poiché il medesimo spirito di ferocia che guidava la mano del legislatore, reggeva quella del parricida e del sicario. Sul trono dettava leggi di ferro ad anime atroci di schiavi, che ubbidivano. Nella privata oscurità stimolava ad
immolare i tiranni per crearne dei nuovi. A misura che i supplizi diventano più crudeli, gli animi umani, che come i fluidi si mettono sempre a livello cogli oggetti che gli circondano, s’incalliscono, e la forza sempre viva delle passioni fa che, dopo cent’anni di crudeli supplizi, la ruota spaventi tanto quanto prima la prigionia. Perché una pena ottenga il suo effetto basta che il male della pena ecceda il bene che nasce dal delitto, e in questo eccesso di male dev’essere calcolata l’infallibilità della pena e la perdita del bene che il delitto produrrebbe. Tutto il di più è dunque superfluo e perciò tirannico.
Non è dunque la pena di morte un diritto, (…) ma è una guerra della nazione con un cittadino, perché giudica necessaria o utile la distruzione del suo essere. Ma se dimostrerò non essere la morte né utile né necessaria, avrò vinto la causa dell’umanità. La morte di un cittadino non può credersi necessaria che per due motivi. Il primo, quando anche privo di libertà egli abbia ancora tali relazioni e tal potenza che interessi la sicurezza della nazione; quando la sua esistenza possa produrre una rivoluzione pericolosa nella forma di governo stabilita. La morte di qualche cittadino diviene dunque necessaria quando la nazione ricupera o perde la sua libertà, o nel tempo dell’anarchia, quando i disordini stessi tengono luogo di leggi; ma durante il tranquillo regno delle leggi, in una forma di governo per la quale i voti della nazione siano riuniti, ben munita al di fuori e al di dentro dalla forza e dalla opinione, forse più efficace della forza medesima, dove il comando non è che presso il vero sovrano, dove le ricchezze comprano piaceri e non autorità, io non vedo necessità alcuna di distruggere un cittadino, se non quando la di lui morte fosse il vero ed unico freno per distogliere gli altri dal commettere delitti, secondo motivo per cui può credersi giusta e necessaria la pena di morte. Quando l’esperienza di tutt’i secoli, nei quali l’ultimo supplizio non ha mai distolti gli uomini determinati dall’offendere la società (…). Non è l’intensità della pena che fa il maggior effetto sull’animo umano, ma l’estensione di essa; perché la nostra sensibilità è più facilmente e stabilmente mossa da minime ma replicate impressioni che da un forte ma passeggero movimento. L’impero dell’abitudine è universale sopra ogni essere che sente, e come l’uomo parla e cammina e procacciasi i suoi bisogni col di lei aiuto, così l’idee morali non si stampano nella mente che per durevoli ed iterate percosse. Non è il terribile ma passeggero spettacolo della morte di uno scellerato, ma il lungo e stentato esempio di un uomo privo di libertà, che, divenuto bestia di servigio, ricompensa colle sue fatiche quella società che ha offesa, che è il freno più forte contro i delitti. Quell’efficace, perché spessissimo ripetuto ritorno sopra di noi medesimi, io stesso sarò ridotto a così lunga e misera condizione se commetterò simili misfatti, è assai più possente che non l’idea della morte, che gli uomini vedono sempre in una oscura lontananza. La pena di morte fa un’impressione che colla sua forza non supplisce alla pronta dimenticanza, naturale all’uomo anche nelle cose più essenziali, ed accelerata dalle passioni. Regola generale: le passioni violenti sorprendono gli uomini, ma non per lungo tempo, e però sono atte a fare quelle rivoluzioni che di uomini comuni ne fanno o dei Persiani o dei Lacedemoni; ma in un
libero e tranquillo governo le impressioni debbono essere più frequenti che forti. La pena di morte diviene uno spettacolo per la maggior parte e un oggetto di compassione mista di sdegno per alcuni; ambedue questi sentimenti occupano più l’animo degli spettatori che non il salutare terrore che la legge pretende inspirare. Ma nelle pene moderate e continue il sentimento dominante è l’ultimo perché è il solo.
È meglio prevenire i delitti che punirli. Questo è il fine principale d’ogni buona legislazione, che è l’arte di condurre gli uomini al massimo di felicità o al minimo d’infelicità possibile, per parlare secondo tutt’i calcoli dei beni e dei mali della vita. Ma i mezzi impiegati fin ora sono per lo più falsi ed opposti al fine proposto. Non è possibile il ridurre la turbolenta attività degli uomini ad un ordine geometrico senza irregolarità e confusione. Come le costanti e semplicissime leggi della natura non impediscono che i pianeti non si turbino nei loro movimenti così nelle infinite ed opposte attrazioni del piacere e del dolore, non possono impedirsene dalle leggi umane i turbamenti ed il disordine. Eppur questa è la chimera degli uomini limitati, quando abbiano il comando in mano. Il proibire una moltitudine di azioni indifferenti non è prevenire i delitti che ne possono nascere, ma egli è un crearne dei nuovi, egli è un definire a piacere la virtù ed il vizio, che ci vengono predicati eterni ed immutabili. A che saremmo ridotti, se ci dovesse essere vietato tutto ciò che può indurci a delitto? Bisognerebbe privare l’uomo dell’uso de’ suoi sensi. Per un motivo che spinge gli uomini a commettere un vero delitto, ve ne son mille che gli spingono a commetter quelle azioni indifferenti, che chiamansi delitti dalle male leggi; e se la probabilità dei delitti è proporzionata al numero dei motivi, l’ampliare la sfera dei delitti è un crescere la probabilità di commettergli. La maggior parte delle leggi non sono che privilegi, cioè un tributo di tutti al comodo di alcuni pochi. Volete prevenire i delitti? Fate che le leggi sian chiare, semplici, e che tutta la forza della nazione sia condensata a difenderle, e nessuna parte di essa sia impiegata a distruggerle. Fate che le leggi favoriscano meno le classi degli uomini che gli uomini stessi. Fate che gli uomini le temano, e temano esse sole. Il timor delle leggi è salutare, ma fatale e fecondo di delitti è quello di uomo a uomo.
L’importanza dei temi della giustizia e della libertà è così grande che anche quando siamo giovani e giovanissimi dobbiamo interrogarci e parlarne. Per questo il progetto di quest’anno vede la partecipazione di un’organizzazione che si chiama Amnesty International e che combatte in tutto il mondo per la difesa dei diritti umani.
E l’importanza del libro di Beccaria è tale che Piero Calamandrei, uno di coloro che ha scritto la nostra Costituzione nel 1945, dirà: “Cesare Beccaria non ha ancora fatto il suo tempo, non ha ancora ricominciato ad essere un antico: sui problemi dei delitti e delle pene, che continuano a dibattersi tra noi, egli ha ancora, prima di poter tornare alla onorata quiete del suo scaffale, da terminare un discorso che non può essere lasciato a mezzo”.
Quanto di quello che scrisse Beccaria è presente negli articoli 13 e 27 della Costituzione: eccoli.
ART. 13
La libertà personale è inviolabile.
Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell'autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge .
In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge l'autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro quarantotto ore all'autorità giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto.
E` punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà
La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva.
ART. 27
L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte.
I temi del Fidelio: l’amore
In Fidelio, l’altro grande tema è l’amore (come sempre), un amore tenace e fedele, come Beethoven non conobbe mai. Il musicista, infatti, s’innamorò, ma sempre di donne che non lo corrisposero; anzi verrebbe da dire che non potevano corrisponderlo, perché già sposate o appartenenti a ceti sociali troppo in alto per lui. C’è chi pensa addirittura che egli scelse sempre l’amore di donne
irraggiungibili, come se fosse cosciente lui per primo che non sarebbe stato in grado, anche per il suo amore assoluto per la musica, di vivere una storia d’amore normale. Una luce particolare su questo aspetto è stata gettata dal ritrovamento di una lettera d’amore, scritta probabilmente nel 1812 e indirizzata ad una “immortale amata”: è molto bella e vibrante.
6 luglio, di mattina.Mio angelo, mio tutto, mio io — Sono poche parole per oggi, e per giunta a matita (la tua) — Il mio alloggio non sarà definito prima di domani — che inutile perdita di tempo — Perché questa pena profonda, quando parla la necessità — può forse durare il nostro amore se non a patto di sacrifici, a patto di non esigere nulla l'uno dall'altra; puoi forse cambiare il fatto che tu non sei interamente mia, io non sono interamente tuo: Oh Dio, volgi lo sguardo alle bellezze della natura e rasserena il tuo cuore con ciò che deve essere — l'Amore esige tutto, e a buon diritto — così è per me con te, e per te con me. Ma tu dimentichi tanto facilmente che io devo vivere per me e per te; se fossimo davvero uniti, ne sentiresti il dolore tanto poco quanto lo sento io — Il mio viaggio è stato terribile; sono arrivato qui soltanto ieri mattina alle quattro. Poiché scarseggiavano i cavalli, la diligenza ha scelto un'altra strada, ma quant'era orribile! Alla penultima stazione di posta mi sconsigliarono di viaggiare la notte; volevano mettermi paura parlandomi di una foresta, ma ciò mi incitò maggiormente — ed ho avuto torto. La carrozza non poteva che rompersi per quel sentiero orrendo, fangoso e senza fondo. Se non avessi avuto con me quei postiglioni sarei rimasto in mezzo alla strada. Esterhàzy, viaggiando per la solita via, con otto cavalli ha avuto la stessa sorte che è toccata a me con quattro — Eppure ho provato un certo piacere, come sempre quando riesco a superare felicemente qualche difficoltà — Ora passo in fretta dai fatti esterni a quelli più intimi. Ci vedremo sicuramente presto; neppur oggi riesco a far parte con te delle mie considerazioni di questi ultimi giorni sulla mia vita — Se i nostri cuori fossero sempre vicini l'uno all'altro, non avrei certo simili pensieri. Il mio cuore trabocca di tante cose che vorrei dirti — ah — vi sono momenti in cui sento che le parole non servono a nulla — Sii serena — rimani il mio fedele, il mio unico tesoro, il mio tutto, così come io lo sono per te. Gli dei ci mandino il resto, ciò che per noi dev'essere e sarà.Il tuo fedele
LudwigLunedì 6 luglio, di sera.
Tu stai soffrendo, creatura adorata — soltanto ora ho appreso che le lettere devono essere impostate di buon mattino il lunedì-giovedì — i soli giorni in cui parte da qui la diligenza per K. — stai soffrendo — Ah, dovunque tu sia, tu sei con me — Sistemerò le cose tra noi in modo che io possa vivere con te. Che vita!!! Così!!! Senza di te — perseguitato da ogni parte dalla bontà della gente — che io non desidero né tanto meno merito — umiltà dell'uomo verso l'uomo — mi fa soffrire — e quando considero me stesso in rapporto all'universo, ciò che io sono e che Egli è — colui che chiamiamo il più grande degli uomini — eppure — qui si rivela la natura divina dell'uomo —piango se penso che probabilmente non potrai ricevere notizie da me prima di sabato — Per quanto tu mi possa amare — io ti amo di più. — Ma non avere mai segreti per me — buona notte — Dato che sto facendo la cura dei bagni devo andare a letto — Oh Dio — così vicini! così lontani! Non è forse il nostro amore una creatura celeste, e, per giunta, più incrollabile della volta del cielo?
Ludwig
Buon giorno, il 7 luglio.Pur ancora a letto, i miei pensieri volano a te, mia Immortale Amata, ora lieti, ora tristi, aspettando di sapere se il destino esaudirà i nostri voti — posso vivere soltanto e unicamente con te, oppure non vivere più — Sì, sono deciso ad andare errando lontano da te finché non potrò far volare la mia anima avvinta alla tua nel regno dello spirito — Sì, purtroppo dev'essere così — Sarai più tranquilla, poiché sai bene quanto ti sia fedele. Nessun'altra potrà mai possedere il mio cuore — mai — mai — oh Dio, perché si dev'essere lontani da chi si ama tanto. E la mia vita a V[iennal è ora così infelice — Il tuo amore mi rende il più felice e insieme il più infelice degli uomini — alla mia età ho bisogno di una vita tranquilla e regolare — ma può forse esser così nelle nostre condizioni? Angelo mio, mi hanno appena detto che la posta parte tutti i giorni — debbo quindi terminare in fretta cosicché tu possa ricevere subito la lettera. — Sii calma, solo considerando con calma la nostra esistenza riusciremo a raggiungere la nostra meta, vivere insieme — Sii calma — amami — oggi — ieri — che desiderio struggente di te — te — te — vita mia — mio tutto — addio. — Oh continua ad amarmi — non giudicare mai male il cuore fedelissimo del tuo amato.Sempre tuo Sempre mia Sempre nostri
Ludwig
Beethoven … al cinemaBeethoven non può raggiungere la sua amata e la manda questa lettera. L’analisi dello scritto e di molti altri elementi ha convinto lo studioso Maynard Solomon che la destinataria fosse Annie Brentano, una donna che dunque corrispondeva i sentimenti del musicista e che nel caso specifico lo stava attendendo a Karlsbad, una stazione termale di moda a quell’epoca, inutilmente. Il soggetto di questo episodio e della lettera, il mistero che ha per anni avvolto il nome della donna, ha ispirato un film che si intitola proprio Amata immortale, uscito nel 1994, che parla della vita di Beethoven, interpretato dal bravissimo Gary Oldman.
La personalità dell’artista, la sua musica e la sua non felice vicenda umana hanno ispirato molti film. Se la sua musica è stata utilizzata come colonna sonora di quasi 300 film (in alcuni è un elemento molto importante), le vicende del compositore sono al centro dei recenti:
• “Amata immortale” diretto da Bernard Rose nel 1994; • “Musikanten”, diretto da Franco Battiato nel 2005; • “Io e Beethoven”, diretto da Agnieszka Holland nel 2006; • “Lezione ventuno”, diretto da Alessandro Baricco del 2008.
La fama di Beethoven
La fama di Beethoven è immensa. Tutti i musicisti successivi ne sono rimasti affascinati e alcuni, soprattutto tedeschi, lo hanno venerato: basti pensare a cosa ne diceva Wagner, che a sedici anni vide proprio il Fidelio e decise di diventare un compositore: “Se ripenso alla mia vita non riesco a trovare nessuna esperienza che sia riuscita a provocare su di me un’influenza comparabile con questa”. Il genio del popolo tedesco, un profeta della nuova musica, questo fu agli occhi di Wagner che vide in Beethoven il grande esempio da seguire, soprattutto per la musica che aveva lasciato con la Nona sinfonia.
E qui c’entriamo anche noi, perché come sapete alla fine del Fidelio canteremo tutti insieme, in omaggio al grande Ludwig, l’Inno alla gioia, quarto movimento e conclusione della Nona. La musica del brano la conoscete ed è bellissima; il testo fu scritto da un poeta tedesco, Friedrich Shiller, nel1785 e intende dirci che la solidarietà sta alla base della Felicità di tutti. Questo inno è stato adottato dal Consiglio d'Europa nel 1972 e viene utilizzato dall'Unione europea dal 1986. Herbert von Karajan, uno dei più grandi direttori d'orchestra del Novecento, ha realizzato, su richiesta del Consiglio d'Europa, tre versioni strumentali per piano solo, fiati e orchestra sinfonica. E proprio l’interpretazione della Nona sinfonia sta alla base di uno dei più celebri omaggi a Beethoven, ovvero il monumento di Max Klinger e lo splendido fregio che Gustav Klimt realizzò nel 1902 e che si trova a Vienna nel Palazzo della Secessione. Secondo il critico e scrittore Alessandro Baricco, Beethoven divenne il prototipo dell’artista romantico, ma soprattutto il modello del musicista che elevava la musica “al di sopra della logica commerciale e che sotto la pressione dei suoi contenuti spirituali era costretta a complicare in modo mirabile il proprio linguaggio. Insomma: una musica impegnata, spirituale e difficile”.
Bibliografia
Premessa
Ogni bibliografia è incompleta. Questo accade per più motivi, alcuni indipendenti dalla volontà e dalla cultura di chi la compila, perché legati alla vitalità del mercato editoriale e alla vastità del soggetto; alcuni sono legati invece all’idea stessa di bibliografia, che deve essere uno strumento utile (almeno utilizzabile) e quindi non infinito. Non solo. La bibliografia rappresenta già una sorta di percorso, di traccia che fa intravedere una volontà di interpretazione, o almeno una preferenza di lettura. Nel Caso del Fidelio, vorremmo qui esplicitare alcuni criteri di scelta bibliografica. Accanto alle note biografie di Solomon e Rizler si sono poi privilegiati i testi che rimandano ai due temi principali dell’opera, ovvero la ricerca della libertà e l’amore. Costruire una bibliografia è inoltre un processo lento e difficile (e, soprattutto, sempre provvisorio). Quella sul Fidelio, in base alla funzione didattica che può assolvere, rappresenta un’intersezione di numerosi insiemi : quello dei testi sulla vita e le opere di Beethoven; quello delle varie storie della musica e del melodramma; quello dei testi sull’età in cui visse il compositore tedesco; quello sui te mi che possiamo isolare nell’opera). Ogni suggerimento da parte dei docenti sarà il benvenuto
Storia della musica e ricostruzione dell’ambiente nel quale visse e operò Beethoven
Massimo Mila, Breve storia della musica, Torino, Einaudi, 1963 (molte le edizioni successive). Un classico e interessante profilo di storia della musica di un grande appassionato verdiano.
M.Baroni, E. Fubini, P. Peruzzi, P.Santi, G.Vinay, Storia della musica, Torino, Einaudi, 1988. Ampia panoramica dedica a Verdi un capitolo molto interessante per la contestualizzazione della sua opera.
Giorgio Pistelli, L’età di Mozart e Beethoven, Storia della musica a cura della Società Italiana di Musicologia, vol. VII, Torino, EDT, 1993. Interessante ricostruzione del quadro storico, politico, ma anche sociale, nel quale si trovò ad agire il grande musicista.
Su Beethoven
Walter Rietzler, Beethoven, Milano, Rusconi, 1994Maynard Solomon, Beethoven, Venezia, Marsilio, 2010 (quinta edizione)Giovanni Bietti, Ascoltare Beethoven, Roma-Bari, Laterza, 2013Il libretto dell’opera si può scaricare. Difficile da trovare, ma non impossibile la Guida all’opera di Luigi Della Croce (Milano, Mondadori, 1983).
Sul tema della giustizia e dei diritti, del carcere
Carcerazione, prigionia sono temi legati ad una vastissima ed eccellente letteratura che parla della Shoah. Su tutti ci sentiamo di consigliare le opere di Primo Levi.
Friedrich Schiller, Maria Stuarda Antoine Francois Prévost, Manon Lescaut
Daniel Defoe, Moll FlandersVictor Hugo, L’uomo che rideCesare Beccaria, Dei delitti e delle peneMichel Foucault, Sorvegliare e punireSplendide da studiare e ridisegnare le incisioni sul carcere di Piranesi che si trovano sullareteAlcuni classici Oscar Wilde, De profundisSilvio Pellico, Le mie prigioniCarlo Bini, Manoscritto di un prigionieroNapoleoneAnche qui il tema è un pretesto per frequentare grande letteraturaStendhal, La certosa di Parma, Il rosso e il neroLev Tolstoij, Guerra e pace