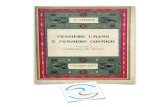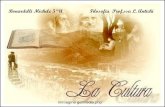SCHELLING Sulla scia di Fichte verso nuove definizioni 1ELVIRA VALLERI 2010-11.
FICHTE PENSIERO
Click here to load reader
-
Upload
lorenzo-petrini -
Category
Documents
-
view
2.941 -
download
1
Transcript of FICHTE PENSIERO

FICHTE
Punto di partenza del pensiero fichtiano è l'insieme dei problemi controversi o lasciati aperti dalla filosofia di Kant. Per cominciare egli elimina la cosa in sé, il noumeno, affermando che tutta la realtà è un prodotto del soggetto, del libero pensiero. Il pensiero che ammette l'esistenza del noumeno è detta da Fichte dogmatismo. L'idealismo invece asserisce l'assoluta indipendenza ed originarietà dello spirito ed ha per soggetto, non la cosa in sé, ma l'Io in sé. Il dogmatismo, prendendo l'avvio dal noumeno, in buona sostanza, deduce dall'oggetto l'atto stesso dal pensiero, ma tale passaggio dall'essere al pensare è impossibile. Il comportamento pratico dell'uomo testimonia a favore dell'idealismo: il dogmatico ha in sé un carattere fiacco, facendo derivare l'attività dello spirito da una realtà preesistente, facendo della libertà del pensiero un mero prodotto delle cose; l'idealista, invece, ha spirito d'iniziativa, affermando la propria autonomia e libertà di fronte alla realtà del mondo, deducendo l'oggetto dal soggetto. Nella “dottrina della scienza” Fichte afferma l’esistenza di un principio unitario, assoluto; assolutamente incondizionato di tutto e su cui si fonda tutto il sapere. Esso è un atto, ovvero comprende e unifica forma e materia. A tale principio, lo spirito, Fichte dà il nome di Io. Esso è realtà universale, ciò che nasce tutte le volte che pensante e pensato sono presenti al pensiero come la medesima cosa. E' l'Io puro, universale e assoluto, e non l'Io empirico di questo o di quell'individuo. Da esso si deduce necessariamente tutto il sistema del sapere umano. Fichte formula tre princìpi logici fondamentali per la sua deduzione dell'unità del sapere. Tesi: l'Io pone se stesso assolutamente. Questo principio è ricavabile da quello di identità, per cui A è A. Esso è assolutamente valido, anche se non dice nulla sull'esistenza di A, ma esclusivamente sull'esistenza di un rapporto necessario tra soggetto e predicato. Tale identità è posta nell'Io e dall'Io, e l'Io non può porla se non pone prima se stesso. L'Io quale autocoscienza è condizione di ogni conoscenza. In questo primo atto originario l'Io ha una capacità di produzione ancora inconscia, che però è la condizione di ogni consapevolezza. Antitesi: l'Io nel porre se stesso pone il non-Io. E' questo il principio di opposizione, con il quale l'Io oppone a se stesso l'oggetto del proprio pensiero,cioè una realtà ad esso esterna (natura). La contrapposizione tra Io e non-Io provoca nell'Io puro una riflessione, che genera la coscienza: nel momento in cui l'Io avverte in sé una limitazione, diventa coscienza. Sintesi: Nell'Io assoluto, l’io divisibile (le singole coscienze) si oppone a un non-Io divisibile (le singole cose). In questo momento del processo dialettico, l'Io prende coscienza della relazione esistente tra l'Io e il non-Io, che si limitano l'un l'altro. Nella coscienza, che è unica, l'Io puro è assoluto, e perciò non può essere né limitato né divisibile. Con questi tre princìpi Fichte afferma l'esistenza di un Io infinito, l'esistenza di un Io finito (il pensiero dei singoli uomini) e la realtà di un non-Io (cioè della natura), che si oppone all'Io finito, ma che è posto dall'Io infinito ed è ricompreso in esso. L'Io conosce il non-Io come un limite che, apparendo dapprima come un dato, risulta poi, con l'autocoscienza, posto e opposto a sé da se stesso. Quando prende coscienza di questo limite, l'Io lo supera con uno sforzo incessante in un processo infinito, cosicché il limite si sposta continuamente senza mai scomparire. L'Io si delimita, ponendo il non-Io, per realizzare se stesso, e per realizzarsi come attività morale. Il continuo sforzo dell'Io per superare il limite posto dal non-Io ha, infatti, un carattere pratico. Nell'incessante superamento del limite, l'Io conquista la propria libertà. L'attività morale è l'azione del soggetto sull'oggetto, e il mondo sensibile non è che lo strumento per l'esplicarsi di essa. Il fine dell'attività è l'affermarsi all'infinito della libertà spirituale che, del resto, non potrà mai essere pienamente conseguita, in quanto il superamento dell'ostacolo non potrà mai essere compiutamente realizzato.Il terzo principio della Dottrina della scienza introduce un nuovo modo di considerare sia l’Io che il non-io. La limitazione di entrambi può esser considerata in due sensi: come azione imitatrice dell’Io sul non-io, o viceversa. Quando l’Io pone il non-io come limitato dall’Io fa riferimento alla coscienza pratica, in quanto capace di limitazione del non-io. Quando invece l’Io pone se stesso come limitato dal non-io fa riferimento alla coscienza teoretica, la quale conduce progressivamente l’Io alla determinazione razionale dei fenomeni, ossia alla trasformazione del dato empirico in fatto scientifico, comprensibile mediante leggi razionali.Causa ultima della conoscenza non è dunque l’urto con il non-io, ma l’attività stessa che muove l’Io e che Fichte definisce “sforzo”, o “tensione”. Dunque quando lo sforzo “urta” nel non-io la realtà si manifesta come resistenza di qualcos’altro e diverso dall’Io. La coscienza si realizza così nel senso della libertà posta come cosa in sé, infine come realizzazione nel mondo della propria tendenza alla libertà. Il non-io, la natura, è così progressivamente trasformato in Io, in cultura, e acquista senso e valore attraverso l’operare dell’uomo. Non esiste tuttavia uno stato di quiete nel percorso della morale, ogni qualvolta raggiunge una vetta se ne presenta un’altra, c’è quindi una tendenza infinita dell’ispirazione morale. La concezione fichtiana della conoscenza pone al suo centro l’affermazione della libertà. Fichte offre nuove formulazioni del suo pensiero, nelle quali riflette sul tema del cominciamento della filosofia dalla libertà: dare un “sistema” alla libertà significa poter dare conto dell’assoluto, cioè raggiungere una comprensione globale della realtà. La filosofia, secondo Fichte, è dunque possibile solo attraverso un radicale mutamento dello sguardo comune dell’esperienza ordinaria a un punto di vista tutto nuovo. Il compito di un indagine che Fichte chiama critica, è

analizzare le forme che l’atteggiamento filosofico pretende di attuare: esse sono l’idealismo e il realismo. L’idealismo esamina le condizioni trascendentali di possibilità del sapere; esso ammette che la filosofia sia frutto ed espressione di libertà; l’idealista accoglie la propria filosofia come frutto di un atto spontaneo. Al contrario il realista pretende che la filosofia abbia un carattere di certezza oggettiva; egli ha perso di vista il valore della propria libertà, al punto da non capire che la scelta di fare filosofia è pura libertà assoluta. Infine, realismo e idealismo si presentano uno come forma di alienazione e l’altro come luogo di realizzazione della filosofia. Nell’ultima fase della propria ricerca teorica l’approccio di Fichte al problema della libertà si concretizza nel tentativo di cogliere l’essenza stesa della ragione ed di darne una descrizione. Il metodo dell’intuizione intellettuale dà modo di interpretare l’essere della coscienza; Fichte riflette così sul senso della possibilità della coscienza umana e sulla stessa esistenza della realtà. Egli infatti, dall’indagine trascendentale della coscienza, passa a interrogarsi su qual è il senso della coscienza, quale il senso del mondo? L’intuizione intellettuale conduce Fichte ad affermare l’unità originaria della coscienza con l’essere, il quale non è oggettivamente pensabile come una cosa del mondo, ma che nella sua assolutezza coincide con il divino nella realtà e quindi con la vita assoluta. In quest’ottica la coscienza si identifica col profondersi e generarsi della vita divina. Il sapere è dunque immagine di Dio, o, in altri termini, la cultura e la vita umana sono manifestazioni della vita divina. E dunque lo sforzo della condizione umana viene santificato e sottratto all’umiltà della condizione stessa.L’evoluzione del pensiero politico fichtiano attraversa tre fasi. La prima fase è rappresentata dalle opere degli anni 1793-94, caratterizzate da un’ispirazione liberistica e illuministica. Secondo Fichte lo stato politico sorge artificialmente per mezzo di un contratto stipulato dagli individui per tutelare i propri diritti inalienabili e i propri interessi particolari. Il diritto di ritirare la propria adesione al contratto statale è anch’esso un diritto inalienabile. Nella concezione fichtiana lo stato ha il compito di favorire al massimo grado il perfezionamento etico del singolo. Lo stato non deve dunque attendere questo momento della storia, ma impegnarsi affinchè esso si avvicini. La seconda fase ruota attorno alla Fondazione del diritto naturale (1796-97). Fichte persiste nell’ideale di una società perfettamente morale, capace di sussistere anche senza il bisogno dello stato. Poiché il fine supremo dell’umanità, la totale perfezione morale, non sarà mai raggiunto, lo stato dovrà lavorare all’infinito al proprio auto superamento. Di diritti dell’individuo diviene possibile parlare solo all’interno della comunità statale perché l’individuo, per essere veramente tale, deve venire riconosciuto dagli altri. L’uomo, secondo Fichte, diviene uomo soltanto fra gli uomini; il concetto dell’uomo non è affatto il concetto di un singolo, ma di un genere. I temi dell’ultima fase della riflessione politica di Fichte sono riassunti nei Discorsi alla nazione tedesca, con i quali nell’inverno del 1807-08 il filosofo si rivolge ai compatrioti per risvegliarne la coscienza nazionale, dopo l’occupazione napoleonica. Il compito è quello di suscitare una trasformazione del popolo tedesco e della creazione di un nuovo mondo non solo tedesco, ma anche europeo, basato sulla morale e sul patriottismo. Fichte esprime la necessità di una nuova educazione nazionale capace di formare un autentico sentimento patriottico e di salvaguardare le radici culturali tedesche contro ogni forma di predominio, anche intellettuale, dello straniero. Questa educazione, dovrà essere pubblica e rivolta a tutte le classi sociali, maschi e femmine. Avrà un’impronta essenzialmente pratica, basata sul lavoro e finalizzata alla formazione morale e religiosa. Le generazioni così educate, sarebbero immuni dalla mentalità individualistica o di ceto, considerata da Fichte la tendenza antisociale più pericolosa della propria epoca, e quindi caratterizzate dal più alto sentimento patriottico e religioso. Il patriottismo fichtiano solleva dunque l’uomo dalla sua chiusura individualistica e gli garantisce una forma di eternità terrena. Nei Discorsi il concetto di popolo è fondato sulla comunanza linguistica, conducendo Fichte a distinguere il popolo tedesco dagli altri popoli di stirpe germanica. Il popolo tedesco, infatti, parla una lingua viva, ossia naturale e non convenzionale, che conserva l’originaria unità di linguaggio e pensiero ed esprime perfettamente il carattere nazionale. Caso di degenerazione spirituale del linguaggio di un popolo germanico risulta invece quello del francese, lingua morta (il suo carattere originario darebbe stato soffocato dagli apporti di una lingua straniera, il latino, che avrebbe introdotto una convenzionalità nel rapporto pensiero-espressione provocando così una frattura tra il mondo dell’esperienza e quello del linguaggio. Nel caso dei popoli a lingua viva è possibile una produzione culturale nazionale, fruibile da tutti i ceti. La concezione nazionalistica fichtiana, nonostante l’esaltazione del germanesimo e la polemica antifrancese, Fichte arriva infine ad assegnare ai termini “straniero” e “tedesco” un valore universale, coerente con la sua filosofia della libertà e dell’impegno. In conclusione, infatti, straniero è colui che, indipendentemente dalla lingua e dalla nazionalità, non crede nella libertà, laddove “tedesco” è chiunque creda nello spirito.