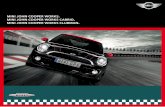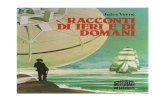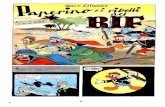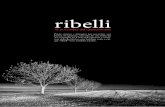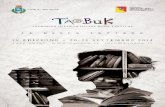Fedeli e ribelli alla realtà. Capote e Saviano a confronto
-
Upload
francesco-castagna -
Category
Documents
-
view
16 -
download
2
description
Transcript of Fedeli e ribelli alla realtà. Capote e Saviano a confronto
Fedeli e ribelli alla realtà. Capote e Saviano a confronto
Nel presente lavoro si prenderà in esame a Sangue Freddo di Truman Capote, quello che generalmente viene considerato il primo esempio di non-fiction novel, per poi rileggere e instaurare un confronto con Gomorra di Roberto Saviano. Nei romanzi verità che andremo ad analizzare il livello aletico, il loro interesse per la verità, è strettamente connesso con quello epistemologico, ovvero con la scelta dello stile più congeniale per toccare la verità che deve essere comunicata al lettore. Ripercorreremo alcune scelte stilistiche che riguardano la costruzione della figura del narratore, tenendo presente che, come Camus ha sottolineato nel suo L’uomo in rivolta, lo stile corrisponde al modo in cui un autore ridistribuisce gli elementi che attinge dal reale. I nostri autori attingono dal reale episodi di cronaca, episodi di violenza che si traducono, a livello sociale e umano, in diffidenza tra gli individui: i due autori descrivono la criminalità osservando come la fragilità umana possa trasformarsi in delirio di onnipotenza e disincarnando la totale presenza del male dalle persone che hanno scelto la via dell’omicidio. Questa operazione di liberazione dell’umanità da un male radicale che la infetta verrà sviluppata secondo stili diversi, per approdare a un diverso tipo di impegno etico della scrittura. Ma con una finalità comune, quella di non dover più soccombere a un male che priva le nuove generazioni di un senso di umanità, attuando un gesto di rivolta. A Sangue Freddo e Gomorra appartengono a un tipo di non-fiction novel che può essere ascritto all’arte della rivolta:
L’arte ci riconduce così alle origini della rivolta, in quanto tenta di dar forma a un valore nel divenire perpetuo, ma che l’artista ha presentito e vuol sottrarre alla storia1
Quella di Capote è una mano che domina completamente lo svolgersi dei fatti che hanno portato al massacro della famiglia Clutter e che tiene saldamente in pugno l’intera vita di chi ha preso parte, anche indirettamente, a quella vicenda. La cura con cui ogni descrizione fisica e psicologica viene eseguita restituisce un ritratto della realtà ad alta definizione, in cui ogni dettaglio o aneddoto ha il suo posto preciso, irremovibile, e una rilevanza capitale: appartiene eternamente al violento destino della famiglia Clutter. Tuttavia quella mano, così intima ai fatti, sembra essere priva di impronte digitali, tanto da non lasciare alcuna traccia narrativa di sé in nessun luogo del romanzo. Una volta trasposta la realtà in fiction, Truman Capote scompare dalla scena, come se non fosse mai stato di persona nelle vaste pianure del Kansas occidentale e lì non avesse intessuto rapporti con chi vi abita. Eppure in quei luoghi il nostro autore c’è stato e ce lo dice lui stesso, in prima persona, all’inizio della sua opera, dichiarando che
Tutto il materiale di questo libro non derivato da mia osservazione diretta o è stato preso da registrazioni ufficiali o è il risultato di colloqui con le persone direttamente interessate, e molto spesso di tutta una serie di colloqui che si sono protratti per un tempo considerevole2.
Scrivendo “A sangue freddo”, Capote compie un’operazione di annientamento di sé più radicale di un suicidio, una damnatio memoriae verso sé stesso. Nessuno dei personaggi serba il ricordo del celebre giornalista del New Yorker, come se non fosse mai esistito, il che appare del tutto inverosimile per quella che dovrebbe essere una fedele e oggettiva ricostruzione dei fatti. Si potrebbe pensare che Capote scelga di sacrificare il proprio punto di vista, non ricreando il proprio alter ego nel romanzo, per garantire una maggiore oggettività e imparzialità al lettore, come se la presenza del suo punto di vista avesse potuto alterare il contenuto veritativo del romanzo. Potremmo supporre chela verità dei fatti verrebbe pertanto
1 Cfr. A.Camus, L’uomo in rivolta, Bompiani, Milano 2002, p.283.2 Cfr T. Capote, A Sangue Freddo, Garzanti, Milano 2005, p. 7.
cercata in una prospettiva behaviourista, che impone di rimuovere il più possibile colui che percepisce da ciò che è percepito, nel tentativo di ottenere la coscienza oggettiva di ciò che è percepito. Viene da osservare, però, che se il tentativo di Capote fosse quello di neutralizzare il proprio punto di vista per un ottenere pugno di oggettività, il suo sacrificio sarebbe comunque inutile: il contenuto veritativo è comunque alterato, perché resta mutilato. Dal momento che la ricostruzione, per ottenere lo status di imparzialità, si svolge presupponendo la totale estraneità di Capote, è condannata ad essere parziale e oltretutto ad essere anche autocontraddittoria nei propri intenti di oggettività. Il compito che si impone al lettore è di comprendere il significato di tale distacco e se Capote vada incontro a queste assurdità. Vedremo che per narrare il destino dei Clutter, però, Capote abbia in mente un altro senso di oggettività e di verità. Capote pur facendo parte, dunque, del destino dei Clutter, così come ne fanno parte la comunità di Holcomb o i due assassini Richard “Dick” Eugene e Perry Edward Smith e ogni altra persona la cui voce sia stata rievocata nel romanzo, effettivamente decide di distanziarsene. Di primo acchito osserviamo che Capote posticipa a lungo la descrizione dell’atto della violenza, che viene rievocato da uno degli esecutori, Perry, soltanto a metà del romanzo, in poche pagine. Anche nel momento della massima violenza la sua crudezza resta velata, non tanto per nascondere l’orrore del sangue, ma, strategicamente, per evidenziare come essa si compia nella rapidità e lucidità di chi aveva già deciso di uccidere secondo uno schema di morte preciso3. L’economia della narrazione mira a seguire i riverberi del delitto, gira attorno a quell’episodio di violenza, come una pietra che gettata in un lago genera un susseguirsi di onde destinate a svanire prima di toccare la riva. La confessione di Perry è il centro di gravità della narrazione, il fuoco di una serie di ellissi, episodi di vite separate e diverse, come in un film di Altman, che si intersecano solo in momenti altamente probatori4. L’inizio e alla fine del romanzo troviamo sono le onde più flebili, quelle più vicine al loro annullamento nelle quali ritroviamo rispettivamente la descrizione degli ultimi giorni di vita dei Clutter e un epitaffio per Nancy
[Bobby Rupp e un’amica di Nancy si ritrovano dopo molto tempo]
Un piacere aver rivisto te, Sue. Buona fortuna, le gridò mentre lei scompariva lungo il sentiero, una graziosa ragazza che correva, i lisci capelli ondeggianti, lucenti… una giovane donna come avrebbe potuto diventare Nancy. Poi tornando verso casa, si diresse verso gli alberi, camminando sotto la loro ombra, lasciando dietro di sé il grande cielo azzurro, il sussurro delle voci del vento nel grano curvo sotto il suo impeto5.
Si dice che la propria vita scorra davanti agli occhi prima di morire, e che, nel momento in cui tutto si fa compiuto, si afferri il senso dei giorni vissuti senza sapere chi, in verità, si è stati. Capote non descrive semplicemente a lungo le abitudini, ad esempio, di Nancy Clutter, per permettere al lettore di sapere qualcosa su di lei en passant, giusto per farsi un’idea. Il suo intento è più umano e ad ambizioso: le pagine che ripercorrono gli ultimi giorni della sua vita, come il momento che anticipa la morte, contengono la sua vita. Quelle pagine, comunicandoci chi essa sia stata, sono il tentativo di donarle quel senso della vita che si compie nell’atto della morte e che gli è stato sottratto con un colpo di fucile esploso in viso; come per
3 «Quell’uomo sarebbe comunque morto, lo so ma on potevo lasciarlo in quello stato. Ordinai a Dick di reggere la pila, di puntargliela addosso. Poi presi la mira. La stanza scoppiò. Divenne azzurrina. Esplose. Gesù, non ho mai capito come non abbiano sentito la detonazione nel raggio di trenta chilometri. All’orecchio di Dewey echeggia quello scoppio, un’esplosione che quasi lo rende sordo al fluire bisbigliante della morbida voce di Smith. Ma la voce va avanti lanciando una sventagliata di suoni e immagini: Hickock che dà la caccia alla cartuccia esplosa; in fretta, a precipizio, e la testa di Kenyon in cerchio di luce, il mormorio di suppliche soffocate […].» (cfr. T. Capote, A Sangue Freddo, cit., p. 261 ).4 Come quando lo sguardo del narratore lascia la camera di Kenyon dalla quale si scopre mancare una radiolina, che scopriremo in possesso di Perry.5 T. Capote, A Sangue Freddo, cit., p. 391.
restituire agli occhi stessi di Nancy una dignità e un senso per una vita che doveva ancora da vivere 6. I personaggi di Capote sono viventi, rivivono nella persona dell’autore, che si fa carico per intero del loro destino, ma su questo aspetto, ci torneremo anche quando tratteremo di Gomorra. Capiamo allora che focalizzare l’attenzione sugli aspetti più cruenti del delitto sarebbe usare altra violenza sulle vittime e impedirebbe di incontrare la fragile psicologia degli assassini, in particolare quella di Perry. Anch’egli dovrà essere incontrato da vicino così come si è incontrata Nancy, senza presupporre che la crudeltà dei suoi gesti esauriscano per intero la sua persona. Siamo di fronte a un senso dell’oggettività che mira a salvare l’umano e che cerca di evitare di ricondurre i personaggi a degli oggetti (narrativi) che scientificamente possono essere inquadrati e definibili nei in comportamenti decodificabili. Sorprendente, a tal proposito, è la scelta narrativa di non raccontare in diretta l’eccidio; proprio quando sembrava che il nostro narratore fosse onnisciente, un’ellissi ci porta all’orlo dell’omicidio, esattamente agli attimo che lo seguono e che lo precedono: i paragrafi si succedono descrivendo alternativamente gli ultimi momenti di vita dei Clutter e l’avvicinarsi di Dick e Perry a Holcomb; poi, all’improvviso un salto narrativo, capiamo che i Clutter sono stati sterminati, perché Bobby Rupp, il ragazzo di Nancy, è nei panni del principale indiziato ed è sotto interrogatorio, alle prese con la macchina della verità. Ancora una volta la scena torna su Dick e Perry in viaggio e per ritornare nella camera di Nancy, che aveva appena finito di annotare sul suo diario che Bobby era andato via alle undici. Dick e Perry sono arrivati a Holcomb7. Se siano loro gli assassini Capote non ce lo dice direttamente. Questo atteggiamento certamente esprime cautela e prudenza investigativa; ma tale cautela è gratuita, una concessione di margine di incertezza e di dubbio temporaneo. I discorsi di Dick e Perry che si trovano nei paragrafi successivi mostreranno chiaramente la loro colpevolezza. Nel rivivere il momento dell’omicidio è come se il nostro narratore si fosse messo le mani davanti agli occhi per non guardare. Solo dopo la cattura, sarà Perry in persona a raccontare come si sono svolti i fatti nella fattoria dei Clutter8.
Anche la cittadina di Holcobm descritta nelle prime pagine è destinata a svanire, lì sono contenuti gli ultimi momenti di vita di una comunità che presto sarà scossa alle propria fondamenta. L’eccidio dei Clutter ha generato un onda di diffidenza9:
6È significativo a proposito quando Capote ci mostra il diario di Nancy: «era un diario che copriva un periodo di cinque anni; nei quattro anni in cui l’aveva avuto non aveva mai trascurato di fare un’annotazione sebbene la straordinarietà di alcuni avvenimenti (il matrimonio di Eveanna, la nascita del nipotino) e il dramma di altri (la sua prima VERA lite con Bobby, una pagina letteralmente chiazzate di lacrime) l’avessero costretta a usurpare spazio destinato al futuro. Un inchiostro di colore diverso caratterizzava ogni anno: il 1956 era verde e il 1957 uno svolazzo rosso, sostituito l’anno seguendo da un vivido colo lavanda, e ora, nel 1959 si era decisa per un dignitoso blu. Ma, come sempre, continuava a gingillarsi con la propria calligrafia, inclinandola a destra o a sinistra, dandole una forma tondeggiante o aguzza, prodiga o contratta, come se stesse domandandosi: «è questa Nancy? O questa? O quest’altra? Quale sono io?» […]. Tuttavia negli ultimi mesi aveva migliorato e ora con una grafia di affiorante maturità […].» (cfr. T. Capote, A Sangue Freddo, cit., p. 73).7 «L’argine, quello deve essere l’argine, ora giriamo a ovest… vedi gli alberi? È qui, deve essere qui» (cfr. T. Capote, A Sangue Freddo, cit., p. 120).8 «Un attimo prima che gli chiudessi la bocca il signor Clutter mi domandò, e quelle furono le sue ultime parole, come stava sua moglie, se stava bene, e io dissi che era tutto a posto, che tra poco si sarebbe addormentata, e gli dissi che non mancava molto al mattino e che allora qualcuno gli avrebbe trovati e tutta quella storia, io, Dick, e il resto, gli sarebbe parsa come un sogno. Non lo stavo prendendo in giro. Non avevo intenzione di farli del male. Mi pareva un signore molto simpatico. Cortese. La pensai così fino al momento in cui gli tagliai la gola» (cfr. T. Capote, A Sangue Freddo, cit., p. 260).9 «Martedì, all'alba, dei cacciatori di fagiani provenienti dal Colorado, forestieri che ignoravano la sciagura locale, rimasero stupefatti da quel che videro quando, superate le praterie, attraversarono in auto Holcomb: finestre illuminate, quasi tutte le finestre di quasi tutte le case, e nelle stanze vivamente rischiarate, gente vestita da capo a piedi, perfino intere famiglie che erano rimaste in piedi tutta la notte, perfettamente sveglie, ben attente, con l'orecchio teso. Di che avevano paura? «Potrebbe accadere di nuovo.» Quella, con varianti, era la risposta usuale. Tuttavia una donna, un'insegnante osservò: «L'impressione non sarebbe stata neppure la metà se fosse accaduto a
Tutti ritenevano che l’assassino fosse tra loro, e tutti, fino all’ultimo, concordavano con l’opinione espressa da Arthur Clutter, un fratello dell’ucciso, che, parlando con i giornalisti nell’atrio di un albergo di Garden City, il 17 novembre, aveva dichiarato: «Quando questa tragedia sarà chiarita, scommetto che chiunque sia stato, è una persona che si trova entro un raggio di sedici chilometri da qui»10.
Ma gli assassini, ci dice nel paragrafo successivo Capote, nel momento in cui Arthur Clutter rilasciava la sua dichiarazione, erano già a seicento chilometri di distanza. Per la brevità di questo lavoro ci limiteremo a seguire la complessa figura di Perry. Tale complessità è voluta dal modo in cui Capote pensa il suo romanzo non-fiction. Come dicevamo, l’atteggiamento di oggettività di Capote non è quello scientifico del behaviorista che sta attento al dato in sé e che cerca di non confondere nel percepito il proprio se. Come altra riprova, possiamo notare che, se fosse così, non potremmo spiegarci la lunga descrizione con cui Perry entra in scena nel romanzo. Inoltre, la stessa cura e lunghezza con cui Capote introduce Perry è stata riservata solo alle vittime Clutter e non è invece stata riservata a Dick. Strategia narrativa, che instaurando un’analogia con le vittime, surrettiziamente fa di Perry una vittima. In questa prima descrizione troviamo Perry avvolto nei suoi pensieri, preso dall’eccitazione, sta aspettando che arrivi Dick, l’ideatore di un colpo che gli avrebbe sistemati per la vita:
e quando la cosa fosse sistemata il Messico. La cartina era lacera, tanto maneggiata da essere divenuta morbida come pelle di camoscio. Poco lontano, dietro l’angolo, nella stanza d’albergo dove alloggiava, ce n’erano centinaia d’altre […].11
e poco più avanti leggiamo che
il suo viso l’affascinava. Ogni punto di vista dal quale lo osservava dava un’impressione diversa. Era un volto mutevole e gli esperimenti guidati dallo specchio gli avevano insegnato a controllarne le espressioni […]; un leggero movimento del capo, una contrazione delle labbra, e lo zingaro corrotto di trasformava nel nobiluomo romantico.12
La voce narrante sa più cose di quante i suoi occhi possano vedere, perché è lì nei suoi pensieri, ne scorge le sue passioni e i suoi sogni, fino a sentire come essi vengono evocati al morbido tatto di quelle cartine geografiche così logore. La descrizione e immersione della vita psichica di Perry, infatti, poi cessa quando accade un fatto appartenente al così detto mondo esterno: «Risuonò un clacson. Finalmente Dick».
Siano gli atteggiamenti paterni o amicali, o investigativo e analitico-psichiatrici, tali punti di vista parziali appartengono ai personaggi del romanzo, come, ad esempio, al dottor Joseph Satten, veterano della psichiatria legale che ha analizzato Perry. Capote non ha, come abbiamo detto, alter ego né per questo punti di vista parziali: è pura voce narrante e puro pensiero che conosce tutto e tutti, ma che nessuno conosce. A tal proposito è significativo il passo in cui Perry è ormai in carcere in attesa di essere processato:
«a parte lo scoiattolo, a parte la signora Meier e gli occasionali consulti col suo avvocato, il signor Fleming, Perry era
praticamente solo»13.
Il momento della sua reclusione è evidentemente l’unico nel quale Capote e Perry possano essersi mai conosciuti. Tanta perizia e delicatezza nelle pagine spese nelle descrizioni di Perry, tuttavia, lasciano
chiunque altro che non fossero i Clutter. Chiunque altro meno ammirato. Prospero. Sicuro.» (cfr. T. Capote, A Sangue Freddo, cit., p. 69).10 T. Capote, A Sangue Freddo, cit., p. 108.11 T. Capote, A Sangue Freddo, cit., p. 25.12 T. Capote, A Sangue Freddo, cit., p.27.13 T. Capote, A sangue freddo, cit., p. 282.
pensare che i due si siano effettivamente incontrati e che abbiano parlato anche a lungo. Ma è solo un dubbio. Se decidiamo di stare al testo non possiamo che escludere che i due abbiano avuto il benché minimo contatto. Ma il dubbio che i due si siano incontrati è legittimo e spinge l’attenzione del lettore al di là dei confini del testo, verso la controversa biografia e la vicenda umana di Capote. Da un punto di vista investigativo, in un romanzo verità scientificamente sorretto da prove, citazioni di fonti, atti e di un metodo teso a dimostrare la verità dei fatti, tale dichiarazione non suonerebbe solo imparziale, ma anche falsa; tale affermazione inoltre risulta apatica e carica di cinismo, poiché significherebbe che Capote conoscerebbe Perry così come si conosce una cavia. Questa interpretazione sarebbe corretta, se presupponessimo che il narratore tratti con oggettività la realtà, nel senso etimologico di ob-jectum, stare di fronte, come se gli fosse estranea. Se Capote avesse avuto un alter ego, l’oggettività che abbiamo rilevato essere parziale sarebbe stata restituita nella sua integrità: ma tale scelta stilistica lo avrebbe costretto a relativizzare e limitare la propria esperienza; l’avrebbe resa certamente più umana e scientificamente controllabile anche a chi non si fosse mai interessato del destino dei Clutter. Ma l’esperienza di un alter ego sarebbe stata alla pari con quella di qualunque altro personaggio, che infatti è mosso da personali motivazioni, come Alvin Dewey Jr., l’investigatore che ha coordinato le indagini sul caso Clutter. L’ambizione di Dewey, oltre a quella di assicurare alla giustizia gli assassini, era quella di «sapere esattamente quel che era successo in quella casa quella notte»14 e aveva un pensiero fisso:
anche se non gli avessi conosciuti [i Clutter], se non avessi avuto tanta simpatia per loro, il mio atteggiamento non sarebbe diverso. Perché di brutte cose ne ho viste, accidenti se ne ho viste. Ma niente di così malvagio. Ma dovessi anche impiegarci il resto della mia vita, saprò cosa accadde in quella casa: chi e perché15.
Ecco, “sapere esattamente cosa era successo in quella casa quella notte” non è l’ambizione di Capote. L’abbiamo visto, posticipa quella che per Dewey è esigenza che è pura ossessione. La non fiction novel di Capote gode di un punto di vista assoluto capace di rivivere e patire in se l’interezza della triste vicenda dei Clutter. E parte anche della figura controversa di Perry Smith, forse un una vittima del sistema, certamente un omicida a sangue freddo. Al momento dell’esecuzione Dewey è presente, ma come Capote al momento dell’omicidio dei Clutter, chiude gli occhi prima che tolgano il terreno ai piedi del prigioniero col cappio al collo
E ora, quando Dewey riaprì gli occhi, ciò che vide furono quegli stessi piedi da bambino che pendevano, oscillanti16
Capiamo che Perry è una figura speculare a quella di Nancy, un adulto la cui infanzia è stata negata e trasformata in un inferno, come l’inferno erano per Perry le sue gambe da bambino che gli procuravano incessantemente dolore.
La voce di Capote è espressione di un destino per il quale il vivere e il morire sono definiti una volta per tutte: non è possibile mutare ciò che è accade ed è accaduto. La scelta di Capote di assumere un punto di vista assoluto lo spinge fuori dal tempo, pur essendovi immerso. Questo punto di vista è un’istanza estetica che si fa metafisica ed etica: per Capote, essere parte della realtà significherebbe sacrificare l’intera verità di ciò che è accaduto. Capote non può fare nulla per i morti, niente per Perry, che prima di morire chiese perdono17, né per i sopravvissuti se non restituire loro solo letterariamente l’umanità che gli è stata
14 T. Capote, A Sangue Freddo, cit., p. 282.15T. Capote, A Sangue Freddo, cit., p. 98.16 T. Capote, A Sangue Freddo, cit., p. 98.17 «Negli ultimi tré anni nella Cella della Morte aveva continuato a dipingere autoritratti e immagini di bambini, per lo più figli di detenuti che gli offrivano le fotografie della loro progenie che vedevano tanto raramente. «Penso,» disse, «che sia una cosa bestiale togliere una vita in questo modo. Non credo nella condanna capitale, né moralmente né legalmente. Forse avevo qualcosa da dire, qualcosa...» La sua sicurezza venne meno; la timidezza gli smorzò la voce
realmente negata. Il distacco, la decisione di non sottostare all’egemonia della storia e della finitezza che essa comporta è il rigetto, da parte di Capote, della libertà che permette di disporre della vita e della morte degli individui e, dunque, del senso della loro esistenza. La rivolta nei confronti del misconoscimento dell’umanità si attua nella parola, che si ripiega nell’interiorità dell’artista e rifiorisce entro i soli limiti della narrazione. Tornano alla mente alcune considerazioni di Camus sulla sull’opera d’arte, che, per dominare le passioni collettive sotto il segno di un’unità che ne riassuma il senso, assume lo stile del reportage:
la bellezza, senza dubbio, non fa le rivoluzioni. Ma viene il giorno in cui le rivoluzioni hanno bisogno di lei. La sua norma, che nell’atto stesso di contestare il reale gli conferisce unità, è anche quella di rivolta18.
La letteratura per Saviano, invece può mutare molte cose, a iniziare, dopo la pubblicazione di Gomorra, dalla sua stessa vita. La scrittura non è meramente ostensiva, non indica dei fatti, ma ha di mira il vissuto dell’io narrante. Di questo ce ne accorgiamo fin dalle prime pagine, nelle quali la violenza è dilagante. Saviano usa l’elemento della violenza per generare una reazione di shock nel lettore:
I portelloni mal chiusi si aprirono di scatto e iniziarono a piovere decine di corpi. Sembravano manichini. Ma a terra le teste si spaccavano come fossero crani veri. Ed erano crani. Uscivano dal container uomini e donne. Anche qualche ragazzo. Morti.19
Fin dalle prime pagine il lettore deve essere al corrente la morte è ovunque e le possibilità di vita sono ridotte alla mera sopravvivenza. La non-fiction novel di Saviano sollecita il lettore a reagire a una guerra che nessuno sa essere in atto, che sta riducendo l’umanità a pura merce e, dunque, alla più perentoria e silenziosa negazione dell’umano20. Per reagire a tale violenza e muro di silenzio, Saviano ci invita a rivivere con lui i cruenti episodi che gli hanno reso chiaro come il Sistema – il modo in cui si autodefiniscono i clan camorristici – per mantenersi vivo, debba asservire a se e possa sacrificare innumerevoli vite umane.
Gomorra narra in prima istanza di un vissuto, quello di Saviano, e solo in seconda battuta di chi compone il Sistema e di come esso funzioni. Le parole di Saviano non rinviano a dei dati solo controllabili che riguardano il Sistema, ma alla modalità, che non è concesso a tutti di poter adottare, attraverso la quale essi sono conosciuti. È su tale modalità che concentreremo la nostra indagine. Come in Capote, la verità non sta in faldoni della polizia, e questo “assioma” a sua volta, l’autore, non lo comprende dai libri, ma lo
riducendola a un volume appena udibile. «Sarebbe senza senso chiedere perdono di quel che ho fatto. E' fuori luogo. Ma lo faccio. Chiedo perdono.» Gradini, cappio, benda» (cfr. T. Capote, A Sangue Freddo, cit., p. 367).
18 A. Camus, L’uomo in rivolta, cit., p. 302.19 A. Saviano, Gomorra, Arnoldo Mondadori Editore, Milano 2006, p. 7.20 «La camorra ha ucciso più di tutti. Mi viene in mente un’immagine. Quella della cartina del mondo che spesso compare sui giornali. Campeggia sempre in qualche numero di “Le Monde Diplomatique», quella mappa che indica con un bagliore di fiamma tutti i luoghi della terra dove c’è un conflitto. Kurdistan, Sudan, Kosovo, Timor Est. Viene di gettare l’occhio sull’Italia del sud. Di sommare i cumuli di carne che si accatastano in ogni guerra che riguardi la camorra, la mafia, la ‘ndrangheta, i Sacristi in Puglia o i Basilischi in Lucania. Ma non c’è traccia di lampo, non v’è disegnato alcun fuocherello». (cfr. A. Saviano, Gomorra, cit., p. 141).
sperimenta sulla sua stessa pelle, ad esempio, in un incontro che ha avuto da ragazzo con Xian.21 o di don Peppino, le cui parole
andavano ben oltre la sua professione di fede disincarnata dalla realtà […].Foggiava un metodo nuovo che andava a rifondare al parola religiosa e politica. Una fiducia nella possibilità di azzannare la realtà, senza lasciarla se non dilaniandola. Una parola capace di inseguire il percorso del danaro seguendone il tanfo.22
Comprendiamo che l’io narrante è agli antipodi da quello che ritroviamo in A Sangue Freddo: apprende dalla realtà perché è dialogico. A livello metanarrativo, Saviano rende partecipe il lettore di quegli incontri che gli hanno permesso di penetrare la realtà del Sistema con un determinato metodo e uso della parola. Il valore di testimonianza delle parole di Saviano e il metodo che ritroviamo in Gomorra non sono frutto di una creazione artistica, ma un passaggio di testimone, l’inanellarsi nella scrittura delle parole di quegli uomini che si sono rivoltati contro la camorra. L’io narrante di Saviano, scrivendo Gomorra, entra in dialogo con loro, e risolve una questione in sospeso anche col proprio padre, in un flashback di quando era ragazzo, sul senso della libertà e del bene:
È come chi decide di fare il filosofo e chi il medico, secondo te chi dei due decide della vita di una persona?Il medico!Bravo. Il medico. Perché puoi decidere della vita delle persone. Decidere. Salvarli o non salvarli. È così che si fa il bene, solo quando puoi fare il male. Se invece sei un fallito, un buffone, uno che non fa nulla. Allora puoi solo fare il bene, ma quello volontario è solo uno scarto di bene. il bene vero è quando scegli di farlo perché puoi fare il male. Non rispondevo non riuscivo mai a capire cosa volesse realmente dimostrarmi. E in fondo non riesco nemmeno ora capirlo. Sarà anche per questo che mi sono laureato in filosofia, per non decidere al posto di nessuno.
Saviano è come se rispondesse al proprio padre che il potere della scrittura, e questo vale anche per Capote, è quello di fermare il corso della storia, quasi strappandola dalle maglie del tempo che scorre in avanti, lasciando libero uno spiraglio di nuova luce per il futuro. La non-fiction novel dei nostri due autori non cerca di cambiare come le cose stanno ora, non mira a decidere della vita e della morte delle persone, ma mira a una presa di consapevolezza che apra a un futuro più umano. Dopo la morte di Francesco Iacomino, Saviano sente pulsare nelle sue vene un istinto rivoluzionario:
Con la morte di Iacomino mi si innescò una rabbia di quelle che somigliano di più a un attacco d’asma piuttosto che a una smania nervosa. […] dovevo forse anche io scegliermi un palazzo, il Palazzo, da far saltare in aria, ma ancor prima di infilarmi nella schizofrenia dell’attentatore, appena entrai nella crisi asmatica di rabbia, mi rimbombò l’ Io so di Pasolini come un jingle musicale che si ripeteva sino all’assillo 23.
Ma, per dirla con Camus, Saviano, non scade nell’atto rivoluzionario, non sceglie di uccidere, di disporre, dunque, della vita e della morte, ma accede al piano della rivolta24 ricordandosi dell’Io so di Pasolini.25 Il che
21 «Mostravo di conoscere i tratti generici del mondo mafioso cinese, con la presunzione che conoscere gli atti d’indagine fosse un modo maestro per possedere il calco della realtà. Xian portò il suo pollo fritto in tavola, prese posto e non disse nulla. Non so se ritenesse interessante quanto dicevo. Non so e non ho mai saputo se fosse parte di quell’organizzazione. Bevve la birra e poi alzò a metà il sedere dalla sedia, tirò fuori il portafogli dalla tasca dei pantaloni, frugò con le dita senza guardare e poi cacciò tre monete. Le stese sul tavolo fermandole sulla tovaglia con un bicchiere rovesciato. “Euro, dollaro, yüan. Ecco la mia triade” Xian sembrava sincero. Nessun altra ideologia, nessuna sorta di simbolo o passione gerarchica. Profitto, business, capitale» (cfr. A. Saviano, Gomorra, cit., p. 17) 22 A. Saviano, Gomorra, cit., p. 264.23 A. Saviano, Gomorra, cit., p.245.24 «La rivolta è nell’uomo il rifiuto di essere trattato come casa e ridotto a pura storia. È l’affermazione di una natura comune a tutti gli uomini, che sfugge al mondo della potenza» (cfr. A. Camus, L’uomo in rivolta, cit., p. 269).25 «un posto dove riflettere senza vergogna sulla possibilità della parola. La possibilità di scrivere dei meccanismi del potere, al di là delle storie, oltre i dettagli. Riflettere se era ancora possibile fare i nomi, a uno a uno, indicare i visi, spogliare i corpi dei reati e renderli elementi dell’architettura dell’autorità. Se era ancora possibile inseguire come
significa non solo sapere i nomi e i luoghi dove si nascondo gli assassini, ma anche conoscerli da vicino. Forse più da vicino di quanto loro stessi si conoscano. Per fermare l’onda di violenza della camorra, occorre capire come funziona il Sistema e come esso crei i propri emissari. Proprio come aveva iniziato a fare don Peppino, per il quale
L’obiettivo non era vincere la camorra. Come lui stesso ricordava «vincitori e vinti sono sulla stessa barca» 26. L’obiettivo era invece comprendere, trasformare, testimoniare, denunciare, fare l’elettrocardiogramma al cuore del potere economico come un modo per comprendere come spaccare il miocardio dell’egemonia dei clan.
All’origine dell’onda di criminalità, per Saviano, c’è la logica dell’accumulazione del capitale. Il Sistema è, non la degenerazione, ma la massima espressione del capitalismo27. Il Sistema, inoltre, non solo porta al massimo livello, secondo Saviano, una prospettiva neoliberista, ma esso abbraccia un’ideologia di prodotti di consumo Hollywoodiani elevandola a immagine di se, e così troveremo emuli di chi pensa di maneggiare una pistola come Jules Winnfield in Pulp Fiction o di impadronirsi del mondo come Tony Montana in Scarface. I camorristi dimenticano chi sono stati alla nascita e si danno una nuova identità dal momento che diventano affiliati del Sistema. L’ignoranza di chi si è stati è la forza per risultare vincenti. Secondo Saviano
la logica dell’imprenditoria criminale, il pensiero dei boss coincide col più spinto neoliberismo. Le regole dettate, le regole imposte sono quelle degli affari, del profitto, della vittoria su ogni concorrente. Il resto vale zero.28
Potrebbe essere interessante riflettere come la vita di questo sistema camorristico sia il volto di una meontologia, un’ontologia del nulla, o di estremo soggettivismo, ma per isolare e riconoscere nello specifico quali idee filosofiche lo influenzino e lo determinino occorrerebbe un’indagine antropologica del fenomeno camorristico che in questo saggio non è possibile approfondire. Tuttavia, spiega Saviano, i camorristi, si creano una nuova identità, sono liberi di interpretare il mondo come sia più conveniente. Negano qualunque fatto che sia loro di ostacolo. Il dominio dell’interpretazione è quello dell’economia di mercato. Sia Capote, come abbiamo cercato di vedere, che Saviano esorbitano dall’idea di controllo dell’ente, che tradotto significa disporre del mondo come si vuole. In Gomorra non sembra valere l’adagio nicciano che non ci sono fatti, ma solo interpretazioni. Sebbene questa tematica filosofica resti inespressa, riassorbita dalla critica al Capitalismo, come se ne fosse una sua emanazione, tuttavia ne scorgiamo una traccia molto rarefatta, in un passo che cita direttamente un interprete del nichilismo europeo, Ernst Jünger, che
direbbe che la grandezza è esposta alla tempesta. Lo stesso ripeterebbero i boss, gli imprenditori della camorra. Essere il centro di ogni azione, il centro del potere. Usare tutto come mezzo e se stessi come fine. Chi dice che è amorale, che non può esserci vita senza etica, che l’economia possiede dei limiti e delle regole da seguire, è soltanto colui che non è riuscito a comandare, che è stato sconfitto dal mercato. L’etica è il limite del perdente, la protezione dello sconfitto29
La logica e la volontà del dominio, insomma, scavalcano ogni cosa. Anche la volontà di chi pratica tale logica soggiace a una volontà più profonda di quella che sgorga dalle viscere del proprio io: è quella stessa
porci da tartufo le dinamiche del reale, l’affermazione dei poteri, senza metafore, senza mediazioni, con sola lama della scrittura»(cfr. A. Saviano, Gomorra, cit., p. 246).26 Dal nostro punto di vista, la barca è il destino di violenza voluto dalla camorra che Saviano ha provato sul suo corpo.27 «La logica dell’imprenditoria criminale, il pensiero dei boss coincide col più spinto neoliberismo. Le regole dettate, le regole imposte sono quelle degli affari, del profitto, della vittoria su ogni concorrente. Il resto vale zero» (cfr. A. Saviano, Gomorra, cit., p. 133).
28 A. Saviano, Gomorra, cit., p.133.29A. Saviano, Gomorra, cit., p.132.
del Sistema, che come un gigantesco Leviatano si nutre della vita dei boss camorristici che Saviano descrive tanto accuratamente30. Di certo i boss non possono essere definiti delle vittime, ma semmai dei burattini in mano a un sistema che non possono controllare e che li tiene in vita nel loro essere criminali. Ogni volta, infatti, che uno dei boss tenta di essere l’unico volto che il potere economico della camorra possa assumere, è destinato a perire:
La dittatura di un uomo nei clan è sempre a breve termine, se il potere di un boss durasse a lungo farebbe lievitare i prezzi, inizierebbe a monopolizzare i mercati irrigidendoli, investirebbe sempre negli stessi spazi di mercato non esplorandone di nuovi. Invece che divenire un valore aggiunto all’economia criminale diverrebbe un ostacolo per gli affari31
Il potere economico di spirito capitalista esprime il massimo della sua potenza quando si colloca al di là di ogni principio di bene o di male e la sua vita, la sua pace, si regge sulla guerra. Ancora una volta siamo costretti a ricorrere all’espressione “destino” per descrivere ciò che anche Saviano ha in pugno nel suo racconto. Il destino è qualcosa che riguarda tutti e che non può essere aggirato, pena la morte. Comprendere come i fatti si svolgono significa rintracciare quel meccanismo – il Sistema – che, invincibile, resiste e determina la morte dei suoi funzionari che vogliono impadronirsene. Il sistema si abbevera della sete di potere dei boss, che, guidati da una sorta di eterogenesi dei fini, non sono che dei sacerdoti di un potere che non comandano e che in realtà li divora. E che con la loro sete di potere annientano la società riducendola in schiavitù. Anche se, ripetiamo, è il Sistema stesso a ridurre gli uomini in schiavi. Saviano ci riporta l’ennesima vittima, ucciso per un sospetto di connivenza con un cartello camorristico rivale a quello dei Di Lauro e nota che
ciò che aleggia sulla morte di Attilio è un ingiusta diffidenza. E la diffidenza è l’assenso silenzioso che viene concesso all’ordine della camorra32.
Nella diffidenza si sottostà alla Sistema, all’ordine della camorra, non per fedeltà a chissà quale clan. L’unico spazio di libertà che l’uomo può trovare glielo concede il Sistema. E dunque è schiavo. Seguire la logica di Saviano amplifica l’orrore delle morti di cui ci racconta, perché la realtà che ha vissuto ubbidisce ai canoni della distopia Orwelliana, impietosa perfino nei confronti dei ragazzini, che vengono programmati a morire e, inevitabilmente, indottrinati a disprezzare la vita.
Per concludere
La non-fiction novel si trae la sua forza dal senso della vista: la visione evoca insieme la visibilità, la possibilità che una cosa appaia, e una certa staticità, quella dello sguardo, che si fissa e che non si differenzia da ciò che è osservato. La realtà in A sangue freddo e in Gomorra ha la forza magnetica di catturare lo sguardo del lettore, dettandogli le regole per interpretare ciò che è visto. La realtà presentata, imponendosi alla mente di chi la osserva è la terra stessa su cui si poggia il lettore, un terreno ermeneuticamente arido, sul quale pregiudizi e opinioni del lettore non possono attecchire facilmente e vengono sradicati. In entrambi gli autori la realtà non rinvia ad altro che a se stessa, dunque non è un simbolo e non è un’allegoria: il significato della narrazione riposa esclusivamente nei fatti narrati. Le
30 Un esempio per rimanere nella tematica dell’ideologia capitalista: «Sandokan [boss del cartello dei Casalesi] chiese di parlare, voleva reagire alla sentenza, ribadire la sua tesi, quella del suo collegio difensivo: che lui era un imprenditore vincente, che un complotto di magistrati invidiosi e marxisti aveva considerato la potenza dell’agro aversano una forza criminale e non il frutto di capacità imprenditoriali ed economiche» (cfr. A. Saviano, Gomorra, cit., p. 233).
31 A. Saviano, Gomorra, cit., p. 234.32 A. Saviano, Gomorra, cit., p 138.
differenze di stile sono evidenti, in Capote il linguaggio è rapido, fuggevole, tocca la realtà in ogni sua piega, mentre in Saviano porta a saturazione ciò che viene esperito da lui in prima persona, rendendolo resistente come pietra. Questo diverso uso del linguaggio si rispecchia nella sostanziale differenza delle due voci narranti: Capote comunica una realtà senza mediazioni, come se fosse la voce delle cose stesse in carne e ossa a parlare; mentre Saviano introduce la realtà criticamente e “dialetticamente” attraverso l’esperienza e soprattutto il suo stesso corpo.
La parola è espressiva di mondo e al tempo stesso portatrice di verità, anche se spesso questa non corrisponde a fatti oggettivamente e scientificamente dimostrabili. La verità che queste due inchieste cercano di far emergere è come la violenza esploda al tentativo da parte dell’uomo di annientare con ogni mezzo la propria condizione – metafisica direbbe Camus – di privazione e di miseria: attraverso l’omicidio in Capote e nel delirio di onnipotenza del Sistema in Saviano.
Capote e Saviano sono due punti cardinali – tra di loro agli antipodi – della non-fiction novel, che, infine, esprimono un senso dell’approccio all’etica della scrittura profondamente diverso: in Capote il suo io si annienta, non ha più libertà, se non quella di restituire nella letteratura dei tratti di umanità a coloro che non possono più alterare il loro destino macchiato di sangue; in Saviano il suo io trova la libertà nella scrittura, anche se quella libertà tuttavia non è la sua propria, ma quella dell’intera umanità che si deve rendere conto di essere schiava della camorra e rivoltarsi a essa.