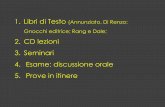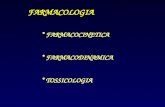Farmacodinamica settembre
-
Upload
chiarapetraroli -
Category
Documents
-
view
1.124 -
download
0
Transcript of Farmacodinamica settembre
FARMACOLOGIA La farmacologia generale si divide in 2 grandi branche: la farmacodinamica e la farmacocinetica. La farmacocinetica studia il destino dei farmaci nellorganismo, assorbimento, distribuzione del farmaco nei vari tessuti, il metabolismo (CYP450) e leliminazione. FARMACODINAMICA Si definisce cos la branca che studia l'interazione farmaco-recettore, quindi il meccanismo d'azione. Per farlo indispensabile fornire alcuni concetti/definizioni di base. ENDOCOIDE: semplicemente la sostanza endogena che attiva un recettore chiamata cos quando viene isolato prima il suo farmaco e quindi l'effetto sullorganismo e solo in seguito si scopre la sostanza endogena. Es. recettore per la morfina (oppioide) endocoidi = encefaline, endorfine AGONISTA: sostanza che provvista di una affinit di legame con un dato recettore (interazioni di legame specifico) e di una efficacia intrinseca, ovvero di una attivit. AGONISTA INVERSO: ci che propriamente si definisce come lagonista avente effetto opposto rispetto allagonista di riferimento. Es. le benzodiazepine e le -carbonine agiscono recettore GABAA, si legano allo stesso sito ma producono effetti opposti, le prime riducono lansia, le seconde la aumentano, quindi abbiamo 2 agonisti (entrambi sono dotati di efficacia intrinseca). Agonisti diretti sono le benzodiazepine, agonisti inversi sono le beta-carbonine. Esiste un farmaco chiamato fumazenil che invece agisce da antagonista legandosi allo stesso sito ma non possedendo efficacia intrinseca blocca sia lazione ansiolitica delle benzodiazepine sia lazione ansiogenica delle beta-carbonine. -riprenderemo altre categorie di sostanze farmacologiche solo dopo aver chiarito alcune propriet AFFINIT DI LEGAME: viene determinata sperimentalmente in genere con la realizzazione di una curva che descrive la funzione che lega il rapporto fra ligande legato e libero alla quantit di ligande legato, detto analisi Scatchard. Per fare ci indispensabile disporre del dato di ligande legato al recettore, il che si ottiene con lo studio del binding-recettoriale: 1- si isola il tessuto con il recettore target; 2- si utilizza un ligande caldo (con tracciante radioattivo, es propanololo triziato, un -bloccante, si usa per lipertensione arteriosa, per la profilassi dellemicrania, per lischemia cardiaca, per lo scompenso cardiaco, per i tremori intenzionali dellanziano); questo si legher non solo ai siti specifici ma anche a siti totalmente aspecifici nel resto delle membrane fornendo una quota di BOUND TOTALE; 3- si dilava con lo stesso ligande, ma freddo; questo per definizione dell'interazione specifica liganderecettore (spiazzabile e saturabile) sostituir selettivamente solo i ligandi legati ai recettori. La radioattivit rimanente indicher il BOUND ASPECIFICO. 4- baster la sottrazione: B. TOT B. ASPECIFICO = B. SPECIFICO. Lanalisi Scatchard permette di ricavare un grafico in cui sullasse delle ascisse posta la quota della sostanza radioattiva legata (bound), mentre nellasse delle ordinate ad ogni punto di bound corrisponde un bound/free cio il rapporto tra il radioattivo che si legato e quello che rimasto libero. Il grafico una retta, lintercetta fra la retta e lasse x detto Bmax,
corrispondente alla densit recettoriale del tessuto target studiato. Linverso del reciproco dellangolo () tra la retta e lasse y (-1/) uguale alla Kd cio alla costante di dissociazione della sostanza radioattiva nei confronti del recettore, che quindi sar inversamente proporzionale all'affinit. EFFICACIA INTRINSECA: in questo caso oggetto di studio non un legame ma una funzione, per questo costruiremo tutta una serie di curve delleffetto in funzione della concentrazione (in ambito di laboratorio) / dose (in ambito clinico) dellagonista, espressa in scala logaritmica. Osserveremo rispetto a queste curve e rispetto a diversi farmaci 2 parametri chiaramente interessanti: 1- EFFICACIA: il max effetto prodotto da un farmaco indipendentemente da concentrazione/dose che lo ha prodotto; si osserva come il plateau della curva (diremo: Emax n.d.r.); Es. Se somministriamo un farmaco che migliora i sintomi della schizofrenia dell80% con un dosaggio di 200-300 mg/die e poi diamo un altro farmaco di 5-10 mg/die con uguale risultato, i farmaci risultano di UGUALE EFFICACIA (legato al n di recettori presenti). 2- POTENZA: l'entit delleffetto in relazione alla concentrazione/dose; si pu prendere come parametro EC50, ovvero la concentrazione/dose che produce il 50% delleffetto massimale. La potenza inversamente proporzionale alla concentrazione/dose e non correlata allefficacia. Es. Nel trattamento della schizofrenia si usano: clorpromazina (largactil) e aloperidolo (haldol). Sono 2 antipsicotici classici (di prima generazione), molto efficaci ma con effetti avversi. Il largactil funziona in maniera ottimale tra 200 e 300 mg/die, laloperidolo tra 2 e 10 mg/die, laloperidolo pi potente, si somministra a gocce che sono inodori, incolori e insapori, ottime perch si possono usare nei pazienti che non hanno compliance (volont di sottostare al trattamento). La loro capacit di ridurre il delirio la stessa (uguale efficacia). Tra gli agonisti si distinguono AGONISTI PIENI (Full Agonist) e AGONISTI PARZIALI (Partial Agonist), dove i primi sono dotati di efficacia pari alla max possibile per il sistema su cui agisce, mentre i secondi a prescindere dalla loro potenza hanno efficacia inferiore a quella dellagonista pieno. L'importanza clinica e commerciale degli Agonisti Parziali sta nella minore incidenza statistica per questi ultimi degli effetti avversi (e.a.) di primo tipo, cio quelli legati al meccanismo d'azione primario del farmaco. Es. farmaco per abbassare la pressione ipotensione del paziente Mentre gli e.a. di secondo tipo sono quelli estranei al meccanismo d'azione primario, detti anche effetti collaterali indesiderati. Es. PENICILLINA attacca la parete cellulare batterica non presente nelle nostre cellule, ma d reazioni immunoallergiche, di ipersensibilit che non hanno niente a che vedere con il blocco della sintesi del peptidoglicano. Si immagini di avere in membrana 5 recettori, la cui attivazione d il 100% della risposta e che ognuno dei 5 contribuisca per il 20%. In questa circostanza non presente riserva recettoriale. Somministrando lagonista pieno (full agonist) questo lega tutti e 5 i recettori e si ha il 100% della risposta con il contributo del 20% da parte di ogni recettore. Dando lagonista parziale (partial agonist) questo lega tutti e 5 i recettori, ma ognuno di essi contribuisce per il 10% dando una risposta totale del 50%.
Si immagini nuovamente di possedere 5 recettori , per questa volta ogni recettore d il 50% della risposta. Quando lagonista pieno viene aggiunto, questo si lega a tutti e 5 i recettori perch ha affinit per tutti, per solo 2 recettori contribuiscono alla risposta mentre gli altri 3 rimangono di riserva, perch anche se legano lagonista pieno ci che a valle del recettore ormai saturato (non si pu andare oltre il 100%). Questo un sistema che ha riserva recettoriale. Ci possibile perch i recettori sono legati a sistemi di trasduzione del segnale che se si saturano non garantiscono pi alcuna risposta. Se a tale sistema si aggiunge un agonista parziale questo stimola ogni recettore del 20% e la risposta diventa del 100% perch in questo caso lagonista parziale attinge dalla riserva recettoriale quei 3 recettori che precedentemente non entravano in gioco. Lagonista parziale dotato di un efficacia intrinseca inferiore e d un effetto massimale inferiore se non c riserva recettoriale, se invece questa presente lagonista parziale si comporta da agonista pieno. Es. Le BENZODIAZEPINE (XANAX, VALIUM, EN) sono farmaci ansiolitici che spesso vengono assunti in maniera inappropriata, causano anche effetti avversi come incoordinazione motoria e atassia. Si immagini la riserva recettoriale per i recettori delle Benzodiazepine (GABAA) (sono PAM per essi), questa diversa nelle regioni cerebrali che controllano lansia e nelle regioni che controllano la coordinazione motoria nel cervelletto. Se si somministra un agonista pieno, questo curer lansia ma dar effetti avversi; se si d un agonista parziale ed presente riserva recettoriale nella zona che controlla lansia ma non nella zona che controlla il movimento si otterr un ottimo controllo dellansia (per via della riserva recettoriale che fa in modo che un agonista parziale si comporti da agonista pieno), ma si avranno meno effetti avversi perch nel cervelletto non presente la riserva recettoriale. Questo meccanismo permette di ottimizzare il rapporto tra efficacia terapeutica ed effetti avversi, cio il rapporto rischio beneficio. -Ancora sulle implicazioni della riserva recettorialeABITUDINE o TOLLERANZA: descrive il comportamento del recettore stimolato dallagonista che attraverso una modifica molecolare tende a desensibilizzarsi, tenta cio di fronteggiare lagonista verificando la perdita delleffetto che si osserva dopo una somministrazione pi o meno frequente del farmaco (che pu avvenire con tempi diversi, bradifilassi o tachifilassi, quest'ultima essendo un tipico problema della nitroglicerina usata come vasodilatatore coronario); per essere precisi labitudine fa riferimento alla riduzione dell'effetto terapeutico, mentre il termine tolleranza riguarda la riduzione degli effetti avversi. DIPENDENZA: l'altra faccia della stessa medaglia, cio della stessa modifica molecolare, il protrarsi della difesa del recettore contro lagonista fa s che lesistenza molecolare del recettore sia modellata sullagonista. Si definisce come una condizione che viene smascherata dall'insorgenza di una sindrome dastinenza nel momento della sospensione del trattamento farmacologico. Esistono 2 tipi di dipendenza distinti in base alle manifestazioni della crisi di astinenza: fisica e quella chiamata psichica, psicologica o motivazionale. La prima quella condizione in cui la sindrome di astinenza caratterizzata da segni clinici rilevabili. Es. Se lassunzione di eroina (una morfina diacetilata che penetra nel cervello con maggiore rapidit e facilit) viene sospesa nellarco 4-5 ore il paziente comincia ad avere dei segni clinici di astinenza molto stereotipati, ad esempio comincia a sbadigliare in modo cos forte che il condilo della mandibola si stacca e lATM si lussa, la pressione arteriosa sale, comincia
ad avere dolori diffusi, orripilazione, midriasi. una condizione che non porta a morte ma crea un tale sconforto che in quel momento il tossicodipendente ricerca leroina in maniera disperata. Es. Se un alcolista cronico sospende lassunzione di alcool, si sviluppa una sindrome nota come DELIRIUM TREMENS (delirio tremando) in cui si hanno convulsioni e anche manifestazioni psichiatriche di vario tipo oltre ad agitazione ed aggressivit. La seconda tipica del binge di cocaina/crack o di altri psicostimolanti con unastinenza non clinicamente evidente ma di forte ANEDONIA (=incapacit di provare piacere), DEMOTIVAZIONE, DEPRESSIONE. Questi due fenomeni si collegano con la riserva recettoriale perch se il sistema non ne dispone pi difficile che si sviluppino con un Agonista parziale, mentre se il sistema ne dispone le situazioni cliniche possono essere variabili, in quanto lAgonista pieno non ha nessuna attivit sulla riserva recettoriale, tuttavia ha maggiore effetto sui recettori saturanti il sistema rispetto allAgonista parziale che comunque attiva tutti i recettori. SUPERAGONISTA: sostanza che possiede un'attivit maggiore rispetto all'agonista endogeno del recettore e induce una desensibilizzazione cos rapida e totale da agire come antagonista funzionale (effetto paradosso); precisiamo che questo riferito solo a un sistema privo di riserva recettoriale, viceversa il superagonista agisce da agonista. Farmacologicamente, ad es, si utilizza il nafarelin, il buserelin e simili che sono superagonisti per il recettore del GnRH nei trattamenti della pubert anticipata per consentire la crescita (evitando la saldatura precoce delle cartilagini epifisarie), dell'endometriosi, del carcinoma prostatico (per bloccare la produzione di androgeni) ecc. La sclerosi multipla una malattia demielinizzante in cui la guaina mielinica del SNC (quella prodotta dagli oligodendrociti) viene distrutta dal sistema immunitario; una patologia abbastanza critica, la maggior parte dei soggetti sviluppa una forma cronica secondaria e progressiva che porta a deficit neurologici. Un farmaco di ultima generazione nel trattamento della malattia il fingolimod (gylenia), un superagonista per il recettore della sfingosina-1-P che media luscita dei linfociti T dai linfonodi. Il farmaco (somministrato per os) si lega a questi recettori desensibilizzandoli immediatamente e i linfociti (tranne le cellule effettrici della memoria che possono raggiungere i distretti periferici) rimangono intrappolati nei linfonodi. In questo modo si comporta da immunosoppressore potente ma intelligente, riducendo le ricadute al 70%, similmente agli anticorpi monoclonali ma evitando gli effetti avversi di grave esposizione al rischio di infezioni opportunistiche. MODULATORE ALLOSTERICO POSITIVO (PAM o enhancer): per definizione una sostanza che riconosce un sito di legame con un recettore che sempre specifico, ma diverso dal sito di legame dell'agonista. Sono tali per es le benzodiazepine; i PAM hanno quindi effetto solo in presenza dell'agonista ortosterico (un agonista che si lega nel sito di attivazione del recettore) agendo da amplificatori delleffetto, migliorando la potenza e in misura minore l'efficienza. Il vantaggio della somministrazione di un PAM rispetto ad un agonista che il secondo attiva tutti i recettori indiscriminatamente, mentre il primo amplifica solo i recettori che in quel determinato momento sono attivati da un agonista ortosterico, agisce in modo attivit-dipendente. ANTAGONISTA: sostanza che dotata di affinit ma non di attivit, dunque etimologicamente improprio, ci non toglie che abbia un effetto osservabile anche da solo perch impedisce alla sostanza endogena di avere effetto. In clinica si pu somministrare per contrastare l'effetto di un agonista assunto dall'esterno come avviene in tossicologia (es per overdose da eroina, riconoscibile per pupilla puntiforme, depressione del respiro e coma, si utilizza il naloxone (nargan), antagonista dei recettori oppioidi). Gli antagonisti possono essere di due tipi, e si riconosce facendo degli studi di shield-plot, cio di rapporto di dosi crescenti di agonista-antagonista con l'effetto misurato.
ANTAGONISTA COMPETITIVO Aggiungendo una concentrazione costante,per es di 10-6M,di antagonista allagonista,si avr una riduzione della potenza dellagonista, in quanto in un determinato range di concentrazioni lantagonista molto efficiente nel bloccare lagonista, mentre la sua efficienza diminuisce non appena si alterano queste concentrazioni. Dal grafico si evince il fatto che si tratti di un antagonista competitivo perch aumentando la [agonista],si perde il blocco operato dallantagonista. Quindi un antagonista pu essere definito competitivo se il suo blocco sullagonista SORMONTABILE in funzione di concentrazioni sufficientemente alte di agonista tali da spiazzare tutto l'antagonista dal sito di legame. Si prende in esempio l'effetto dellacetilcolina (Ach) su di un muscolo. Se si analizza la prima curva la contrazione, indotta dall'acetilcolina, raggiunge in poco tempo l'effetto massimo, perch la concentrazione dell'antagonista pari a zero. Nella seconda curva si ha una determinata concentrazione di antagonista: ATROPINA. Questo antagonista si lega ad un certo numero di siti recettoriali sequestrandoli allAch. L'effetto dellacetilcolina naturalmente sar pi basso perch molti siti recettoriali saranno occupati dall'antagonista. Per ottenere lo stesso effetto della curva 1, basta aumentare la dose dell'agonista che va a sormontare l'antagonista; in questo modo l'Ach trova a sua disposizione tutti i recettori. Come si pu notare, la curva 2, rispetto al curva 1, spostata verso destra, per raggiunge sempre l'effetto massimo. Inoltre si pu dire che l'acetilcolina meno potente perch alcuni recettori sono occupati dall'antagonista. Lo stesso discorso vale per la terza curva dove stata aumentata ulteriormente la dose di antagonista. L'effetto massimo viene sempre raggiunto aumentando la dose di somministrazione di Ach. LAtropina (un alcaloide contenuto nelle foglie o nelle radici di alcune Solanacee come Atropa Belladonna) un antagonista dei recettori muscarinici M3, storicamente usato per il trattamento dellasma e per la dilatazione della pupilla. ANTAGONISTA NON COMPETITIVO Aggiungendo una concentrazione costante di antagonista allagonista, invece che avere una riduzione di potenza si avr una riduzione di efficienza (la curva si sposta verso il basso): questo vuol dire che se pur dovesse essere aumentata la [agonista],comunque non verrebbe annullato il blocco dellantagonista. Questo avviene perch lantagonista non competitivo si lega ad un sito del recettore diverso da quello a cui si lega lagonista Lantagonista non competitivo detto anche NAM (modulatore allosterico negativo). Lazione del NAM non sormontabile,cio non pu essere annullata da unelevata [agonista]. Questo pu essere ad esempio determinante nel combattere le conseguenze deleterie nell'ictus cerebrale al rilascio massiccio del Glu, evento in cui la quantit enorme di agonista renderebbe del tutto inutile l'impiego di un antagonista competitivo.
b) Recettori Quali bersaglio privilegiato dei farmaci ne tratteremo in primo luogo quelli di membrana. Questi sono suddivisi in modo molto didattico, anche se poco scientifico, in 2 categorie, metabotropici (cio alteranti il metabolismo della cellula) e ionotropici (cio determinanti correnti ioniche); in questo sono tutti distinti dai canali ionici voltaggio-dipendenti (VOC). tuttavia chiaro che l'interconnessione degli equilibri elettrochimici con tutte le funzioni omeostatiche renda evanescente tale rigida distinzione. Es. Il recettore NMDA per il Glu, importante per lapprendimento e la memoria, diventa attivo quando vi una depolarizzazione di membrana,quindi sarebbe un VOC, ma siccome un recettore attivato dal Glu, in realt classificato come ionotropico. R METABOTROPICI Si distinguono in 2 grandi categorie, a seconda che siano o meno accoppiati a proteine G. 1. Recettori accoppiati a proteine G RECETTORI Sono in numero maggiore di 1000 (ma pi di 706 sono odoranti, cio deputati alla percezione olfattiva e gustativa, sicuramente retaggio filogenetico della fisiologia animale in cui il sistema dei feromoni influenza in modo determinante l'aspetto riproduttivo, cos importante per la continuazione della specie e l'evoluzione). Rappresentano anche il bersaglio del 90% dei farmaci in commercio. Le comuni caratteristiche molecolari sono: presenza di un dominio extracellulare molto variabile per sequenza e dimensione solitamente N-terminale; presenza di 7 domini transmembranari (detti TM da 1 a 7), collegati da 3 loops extracellulari e 3 intracellulari; dominio C-terminale intracellulare; sito di interazione intracellulare con proteina G (subunit ) solitamente relegato a 2 e 3 loop e dominio C-terminale; sito di interazione con il ligande solitamente costituito dalla tasca extracellulare formata dai domini transmembrana, pi difficilmente dal dominio N-terminale (come ovvio anche il sito di interazione con il PAM o il NAM variabile ma sempre diverso dal sito per l'agonista).
CLASSIFICAZIONE Cl. St.gr Recettori / Agonisti endogeni / Endocoidi Farmaci e altro
A Alfa Sono tutti legati in corris ponde nza
(rec per la luce; rodopsina e opsine dei Rodopsina e lOpsina dei coni sono i due recettori che rispondono alla luce bastoncelli) e sono responsabili della sensazione visiva (la percezione la presa di coscienza della sensazione. Cio la percezione visiva fa riferimento alla corteccia calcarina del lobo occipitale, mentre la sensazione si riferisce al viaggio degli impulsi che passano lungo la via visiva). Rec per le AMINE:
della tasca tra i segme nti transm embra nari
- Catecolamine: NA (alfa 1-2), A (beta 1-2-3), DA (D 1/5); - Indolamine: 5-HT (da 1 a 7); - Istamina: H ; Gli H1 sono bersaglio degli antistaminici; H2 nelle terapie dell'ulcera peptica; gli H3 sono presenti nel midollo spinale - Ach: (muscarinici, M 1/5) Il nome deriva dalla sensibilit a una sostanza (muscarina) contenuta nella amanita muscaria, a sua volta chiamata cos perch in passato usata per scacciare le mosche. Induce effetti allucinogeni e intossicazione. rec del gruppo MECA: - Melanocortine (MSH alfa-betagamma; ACTH); - Endocannabinoidi (rec CB 1-2) 2CB1 riconosce come agonista ortosterico il 9-THC, contenuto nelle arachidonilglicerolo e anandamide; inflorescenze (Marijuana) o nelle resine (Hashish) derivanti della cannabis sativa di variet indica. Il 50% degli schizofrenici attualmente in terapia lo sono per questa assunzione. In condizioni normali la corteccia prefrontale dorsolaterale ha il compito di assemblare i contenuti della sfera percettiva che attraversano la corteccia calcarina, lassemblaggio avviene in base alle esperienze vissute e alla conoscenza a priori. La corteccia prefrontale dorsolaterale esercita unattivit di elaborazione delle funzioni esecutive ed inoltre sede di una particolare memoria che si chiama working memory, o memoria di lavoro (cio una memoria che porta a delle esecuzioni molto rapide). Tutte queste funzioni della corteccia sono permesse dalla presenza delle CELLULE PIRAMIDALI che tramite i loro assoni mandano il segnale fuori dalla corteccia; normalmente queste cellule scaricano in modo sincrono affinch le percezioni vengano assemblate in modo coerente e affinch si possa rispondere con comportamenti adeguati. Il sincronismo di scarica assicurato da degli interneuroni inibitori particolari GABAergici (CELLULE A CANDELABRO) che fanno sinapsi sul cono demergenza dellassone delle cellule piramidali controllandone il grado di scarica, cio il cosiddetto finding delle cellule piramidali. Lo scorretto spegnimento delle cellule a candelabro (tramite il segnale mediato dal recettore CB1 in seguito al legame con il 9-THC) con successiva alterata attivazione delle cellule piramidali pu portare ad un assemblaggio incoerente delle informazioni (come nel sogno) con risultante inadeguatezza dei comportamenti SCHIZOFRENIA Nella schizofrenia per difetto di neurosviluppo, le cellule a candelabro non si sviluppano correttamente e si ha una disorganizzazione funzionale della corteccia. I soggetti pi esposti al rischio sono i minori di 15 aa che consumano cannabis e sono mutati omozigoti per il gene COMT nel sito V151. - Sfingosina-1-P (5 sottotipi); Il fingolimod, di ultima generazione nella terapia della sclerosi multipla, precedentemente classificati come rec primo farmaco orale per questa patologia, superagonista di uno di questi. regolanti il differenziamento dell'epitelio; - Sostanza simile all'adenosina (funzione sconosciuta) rec per la MELATONINA (MT 1-2) L'agomelatina di questi stimolanti ma anche antagonista dei 5-HT2c (azione duale), usato come antidepressivo di ultima generazione; il razionale la connessione ipotetica tra disturbi del sonno e depressione. beta Rec responsivi a peptidi: - ADH - Ossitocina responsivi a: - NPY (neuropeptide Y) - GnRH, TRH - CCK - GHS (il prototipo di questa serie di ormoni la Ghrelina) gamma Rec gruppo SOG: - Somatostatina (GH-IH), rec St 1-5; - Oppioidi: MOR () (attivato preferenzialmente dalla morfina)
Iniettata intraventricolo induce sbadigli e erezione del pene; ancora piuttosto oscura implicata nell'ansia, nella depressione. Sono i secretagoghi del GH, secreti dallo stomaco creano il ponte tra questo e l'ipofisi. Il GH-IH utilizzato nel trattamento dellacromegalia e delle varici esofagee La morfina, alcaloide naturale, deriva dalla pianta del papaver somniferum, raccolta per mezzo di un grembiule cui aderisce direttamente dalle piante il lattice condensato. Rappresenta il farmaco gold standard (di 3 scalino) nella terapia del dolore; quello di ultima generazione il tapentadolo (palexia). Da questa deriva l'eroina come sostanza d'abuso che una
morfina diacetilata a pi rapida penetrazione cerebrale. DOR () (isolato nel dotto deferente) KOR () (caratterizzato nell'uso della ciclazocina, ketociclatocina) ORL-1 - Galanina
stata da alcuni richiamata nei meccanismi della schizofrenia e di altri disordini psichici
rec MHC (una sostanza che concentra la melanina diversa da MSH) rec Chemiochine (in particolare sostanze che partecipano con funzione chemiotattica all'infiammazione e in CCR5, CXCR4) genere alla risposta immune; i due recettori citati sono co-recettori rispetto al CD4 per l'HIV. Sembra che una particolare mutazione per CCR5 possa fornire protezione rispetto all'infezione; il maraviroc, di ultima generazione nella terapia dell'HIV, antagonista di questo recettore. Tuttavia durante linfezione pu avvenire lo shift del tropismo da CCR5 a CXCR4. delta Rec per MAS-1 (prodotto di un proto-oncogene) rec per glicoproteine (gli unici di classe A legati nel dominio N-terminale): - TSH; - LH/FSH; - hCG rec dell'olfatto (>700)
B
Rec per Secretina rec per PTH, Calcitonina rec per GH-RH e CRH rec per Glucagone rec per GIP (peptide gastrico inibitorio, detto glucosio-dipendente insulino-tropico) rec per GLP-1 (glucagon-like peptide)
Principale iperglicemizzante; pi potente dell'insulina (la rimozione del pancreas provoca quindi ipoglicemia e non iperglicemia) Questi due ormoni entrambi prodotti da cell endocrine dello stomaco sono responsabili della secrezione di insulina dal pancreas endocrino; in terapia vengono usati agonisti dei rec per GLP-1, di cui il prototipo l'exenatide (exendina IV), ovvero in sostanza un GLP sintetico pi stabile, per aumentare la secrezione insulinica nel diabete tipo II. Molti farmaci stanno entrando in commercio; in particolare un NAM di mGlu5 (AFQ056) stato sviluppato ed in fase di valutazione da parte dell'EMA e sembra promettente per la terapia dell'autismo dovuto a Xfragile, malattia genetica in cui si riscontra la carenza di FMRP (malattia rara che coinvolge a seconda della gravit 1 / 3000 o 5/6000 nati vivi). Alcune sinapsi mediate da questo sottotipo risultano iperfunzionanti e derivanti forme di plasticit sinaptica risultano amplificate causando diversi livelli di ritardo mentale ma anche talune eccellenze in settori parziali delle capacit cognitive. Il baclofene (para-Cl-fenilGABA) o lioresal un miorilassante (la parola si riferisce alla muscolatura scheletrica, viceversa miolitico per la muscolatura liscia) centrale potente impiegato per la spasticit nella sclerosi multipla, come anche nel low-back-pain (lombalgia). Presente nel rene e nelle paratiroidi (monitora la [Ca2+] plasmatica)
C Rec per Glu (mGlu 1-8) genera lmente l'agoni sta si lega nella porzio ne Nterm rec GABAB
rec CaS (calcium sensing) rec gustativi e per i feromoni (TAS1R 1/3) D Rec gustativi TAS2 rec FRIZZLED (10 tipi)
crucialmente implicato nella via del segnale di Wnt. Si tratta di un segnale essenziale per lo sviluppo del SNC, in particolare per il differenziamento dei neuroni e pure per il loro trofismo adulto; i geni che devono essere trascritti per questo sono attivati dalla beta-catenina, legante i fattori di trascrizione della famiglia TCF/LEF. La beta-catenina si trova normalmente nel citoplasma legata nel complesso di degradazione a axina prot APC (ovvero della poliposi adenomatosa del colon) - GSK3- (glicogeno sintasi chinasi) che un enzima pleiotropico implicato non solo nella deposizione di glicogeno ma responsabile pure della fosforilazione della beta-catenina e quindi della sua veicolazione alla via ubiquitina-proteasoma. Quando per il Wnt (un insieme di glicoproteine prodotte dalle cell con attivit paracrina e autocrina) si trova extracell e lega a ponte LRP 5/6 (LDLreceptor-related-protein 5/6) e FRIZZLED attiva quest'ultimo che a sua volta con il dominio intracell invia un segnale mediato da dishevelled che lega axina e inattiva il complesso di degradazione permettendo il
rec SMOOTHENED
trasferimento nucleare di beta-catenina [via canonica di Wnt]. Una delle vie endogene antagoniste di Wnt mediata da Dickkopf-1 che lega extracell a ponte kremen e LRP 5/6 agendo da antagonista funzionale di Wnt; questa proteina Dickkopf aumenta ogni volta che si verifica una degenerazione neuronale (ischemia cerebrale, epilessia temporale, morbo di Alzheimer, sclerosi ippocampale, etc). La via di segnale in cui implicato quella di SONIC HEDGEHOG, ancora una volta importante nello sviluppo, in particolare nella proliferazione dei precursori dello strato dei granuli int della corteccia cerebellare (popolazione pi numerosa del SNC, ordine dei mlrd di unit, significativa nel numero per lo sviluppo neuro-motorio dell'organismo) che poi migreranno guidati dagli astrociti. Se la proliferazione eccessiva si ha il tumore maligno del SNC pi frequente e grave nei bambini, ovvero il medulloblastoma. SMOOTHENED generalmente inibito dal rec PATCHED; parallelamente il fattore di trascrizione Ci (cubitus interruptus) viene legato da costal-2 (Cos2), a sua volta ancorato ai microtubuli, e cos degradato a CiR (cio repressore perch reprime la trascrizione genica nel nucleo); la funzione di HEDGEHOG di legare PATCHED, liberare cos SMOOTHENED e permettere a questo, legando Cos2, di non far degradare Ci. La trascrizione non viene cos repressa; il tumore in genere deriva da una mutazione di PATCHED che lo rende costitutivamente slegato da SMOOTHENED; il problema mortale del medulloblastoma il suo potere metastatico attraverso il liquor, rappresentando un eccezione tra i tumori del SNC.
E
Rec per le ADESINE (dominio N-terminale molto lungo che si adatta all'interazione con molecole della matrice extracellulare o di cellule adiacenti)
PROTEINE G Raccoglie un insieme molto ampio in cui si distinguono prima di tutto una famiglia di proteine monomeriche costituite dalla sola sub (prot Ras, Rap, Rab, Ran, Rac, Rho,...) da una di proteine trimeriche ( + beta-gamma). In tutti i casi le sub (da 39 a 52 kDa) sono responsabili dell'interazione con il recettore per mezzo della loro estremit C-terminale e di molte altre regioni della loro struttura; a quanto gi noto riguardo al funzionamento delle prot G aggiungeremo: per le monomeriche: che non necessaria l'attivazione del recettore per la loro attivazione; che invece essenziale l'intervento di prot GEF per effettuare lo scambio nucleotidico e quindi per attivarle; che necessario per la loro inattivazione, ovvero per effettuare l'idrolisi di GTP, l'intervento di proteine GAP; per le trimeriche: che pur non essendo necessario, talvolta possibile che lo scambio nucleotidico sia assistito da prot AGS e che l'idrolisi sia favorita da prot RGS. Per quanto riguarda le sub beta (36 kDa) e gamma (7kDa) diremo che queste non hanno solo funzione di repressore ma sono anche in grado di legare e attivare tutte le proteine dotate di un dominio PH, cos definito perch omologo alla sequenza aminoacidica della proteina PLECKSTRINA; fra queste proteine ci sono canali di membrana, vie del segnale intracellulari, enzimi che modulano le concentrazioni di secondi messaggeri. CLASSIFICAZIONE prot G trimeriche La distinzione in diverse famiglie avviene solo in base al tipo di sub . I gruppo: Gs (s); Golf (olf) II gruppo: Gi (i, divise in i 1-3 codificate ciascuna da un gene); Go (o, ovvero other, divise in A e B a seconda dello splicing alternativo di uno stesso trascritto primario); Gz (z, promiscua rispetto ai recettori cui si lega); Gt (t; detta transducina, divisa in 1 (presente nei bastoncelli) e 2 (presente nei coni); Gg (g, secondo alcuni t3, detta anche gusducina, perch presente nelle papille gustative) III gruppo: Gq (q); G11; G14; G16; G15 (semplicemente l'ortologo(=proteina identica per funzione) murino della G16) IV gruppo: G12; G13 Si contano dunque un totale di 16 geni diversi in grado di codificare per tutte le proteine G trimeriche. I Gruppo
Gs (e Golf): l'iniziale in pedice sta per stimulating rispetto all'adenilato ciclasi (famiglia enzimatica comprendente 9 isoenzimi che catalizzano la conversione di 1 ATP in 1 cAMP; il tipo I prot G dipendente ma pu anche essere attivata dal Ca citoplasmatico; il tipo II e IV possiede invece dominio PH, quindi pu essere attivata da qualsiasi beta-gamma! Ci si traduce in un effetto paradosso che consiste in un aumento di [cAMP] dopo stimolazione di un recettore accoppiato a proteina Gi). Una delle principali attivit di cAMP di attivare la PKA (una Ser/Thr chinasi) ATP-dipendente che cos pu innescare una cascata chinasica; ci sono altre vie non mediate da PKA, come la stimolazione del fattore EPAC (prot di scambio nucleotidico, in pratica il GEF di Rap), facendo da ponte tra l'attivazione di una prot G trimerica e una monomerica! Infine una proteina chiave nei meccanismi patogenetici endocrini legati all'imprinting. RECETTORI accoppiati a Gs a) -Adrenergici (1, 2, 3): (1) presente nel SNC; sono presenti nel cuore, sia miocardio specifico che di lavoro, dove svolgono la fondamentale mediazione dell'effetto ortosimpatico per la liberazione surrenalica di adrenalina circolante. Hanno effetto positivo su tutti i 4 parametri cardiaci (cronotropismo, dromotropismo, batmotropismo, inotropismo); i 1-agonisti sono farmaci d'elezione nel trattamento dell'insufficienza cardiaca (insufficienza della gittata cardiaca rispetto alle richieste periferiche) acuta; i -bloccanti (antagonisti competitivi) sono invece fra i 5 farmaci salvavita nel trattamento dell'insufficienza cronica, perch servono ad antagonizzare l'effetto dannoso, aggravante delle condizioni strutturali cardiache e della cavit ventricolare, dell'iperstimolazione simpatica che consegue allo scompenso. Questo rappresenta un'innovazione radicale rispetto ai vecchi trattamenti a base di agonisti (tra cui la dopamina ad alta dose). Sono poi presenti nell'apparato iuxtaglomerulare dove stimolano il rilascio di renina; i 1-bloccanti diventano quindi tra i farmaci di scelta nel trattamento dell'ipertensione arteriosa (che chiaramente riducono anche la sistole ventricolare). (2) presente nel SNC; presente nella muscolatura liscia di tutti gli organi cavi e dei vasi con effetto miolitico ( un principio generale per la muscolatura liscia che l'aumento di [cAMP]/ [cGMP] comporti sempre rilasciamento). Il viagra (e simili) proprio un inibitore della fosfodiesterasi PDE5 (degradante il cGMP nei corpi cavernosi e nei vasi elicini del pene); infatti stato sviluppato mentre si cercava un'alternativa alla nitroglicerina nella terapia dell'angina pectoris. (3) sono esclusivi del tessuto adiposo dove inducono lipolisi per fosforilazione della lipasi ormone sensibile (trigliceride-lipasi); questo determina aumento degli acidi grassi liberi nel sangue e riduce la massa adiposa, non a caso ci sono mutazioni a carico connesse all'obesit nonch diversi agonisti in sviluppo contro l'obesit nonostante ancora non ci siano farmaci in commercio. b) dopaminergici (D1 [legati alla malattia di Parkinson, sindrome di deficienza del circuito dopaminergico, per quanto non un legame cos stretto come i rec D2] e D5) c) H2 per l'istamina (contribuiscono alla produzione di HCl nello stomaco; i bloccanti di questi recettori come la ranitidina [zantac] sono impiegati nel trattamento dell'ulcera gastrica e dell'MRGE, efficaci particolarmente durante la notte) d) rec per TSH, FSH, LH, CRH, PTH, hCG, GH-RH, melanocortine e molti altri ormoni; un eventuale mutazione della Gs si ripercuote quindi come una malattia endocrina generalizzata. Ancora a proposito della Gs diremo che la tossina colerica (esotossina del Vibrio cholerae) comporta una ADP-ribosilazione a partire da una molecola di NAD+ a carico del sito Arg 201 di s compreso nel dominio GTP-asico; la Gs non viene inattivata quindi l'aumento di cGMP negli enterociti comporta secrezione di Cl- e acqua con conseguente diarrea acquosa profusa con morte per disidratazione. La s codificata da un unico gene il 20q13.2-13.9 (gene GNAS) che codifica per tre proteine con 12 dei 13 esoni totali in comune e il primo diverso (corrispondente alla parte N-terminale) perch ciascuno riconosciuto da un diverso promotore di trascrizione: s (da 47 a 52 kDa): di cui sono possibili due varianti (una SHORT e una LONG) sempre per
uno splicing alternativo riguardante 15 codoni dell'esone 3 che possono essere o meno presenti; inoltre per ciascuna variante possibile avere o meno una Ser codificata all'interno dell'esone 4 (il totale quindi delle varianti di s di 4!); XLs (extra-large): dispone di 370 aa in pi all'N-term, funzione decisamente sconosciuta; Nesp55, (presente nelle vescicole sinaptiche un po' associabile alle cromogranine della midollare del surrene) non stata ancora ricondotta a una funzione precisa. Le principali mutazioni a carico di GNAS si possono racchiudere in 3 categorie: i) loss of function: in dizigosi letale, incompatibile con l'ontogenesi; in unico allele le manifestazioni cliniche derivano dall'aploinsufficienza a carico dell'unico allele funzionante. Il quadro clinico si riassume nella sindrome detta osteodistrofia di Albright in cui si osservano effetti legati alla distribuzione dei recettori associati a s e cio: ossificazione esagerata e chiusura anticipata delle cartilagini di accrescimento per la minore efficacia del PTH (con brachidattilia e ossificazione che invade anche il sottocute); obesit centripeta (interessante principalmente il tronco a mela, principale fattore di rischio per insorgenza del diabete tipo II); bassa statura anche associata alla riduzione del GH (minore effetto del GH-RH); ipotiroidismo; ritardo mentale. Una particolare condizione che pu o meno associarsi alla osteodistrofia di Albright lo pseudoipoparatiroidismo (con ipocalcemia, iperfosfatemia) legato alla resistenza al PTH instauratasi a livello del TCP renale; non si registra ipercalciuria proprio perch il PTH ha un certo effetto anche su regioni pi distali del nefrone (branca ascendente spessa ansa Henle). In questa circostanza si osserva una totale insensibilit del TCP al PTH (se viene somministrato non ne risulta alcuna concentrazione di cAMP nelle urine) piuttosto che un'aploinsufficienza; questo deriva dall'imprinting a cui soggetto l'allele paterno che silenziato da un repressore che non riconosce la regione responsiva omologa dell'allele materno (promotore) in quanto quest'ultima metilata. A questo punto possiamo distinguere: (1) uno pseudoipoparatiroidismo tipo Ia associato a Albright quando mutato l'allele materno; (2) uno pseudo-pseudoipoparatiroidismo (ovvero non c' alterazione in calcemia e fosfatemia) in presenza di osteodistrofia di Albright quando mutato l'allele paterno. Parallelamente a queste situazioni si possono avere: (3) uno pseudoipoparatiroidismo tipo Ib in cui si ha insensibilit al PTH nel TCP non associato a osteodistrofia di Albright dovuto a mutazione nella regione regolatoria (promotore) dell'allele materno di GNAS che non lo rende metilabile, dunque lo rende reprimibile dal repressore responsabile del gi detto silenziamento insieme a quello paterno; (4) uno pseudoipoparatiroidismo tipo Ic, del tutto assimilabile clinicamente a Ia, ma senza mutazione del gene GNAS, probabilmente coinvolgimento di geni che codificano a valle del cAMP; (5) uno pseudoipoparatiroidismo tipo II del tutto assimilabile clinicamente a Ib ma senza coinvolgimento del gene GNAS, probabilmente legato a una resistenza al PTH localizzata non nel TCP ma nelle regioni pi a valle (branca ascendente spessa dellansa di Henle e dotto collettore). ii) gain of function: la mutazione sempre somatica per definizione (cio non pu essere germinale) e coinvolge gli aminoacidi della regione GTP-asica, in particolare Arg 201 e Gln 227; le conseguenze possono essere tumori ipofisari o altre conseguenze dell'attivazione costitutiva della proteina G derivante dall'impossibilit dell'inattivazione da idrolisi del GTP. Clinicamente si definisce nella forma pi piena come sindrome di McCune-Albright: - distrofia fibrosa poliostotica (sostituzione di tessuto osseo con tessuto fibroso, quadro simile a rachitismo-osteomalacia, sensibilit a fratture); - ipersurrenalismo (da ipereffetto di ACTH) con surrene iperplastico e iperpigmentazione cutanea (macchie cafflatte sulla cute); - iperincrezione di GH e possibile comparsa di adenomi GH-secernenti (conseguenti
gigantismo/acromegalia) e TSH-secernente con conseguente ipertiroidismo; - iperstimolazione ovarica (ipersecrezione estrogenica). Trattandosi di una mutazione somatica (cio compare durante le divisioni cellulari dello zigote) si possono avere manifestazioni cliniche progressivamente pi blande con un ritardo progressivo della mutazione nel corso dell'embriogenesi; ad es spesso adenomi GH secernenti con nessuna altra manifestazione clinica derivano proprio da questo tipo di mutazioni a carico di GNAS (30-40 % di micro e macro adenomi). iii) loss & gain of function: atipico perch la mutazione Ala366Ser comporta da un lato l'acquisto di funzione per unalterazione ancora una volta del sito GTP-asico, ma poich la proteina risulta termolabile, l'acquisto di funzione risulta solo nel testicolo (riscontrando cos una testotossicosi, cio un'iperincrezione di testosterone per l'effetto amplificato di FSH/LH) dove la temperatura pi bassa di 1-2, mentre nel resto dell'organismo si osservano le conseguenze della perdita di funzione, ovvero un quadro sovrapponibile all'osteodistrofia di Albright. Ancora sull'imprinting a carico di GNAS: si possono riconoscere delle sequenze tipiche di imprinting sia per Nesp55 che per XLs che valgono per tutti i tessuti, rispettivamente con silenziamento dell'allele paterno e materno. Rispetto a s abbiamo gi detto dell'imprinting totale dell'allele paterno nel TCP, ebbene si riscontra anche parziale ma dello stesso genitore nell'ipofisi, nelle ovaie, nella tiroide, negli adipociti. II Gruppo Non sono omogenee nel meccanismo d'azione e il raggruppamento deriva da omologia aminoacidica, una specie di albero genealogico delle proteine! 1)Gi (1, 2, 3) Go Gz: agiscono tutte secondo 3 vie d'azione: i) riducono [cAMP] intracellulare bloccando l'adenilato ciclasi; ii) inibiscono alcuni canali VOC per il Ca, quali L (large, longlasting, bersaglio dei Ca2+antagonisti come il pregabalin) N (neuronale) e P/Q questi fondamentali per il rilascio di neurotrasmettitori [non sono associati a queste prot G R T (tiny, transient) questi principali responsabili delle cosiddette assenze epilettiche (distacco dalla realt con amnesie) (bloccati dai farmaci anti-assenze), ovvero crisi generalizzate (non come le epilessie focali in cui l'iperattivazione corticale localizzata [singhiozzo parossistico, parestesia dito indice, clonia al pollice]) simili come grado di attivazione al grande male epilettico (crisi tonico-cloniche, convulsivanti)]; iii) attivano alcune conduttanze al K+, sono dunque iperpolarizzanti sulla membrana. iv) Solo o: attiva l'idrolisi del fosfatidilinositolo-4,5-bisfosfato a formare IP3(1,4,5-trisfosfato) e DAG. D'altro canto non bisogna escludere l'effetto di incremento di [cAMP] dopo stimolazione di Gi legato all'effetto di - sugli isoenzimi II e IV dell'adenilato ciclasi. Sia i che o sono sensibili alla tossina pertossica (la infezione da bordetella viene trattata con macrolidi, quali eritromicina, claritromicina, azitromicina, bloccanti la sub 50S del ribosoma batterico) sempre secondo un meccanismo di ADP-ribosilazione che interessa un residuo di Cys al dominio C-terminale (la parte maggiormente interagente con il recettore) e le rende impossibile l'interazione con il recettore. Per z, invece, non si riscontra questa sensibilit, motivo per cui la tossina pertossica utilizzata in laboratorio per studiare e caratterizzare le proteine G e distinguere quella che interagisce con uno specifico recettore. RECETTORI accoppiati: a) dopaminergici D 2, 3, 4 (D2 decisamente il pi importante); nella terapia del Parkinson pur utilizzando principalmente la levodopa (precursore di dopamina che pu penetrare nel cervello) si possono utilizzare agonisti dei D2; anche nella schizofrenia si utilizzano farmaci (definiti impropriamente neurolettici) che sono D2-bloccanti, alcuni lo fanno per pi del 90% causando il parkinsonismo farmacologico (tremito, bradicinesia) perch simulano la mancanza di dopamina,
caratteristica del Parkinson, altri lo fanno per il 45% ca, sono definiti atipici e non danno il parkinsonismo farmacologico. Un altro ambito in cui questi recettori sono fondamentali il circuito mesolimbico che originando nel mesencefalo coinvolge diverse stazioni del sistema limbico tra cui il nucleus accumbens septi; essendo sottocorticale non pu generare percezioni (viene considerato erroneamente da alcuni il circuito generatore del piacere), al contrario del tutto analogo al sistema nigrico-striatale nella programmazione del movimento, con la differenza che non si tratta di un programma motorio abitudinario ma finalizzato al raggiungimento della sorgente del piacere; tutte le droghe sono potentissimi attivatori del sistema mesolimbico, riproducendo su larga scala gli effetti edonistici naturali. Questo induce delle traslazioni della memoria motoria dal sistema mesolimbico al sistema nigricostriatale tipicamente nella assunzione della droga (habit memory), risultando in un ancora maggiore radicamento della dipendenza. b) 2 (tipo A, B, C) noradrenergici: sono importanti nella attivazione del centro vasomotore troncoencefalico che regola l'attivazione ortosimpatico; 2 farmaci antiipertensivi sono antagonisti di questi recettori e sono la clonidina e -metilDOPA (aldomet, indicato unicamente nelle donne ipertese in gravidanza per cui ACE-inibitore e sartani sono teratogeni nel II e III trimestre di gravidanza). c) 5-HT1 (sottotipo a, b, d, e, f): i triptani sono degli agonisti (di b-d-f) che si utilizzano nell'emicrania quando si avverte il dolore; l'emicrania classica non si identifica con la cefalea, ma una sindrome neurologica che caratterizzata sempre da un'aura visiva (cio uno scotoma, un buco nero nel centro del campo e lampi di luce intorno) e poi pu pi o meno (emicrania sine emicrania) essere seguita da dolore tipicamente pulsante, accompagnato talvolta da nausea e vomito. d) rec per i cannabinoidi (CB1 e CB2) che abbiamo gi trattato nella classificazione. e) rec oppioidi: particolarmente importanti nella terapia del dolore per cui si utilizzano morfina e derivati che attivano in particolare MOR e DOR. f) M2 e M4 muscarinici (colinergici): in particolare M2 il mediatore dell'effetto cronotropo negativo vagale sul miocardio specifico. Quest'azione mediata da - piuttosto che da i nella misura in cui attivano una conduttanza al K+ detta GIRK. 2)Gt: indipendentemente la 1 e la 2 agiscono entrambe attivando una fosfodiesterasi (PDE 6) che riduce il [cGMP], inibendo cos la PKG e di conseguenza le conduttanze cationiche (Ca2+ e Na+) che mantengono il fotorecettore depolarizzato quando questo non stimolato dalla luce. La quiescenza del fotorecettore si traduce con il mancato rilascio da queste di Glu, determinando l'inattivazione della cell bipolare OFF (recet AMPA per il Glu) e contemporaneamente l'attivazione della cell bipolare ON (recet mGlu6 inibitorio, responsabile se mutato di alcune forme congenite di cecit notturna [emeralopia]). Rispetto a questo appunteremo un particolare effetto avverso proprio di sardenafil (viagra) e valdenafil (levitra, cialis) che pur avendo maggiore effetto su PDE 5 hanno anche una seppur minima attivit su PDE 6 comportando possibili disturbi nella percezione dei colori. III Gruppo Gq G11 G14 G16: sono simili a Go ma insensibili alla tossina pertossica, infatti agiscono attivando la PLC-, che produce IP3 e DAG e porta quindi rispettivamente alla liberazione di Ca2+ dai calciosomi (vescicole del REL sensibili a IP3) e all'attivazione della PKC. RECETTORI associati: a) muscarinici M1 M3 M5: principali mediatori degli effetti parasimpatici periferici, in particolare M3, con effetto di contrazione della muscolatura liscia delle mucose (peristalsi intestinale, m detrusore della vescica, m brionchiolare), della miosi pupillare e dellaccomodazione del cristallino; tuttavia pure responsabile della vasodilatazione poich non si trova direttamente sulla tonaca muscolare ma mediata dall'endotelio in cui si attiva l'enzima eNOS con formazione di monossido d'azoto radicalico (NO). b) H1: sono responsabili della triplice reazione di Luys, ovvero il nucleo dell'infiammazione, nonch delle riniti allergiche stagionali; i vecchi antistaminici per la capacit di attraversare la barriera ematoencefalica avevano effetto di sedazione, sonnolenza, aumento ponderale, diversamente da quelli di ultima generazione (come l'azomyr, desloratadina).
c) NA 1 (a, b, d): sono i maggiori recettori vascolari, presenti nella tonaca muscolare in cui mediano la vasocostrizione simpatica, ma anche nelle muscolature mucose come lo sfintere vescicale; proprio per questo antagonisti di questi recettori sono impiegati comunemente come ipotensivanti e nell'iperplasia prostatica nodulare proprio per favorire lo svuotamento della vescica, pur potendo comportare come effetto avverso leiaculazione retrograda. d) 5HT2 (a, b, c): il tipo c importante nel dimagrimento, infatti alcuni antipsicotici, come la clozapina, che come e.a. interagiscono inibendolo possono determinare un consistente aumento ponderale; il tipo a coinvolto nella schizofrenia, infatti sono bloccati dai farmaci atipici impiegati nel trattamento. Il tipo a non solo coinvolto nella patofisiologia della schizofrenia, ma anche bersaglio di alcuni allucinogeni prototipizzati dall'LSD (dietilamide dellacido lisergico): questa senz'altro la droga pi potente, per questo pu anche essere somministrata in modo occulto. L'effetto allucinogeno mediato dalle sinapsi 5HT2a dipendenti corticali che ne vengono iperattivate simultaneamente cos da evocare un viaggio dispercettivo, soprattutto rispetto alle percezioni visive (visione kaleidoscopica) (mentre nella schizofrenia pi che altro uditivo). Il pericolo maggiore legato all'uso innanzitutto di esporsi per via delle allucinazioni a rischio mortale dovuto a sottovalutazione, e poi a quello di slatentizzare una psicosi maniacale di cui si pu rimanere fatalmente vittime poich i contenuti incresciosi del subconscio affiorano nellio (bad trip). Sostanze ad effetto simile a quello dellLSD sono quelle contenute nei miceti del genere Psilocybe. Normalmente lattivazione regolata dei recettori 5HT2a mediata dai nuclei del rafe (serotoninergici) permette la filtrazione a livello corticale delle percezioni talamiche.
Lezione del 21/9/2011
REGOLAZIONE E ATTIVITA DELLE PROTEINE G
Trattiamo della famiglia di recettori accoppiati alle proteine G12 e G13 che hanno rispettivamente le sub unit 12 13. Il compito di tali proteine G controllare lattivit di una proteina che si chiama P155 che agisce da GEF per la proteina Rho. Quindi abbiamo un evento insolito: una proteina GTP dipendente trimerica controlla lattivit di una proteina GTP dip monomerica. Queste proteine sono molto atipiche. Devono avere un ruolo importante perch sono espresse per esempio nelle cellule della linea ematopoietica quindi evidentemente avranno un compito rilevante. Sappiamo che la proteina monometrica Rho costituita da una sola subunit fondamentale nel controllo del citoscheletro. Quindi G12 e G13 attivano il GEF che permette di trasformare Rho legata a GDP con Rho legata al GTP, attivandola. PROTEINE RGS Avevamo detto che le proteine G trimeriche sono in grado di scambiare il GDP con GTP in maniera autonoma senza bisogno di GEF. Di conseguenza la sub legata al GTP si stacca dal complesso . Successivamente interviene lattivit GTPasica e quindi la subunit si inattiva. Questo stato un dogma della biologia fino a poco tempo fa, che stato superato da nuove scoperte: esistono delle proteine che si chiamano RGS = Regolatori del Segnale delle proteine G che hanno il compito di attivare le funzioni GTPasiche delle sub e quindi spegnere le proteine G. per esempio consideriamo un s di una proteina Gs il cui compito attivare ladenilato ciclasi e aumentare lAMPc; dopo che ha effettuato questo compito la sua intrinseca attivit GTPasica la spegne. Per se questo processo di spegnimento deve essere accelerato la cellula trascrive una particolare RGS la quale assolve tale funzione. Le proteine della grande famiglia delle RGS hanno delle sequenze aminoacidi che formano i domini RGS. Alcune sono cos piccole da essere costituite solo da tale dominio, altre si avvalgono anche di pi domini diversi. Si distinguono diversi gruppi che comprendono RGS da 1 a 5, 8, 13, 16 6,7,9,11 10,12,14 17,19,20,21 Axina 1 e Axina 2 (di cui abbiamo parlato a proposito della via di Wnt. Queste ultime rientrano in questa classificazione per motivi strutturali e non funzionali. [classificazione da non trattare per lesame] Molto importanti sono soprattutto le RGS 2 e 4. il loro ruolo pu essere compreso analizzando lesempio della tossicodipendenza da assunzione di Cocaina, la quale una sostanza naturale estratta dalla pianta Erythroxylon Coca( pianta dellAmerica Latina. La coca nativa di questa localit infatti sono state ritrovate mummie vecchie di 3000 anni in cui era presente un metabolita della cocaina la Benzoilectegonina in quanto masticavano le foglie per una migliore performance fisica). La cocaina ha la funzione di bloccare la ricaptazione di - dopamina - noradrenalina - serotonina (parzialmente) Al terminale nervoso ove rilasciata la dopamina, normalmente essa viene ricaptata attraverso il trasportatore DAT(trasportatore ad alta affinit della dopamina) dallo stesso terminale. Se ci viene bloccato, i livelli di dopamina al livello del terminale aumenteranno molto amplificandone lazione. La cocaina pu essere consumata in quattro modi: 1) masticare le foglie. Ma ci implica che prima che entri in circolo e medi i suoi effetti passano circa 30-35 minuti, gli effetti sono molto diluiti perch il fegato la metabolizza e quindi non si provano i piaceri che essa d. 1) 2) 3) 4) 5)
2) in vena. Questo estremamente pericoloso anche per la possibilit di infettarsi con lago 3) sniffare 25 mg per narice. Questa cocaina detta snow(=neve) 4) fumare. Per fare ci va modificata chimicamente e fare una base libera, cio modificarla con NaOH rendendola resistente alla pirolisi ( non cocaina cloridrato come era originariamente). Questa forma di coca detta CRACK per il rumore dei cristalli che al calore vengono disciolti producendo tale rumore. Pu verificarsi, in questo caso, leventualit di morire allistante nel caso in cui il soggetto non conoscenza di essere affetto da una cardiopatia, in quanto la pressione sale a mille, si pu perci rompere anche un vaso a livello cerebrale provocando emorragia cerebrale ma nella maggior parte dei casi non succede nulla di tutto questo. Quello che si prova : - una grande sensazione di euforia, ovvero benessere - grande incentivazione a sniffare nuovamente. Questo dovuto al sistema mesolimbico che elabora gli atti motori che portano al raggiungimento del piacere. N.B. le droghe non danno piacere! Il piacere una rappresentazione cerebrale. Per essere raggiungono un sistema estremamente importante in natura. Perch se io ho un rapporto sessuale che finalizzato a perpetuare la specie deve scattare un meccanismo che mi fa reiterare il rapporto sessuale. Il problema che le droghe attivano a dismisura questo sistema e quindi abbiamo un elaborazione del movimento che mi porta alla sorgente del piacere che la droga. Quando prendiamo cocaina si riduce la soglia dei reward(=gratificazioni) naturali . questo significa che una cosa che normalmente mi era indifferente, se assume cocaina o fumo crack, diventa significativa(es. ragazza brutta diventa bella e attraente). Inoltre lassunzione della droga fa si che - la mia prestazione fisica sia potenziata senza stancarmi mai - durante il suo effetto non ho appetito. Effetto anoressizzante. Gli effetti della cocaina durano circa 2-3 ore perch questa la sua emivita, pi vanno via via scemando. Per ripristinare questi effetti necessaria una nuova sniffata. Durante i Binges( festini di coca) si sniffa ogni 2-3 ore per una settimana in quanto d meccanismi incentivanti clamorosi. Aumentando la frequenza delle sniffate lEUFORIA va man mano riducendosi, mentre compare la DISFORIA, ovvero il tono dumore mutevole, che si realizza a seguito di meccanismi complessi. La diminuzione delleuforia invece data dai recettori D2 per la dopamina, che sono essi stessi coinvolti nel conferire tale sensazione, ma che si desensitizzano. Quindi inizialmente i recettori D2 della spina dendritica sono fortemente stimolati dalla dopamina non pi ricaptata a seguito del blocco di DAT operato dalla cocaina, generando euforia. Poi i recettori D2 si spengono poco a poco. Questo molto importante perch se leuforia diminuisce il consumatore indotto a pensare ad una diminuzione dellefficacia della sostanza piuttosto che ad una desensitizzazione recettoriale, questo e la disforia che ne consegue portano ad un incremento dellassunzione della droga. Uno dei motivi per cui i recettori si spengono che vengono espresse le proteine RGS2 e RGS4. quindi queste proteine che hanno il compito di spegnere la sub delle prot G vengono indotte allespressione dalla cocaina in una particolare zona del cervello che si chiama Nucleus Accumbens. RGS 2- 4 stimolano lattivit GTPasica e inducono la conversione di i- GTP -> i- GDP e a questo punto gli effetti della coca vengono meno. Quindi RGS 2 - 4 sono importantissime per la dinamica delle tossicodipendenze, con il particolare riferimento alla cocaina. Quindi le proteine RGS sono le GAP delle proteine G trimeriche, questa linnovazione nella biologia AGS Il secondo gruppo delle proteine che regolano lattivit delle proteina G sono le AGS. Esse agiscono nel momento in cui la sub legata al GDP e complessata con . Quindi sono attivatori del segnale dei recettori accoppiati a proteine G scambiando i nucleotidi : si comportano da GEF permettendo alle sub e al complesso di agire. Le proteine AGS si dividono in tre gruppi: 1) AGS 1 agisce su Gi e Go ( che hanno le sub unit i e o) potenziandone lazione e agendo da
GEF su esse 2) AGS 3, 4, 5, 6 interagiscono invece con la sub unit -GDP ed come se la bloccassero. Quindi bloccano la subunit che non pu pi scambiare il GDP ma liberano dal complesso le subunit che sono in grado di segnalare attivando le subunit 2 e 4 delladenilato ciclasi o regolando canali ionici per esempio.. 3) AGS 2, 7, 8 LAGS 3 sta riscontrando molto interesse ancora una volta nelle tossicodipendenze. Nei tossicodipendenti abbiamo una storia che si articola in tre momenti: 1) momento del Binge. Inizialmente il soggetto sniffa in maniera occasionale, una volta ogni tanto, senza necessit di sniffare di continuo. Ma nel 10-15 % dei soggetti, alcuni mostrano una predisposizione a sviluppare la dipendenza. Tale predisposizione di natura sconosciuta, pu essere epigenetica, ambientale si sviluppa lincentivazione a sniffare e si entra nel binge. In tale fase si attiva enormemente il sistema mesolimbico. Esiste un modello animale che si chiama self stimulation. Si pone dentro una gabbia un ratto con una leva collegata a un elettrodo che pesca nel sistema mesolimbico = zona del cervello che proietta dal mesencefalo al nucleus accumbens (zona attivata pi o meno da tutte le droghe). In questo caso premendo la leva si autostimola perch connesso al mesolimbico. La cavia viene talmente incentivata allautostimolazione che comincia a premere la leva tante di quelle volte da morire di fame e di sete in quanto in quel momento ignora il cibo. Nella pressione della leva viene incluso anche il fatto che ci sia una certa soglia elettrica. Se la pressione della leva produce una scarica di frequenza minore della soglia di stimolazione del mesolimbico (es. 50 Hz) il ratto preferir mangiare piuttosto che premere la leva. Valutiamo ora la soglia di stimolazione: se somministriamo cocaina si abbassa la soglia di stimolazione, di reward naturale. Quando leffetto della cocaina finisce la soglia ricresce a un valore maggiore di quello precedente alla somministrazione della coca (quella normale) e dopo un po si stabilizza. Risomministro coca , la soglia si riabbassa per poi rialzarsi nuovamente e durare di pi: questo perch esiste un isteresi residua ovvero una componente che man man si fa sempre pi lunga. Ad un certo punto non somministriamo pi coca e la soglia terminale enormemente elevata: si sviluppata la cosiddetta dipendenza motivazionale. La soglia della gratificazione talmente alta che non provo pi alcuno sentimento gratificante e di stimolazione. Si entra quindi nella: 2) sindrome di astinenza che riflette lo sviluppo di una dipendenza non fisica ma motivazionale. In questa fase si infelici e demotivati. Questo dura per diverse settimane in cui vi un incredibile craving = bisogno incoercibile di procurarsi la sostanza. Se si supera tale fase rimanendo indenni si entra nella 3) fase di potenziale remissione. Si nelle condizioni di non sniffare mai pi. Ma anche una fase di grandissima vulnerabilit. Si rischia un relapse ovvero una ricaduta ( in neurologia si parler della sclerosi multipla come sindrome del relapsing and remitting di ricadute e remissioni) e se c la ricaduta si ritorna nel binge ovvero si riprende a sniffare a grande frequenza. Questo riflette una vulnerabilit che durer per anni e in tale periodi sono validi anche farmaci e sedute psicanalitiche. La ricaduta pu avvenire a seguito di : - stress - ri-esposizione passiva alla sostanza - esposizione a stimoli ambientali precedentemente associati allassunzione della sostanza (per es. ritrovarsi in luoghi in cui si sniffavano ritrovarsi in ambienti simili). Ci sono 2 regioni del cervello che sono critiche nella predisposizione al relapse: 1. corteccia orbito frontale( parte della corteccia frontale). Essa ha due funzioni:
controllo sfera degli impulsi (un giocatore dazzardo ha una corteccia orbito frontale che non funziona bene, cosi come il tossicodipendente) - rapporto rischio beneficio quindi una sorta di centrale di controllo delle nostre funzioni esecutive. Le fibre che si dipartono dalla corteccia orbito frontale raggiungono il core del nucleo accumbens. 2. Il nucleo accumbens si compone di due parti: una parte esterna detta Shell (conchiglia) che riceve le fibre dopaminergiche del mesolimbico in particolare dalla regione VTA (area 10) ovvero lArea Ventrale del Tegmento mesencefalico. - la parte centrale che si chiama Core, ed la pi importante per via delle connessioni che riceve dalla corteccia frontale (orbito frontale). Questa parte fondamentale per la funzione motoria. Lalterato funzionamento della corteccia orbito frontale non permette ad un tossicodipendente esposto ad uno stimolo ambientale riconducibile alla droga di calcolare il corretto rapporto rischio-beneficio. Parte dunque un comando motorio verso il core del nucleo accumbens e si programma il movimento che riconduce allassunzione della droga. Normalmente il core del nucleo accumbens ha una sorta di limitatore di velocit cio ha un recettore (che si trova sul colletto dellassone) che si occupa di inibire il rilascio di neurotrasmettitore. Si tratta del recettore mGlu2 (recettore metabotropico del Glu di tipo 2) che pure essendo un recettore per il Glu accoppiato a proteina G inibitoria (quindi riduce cAMP e apertura canali del Ca2+) e riduce la liberazione del Glu stesso. Ci permette al tossicodipendente di valutare il rischio e non cadere nel relapse, frena il movimento. Tale recettore localizzato nella parte pre-terminale dellassone, quindi non pu essere attivato dal Glu rilasciato a livello della terminazione stessa (che invece viene prelevato dagli astrociti). mGlu2 normalmente attivato dal Glu rilasciato dal trasportatore antiporto xCT della glia il quale trasporta allesterno il Glu e allinterno la cistina. Ci permette attivatore di mGlu2 che il limitatore di velocit nella sinapsi tra le fibre della corteccia orbito frontale e i neuroni del nucleo accumbens. La cistina utilizzata dalle cellule della glia per sintetizzare glutatione che utilizzato per la difesa dai radicali liberi , quindi xCT molto importante. Esso presente in cellule dendritiche, linfociti, neuroni Nel tossicodipendente si osserva: - una riduzione di xCT del 40-50% quindi mGlu2 pu essere attivato limitatamente - Lespressione della proteina AGS3 che fa parte del secondo gruppo degli attivatori delle proteine G. Essa complesser la sub i-GDP impedendole di funzionare, mentre permette a di trasmettere il segnale, ma il ruolo chiave assolto da i! queste sono le basi molecolari per la ricaduta nella tossicodipendenza Trattamento del cocainomane Nella fase del binge usando farmaci che bloccano lattivazione, da parte della droga del sistema mesolimbico. Questapproccio ha un limite: se il cocainomane sniffa per avere certi effetti e sottraiamo tali effetti il cocainomane assumer sempre pi droga fino al punto di superare il blocco, quindi rischiamo un overdose. Per esempio somministriamo antagonisti dei recettori per la morfina per impedire che leroina attivi il sistema mesolimbico con altissimo rischio che il soggetto ricorrer a dosi eccessive con overdose. Se invece interveniamo nella fase di astinenza in cui la soglia alta e si ha un bisogno assoluto di riprendere la droga per abbassare la soglia, in questo caso utilizziamo una sostanza che si comporta come la droga, con lo stesso meccanismo dazione, ma non ha potenziale tossico. Se passata lastinenza si detossificati ma vulnerabili, per cercare di non ricadere si pu: - riattivare xCT che espresso di meno - bloccare espressione AGS3 -
-
- agonista farmacologico di mGlu2 una di queste tre possibilit si materializzata in terapia. In particolare il farmaco si chiama Nacetilcisteina. Questo un farmaco che normalmente si usa in 2 situazioni: 1) fluidificante bronchiale. Rende meno dense le secrezioni dei bronchi. il principio attivo di Fluimucil 2) danno epatico da paracetamolo in quanto esso viene metabolizzato nel fegato e trasformato, in particolari circostanze (intossicazioni, pregressi danni epatici come epatiti), in una specie tossica che genera radicali liberi. In questo caso si d N-acetilcisteina come precursore del glutatione. LN-acetilcisteina entra nella cellula attraverso il trasportatore cisteina-glutammato quindi un attivatore di questo trasportatore. Somministrata al paziente in dosi molto alte 1 - 2 g ( nel fluimucil 300-400 mg) attiva xCT, fa rilasciare Glu che ripristina il freno prevendo il relapse. Gli studi rivelano ottimi risultati in cocainomani e fumatori di sigaretta e adesso tale farmaco in fase di trattazione per lingresso nel mercato con questa specifica indicazione. Il professor Smeraldi (che non conosce questi meccanismi) ha dichiarato che nella sua esperienza tratta cocainomani con un cocktail di - vitamina E - N-acetilcarnitina - N-acetilcisteina Supponendo che agisse solo come antiossidante. Nelluomo non si sa ancora la durata della terapia con tale farmaco, quanto dura questa modificazione della plasticit sinaptica e se momentanea o permanente. Certamente potrebbe essere adeguato per un ex cocainomane iniziare un ciclo di terapia(2-3 mesi) se si prevede un periodo di forte stress, per poi ridurre il dosaggio. La predisposizione a sviluppare la tossicodipendenza sicuramente correlata a meccanismi epigenetici di metilazione del DNA , acetilazione e fosforilazione delle code degli istoni e fattori di trascrizione, ma nel dettaglio ancora non si sa. Per epigenetica, in neurologia, si intende tutto ci che altera lespressione di un gene e non correlato a un alterata sequenza delle basi del DNA. Per i genetisti invece epigenetica unalterazione spesso permanente dellespressione genica mediata da meccanismi di acetilazione, deacetilazione, fosforilazione ecc.. che pero pu essere trasmessa da cellula a cellula, da individuo a individuo. Quindi la trasmissione alla progenie una parte integrante dellepigenetica, meccanismo che in neurobiologia non pu sussistere perch le cellule nervose non hanno capacit di riprodursi a causa della notevole specializzazione nelle loro funzioni. La costruzione della rete neuronale avviene gi durante la vita prenatale, evento che rende difficile linserimento di ulteriori componenti nel circuito in fasi successive della vita dellindividuo. Solo in due sedi si ha neurogenesi nella vita adulta: 1) giro dentato dellippocampo : in questa sede necessario produrre nuove cellule per generare nuove memorie con tutta una dinamica particolare 2) regione sub ventricolare (intorno ai ventricoli cerebrali): da qui si dipartono cellule nuove e non si sa dove vanno. Nel topo nel bulbo olfattivo, nelluomo non si sa. Se un evento esterno spinge la cellule nervosa alla riproduzione, ovvero si altera il rapporto tra cellula e matrice extracellulare, questa rientra nel ciclo mitotico, passa la fase G1, entra nella fase S (duplicazione DNA) e in quella fase innesca un meccanismo di apoptosi e si uccide. cosi che muoiono le cellule nellAlzheimer, nelle malattie degenerative, nelle vasculopatie croniche.. Questo rende dubbi gli studi sulle cellule staminali. Il terzo gruppo di AGS, le AGS 2, 7, 8 legano il complesso staccandolo dalla che si lega al GTP permettendole di funzionare per la complessata alle AGS e quindi non possono trasmettere. MECCANISMI DI TRASDUZIONE DEL SEGNALE DEI RECETTORI ACCOPPIATI A PROTEINE G:
IDROLISI DEI POLIFOSFOINOSITIDI Lidrolisi dei polifosfoinositidi il meccanismo di trasduzione del segnale generato dai recettori accoppiati alle proteine Gq, G11, G14, G16, Go, G12, G13 e recettori tirosin chinasici( come quelli dellinsulina, EGF, BDNF e recettori dei linfociti T che servono per il differenziamento e lespansione clonale dei linfociti T naive ). Per capire tale via di trasduzione va analizzata una molecola che normalmente si trova tra i fosfolipidi di membrana che prende il nome di fosfatidilinositolo. Esso strutturalmente costituito da uno scheletro di glicerolo che esterificato in posizione 1 con un acido grasso normalmente saturo; in posizione 2 esterificato con un acido grasso insaturo, nella maggior parte dei casi acido arachidonico; in posizione 3 esterificato con un gruppo fosforico che legato a un inositolo cio a una molecola ciclica (che non uno zucchero, non c nessuna aldeide) che ha diversi gruppi ossidrilici. Il fosfatidilinositolo rappresenta il 10 % di tutti i fosfolipidi (il pi rappresentato di tutti la fosfatidilcolina, poi c la fosfatidiletanolammina, fosfatidilserina e fosfatidilglicerolo che si differenziano per il gruppo legato al fosfato). Lenzima che effettua il taglio tra il glicerolo e lacido grasso in posizione 1 la FOSFOLIPASI A1; quello che effettua tale taglio in posizione 2 la FOSFOLIPASI A2 la quale molto importante in quanto permette il distacco dellacido arachidonico che il precursore di prostaglandine, prostacicline, leucotrieni e endoperossidi che si formano per azione delle ciclossigenasi, lipossigenasi e endossigenasi che attaccano lacido arachidonico. Le fosfolipasi che intervengono in posizione 3 lo fanno in maniera diversa a seconda del punto di attacco. il taglio che avviene tra lossigeno dellOH del glicerolo esterificatosi con il fosfato e il fosforo catalizzato dalla FOSFOLIPASI C che quindi stacca il gruppo distintivo del fosfolipide mantenendo il fosforo attaccato a tale gruppo. Mentre se il taglio viene effettuato pi a valle(tra il fosforo e il gruppo a esso legato) e lascia il gruppo fosforico legato al glicerolo si parla di FOSFOLIPASI D. Il fosfatidilinositolo nelle membrane viene ulteriormente metabolizzato. Infatti interviene una chinasi che fosforila linositolo in posizione 4 . Successivamente il fosfatidilinositolo 4-fosfato (PtdIns 4-P) viene attaccato da un altra chinasi che lo fosforila in posizione 5 trasformandolo in fosfatidilinositolo 4,5-bisfosfato che probabilmente il fosfatide pi importante presente nelle cellule ( PtdIns 4,5-P2). Esso viene attaccato dalla FOSFOLIPASI C e il suo taglio porter alla formazione di : - DIACILGLICEROLO (glicerolo + acidi grassi in posizione 1 e 2) - INOSITOLO 1,4,5 TRISFOSFATO (Ins 1,4,5 P3) Il DAG una sostanza lipidica quindi rimane a livello della membrana. Il suo compito contribuire a attivare la PKC, la quale pu essere attivata anche da: - calcio - fosfatidilserina - acido arachidonico L Ins 1,4,5, P3 invece ha il ruolo di rimuovere Ca2+ da depositi intracellulari detti calciosomi IP3 sensibili. Il PtdIns 4,5 P2 pu essere attaccato , attraverso una via alternativa, da un enzima chiamato FOSFATIDILINOSITOLO 3 CHINASI (PI3K) che opera laggiunta di un gruppo fosforico in posizione 3 portando alla formazione del PtdIns 3,4,5 P3. Questi meccanismi di trasduzione si riscontrano nellattivazione dei recettori per linsulina, per lEGF, BDNF ed lenzima pi importante per la protezione e proliferazione della cellula e inoltre permette allinsulina di far entrare il glucosio nelle cellule del tessuto adiposo TIPI DI PLC NELLE CELLULE Nelle cellule possiamo riscontrare diversi tipi di PLC : PLC ulteriormente classificate in - PLC 1 e 4 che sono attivate dalle sub unit q, 11, 14, 16,o. Quindi le proteine G che hanno queste subunit attivano le PLC 1 e 4 inducendone lattacco sul fosfatidilinositolo 4,5 P2. i recettori pi importanti del nostro organismo sono coinvolti in questi meccanismi..per es :
recettori M3 e M1 muscarinici, H1,1, 5HT2 (a,b,c), mGlu 1,5. - PLC 2 e 3 presentano domini PH e sono dunque attivate dal complesso . Quindi anche una proteina G diversa da Gq come Gi pu attivare attraverso PLC 2 e3 PLC in - 1 - 2 esse hanno una caratteristica : hanno il dominio SH2= SRC homology 2 ovvero sequenza di aa simile a quella della proteina SRC. Questo dominio interagisce con la fosfotirosina dei recettori tirosinchinasici attivati, permettendo a sua volta lattivazione della PLC e quindi la conversione del fosfatidilinositolo 4,5 bisfosfato in DAG e IP3. Questo quello che accade per i recettori dei linfociti T quando entrano in contatto con lantigene presentato dalla cellula dendritica APC: il recettore viene attivato e si mobilizza Ca2+ a sua volta mobilizzato grazie a PLC (quindi N.B. PLC -> proteine G PLC -> recettori tirosinchinasici ) PLC 1,2,3,4 funzione sconosciuta. Probabilmente non associate a recettori ma attivate dal Ca2+ ( pur vero che il Ca2+ viene dallIP3 ma pu aumentare anche grazie a altri meccanismi per es. apertura canali ionici) PLC localizzata unicamente negli spermatozoi, quindi nelle cellule della linea riproduttiva. La loro funzione sconosciuta. Come vedremo, lidrolisi dei polifosfoinositidi il primo evento fondamentale per la formazione dello zigote, per il quel caso la PLC della cellula uovo, mentre la PLC nello spermatozoo. Forse serve per la motilit dello spermatozoo. PLC 1 e 2 con funzione sconosciuta PLC 1 e 2 (anche se questa divisione ultimamente non vale pi). Questa fosfolipasi pu essere attivata da 1) proteina Rho attivata da 12 e 13 di G12 e G13 2) proteina Rap attivata da cAMP (quindi dalle proteine Gs) attraverso EPAC 3) proteina Ras attivata da recettori tirosinchinasici
-
DESTINO FUNZIONALE DI DAG E INOSITOLO 1,4,5 P3
22/09
La difficolt nel determinarne gli effetti risiede nella brevissima emivita dellIns 1,4,5 P3. Supponendo dunque di condurre un esperimento con una cultura di cellule nervose, in cui viene inserito un agonista dei recettore muscarinici M1 che stimolino la formazione dei polifosfoinositidi, si osserva che la misurazione della concentrazione di IP3 resa difficoltosa dalle immediate comparsa e scomparsa di IP3 tali che non possibile n arrestare adeguatamente la reazione, n renderla riproducibile. L Ins 1,4,5 P3 formatasi infatti viene subito metabolizzato a Ins 1,4 P2 a seguito della rimozione di un fosfato dall enzima inositolo bisfosfato fosfatasi. Tale enzima bloccato dal 2,3 BPG che dunque blocca il metabolismo dell IP3. Tale blocco ha particolare valore funzionale nella cellula del pancreas in cui il 2,3 BPG si forma a partire dalla glicolisi anaerobia permettendo in questo modo che a seguito dellentrata di glucosio nella cellula (trasportatore GLUT 2 insulina indipendente glucosio indipendente) si abbia secrezione di insulina. Questo perch 2,3 BPG prodotto nella glicolisi inibisce la conversione di IP3, in modo tale che esso permetta la mobilizzazione del calcio con conseguente rilascio di insulina (tenuto conto che questo meccanismo comunque secondario alla chiusura dei canali KATP , che rappresentano il meccanismo fondamentale nel mediare la secrezione di insulina). Una rara forma genetica di diabete, patologia nota come MODY (diabete della giovinezza con insorgenza nella maturit) dovuta alla mancata sintesi di glucochinasi che non rende possibile la sintesi di insulina da parte delle cellule del pancreas. Tornando allIns 1,4 P2 esso a seguito della rimozione di un fosfato viene convertito in Ins 4P , per
essere infine convertito in inositolo libero (myo D inositolo per la prevalente localizzazione nella muscolatura scheletrica) grazie all enzima inositolomonofosfatofosfoidrolasi. Questo enzima di fondamentale importanza perch: 1) linositolo libero utilizzato dalle cellule per la formazione di PtdIns 4,5 P2 2) Il LITIO (Li+) blocca lultima reazione di defosforilazione, e dunque la formazione di inositolo libero bloccando tale enzima, con una costante di inibizione Ki = 0.5mM (500microM di litio determinano un blocco del 50% dell attivit enzimatica). Il litio dunque il farmaco d elezione nel trattamento del DISTURBO BIPOLARE (mania= esaltazione smisurata del tono dell umore [fuga dalle idee] che permette di distinguere i soggetti in manico: disturbo bipolare di tipo 1 ipomanico: disturbo bipolare di tipo 2 ipertinico: con temperamento esaltato ma non definibile patologico.) Il disturbo bipolare dunque vede l alternanza di fasi MANIACALI e fasi DEPRESSIVE molto pi frequenti delle precedenti e caratterizzate da un alto rischio di suicidio. Tuttavia sufficiente una singola fase maniacale, pur non avendo evidenza di fasi depressive, per fare diagnosi di disturbo bipolare. La terapia dunque pu essere attuata - in profilassi trattando il paziente con litio giornalmente ad una concentrazione plasmatica compresa tra 0.4 e 1.5 mM tenuto conto che in tale range di valori pu essere somministrato per tutta la vita, e che la sua soppressione determinerebbe il ritorno delle fasi prevalentemente maniacali del disturbo. - in fase acuta correndo tuttavia il rischio di switch da una fase all altra trattando per es. la fase maniacale ma rischiando di sfociare nella depressiva. Il litio inibendo la formazione di inositolo libero e preludendo cos la formazione del pool di fosfoinositidi presenta un determinato profilo di tossicit con effetti cardiotossici, ipotiroidismo (blocco dellorganicazione dello I-), aumento ponderale dovuto ad unazione diretta sullipotalamo e disturbi a livello del SNC (tremori) e del rene, ed eventuale inibizione della sintesi di insulina da parte delle cellule del pancreas, ma che effettivamente non si manifestano alle concentrazioni sopra indicate. Tornando all Ins 1,4,5 P3 si osserva come possa diventare substrato di PKC e dunque fosforilato per divenire Ins 1,3,4,5 P4 (inositolo tetrakis fosfato) la cui funzione non ancora del tutto nota ma che pu essere intuita facendo riferimento ad un esperimento condotto da ?Moby Irvine?. Si osserv come somministrando Ins 1,3,4,5 P4 si verificasse nella cellula uovo una reazione acrosomiale analoga a quella che fa seguito alla penetrazione dello spermatozoo. Al contrario a seguito delliniezione di Ins 2,4,5 P3 non avviene tale reazione nonostante anchesso determini il rilascio di calcio. Probabilmente ci legato all incapacit di Ins 2,4,5 P3 di convertirsi in Ins 1,3,4,5 P4 a differenza di quanto si osserva per l Ins 1,4,5 P3 che pu invece convertirvisi. Il ruolo di Ins 1,3,4,5 P4 quello di determinare la diffusione intracellulare di calcio rilasciato in sede localizzata. La conferma a tale teoria si ottiene osservando come la somministrazione nella cellula uovo di Ins 2,4,5 P3 con Ins 1,3,4,5 P4 fa s che la reazione avvenga confermando il ruolo di quest ultimo nella diffusione del calcio intracellulare. L Ins 1,3,4,5 P4 pu diventare substrato di una fosfatasi ed essere convertito in Ins 1,3,4 P3 (metabolita inattivo [nessun ruolo nel rilascio di Ca2+ di maggiore emivita) che grazie alla chinasi diviene Ins 1,3,4,6 P4 il quale a sua volta ad opera della stessa chinasi diviene Ins 1,3,4,5,6 P5 (inositolo pentakisfosfato) di funzione non nota ma che pu essere o defosforilato in posizione 1 (Ins 3,4,5,6 P4 ) oppure fosforilato da una chinasi k in Ins 1,2,3,4,5,6 P6 (inositolo esakis fosfato = acido fitico), entrambi con funzione non nota.
La difficolt nel determinarne il ruolo correlata alla loro breve emivita e quindi alla difficolt a determinarne la concentrazione. Una strategia di laboratorio per misurare lidrolisi dei polifosfolipidi potrebbe prevedere: 1) utilizzo di Ins radioattivo (3H Ins) incorporato nei fosfolipidi, ottenendo cos Ins 1,4,5 P3 triziato 2) le cellule vengono cos trattate con Li+ impedendo la conversione di inositolo monofosfato (Ins 4 P) in inositolo libero. L Ins 4P si forma e si accumula nella cellula e ne viene rilevata la radioattivit con una cromatografia a scambio ionico (utilizzando una resina che leghi i fosfati acidi), esso diviene perci un indice dellattivazione del recettore e della formazione di Ins 1,4,5 P3 . Allora, tenuto conto che per pi tempo blocco la reazione, maggiore la quantit di Ins 4P che si accumula (derivante dallIns 1,4,5 P3), posso facilmente valutare la funzionalit (ipo- iper-) del recettore in un fenotipo patologico. L idrolisi del PtdIns 4,5 P2 ad opera della PLC d vita non solo a Ins 1,4,5 P3 ma anche a DAG. Il DAG si compone di uno scheletro di glicerolo a cui in posizione 1 legato un acido grasso saturo, in posizione 2 un acido grasso insaturo (acido arachidonico) e infine un ossidrile in posizione 3. La diacilglicerolo lipasi un enzima con 2 isoforme: una determina il distacco di acido arachidonico in posizione 2, laltra dellacido grasso in posizione 1. Questultima reazione produce 2-arachidonilglicerolo (2Ag) endocoide di CB1. COME FUNZIONE IL 2-ARACHIDONILGLICEROLO? Dal terminale assonico presinaptico viene liberato un neurotrasmettitore che si lega ad un recettore accoppiato a proteina Gq presente sul terminale postsinasptico. Lattivazione del meccanismo di trasduzione del segnale induce lidrolisi dei polifosfoinositidi producendo DAG, substrato della DAG lipasi ottenendo quindi 2Ag. Il 2Ag viene liberato e si lega sul recettore CB1 presente sul terminale assonico presinaptico o su un assone vicino, agendo quindi da messaggero retrogrado (inverte la direzione del flusso sinaptico). Possono allora verificarsi due fenomeni: - DSI (soppressione dellinibizione indotta dalla depolarizzazione) se lassone su cui agisce il 2Ag inibitorio - DSE (soppressione delleccitazione indotta dalla depolarizzazione) se lassone su cui agisce il 2Ag eccitatorio Entrambi queste fenomeni sono fondamentali nel sincronismo di scarica delle cellule nervose e alterati nei pazienti schizofrenici (soprattutto la DSI) a seguito delluso di 9THC. Il DAG pu anche essere soggetto a fosforilazione dalla DAGchinasi determinando la formazione di acido fosfatidico che reagisce con CTP con distacco di un pirofosfato formando CDP-DAG che si unisce con Ins libero formando fosfatidilinositolo. COME AGISCE IP3 ? Esso media il rilascio di calcio dai calciosomi IP3 sensibili. La concentrazione di Ca2+ extracellulare di 1mM, mentre quella intracellulare invece pari a 10-7 M con un gradiente di diecimila volte. Lapertura di canali ionici di membrana determinerebbe dunque un rapido afflusso di calcio secondo gradiente secondo quanto si osserva nei fenomeni di depolarizzazione di membrana o nel rilascio di neurotrasmettitore, in tali casi il calcio viene poi rapidamente estruso onde evitare la morte cellulare. Al contrario quando necessario indurre un aumento a lungo termine della concentrazione intracitoplasmatica di ioni Ca2+ esso viene mobilizzato dai calciosomi con una CINETICA OSCILLATORIA che pu essere di 2 tipi: - con oscillazioni lente della linea di base (la concentrazione di calcio sale per poi tornare al valore basale alternativamente) - con oscillazioni sinusoidali molto pi rapide senza il ritorno alla linea di base. La diffusione dellonda di calcio quindi deve essere permessa da un meccanismo che agisca anche nelle sedi intracellulari dove l IP3 non pu arrivare a causa della sua effimeratezza. Sono infatti
presenti calciosomi IP3 insensibili che vengono attivati dal calcio per cui rispondono allo stesso calcio con un meccanismo CICR (Calcium Induced Calcium Release). Le caratteristiche del rilascio di calcio dalle sedi intracellulari si caratterizzano per: 1) cinetica oscillatoria 2) diffusione dell onda che dipende dalla coesistenza di calciosomi IP3 sensibili ed insensibili. CALCIOSOMA= formazione del reticolo sarco- ed endoplasmatico contenente ioni calcio grazie ad una ATPasi che trasferisce tali ioni dal citosol all interno del calciosoma. Si tratta della pompa SERCA che esiste nelle diverse isoforme : - SERCA1a : nella muscolatura scheletrica a contrazione rapida delladulto (es. muscoli oculomotori) - SERCA1b: nella muscolatura scheletrica a contrazione rapida dellembrione - SERCA2a: nel muscolo cardiaco e nella muscolatura liscia - SERCA2b: ubiquitario - SERCA3(a-f): con bassa affinit per il calcio L attivit della pompa SERCA modulata dalla concentrazione di calcio nel calciosoma. Questa pompa inibita da un farmaco quale la tapsigargina, utilizzata in sperimentazione con deplezione di calcio nei calciosomi. La pompa SERCA regolata nella sua attivit dal fosfolambano . Quando questo presente in forma defosforilata impedisce al calcio di entrare nel calciosoma, quando invece fosforilato (da PKA a PKG) non pi in grado di inibire SERCA. Dunque PKA e PKG attivano rispettivamente AMPc e GMPc con fosforilazione del fosfolambano che non pi in grado di inibire l attivit di se SERCA e cos il calcio veicolato nei calciosomi con sottrazione dallapparato contrattile. Inibitore di SERCA anche la sarcolipina che ha meno importanza rispetto al fosfolambano ma che a differenza di questo ha effetto anche su SERCA di tipo 3. Nella muscolatura liscia vasale si rintracciano, alla luce di quanto detto, diversi recettori che ne mediano contrazione e rilasciamento: recettori 1 accoppiati a Gq, attivati dal rilascio di NA da fibre simpatiche che a seguito della formazione di IP3 e della mobilizzazione di calcio inducono contrazione. recettori 2 accoppiati a Gi che riducono l AMPc determinando contrazione della parete vasale recettori 2 accoppiati a Gs che aumentano l AMPc e ne determinano il rilasciamento recettori 5HT2a accoppiati a Gq, attivati dalla serotonina e maggiormente presenti a livello delle coronarie che determinano un aumento del tono vascolare recettori 5HT1b accoppiati a Gi che determinano una riduzione dell AMPc con costrizione del vaso recettori 5HT7 accoppiati a Gs che aumentando l AMPc determinano rilasciamento. [Ca2+ = vasocostrizione cAMP = vasodilatazione cAMP = vasocostrizione] GMPc tuttavia anche prodotto grazie al monossido dazoto radicale NO che viene sintetizzato in sede endoteliale dallenzima eNOS (la cui attivit correlata allattivazione di un recettore accoppiato a Gq che mobilizza Ca2+) o eventualmente rilasciato da fibre parasimpatiche specializzate dette NANC (non adrenergiche non colinergiche) e che migrando nella tonaca media vascolare determina produzione di GMPc e dunque rilasciamento. Lattivit del GMPc fondamentale nel rilasciamento dei corpi cavernosi del pene. Farmaci come SILDENAFIL (viagra), TADALAFIL (cialis), VARDENAFIL (levitra) inibendo la fosfodiesterasi5 (PDE5) impediscono la degradazione di GMPc, permettendo cos un aumento della concentrazione di GMPc nelle cellule della muscolatura liscia dei corpi cavernosi e permettendone cos il rilasciamento
(i corpi cavernosi sono gli unici muscoli perennemente contratti, poich si rilasciano in erezione). [Viagra e Levitra non devono essere presi a stomaco pieno, non si possono combinare con lalcool e hanno una durata di 3-4 ore, il Cialis pu essere preso a stomaco pieno e combinato con lalcool ed ha una emivita di 17 ore (anche 3 giorni), questo farmaco non d priapismo ma aiuta la funzione erettile quando ci sono gli stimoli necessari per la comparsa.] Il viagra anche utilizzato nellipertensione polmonare cronica poich dilata i vasi sanguigni in prossimit degli alveoli in espansione per lingresso di aria, ottimizzando il rapporto ventilazione perfusione, migliora anche la funzione del ventricolo dx. Cialis e nitroglicerina (usata nel trattamento dei pazienti cardiopatici) se somministrati insieme possono determinare collasso cardiocircolatorio venendosene a sommare gli effetti vasodilatatori con conseguente crollo del ritorno venoso. Somministrando endovena Ach vi un immediato calo pressorio poich tale neurotrasmettitore attivando i recettori M3 dellendotelio vascolare determina vasodilatazione. Infine nel calciosoma il