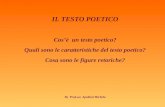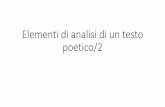IL TESTO POETICO Cos’è un testo poetico? Quali sono le caratteristiche del testo poetico?
Esplorare il testo poetico in classe
description
Transcript of Esplorare il testo poetico in classe

UNIVERSITÀ PER STRANIERI DI PERUGIA
_________________________________________________________________________________________________________________________________________
FACOLTÀ DI LINGUA E CULTURA ITALIANA
MASTER IN DIDATTICA DELL’ITALIANO LINGUA NON MATERNA
ESPLORARE IL TESTO POETICO IN UNA CLASSE D’ITALIANO L2
TESINA INTERDISCIPLINARE
RELATORE: PRESENTATA DA: CHIAR.MO PROF. ERMINIA ARDISSINO BARBARA PROCHILO
ANNO ACCADEMICO: 2004/2005

Premessa
Questo lavoro, basato su una proposta didattica di un testo poetico, racchiude alcune delle
osservazioni fatte lungo tutto il percorso formativo del Master.
Nei vari moduli studiati e nel Practicum si è dato particolare rilievo a due aspetti dell’insegnamento
di una lingua: il ruolo fondamentale del discente che nella didattica moderna delle lingue viene
posto al centro delle scelte che determinano gli obiettivi glottodidattici e la centralità del testo,
quest’ultimo da intendere soprattutto come strumento di comunicazione e di interazione oltre che
come “attivatore” di apprendimento.1 Prima di focalizzare l’attenzione sull’analisi del testo poetico
scelto, ho ritenuto opportuno partire da una breve introduzione sul ruolo della letteratura all’interno
di un corso di lingua, alla luce di quanto emerso dal modulo di Didattica dei testi letterari e dalla
mia breve esperienza di insegnamento dell’italiano L2 e del francese LS.
Incontro con la letteratura: tra formazione ed esperienza
Sono considerevoli i vantaggi derivanti dall’utilizzo della letteratura in un corso di lingua seconda o
straniera; il testo letterario, che sia narrativo, teatrale o poetico, è portatore di cultura, accresce il
bagaglio linguistico dello studente, sviluppa il suo pensiero, le sue capacità di comprensione e di
giudizio, lo incuriosisce e lo gratifica. È anche vero, però, che sono diverse le difficoltà che presenta
e complessa l’analisi che richiede, motivi per cui l’insegnante, di fronte alla prospettiva di
introdurlo nella sua classe, si pone molteplici interrogativi su quando affrontarlo e quale
competenza linguistica deve possedere lo studente per poterlo apprezzare, come farlo leggere e
quale testo scegliere.
Prima di aver modo di riflettere sull’utilizzo di testi letterari in un corso d’italiano per stranieri ero
convinta che lo studente potesse “accedere” al mondo della letteratura e in particolare a quello della
poesia solo dopo aver maturato un' adeguata competenza linguistica. Ma l’esperimento condotto in
un corso per principianti di italiano e basato sull’utilizzo di una poesia di non facile comprensione
come L’infinito di Leopardi, ha dimostrato, invece, come, con il ricorso ad opportune strategie di
avvicinamento al testo utili per abbassare il filtro affettivo dell’apprendente e fargli superare il duro
impatto con un testo linguisticamente complesso, sia possibile proporre un testo poetico persino nei
primi stadi dell’apprendimento di una lingua e che pertanto non occorre aspettare che la classe in
cui si insegna raggiunga un livello alto per “fare letteratura”.
2
1 CFR Vedovelli, M. Guida all’italiano per stranieri, citato in Adorno C., Bosc F., Ribotta P, Grammatica: insegnarla e impararla, Perugia, Guerra Edizioni, 2003, p.65

Riguardo, poi, al modo di introdurre un testo letterario, mi rendo conto di aver finora utilizzato nei
corsi d’italiano e di francese due strategie di approccio totalmente differenti. Probabilmente la
ragione va cercata nel fatto che i docenti italiani ritengono più importante partire dalla “cornice” del
testo, valorizzando biografia e poetica dell’autore e affrontando il testo letterario solo in un secondo
momento e con continui rimandi alla vita dell’artista; un metodo alquanto discutibile per i francesi,
che partono, al contrario, dal testo, sezionandolo, quasi in maniera maniacale, in tutte le sue diverse
componenti. Approcci, dunque, del tutto opposti che ho “assimilato” durante la mia formazione a
scuola e all’università e nel corso della mia esperienza, seppur breve, di assistente di lingua italiana
in Francia e che poi ho riprodotto in maniera del tutto automatica nel momento in cui ho iniziato a
insegnare le due lingue. Prescindendo da questo modo diverso di operare, ciò che più importa,
secondo le studiose Ardissino e Stroppa, è che nessuno dei due metodi riesce ad impedire che lo
studente sovrapponga alla lettura del testo un suo personalissimo istinto interpretativo che lo
spinge a identificare nella scrittura letteraria il riflesso immediato di una biografia2. Per far sì che
lo studente abbia una percezione diretta del testo che verrà presentato si può ricorrere, come
suggeriscono le due autrici, ad una lettura fatta a più riprese attraverso cui l’insegnante focalizzerà
di volta in volta singole parti del testo3 facendo, nello stesso tempo, acquisire agli allievi una
maggiore competenza letteraria, in termini di abilità e non di nozioni, che permetta loro di cogliere
la ricchezza di un’opera letteraria.
Infine, per quanto riguarda la scelta dei testi l’insegnante dovrà tener in considerazione il livello
linguistico-culturale degli studenti oltre ai loro bisogni e alle loro aspettative in termini di
metodologie e contenuti. A questo proposito nei vari moduli del Master si è posta, spesso,
l’attenzione sulla centralità dello studente; questo è, infatti, il concetto cardine che ha segnato in
anni recenti il cambiamento di prospettiva nella didattica delle lingue straniere, fondamento assunto
dal Quadro Comune di Riferimento per le lingue, che colloca il discente al centro dei processi di
insegnamento e apprendimento di una lingua straniera.
Proposta didattica di un testo poetico
Il testo di Umberto Saba, dal titolo Quando nacqui mia madre… , che ho scelto di analizzare, non
presenta eccessive difficoltà lessicali, per cui potrebbe essere proposto anche in un B1, livello in cui
l’apprendente, secondo le indicazioni contenute nel Quadro Comune di Riferimento per le lingue, è
in grado di comprendere testi scritti in un linguaggio quotidiano e di capire la descrizione di eventi
e di sentimenti, presenti per l’appunto nel testo scelto. Se, però, oltre al lessico, si intende mettere a
fuoco l’aspetto morfo-sintattico, che invece, in alcuni punti della poesia, risulta complesso per la
3
2 Ardissino E., Stroppa S., Leggere testi letterari, Torino, Paravia Mondatori Editori, 2001, p. 47 3 Cfr, IBIDEM, p. 47

disposizione dei costituenti della frase, bisognerebbe, a mio avviso, presentarlo in un livello più
alto. Rispetto anche al tipo di analisi suggerita e di attività predisposte, la mia proposta didattica si
indirizza ad un corso B2 e il tempo previsto per lo svolgimento è di circa 3 h.
Quando nacqui mia madre… Come bella doveva essere allora Quando nacqui mia madre ne piangeva, la mia città: tutta un mercato aperto! sola, la notte, nel deserto letto, Di molto verde, uscendo con mia madre Per me, per lei che il dolore struggeva, trafficavano i suoi cari nel ghetto. io, come in sogno, mi ricordo ancora. Ma di malinconia fui tosto esperto; Da sé il più vecchio le spese faceva, unico figlio che ha lontano il padreper risparmio, e più forse per diletto.
Con due fiorini un cappone metteva nel suo grande turchino fazzoletto.
1° fase: alcune tecniche elicitative per introdurre il testo poetico
Per superare la fase ansiogena e di tensione che un testo poetico rischia di provocare si dovrà creare
un clima favorevole all’apprendimento e allo stesso tempo far nascere nello studente il desiderio di
leggere il testo scelto, creandogli delle aspettative.
L’attività che segue ha, pertanto, come scopo principale quello di coinvolgere emotivamente la
classe: si leggerà ad alta voce e con espressività il sonetto, avvertendo gli studenti che nel corso di
questa fase dovranno lasciarsi trasportare dalla musicalità dei suoni, cercare di cogliere tutte le
sensazioni (tristezza, nostalgia..) che la poesia suscita e trovare associazioni di idee che essa ispira.
Per stimolare la loro curiosità si focalizza, poi, l’attenzione sul titolo della poesia che corrisponde
anche alla prima parte del primo verso (quando nacqui mia madre) e anticipando alcune parole
difficili del testo come diletto, struggere, turchino, tosto, cappone si potrebbe chiedere di comporre
un breve testo sulla loro autobiografia.
Un espediente alternativo potrebbe essere quello di far anticipare il contenuto della poesia. In
questo caso oltre alle parole elencate precedentemente se ne potrebbero fornire altre come madre,
padre, figlio, città, sogno, presenti nel testo poetico e com’ è noto motivi ricorrenti nella poesia di
Saba. In questo modo gli studenti, impegnati nella formulazione di ipotesi, miglioreranno la loro
competenza comunicativa e allo stesso tempo amplieranno le loro conoscenze sugli autori della
letteratura italiana.
2a fase: analisi del testo
La metrica
Una volta superati gli ostacoli di natura psico-affettiva, si potrà entrare in stretto rapporto con il
testo poetico, che in questa fase diventa il protagonista assoluto della lezione.
4

Dopo aver distribuito la poesia si potrebbe chiedere agli studenti di esaminarne la struttura (due
quartine e due terzine, struttura caratteristica del sonetto) e di sottolineare le rime presenti,
osservandone anche la disposizione (ABAB ABAB CDE CDE).
Leggerei una seconda volta il testo, scandendo chiaramente gli accenti e una volta evidenziata
l’importanza dell’accento principale del verso (esso cade sulla decima sillaba), aiuterei gli alunni
nel conteggio delle sillabe che compongono i versi allo scopo di individuarne il tipo (si tratta di
endecasillabi piani).
Poi farei rilevare le numerose sinalefi (verso 3: che il ; verso 4 trafficavano i; verso 5 sé il; verso 6
risparmio e….), la cui presenza rende il testo più fluido e più melodioso.
Avvalendosi delle indicazioni fornite durante la lezione ed eventualmente delle conoscenze di
analisi letteraria che hanno acquisito nella loro lingua madre, gli studenti noteranno la presenza di:
- suoni consonantici uguali che si ripetono in più parole vicine (allitterazioni):
Es: Quando nacqui mia madre ne piangeva,
sola, la notte, nel deserto letto
Per me, per lei che il dolore struggeva,
trafficavano i suoi cari nel ghetto
- suoni vocalici uguali (assonanze)
Es: io, come in sogno, mi ricordo ancora.
Ma di malinconia fui tosto esperto.
A questo punto porrei l’attenzione su quello che la scrittrice Bisutti definisce i due diversi
andamenti della poesia, i due diversi modi di muoversi: il primo, in orizzontale, che è quello della
lettura e secondo il quale procede il suo normale significato; e il secondo, in verticale, che lega le
parole alla fine dei versi come se si trattasse di infilare perle per farne una collana.4
Dalla disposizione delle rime presenti alla fine dei versi si metterà, dunque, in evidenza lo stretto
legame tra il suono e il senso delle diverse parole:
- piangeva/struggeva, rima composta da due verbi all’imperfetto che esprimono la condizione di
dolore della madre;
- letto/ghetto: rima composta da due sostantivi che rimandano rispettivamente alla solitudine della
madre e alle attività commerciali degli ebrei; in comune hanno il fatto di simboleggiare una
condizione di chiusura e isolamento;
4 Bisutti D., La poesia salva la vita, Milano, Oscar Mondadori, p. 105 5

- diletto/fazzoletto, entrambi sostantivi, appartengono a due campi semantici opposti: il piacere, la
gioia e il dolore, stati d’animo che si alternano nel testo;
- ancora/allora: i due avverbi congiungono il passato ed il presente nel ricordo della sua città;
- madre/padre: l’opposizione tra le due figure genitoriali, verso cui il poeta ha nutrito, seppure in
modo diverso, un sentimento conflittuale.
Il lessico
Riguardo al lessico, si è gia detto che, l’autore fa uso di termini molto comprensibili (città, letto,
mercato, notte, padre, figlio, madre) alternandoli ad un lessico molto più ricercato come diletto,
struggeva, tosto.
Partendo da considerazioni sulla frequenza e disponibilità del lessico utilizzato nella poesia, ho
consultato la versione digitale del Vocabolario di base (VdB) di Tullio De Mauro,5 indicatoci
durante il modulo sul Lessico, ed ho riscontrato che molti termini utilizzati nella poesia sono di
livello fondamentale (deserto, dolore, città, ricordare, sogno…). Ne consegue che molte di queste
parole fanno già parte probabilmente del vocabolario ricettivo degli studenti (per lo meno di quelli
che studiano italiano come L2), vista l’elevata frequenza con cui vengono utilizzate dai parlanti
italiani. Tre termini sono classificati dal VdB di alto uso (malinconia, esperto, fazzoletto) ed uno
solo (risparmio) è di alta disponibilità6. Infine pochissimi sono quelli non segnalati nel Vocabolario
di base: cappone, turchino, struggeva, diletto, ma di cui gli studenti hanno già una conoscenza
ricettiva, in quanto sono stati introdotti nella prima fase di avvicinamento al testo.
Al fine di rinforzare l’organizzazione mentale del lessico potrebbe essere utile invitare gli alunni ad
individuare delle categorie semantiche che raggruppino i diversi termini che compaiono nel sonetto.
Complessivamente sono 4 i campi semantici che gli studenti possono ricavare:
1) affari/economia: fiorini, mercato, risparmio, trafficavano, spese;
2) famiglia: padre, madre, figlio;
3) realtà psicologiche/sentimentali: piangeva, struggeva, dolore, malinconia, ricordo;
4) vita quotidiana: letto, spese, fazzoletto;
Per arricchire il bagaglio lessicale degli studenti, suggerirei di ampliare il campo semantico relativo
agli stati d’animo, facendo trovare, con l’ausilio di un dizionario o attraverso attività ludiche, i
contrari di alcuni sostantivi e verbi: piangeva/rideva, dolore/gioia, malinconia/allegria oppure dato 5 Il lemmatizzatore, consultabile nel sito : http://www.eulogos.net/it/lemmatizzatore/default.htm , oltre ad analizzare la parola e a ricondurla alla forma del lemma, ne indica il livello del Vocabolario di base : fondamentale, alto uso o alta disponibilità. 6 Con parola di alta disponibilità si intende un termine che, pur essendo noto ai parlanti d’italiano, ha una frequenza relativamente bassa nello scritto e nel parlato. 6

un sostantivo trovare il verbo o aggettivo corrispondente e viceversa: piangeva /pianto, rideva/riso,
malinconia/malinconico. Oppure, seguendo le indicazioni fornitemi durante il Practicum, dato un
sostantivo (presente nel testo) far trovare degli aggettivi ad esso associabili: dolore- lieve,
insopportabile, lancinante…
Sarebbe interessante e utile lavorare anche sulla polisemia del verbo trafficare: commerciare,
esercitare traffici illeciti, vendere, darsi da fare (significato che ha nel testo). A questo scopo si può
proporre un esercizio dove siano presenti diverse frasi con il verbo in questione da sostituire con un
altro sinonimo.
La morfosintassi
Si procederà con l’analisi dei tempi verbali, da cui emerge l’uso di:
- due verbi al passato remoto (nacqui, fui), tempo dell’azione puntuale e dunque perfettivo;
- diversi verbi all’imperfetto indicativo, tempo della descrizione e reiterazione; due indicano la
condizione permanente di sofferenza (struggeva, piangeva) in cui viveva la madre; altri
esprimono azioni quotidiane abituali (metteva, faceva, trafficavano). Ed infine si nota il verbo
modale doveva che esprime una probabilità, un’ipotesi; il poeta, non riuscendo ad avere un
ricordo nitido della sua città, ne immagina la bellezza, idealizzandola.
- due verbi al presente indicativo (mi ricordo, ha);
- un gerundio con valore temporale, che si potrebbe rendere con un’esplicita: quando uscivo con
mia madre .
Dall’uso abbondante di verbi all’imperfetto si evince che la poesia è basata su una nostalgica e
dolorosa rievocazione (come il verbo mi ricordo suggerisce) di immagini del passato a cui segue un
presente (evidenziato da un “presente” indicativo) altrettanto doloroso a causa di un padre che
continua a non esserci (unico figlio che ha lontano il padre).
In seguito l’attenzione sarà rivolta all’aspetto sintattico della poesia.
Si osserva, innanzitutto, come nelle quartine la sintassi obbedisce alla struttura metrica, per cui ogni
verso contiene unità di senso, mentre nelle terzine la divisione ritmica del verso non coincide con la
divisione sintattica; infatti il primo verso della prima terzina si conclude con un enjambement, che
lascia in sospeso città, termine accompagnato da due punti, a cui segue una definizione del tutto
personale del poeta, che la ricorda come un mercato aperto. Inoltre il senso dell’ultimo verso della
prima terzina è strettamente legato al verso successivo.
Anche la posizione di alcuni termini si presta ad essere analizzata:
7

- sola, aggettivo separato dalle due virgole che si trova distante dal termine a cui fa riferimento
(la madre); distanziandolo, il poeta ha creato un maggior effetto comunicativo e ha trasmesso al
lettore l’idea della profonda solitudine della madre.
- bella, aggettivo che viene anticipato rispetto a città, per enfatizzarne ulteriormente la bellezza;
- di molto verde, complemento che messo in testa alla frase stravolge l’ordine naturale dei
costituenti7, quello suggerito tradizionalmente dalla grammatica: soggetto, verbo, oggetto.
Questa violazione è dettata dalla necessità di mettere in rilievo il ricordo che il poeta ha della
sua città.
- di malinconia: anche qui l’ordine marcato con un tema focalizzato a sinistra suggerisce
maggiormente l’esperienza interiore del poeta. Inoltre, la congiunzione avversativa ma
preannuncia un cambiamento di stato d’animo: il bel ricordo coloristico che serba della sua città
(di verde) è repentinamente offuscato dal ricordo della sua malinconia, causata dall’assenza del
padre e di cui ha sofferto sin dalla sua giovane età (tosto).
3° Fase di uscita
Questo è il momento in cui lo studente deve esser messo nella condizione di sistematizzare e fissare
le conoscenze acquisite nel corso delle due precedenti fasi: attraverso la messa in atto di opportune
strategie di decostruzione e ricostruzione del testo, l’insegnante richiederà una sua riflessione
personale oltre che una rielaborazione dei contenuti linguistici.
Suggerirei in questa fase di uscita un esercizio basato sulla parafrasi della poesia, utile per far capire
ulteriormente il significato del testo, ma deve essere proposto, come consigliato nel modulo di
letteratura, per campi distinti, focalizzando l’attenzione prima sul lessico, poi sulla disposizione. In
alternativa suggerirei di scrivere osservazioni e commenti personali sulla poesia o ancora per
stimolare la loro creatività proporrei, sulla base degli antonimi visti durante la riflessione sul
lessico, di riscrivere la poesia, facendo cambiare alcuni aggettivi e verbi (es: quando nacqui mia
madre ne sorrideva).
Raccogliendo infine le considerazioni fatte nel corso di Fonetica e Fonologia, avanzerei la proposta
di far drammatizzare il testo poetico. Non dimentichiamo che i brani di letteratura, come suggerisce
la studiosa Costamagna, possono essere sfruttati anche per migliorare la capacità interpretativa e per
eseguire esercizi di lettura.
Si conclude qui la mia proposta didattica attraverso cui ho cercato di mettere in pratica in modo
interdisciplinare le conoscenze e le strategie didattiche trasmesse e suggerite dai vari docenti lungo
il percorso formativo del Master.
8
7 Nel modulo sulla grammatica si è parlato di fenomeni di alterazione dell’ordine sintattico della frase. La struttura sintattica naturale o canonica dell’italiano, come si è già detto, presenta una disposizione di tipo SVO mentre la struttura informativa di un enunciato tende invece a disporre le parole a seconda del loro valore informativo.

BIBLIOGRAFIA/SITOGRAFIA/DISPENSE
Andorno C., Bosc F., Ribotta P., Grammatica: insegnarla e impararla, Perugia, Guerra Edizioni, 2003.
Ardissino E., Stroppa S., Leggere testi letterari, Torino, Paravia Bruno Mondatori Editori, 2001.
Bisutti D., La poesia salva la vita, Milano, Oscar Mondatori, 1992.
Comodi A., Dispensa sul seminario: Analisi ed adattamento dei materiali didattici.
Corda A. Marello C., Lessico: insegnarlo e impararlo, Perugia, Guerra Edizioni, 2004.
Costamagna L., Insegnare e imparare la fonetica, Torino, Paravia Scriptorium, 2000.
De Mauro T., Vocabolario di base (VdB): http://www.eulogos.net/it/lemmatizzatore/default.htm
Greco Bolli G., Dispensa sul seminario: Forme di pratica e di verifica delle abilità linguistiche.
Manili P., Dispensa sul seminario: L’insegnamento della grammatica dell’italiano in prospettiva
interculturale.
9