Educazione al pensiero compositivo. - audiation-rivista.it · pensiero compositivo. Dalle...
Transcript of Educazione al pensiero compositivo. - audiation-rivista.it · pensiero compositivo. Dalle...

audiation n.02/2016 pedagogia
!!
!!!
!!Per varie ragioni, prevalentemente autobiografiche, ho
sempre avuto interesse a lavorare con i giovani e i giovanis-
simi, immaginando e provando a proporre loro quello che
mi sarebbe piaciuto vivere durante gli anni della mia forma-
zione. Ho anche avuto la fortuna, pur non essendo un pe-
dagogista o uno studioso, di poter sperimentare alcune
idee personali sulla didattica della musica, con i giovani
musicisti e non.
Negli ultimi sei anni, grazie a progetti sostenuti dal MIUR (e
in particolare dalla Direzione Generale per lo studente,
l’integrazione e la partecipazione), mi sono trovato a lavora-
re insieme ad un grande numero di ragazzi e bambini, non-
ché a musicisti professionisti di grande livello (e anche di
grande statura umana). Per questo mi piace iniziare queste
riflessioni condividendo una frase che il compositore, didat-
ta ed amico, Claudio Rastelli scrive in un suo recente artico-
lo per il magazine della Filarmonica del Teatro Comunale di
Bologna:
![…] rarissimi sono i casi di persone a-musicali, credo di averne
conosciute due in tutta la mia vita.
!Sono concorde con Rastelli. Sono convinto che – a parte
rarissimi casi – tutti siano potenzialmente in grado di fruire
la musica ed esprimersi musicalmente. È ovvio che nel con-
testo di una rivista che si intitola “Audiation”, mi trovo a
sfondare delle porte aperte…
Meno ovvia, credo, è forse l’idea che anche la composizione
possa essere qualcosa di naturale, né più né meno come
l’ascolto della musica.
!�66
!
!
Educazione al pensiero
compositivo. Dalle composizioni per
giovani esecutori al rendering
di Paolo Marzocchi
!!

audiation n.02/2016 pedagogia
Prima di tutto una considerazione. Il mito del compositore
come essere superiore, che riceve l’ispirazione da non si sa
bene quale divinità, è uno degli effetti più longevi di una
“campagna di marketing” tra le più riuscite e inconsapevoli
che abbiamo ereditato dal romanticismo. Funziona tuttora
così bene, che figure più o meno discutibili (e talvolta riccio-
lute) del panorama nostrano, hanno costruito il loro perso-
naggio (e il loro marketing) su queste idee. Sul grande pub-
blico, sempre meno avvezzo al fare musica, e di conseguen-
za consumatore bulimico e distratto della stessa, l’idea che
un pezzo di musica si materializzi epifanicamente nella te-
sta del compositore, bell’e pronto, mentre questi è in tutt’al-
tre faccende affaccendato (nuota in piscina o mangia nutel-
la), ha una presa fortissima. Chiunque abbia provato a scri-
vere quattro note in fila, sa che questa è una colossale pan-
zana. Ma perché abbiamo bisogno di crederci? La prima
risposta che mi viene in mente è semplice: perché ci solleva
dalla responsabilità di non produrre anche noi qualcosa.
Noi non siamo eletti, non ci vengono in mente capolavori
mentre facciamo jogging, quindi siamo liberi di stupirci e
venerare il genio.
Il romanticismo, ci piaccia o meno, è il primo responsabile
di un modo di fruire e intendere la musica – per lo meno
quella cosiddetta classica, ma non solo – che ancora resiste
nonostante i due secoli trascorsi. L’aura di sacralità, la di-
stanza sempre più grande tra gli ascoltatori e gli artisti,
l’unicità del genio, la ritualità dell’esecuzione in cui l’artista
è il celebrante, il profeta. In tutto questo, per aumentare
l’effetto, si è iniziato a ricorrere già dall’ottocento (e Franz
Liszt è stato in questo di un’abilità quasi diabolica) a piccoli
effetti speciali, come l’esecuzione a memoria, le luci, e così
via.
Nel novecento, all’armamentario romantico si va ad ag-
giungere la progressiva e crescente distanza tra composito-
ri e ascoltatori. Che dico, tra compositori e il resto del mon-
do… ad esclusione della piccolissima cerchia di integralisti
o di addetti ai lavori, che – come tutte le comunità piccole e
un po’ chiuse – fanno della diversità, quindi dell’apparte-
nenza al gruppo degli eletti che capiscono, un punto di
forza e di orgoglio. Senza uscire dal seminato, bisogna però
essere onesti: non è che il resto del mondo si allontana dalla
musica contemporanea senza una ragione. Ma al di là delle
ragioni possibili, su cui possiamo discutere e magari anche
litigare, qualche riflessione dovremmo farla. La musica è
percepita come qualcosa di difficile, e – per citare un’altra
volta il Rastelli – ai giorni nostri
!la difficoltà è un’accusa e un pericolo. I genitori, senza volere,
proteggono spesso i bambini dalla difficoltà e, nel caso della
musica, chiedono solo disimpegno ("in musica devono diver-
tirsi"). Insomma, la musica non è importante: è intrattenimen-
to. Non deve essere complessa. Non dobbiamo dare fastidio,
né io né la Musica. E poi dire o produrre qualcosa giudicato
difficile ti rinchiude automaticamente nella “torre d'avorio”.
!!Negli ultimi anni ho provato a scrivere delle composizioni
che coinvolgessero i ragazzi delle scuole medie a indirizzo
musicale, le famigerate “SMIM”, insieme a musicisti profes-
sionisti. Parlo di composizioni sinfoniche a tutti gli effetti,
ovvero con uno sviluppo ampio (intorno ai 15 minuti, come
un tempo di sinfonia o un poema sinfonico), con un lin-
guaggio ed una forma complessi, e che pongano gli esecu-
tori davanti a problematiche tecniche e interpretative affini
a quelle che si possono incontrare nel repertorio contem-
poraneo per professionisti.
Il mio obiettivo a lungo termine è di arrivare a creare un
repertorio d’autore per le orchestre di scuola media (o più
in generale “di giovani esecutori”), formazioni per certi versi
paradossali e sbilanciate, limitate spesso a sole quattro tipo-
logie di strumenti, anzi in prevalenza composte da qualche
violino, decine di flautisti, decine di chitarristi, file di piano-
forti (che necessariamente diventano tastiere elettroniche),
assenza di altri strumenti.
L’idea è stata quella di provare ad usare i limiti dell’orchestra
di scuola media come un punto di forza: non un’orchestra
vera e propria, ma un complesso “strumento collettivo”, in-
capace di produrre alcuni suoni (come ad esempio i suoni
�67

audiation n.02/2016 pedagogia
bassi) ma in grado di produrne altri (compresi alcuni timbri
“inimitabili”, come gli unisoni stonati, che possono comun-
que essere usati in modo espressivo…); e quindi mettere in
relazione questo “strumento” con un ensemble di profes-
sionisti incaricato di produrre gli altri suoni e le parti virtuo-
sistiche. Come nel dualismo concerto grosso-concertino
della tradizione barocca. Non musica “per bambini” o “per
ragazzi”, ma musica “con bambini” e “con ragazzi”, che abbia
– perché no – la dignità di poter essere eseguita in una sta-
gione. Forse un sogno, ma continuo a crederci.
!Ci sono anche altre motivazioni che mi hanno spinto a
comporre questi pezzi.
Per esempio quella di dare a giovani e giovanissimi la pos-
sibilità di lavorare per una volta su un vero palcoscenico di
un vero teatro, insieme a persone che nella vita svolgono la
professione di musicista. In sostanza, far provare loro l’espe-
rienza del far musica da professionisti, in un momento in
cui sempre meno persone scelgono gli studi musicali. In
questo modo si acquista la consapevolezza dei ruoli e delle
professionalità: dall’esecutore, al direttore d’orchestra, al
compositore.
C’è poi una motivazione non strettamente musicale, che
consiste nell’utilizzare lo studio della musica come un vei-
colo per trasmettere contenuti extramusicali, come quelli
connessi ad esempio alle problematiche sociali, o ai diritti
umani, o per parlare di culture e tradizioni diverse.
Infine c’è la motivazione – per me non secondaria – di uti-
lizzare la musica scritta appositamente per queste bizzarre
compagini orchestrali, come un mezzo per introdurre i ra-
gazzi ai linguaggi e alle tecniche della musica contempora-
nea, e abituarli a sviluppare un interesse e una curiosità per
forme d’arte più complesse e articolate rispetto a ciò che
viene loro proposto dai media.
!
In questi progetti ho avuto la conferma che la complessità e
la difficoltà non spaventano affatto i bambini. Spaventano
forse un poco i ragazzi più grandi, spaventano sicuramente
molto gli adulti.
Per i giovani, abituati ad assumere dosi massicce di “suono
organizzato” di ogni tipo da una molteplicità di media, dai
film ai videogames, dai telefoni ai nuovi gadget digitali, tro-
varsi a dover fare musica usando qualsiasi tipo di suono
(per esempio utilizzando strumenti insoliti come i “tubi cor-
rugati” degli elettricisti, o le cosiddette tecniche strumentali
avanzate) è un passo molto breve e tutto sommato natura-
le. Un po’ più complicato forse il confrontarsi con durate e
forme musicali estese, visto che la maggior parte dei brani
musicali a cui ha accesso un giovane difficilmente superano
i 4 minuti (anche i brani didattici non si discostano da dura-
te brevissime). Ma posso affermare con sicurezza che i ra-
gazzi e i bambini si adattano molto rapidamente alle novità,
e superano senza problema tutte le difficoltà.
!Nelle mie opere per giovani esecutori ho cercato di affron-
tare ogni volta un aspetto diverso, l’uscita dal sistema tona-
le, la poliritmia, la composizione con suoni concreti, sistemi
scalari alternativi al modo maggiore e minore (per esempio
utilizzando modi mutuati dalla musica popolare o il modo
ottatonico). Nell’esperienza che ho vissuto nel 2014 a Lam-
pedusa ho provato a comporre insieme ai bambini, fa47 -
cendo ricavare direttamente a loro le strutture ritmiche che
poi ho impiegato nella composizione “Luna Lunedda”, per
coro, banda, percussioni e quintetto di fiati professionista.
Osservando le reazioni dei bambini si è fatta via via più for-
te la tentazione di fare un “salto quantico”: non più scrivere
musica da far eseguire ai giovani esecutori, ma far scrivere
la musica direttamente a loro.
!
�68
Il progetto “Le nuove vie dei canti”, ideato da Guido Barbieri, si è svolto a Lampedusa durante il 2014, concludendosi il 5 ottobre 2014 con uno 47
spettacolo itinerante che ha coinvolto circa 250 bambini e ragazzi dell’isola, insieme alla Banda Lipadusa e a un grande numero di artisti tra cui il Quintetto Papageno, la violista Danusha Waskiewicz, il violoncellista Alfredo Mola, l’attore Mario Perrotta insieme a diversi attori del Teatro dell’Argine, i percussionisti Fulvia Ricevuto e Antonio Caggiano, i direttori di coro Gianluca Ruggeri e Anna Di Baldo.

audiation n.02/2016 pedagogia
Dunque, “composizione per non musicisti”, o quantomeno
per non compositori. Il problema è prima di tutto di ordine
tecnico. Per scrivere musica, oltre a saper (in teoria) scrivere
le note, è inevitabile doversi destreggiare tra un numero
incredibilmente alto di tecniche diverse: le tecniche stru-
mentali, il contrappunto, l’armonia, l’organizzazione forma-
le, problemi di notazione, etc. Spesso neanche musicisti di
professione posseggono le competenze necessarie ad af-
frontare la scrittura in partitura.
Ma cosa succederebbe se fosse possibile eliminare improv-
visamente tutti i problemi tecnici? In teoria chiunque po-
trebbe dare sfogo alla propria vena creativa, comporre con-
certi e sinfonie. Con quali risultati?
!L’idea, apparentemente un po’ strampalata, mi è venuta da
questa considerazione: i bambini, già a quattro o cinque
anni, sono perfettamente in grado di elaborare storie com-
plesse, piccole drammaturgie, raccontare avventure elabo-
rate; e quando giocano imbastiscono delle vere e proprie
sceneggiature, con dialoghi, situazioni, personaggi.
Quando iniziano a scrivere, ecco l’improvvisa regressione: si
deve ripartire dal “pensierino”, da “oggi splende il sole”, sog-
getto e predicato, in qualche caso complemento oggetto…
Questo perché il bambino che si accinge a scrivere si scon-
tra con il problema dei problemi, la tecnica. La poiesis, per
potersi compiere, necessita inevitabilmente della tèchne. E
l’apprendimento della tecnica è lento e faticoso, in una pa-
rola: difficile.
Ma se io mettessi a disposizione del bambino uno scrivano,
che sotto dettatura trascriva fedelmente (magari anche
correggendo eventuali strafalcioni) il testo orale del bambi-
no, il problema sarebbe risolto, il bambino potrebbe sentirsi
libero di raccontare quello che vuole, di pensare in grande.
In musica può essere la stessa cosa? Secondo chi scrive sì.
Sviluppare un pensiero compositivo non è in fondo così
diverso da immaginare una piccola storia, una breve sce-
neggiatura, e qualsiasi bambino o ragazzo è in grado di
immaginarsi per esempio un inizio di un film.
E, dato che la musica occidentale è quasi sempre assimilabi-
le ad una drammaturgia, immaginare una piccola dramma-
turgia fatta di suoni non dovrebbe essere cosa impossibile.
!L’occasione per sperimentare e verificare sul campo queste
intuizioni si è materializzata grazie ad un progetto sostenu-
to dal MIUR, intitolato “La musica, il lavoro minorile e il dirit-
to all’istruzione”, svoltosi durante l’anno scolastico 2013/14.
L’iniziativa prevedeva una parte sperimentale, dove gli stu-
denti – in seguito ad un workshop di approfondimento sul
tema del lavoro minorile – dovevano elaborare una partitu-
ra grafica che un compositore professionista (in questo caso
chi scrive) avrebbe poi convertito in una partitura sinfonica
tradizionale. La composizione ottenuta è stata poi eseguita
al Teatro Manzoni di Bologna il 16 aprile 2015 dalla Filar-
monica del Teatro Comunale diretta da Carlo Tenan.
Il processo di conversione dallo stato di progetto/partitura
grafica a quello di partitura notazionale vera e propria, è
quello che definisco “rendering”.
Il rendering è di fatto un modo di fissare il pensiero creativo
di un analfabeta.
Ovviamente, perché l’operazione abbia senso, il composito-
re professionista deve porsi completamente al servizio del
vero autore del progetto (l’alunno), deve in qualche misura
annullarsi, per sopravvivere solo in qualità di tecnico che
risolve i problemi compositivi e di orchestrazione, deve in
altre parole trasformarsi nel “motore di rendering”. È altresì
inevitabile che il motore di rendering, in quanto non mac-
china ma essere umano, metterà comunque qualcosa di
suo nella partitura (tracce stilistiche, gesti caratteristici, ar-
monie), ma questo va messo in conto, fa parte dell’opera-
zione. Cambiando il motore di rendering, ovvero sostituen-
do il compositore con un altro, si ottiene di conseguenza
una partitura differente, ma originata dal medesimo pro-
getto compositivo, dalla stessa organizzazione formale,
dagli stessi segni espressivi della partitura grafica. Un corol-
lario potrebbe essere proprio l’affidare lo stesso progetto a
differenti compositori e vedere come la stessa idea possa
giungere ad esiti completamente diversi, pur rimanendo
�69

audiation n.02/2016 pedagogia
concettualmente fedele a se stessa. Un po’ come fece Dia-
belli con il suo piccolo valzer, all’origine delle celebri “33
Variazioni” di Beethoven..
!La sperimentazione si è svolta con i ragazzi delle scuole
superiori di Bologna che aderivano al progetto di orchestra
giovanile “Musicalliceo”, e si è articolata in tre fasi preparato-
rie, più una fase esecutiva.
!1. La prima fase consisteva nel familiarizzare il ragazzo con
il concetto di “partitura grafica”, attraverso ascolti anali-
tici di musica tratta dal repertorio classico e contem48 -
poraneo. La partitura grafica è una partitura d’ascolto,
una schematizzazione a posteriori dei tratti identificabi-
li attraverso l’ascolto anche ripetuto di un brano musi-
cale. Spesso assomiglia ad uno “storyboard” della com-
posizione, in cui (semplificando un po’) la storia raccon-
tata è la “forma” musicale del pezzo.
2. Nella seconda fase è stato chiesto ai ragazzi di provare a
creare un loro primo “storyboard”, molto semplice, in cui
provare ad organizzare delle idee musicali, indipenden-
temente da limiti strumentali, da stili e linguaggi. Prova-
re a giocare con l’idea di costruire attraverso i suoni.
3. Nella terza fase si è passati al cuore della sperimenta-
zione, il progetto sinfonico vero e proprio. In questa
fase è risultata fondamentale l’attività svolta nei work-
shop precedenti, sul tema dello sfruttamento del lavoro
minorile. Tali workshop, condotti utilizzando la metodo-
logia “S.C.R.E.A.M.” hanno suscitato nei ragazzi una 49
grande quantità di reazioni, di idee, di riflessioni. È stato
loro chiesto di provare a immaginare come una di que-
ste idee potesse in qualche modo essere messa in mu-
sica, senza porsi nessun limite. Il progetto più compiuto,
intitolato “Gioco di Società”, del sedicenne Francesco
Spina (studente del Liceo Classico Galvani), è stato scel-
to per il rendering, e di questo è stata realizzata una par-
titura grafica sufficientemente dettagliata per poter
procedere.
4. La quarta fase è quella propriamente esecutiva, in cui
ha luogo il rendering vero e proprio. La partitura grafica
di Spina è stata trasposta in una partitura orchestrale
dal compositore professionista – cioè il sottoscritto –
sempre in stretto contatto con il giovane compositore,
e poi “materializzata” nell’esecuzione dell’orchestra di
professionisti.
!!Una delle cose che mi porterò sempre dentro, è l’espressi-
one di stupore apparsa sul volto del giovane Spina nel
momento in cui l’orchestra ha cominciato a suonare qual-
cosa che fino a quel momento era esistita solo come idea
più o meno definita nella sua immaginazione, alla quale
come mi scrisse “non aveva voluto porre limiti”.
L’approccio incoraggiato è stato infatti di totale libertà,
pensare in grande. Immaginare di essere degli architetti, e
di sognare una costruzione, anche la più folle, senza preoc-
cuparsi dei calcoli strutturali, della statica, dei materiali.
Pinnacoli obliqui, pareti liquide, ponti di foglie. Di tutti que-
sti problemi si incaricheranno poi gli ingegneri e i capoma-
stri gentilmente messi a disposizione dall’iniziativa.
Quest’ultimo è per certi versi il punto critico di un progetto
di questo tipo. Come si può facilmente capire, l’operazione
ha dei costi non trascurabili. Il progetto risulta veramente
efficace se compiuto in tutte le sue fasi, e ovviamente ren-
�70
Sulla didattica dell’ascolto si veda ad esempio: G. La Face, Testo e musica: leggere, ascoltare, guardare, in «Musica Docta. Rivista digitale di 48
Pedagogia e Didattica della Musica», II, 2012 e C. Cuomo, Il linguaggio della musica. Didattica dell’ascolto su un ‘Minuetto’ di J.S.Bach, «Innovazione educativa», n.3-4, marzo-aprile 2006.
La metodologia S.C.R.E.A.M (Supporting Children Rights through Education, the Arts and the Media) è stata sviluppata all’interno del programma 49
educativo dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro (ILO), l’agenzia delle Nazioni Unite che ha il mandato di promuovere la giustizia sociale e i diritti e i principi fondamentali nel lavoro. Maggiori informazioni sul sito dell’ILO: http://www.ilo.org/ipec/Campaignandadvocacy/Scream/lang--en/index.htm

audiation n.02/2016 pedagogia
�71

audiation n.02/2016 pedagogia
�72

audiation n.02/2016 pedagogia
�73
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
��������
������
������
������
������������������
������������������
���������
�������������
�������������
�������������
���������������
���������������
�������
����������
����������
��������
���������
����
��������
������������
��
���
��
������ �� �!"
��� �� � �� �
��� �� � ������ �� �
���
��� ������
���
��� �� � ���
��
��� �� �
������
��� ��
���
��
� ������ ��
��� �� � ������
�����
������ ��� ��
��� ��
��� ��
��� �� � �� ��
���
������ ��
��
��
��
��
���
���
������� � ������ ��
�� �!"
��� ��� ������� � ������ ��
���
��� ������� � ������ ��
���
��� ������� �
������
��
��� ��� ������� � ������ ��
��� ��� ������� � ������ ��
��� ��� ������� � ������ ��
���
���
�������
�������
��
��� ��� ������� �
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
#���
� �
$��%������%�������&��'���(�
������%��������)
�������������������%�����������������
�
� �
�
� �
�
� �
�
� �
#���
�
� �
#���
�
� �
�
� � �
�
� �
#���
�
� �
#���
�
� �
#���
�
� � �
#���
�
� � �
�
�����������������������������������
� � �
�
� �
������
�
���������
� � �
�
���������%��� �
� � � � � �
�
%��
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
%��
"
�
�
� �
�
"
�
� �
�
%��
�
�� �
��
� ��
�
�
�
�
%��
�� �
�
�
�
�
�
�
�
%��
�
�
�
�
� ���
�
���
�
���
�
�
� � �
� �
� � � �
� �
�
�
���
�
� � �
��
�
��
�
�
�
�� �
�
� �
� � �
� �
�
��
�
�
�
� �
�
� �
�
�
� ��
�
� �
� �
� �
�
� � �
��
�
�
� �
�
�
� ��
�
� �
��
�
�� �
�
� �
�
�
���
��
���
�
�
�
�
��
� �
� �
�� �
� � �
�
�
���
� �
���
�
�
�
�
�
� �
� �
��
� �
�
�
�
�
�
�
�
� �
� �
�
�
��
�
� �
�
� � �
� �
� � �
� �
�
� � �
��
�
���
�
���
�
� � � �
�
� �
� �
� �
�
� � � � �
���
�
���
�
� � �
�
�
� � � �
��
�
� � �
� �
�
�
�
� �
���
����
� � � �
� �
�
�
� � � �
���
�
���
�� � �
� �
�
�
�
���
��
���
�
�
� � �
��
�
�
�
�
� � ����
�
���
�
���
��
� ��
� �
�
�� �
�
�
�
�
��
� �
�� �
���
�
���
�
���
��
� � � �
�
�
��
�
�
� �
� � ���
� �
���
�
���
� � � �
� �
�
�� �
�
� ��
� �
� � ���
� �
���
�
���
� �
� � �
�
�
��
�
���
�
�
� �
�� �
���
� �
�
���
�
��
���
�
� �
�
�
�
� �
�
� �
�
��
�
�
���
� �
� �
���
� �
�
���
�
��
���
�
� �
�
�
�
� �
�
�
�
��
�
��
�
��
� �
�� �
���
��
���
�
�
���
�
�
��
�
� �
� �
�
��
�
��
�
�
�
�� �
���
�
�
���
�
�
���
�
�
�
�
�
�
�
� �
�
��
�
�
�
�
�
�
�� �
���
�
�
���
�
�
���
�
�
�
�
�
�
��
�
�
�

audiation n.02/2016 pedagogia
�74

audiation n.02/2016 pedagogia
dering e un teatro hanno dei costi importanti. Certamente i
costi possono abbattersi drasticamente se al posto di un’or-
chestra si usa un ensemble ridotto, ma è chiaro che l’orch-
estra è la vera soluzione se vogliamo che il ragazzo o il
bambino possa esprimersi in totale libertà, e se vogliamo
(ma lo vogliamo veramente tutti?) che i ragazzi scoprano
cosa significa il suono dell’orchestra, il suonare insieme,
l’espressione “a colori” di un pensiero musicale. I costi diven-
terebbero sostenibili se il progetto però fosse adottato da
una fondazione, e rientrasse nella normale programmazio-
ne. Chiaramente, per una scelta di questo tipo sarebbe ne-
cessaria una certa dose di coraggio da parte delle direzioni
artistiche.
!Un’ultima considerazione.
A Bologna l’esperimento è stato compiuto su adolescenti
liceali, ma sono sicuro che i risultati sarebbero ancora più
sorprendenti con bambini più piccoli.
I bambini e i ragazzi devono solo scoprire che quello che
viene loro richiesto è un qualcosa che forse inconsapevol-
mente fanno già. Vanno semplicemente guidati alla scoper-
ta di qualcosa che è sotto i loro occhi (e le loro orecchie). E
contemporaneamente alla scoperta di qualcosa di cui non
sospettavano minimamente l’esistenza.
!
�75


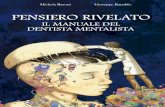





![Facoltà di Architettura | Il Futuro è passato qui · [modello: Le Corbusier, Villa Savoye] L’esplosione dello spazio Il Pittoresco come processo compositivo Il montaggio: inquadrature](https://static.fdocumenti.com/doc/165x107/603854f510d52031fa1baff8/facolt-di-architettura-il-futuro-passato-modello-le-corbusier-villa-savoye.jpg)










