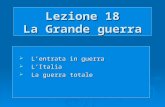ECONOMIA: LA GUERRA FA BENE SE È «INFINITA» · PDF filesi, della guerra in...
Click here to load reader
-
Upload
truongquynh -
Category
Documents
-
view
212 -
download
0
Transcript of ECONOMIA: LA GUERRA FA BENE SE È «INFINITA» · PDF filesi, della guerra in...

La seconda guerra nel Golfo, dopoquella del 1991 di Bush sr., si èsvolta e «risolta» rapidamente. In-frangendo la legalità internazio-nale, distruggendo l’unità dell’Eu-ropa, gettando l’Iraq nel caos,creando le premesse di disordinifuturi. In quel che segue, avanzoalcune considerazioni schemati-che e preliminari, tutto meno checomplete, sugli aspetti strettamen-te economici che stanno dietro l’ul-timo conflitto. Un’ottica certo par-ziale, ma indubbiamente rilevan-te.
I costi della guerra
Cominciamo dalla questione dei«costi» della guerra. Non vi sonostati molti studi, ma alcuni sì, e diindubbio interesse. In settembre,Larry Lyndsey, al tempo consiglie-re di Bush, previde un costo diret-
to tra i 100 e i 200 miliardi di dol-lari. Fu smentito il giorno dopodall’Amministrazione, e in seguito«dimesso». Le stime del costo diret-to della guerra prodotte successi-vamente dal Congressional BudgetOffice prevedevano un costo piùmodesto, tra 22 e i 29 miliardi. Piùsostenuta la bolletta secondo lostudio dell’opposizione democrati-ca, il Democratic Staff of the HouseBudget Committee, che la valutavatra i 31 e i 60 miliardi. Il Center forStrategic and International Stu-dies si è collocato su una stima in-termedia, 44 miliardi. Un successi-vo articolo di William D. Nordhaus,comparso sulla New York Review ofBooks (Iraq: The Economic Conse-quences of War, 5 dicembre 2002) eche sintetizza uno studio più cor-poso presente sul web, si è tenutosu cifre decisamente più alte e com-patibili con quelle di Lindsey, cioètra i 50 e i 140 miliardi.
L’interesse della ricerca diNordhaus sta soprattutto nel fattoche essa ha giocato su uno spettropiù ampio. Ha cioè cercato di valu-tare anche i costi indiretti.Nordhaus ha messo a confrontodue stime: una «ottimista» (guerrabreve, e di rapido successo), l’altra«pessimista» (guerra protratta,sfavorevole agli Usa), tenendo con-to non soltanto della spesa milita-re ma anche degli esborsi per l’oc-cupazione e il peace-keeping, la ri-costruzione, e l’assistenza umani-taria, come anche dell’impatto suimercati petroliferi e del rischio direcessione. Tutti costi che gli altristudi non consideravano, e cheavrebbero fatto salire le spese trai 121 e i 1595 miliardi nei due casi:i soli costi a carico del bilancio del-lo Stato oscillavano tra i 106 e i 615miliardi. È chiaro che la rapida ri-soluzione del conflitto ha fattoscomparire una serie di variabili
ECONOMIA: LA GUERRA FA BENE SE È «INFINITA»
Riccardo Bellofiore
Una guerra breve e circoscritta come quella irachena non serve a rivitalizzare l’economia. Diverso il discorso se la guerra è «infinita».
La questione del petrolio: aspetti geopolitici e finanziari.Le prospettive del dopoguerra e i prezzi che gli Stati Uniti potrebbero pagare.
Osservatorio

che potevano far salire i costi di-retti del conflitto nei vari scenari:come l’impiego di armi biologiche echimiche da parte dell’Iraq, un at-tacco ad Israele, una crisi in Tur-chia e Arabia Saudita, una ripresadel terrorismo, e così via. D’altrocanto, il caos determinato dal col-lasso dello Stato-nazione irachenopotrà far esplodere molte voci al dilà di quanto non fosse stato origi-nariamente valutato da tutti gliesperti.
Nel calcolo di Nordhaus rien-trano, come si è detto, stime sulleconseguenze del conflitto relativeall’impatto sui mercati petroliferie agli effetti macroeconomici. Al-cuni di questi fattori sono staticonsiderati anche da altri studi.Attualmente, la quota dell’Iraq sulmercato petrolifero mondiale èmolto bassa (3%), ma si ritiene ge-neralmente che la domanda di oronero sia molto poco elastica. Inquesto campo, le previsioni sulleconseguenze della guerra variava-no in un arco che andava da unaipotesi «pessima» (guerra prolun-gata) con prezzi a 60 dollari al ba-rile nel 2003 e 40 nel 2004, a unaipotesi «intermedia» (guerra velo-ce ma con molti morti, e messa fuo-ri gioco del petrolio iracheno per al-meno 6 mesi) di 37 dollari nel 2003e 30 nel 2004, a una ipotesi «beni-gna» (quella che si potrebbe rite-nere verificata) che si colloca sui 26dollari nel 2003 e 22 nel 2004.
Nordhaus era, come partedell’opinione pubblica «democrati-ca», contro la guerra: in questocaso, anche per ragioni, come si di-ceva una volta, materiali. Non ser-
virebbe più a rivitalizzare imme-diatamente l’economia, innanzi-tutto. Lo avrebbe dimostrato pro-prio la guerra del 1991, quando laspesa militare crebbe di solo lo0,3% del Pnl, e dopo la quale l’eco-nomia statunitense entrò in unarecessione tra le più serie dallafine del secondo conflitto mondiale(per avere un termine di paragone,la seconda guerra mondiale ebbeun impatto sulla crescita della spe-sa militare del 41,4%, la guerra diCorea dell’8%, il Vietnam del-l’1,9%). L’impatto macroeconomi-co negativo verrebbe insomma perlui prevalentemente dal petrolio.Ma sarebbe significativo. La guer-ra, inoltre, avrebbe aggravato il di-savanzo, che già corre per contosuo. In solo un anno e mezzo lanuova maggioranza conservatriceha cancellato l’avanzo di 300 mi-liardi lasciato da Clinton, man-dando in rosso le casse dello Statoper almeno altrettanti; e a conflit-to iniziato Bush jr. ha ottenuto dalCongresso altri 75 miliardi specifi-camente dedicati alle spese diguerra. Per Nordhaus, un ulterio-re elemento da considerare sareb-be anche stato, e crucialmente,l’incertezza accresciuta in una faseancora di recessione.
Le tesi di Nordhaus sono sta-te in sostanza riprese dal premioNobel Joseph Stiglitz, in un edito-riale tradotto per il Corriere dellasera all’inizio di gennaio. Il suo ar-gomento era il seguente: la guerrain Iraq, al contrario della secondaguerra mondiale, che fece uscire ipaesi capitalistici dalla grande cri-si, della guerra in Corea e di quel-
la nel Vietnam, coinvolgerebbe re-lativamente pochi uomini per pocotempo, e impegnerebbe poche ri-sorse. Più rilevante, in senso ne-gativo, sarebbe appunto l’aumentodell’incertezza indotto dal conflit-to, sia sui consumi e gli investi-menti, sia sul prezzo del petrolio.Anzi, la guerra potrebbe, per il suoimpatto sui disavanzi, far scoppia-re una grande deflazione, perché sisommerebbe alle sciagurate politi-che di Bush jr. di riduzione delletasse a favore dei ricchi, conge-gnate in modo tale da generarescarsi effetti espansivi. In un qua-dro, peraltro, di assenza di aiuti aibilanci dei singoli Stati, già de-pressi per la caduta delle entratedovuta alla crisi degli ultimi anni.La guerra potrebbe essere il colpodi grazia.
È evidente che c’è però unacontraddizione nel ragionamentodi Nordhaus e di Stiglitz, e unacontraddizione non tolta dall’esitodel conflitto favorevole agli StatiUniti – una contraddizione chevale la pena segnalare pur volendotrascurare l’ipotesi, tutt’altro cheperegrina, che la coalizione anglo-americana possa incontrare qual-che difficoltà più seria a vincere lapace in Iraq che la guerra con Sad-dam. Se è vero che una guerra«breve» ha capacità di trainodell’economia statunitense ridot-te, le sue ricadute sulle altre va-riabili sarebbero comunque tolle-rabili. Ma se la guerra sarà invece«infinita» – non questa guerra sol-tanto, insomma; ma l’insieme degliinterventi preannunziati per iprossimi venti-trent’anni nella
38Riccardo Bellofiore

guerra alle «forze del male» e agli«Stati-canaglia» – i fasti del com-plesso militare-petrolifero potreb-bero rinverdirsi, come di fatto giàsta avvenendo. Lo spostamento delfuoco dei neoconservatori statuni-tensi verso la Siria, neanche chiu-sa la guerra in Iraq, conferma que-sto ragionamento.
Chi paga?
Se le cose stanno così, le variabilida considerare sono almeno sei: a)il peso del settore militare nell’eco-nomia degli Stati Uniti; 2) chi pagail costo della guerra, e chi ci puòguadagnare; 3) la questione delprezzo del petrolio; 4) il legame trafinanza e petrolio; 5) le contraddi-zioni tra Europa e Stati Uniti; 6)l’instabilità geopolitica.
Sul fatto che le spese milita-ri Usa dopo l’11 settembre stianocrescendo in modo straordinarionon vi è dubbio, come è stato docu-mentato con precisione sulla rivi-sta Guerre e Pace negli ultimi nu-meri. Nel 2001 il bilancio per gliarmamenti era, sempre in miliar-di di dollari, di 307; nel 2002 è sa-lito a 339; nel 2003 Bush jr. lo vo-leva portare a 379, ma in realtàaumenterà di più per gli ultimistanziamenti: ci aggiriamo su unaumento di circa 150 miliardi didollari in soli tre anni, cioè di cir-ca la metà della cifra di partenza.Ma già nella tabella di marcia ini-ziale si trattava solo dell’antipa-sto, visto che nel 2007 si volevanoraggiungere i 451 miliardi, conuna spesa totale tra il 2002 e il
2007 di 2.144, che rischiano di es-sere ovviamente sfondati versol’alto. Uno sforzo del genere, che èstato già preso a pretesto per taglinella spesa sociale – tanto più perla presenza del disavanzo prodottoda Bush: ma sia chiaro, il proble-ma non è il disavanzo, quanto lapessima qualità della spesa, el’inefficacia a stimolare l’economiadei tagli fiscali – può influire po-tentemente su livello e composizio-ne del reddito nazionale. E d’al-tronde la crisi attuale sarebbe sta-ta ben più grave senza la politicafiscale attiva dello Stato-nazioneUsa, che si è affiancata alla ormaiinsufficiente politica monetariaespansiva della Fed.
Per quel che riguarda chipaga, e chi potrebbe guadagnaredalla guerra in Iraq, il quadro almomento tutto è meno che chiaro.Si può allora provare a ricordarequello che è avvenuto nel prece-dente conflitto del 1991. Il costo fudi circa 60 miliardi di dollari, maesso fu coperto soltanto parzial-mente dagli Stati Uniti: per il re-sto dagli alleati, e in particolare daArabia Saudita e Kuwait. Non èdetto che anche questa volta non sifaccia pagare in termini analoghiad altri un qualche ruolo ex postdell’Onu e/o di altri paesi non par-tecipanti o addirittura ostili al con-flitto, come condizione per poterpartecipare al banchetto della ri-costruzione dell’Iraq. Nel 1991,poi, l’incertezza e le stesse distru-zioni di impianti petroliferi legateal conflitto fecero salire notevol-mente il prezzo del petrolio, da 15a 42 dollari al barile, per qualche
tempo. Le rendite petrolifere «ec-cezionali» furono spartite tra i pae-si produttori e le compagnie petro-lifere, che sono in parte (non tutte)statunitensi. Sicché, allo Stato e aiprivati statunitensi si può stimaresia «tornata» una qualche fetta si-gnificativa delle maggiori entrate.Senza contare, ovviamente, i gua-dagni dell’industria militare,anch’essa in larga parte statuni-tense. E senza tener conto, ancora,degli interessi di ditte statuniten-si nella ricostruzione – qualcosa sucui la stessa stampa economica in-glese e statunitense sta iniziandoa dare informazioni preoccupate, esu cui esistono interrogazioni alCongresso Usa per il coinvolgi-mento diretto di imprese legate auomini dell’AmministrazioneBush al massimo livello. Ci sareb-be poi da considerare quanto delcosto della guerra non sarà fattopagare sulle entrate future dellostesso petrolio iracheno. Il bilanciocosti-benefici della guerra sarà in-somma da fare un qualche tempodopo l’evento, anche perché non è,questa volta, chiaro in anticipo chipossa esser chiamato a contribuirealle spese: ma il consuntivo po-trebbe riservare sorprese rispettoalle previsioni attuali.
Credo sia anche scorretto at-tribuire alla prima guerra delGolfo le gravi difficoltà dell’econo-mia statunitense nel 1991-1992,come fanno Nordhaus e Stiglitz.Peso ben maggiore ebbero le crisi ei fallimenti di numerose banche edi intermediari finanziari, con laconseguente penuria di credito checolpì gli investimenti privati. Nel
39 osservatorio

40
medesimo periodo la Riserva fede-rale, temendo a torto una vampa-ta inflazionistica, peggiorava lecose restringendo i cordoni dellaborsa. L’effetto negativo principa-le della guerra fu una temporaneacontrazione dei consumi privatiper l’effetto negativo sulle aspetta-tive.
Petrolio
Passiamo al nodo del petrolio. Noncredo che vi sia il rischio di un au-mento permanente e rilevante, nellungo periodo, del prezzo decisodai paesi mediorientali dell’Opec.Si registra, certo, come sempre,una fiammata speculativa nell’im-minenza della guerra, che si per-petuerà per qualche tempo duran-te il conflitto, e che sarà più o menoduratura e grave a seconda del suoandamento. Ma sarà seguita dinuovo, come dopo il 1979-1980, daun contro-shock al ribasso: in que-sto caso qualcuno stima addirittu-ra che esso possa portare l’oro neroa 5 dollari al barile – una ipotesi,come dirò, poco probabile. Si devetenere conto che l’Iraq del dopo-guerra non soltanto tornerà piena-mente sul mercato, da cui adesso ètagliato fuori in gran parte, ma an-che che sarà costretto, per le esi-genze della ricostruzione e per ilpagamento dei debiti di guerra cheprobabilmente gli verranno impo-sti, a far crescere la sua offertaquotidiana da due milioni e mezzodi barili al giorno a tre volte tanto.Anche se vi è chi, come Daniel Yer-gin, sostiene che portare l’offerta
irachena a 3,5 milioni di barili algiorno è possibile solo nell’arco ditre anni, e che farla arrivare a 5,5milioni sarà possibile solo entro il2010.
Per mio conto, non penso chegli Stati Uniti abbiano interesse aprezzi troppo bassi del petrolio.Hanno da tempo messo le manisulle riserve di petrolio del Cauca-so, al momento però di scarsa con-venienza da estrarre, tra l’altro,proprio per i bassi prezzi attuali (leriserve sono stimate tra gli 85 e i195 miliardi di barili, cioè tral’1,5% e il 2% delle riserve globali).Giocano anche i loro interessi im-mediati di produttori. Come ancheil fatto di non essere i più danneg-giati tra le grande aree capitalisti-che dal rincaro dell’oro nero. Pertutte queste ragioni, un aumentofuturo non sarebbe per loro soltan-to una cattiva notizia. Controllareun prezzo moderatamente cre-scente significa rendere profittevo-li – dopo un lungo periodo di «vac-che magre» durato dalla metà de-gli anni ottanta sino alla metà de-gli anni novanta – giacimenti pocosfruttati sinora, costi di trasportocrescenti, e così via.
Il punto che giustifica il con-flitto, sempre legato al petrolio,non è insomma il prezzo, è un al-tro. L’Iraq, si dice, è il secondo pae-se mondiale per riserve di petrolio(stimate al momento come l’11% diquelle mondiali: 112 miliardi dibarili contro i 262 miliardidell’Arabia Saudita). Anzi il pri-mo, se si contassero le riserve sco-perte del deserto occidentale, sti-mate dal Dipartimento dell’ener-
gia degli Stati Uniti a 220 miliar-di di barili (le stime degli analistioscillano in genere in una forchet-ta che va dai 150 ai 250 miliardi dibarili). Tutto ciò, evidentemente,non può non interessare gli StatiUniti, che con il 4,6% della popola-zione mondiale consumano il25,5% del greggio mondiale: 19 mi-lioni di barili al giorno su un tota-le di 77 estratti (la recessione haultimamente abbassato un po’questo dato negli ultimi due anni).Controllare quelle riserve è impor-tante anche per altre ragioni, oltreche per definirne il prezzo: consen-te, per esempio, di impedire che sisolidifichi l’intervento in quel-l’area di compagnie russe, france-si e italiane, che si è avuto in que-sti ultimi anni, e che ha fatto mol-ta paura alle compagnie america-ne e inglesi. Come rileva a ragioneSergio Finardi sul manifesto del 7marzo (Guerra, il fine giustifica ipozzi), questa è però soltanto unaparte della storia, forse non la piùimportante. Se lasciamo fuori dalquadro le riserve nascoste nei de-serti dell’Iraq, su cui le stime sonoipotetiche al massimo grado, il se-condo posto nelle riserve mondialiè del Canada (a due passi negliStati Uniti), che nel 2002 ne ave-vano accertate per 180 miliardi dibarili. Si dice che la rilevanza delpetrolio sarebbe accresciuta dalrapido esaurirsi delle risorse, edalla persistente dipendenza delleeconomie capitalistiche oggi dalpetrolio. Nel 1998 il petrolio più ilgas contavano per il 60,7% (di cuiil gas per il 25,7%), non molto dimeno dunque del 1970 (quando in-
Riccardo Bellofiore

sieme contavano per il 64,88%, dicui 19,5% di gas); mentre l’energianucleare è balzata dal 0,1 al 7,4%.Nel 2030 il consumo giornalierodovrebbe raggiungere i 120 milio-ni di barili giornalieri. E da qual-che tempo l’esaurimento dei giaci-menti è più veloce della scoperta dinuovi giacimenti (le ultime rivalu-tazioni verso l’alto delle riserve dipetrolio sono, si deve dire, un po’dubbie, e sembrano più artificicontabili, consistendo spesso dinuove autostime da parte deglistessi produttori, non propriamen-te disinteressate quindi). Ma, insi-ste ancora giustamente Finardi, aquesto ritmo sono garantiti alme-no altri 40-50 anni di consumi cre-scenti: ipotizzare che in un arco delgenere l’orizzonte tecnologico ri-manga inalterato è irragionevole.
In realtà, ancora più impor-tante è controllare i «corridoi» de-gli oleodotti e dei gasdotti che por-tano il petrolio dal Medio Orientee dal Caucaso verso Occidente everso Oriente, sottraendoli all’in-fluenza della Russia o dell’Iran. Ènoto che la scelta tra, e il costo del-le, vie di distribuzione del petrolioe del gasolio sta almeno in partedietro i conflitti nel Kossovo e inAfghanistan: dove molto giocaronogli interessi geopolitici del governoamericano e le strategie di investi-mento delle compagnie petrolifereUsa. La guerra nell’ex-Jugoslavia,in effetti, mise in chiaro la debo-lezza politica dell’Europa e stroncòil tentativo di alcuni paesi del vec-chio continente di rendersi auto-nomi sul piano energetico lungopercorsi alternativi (il corridoio
Balcani - Mar Nero – Caucaso -Asia Orientale). a quelli privile-giati dagli Stati Uniti. La guerra inAfghanistan «miracolosamente»sanzionò poi anni di tentativi sta-tunitensi di rendere praticabile un«corridoio» per loro convenientenel Centro Asia verso l’India oltreche verso la Cina. Basti ricordaregli interessi in quel paese dellacompagnia argentina Bridas e diquella statunitense Unocal (legataa Enron, e quindi a Cheney e Bush)che contrattarono, almeno dal1996-1997, la possibilità di unnuovo transito con i talebani al po-tere. Talebani i quali, sia detto traparentesi, proprio come Bin Ladene Saddam nascono «graditi» agliStati Uniti: in questo, caso, per lasperanza che avrebbero portato or-dine nel caos della guerra feudaletra signori della guerra locali. È dipoco dopo, nel 1998, l’intervista alCongresso degli Stati Uniti del vi-cepresidente della Unocal, JohnMaresca, dove si giustificavano icontatti con i talebani per la ne-cessità di controllare in prospetti-va, tramite la monopolizzazionedell’offerta energetica, lo sviluppocinese. I contatti con i talebani, in-terrotti per qualche tempo, ripre-sero nel 2001, sino a un mese sol-tanto prima dell’11 settembre, efurono conclusi dalla famosa (eprofetica) alternativa posta dairappresentanti degli Stati Uniti di«coprire» l’Afghanstan di un tap-peto di dollari o di un tappeto dibombe. In questi più recenti con-tatti protagonista fu al solito laHalliburton di cui Cheney era sta-to amministratore delegato prima
di entrare nel governo di Bush jr.Insomma: controllare la di-
stribuzione del petrolio mediorien-tale e caucasico significa ben di piùche contribuire a controllare ilprezzo del petrolio soltanto. Signi-fica tenere in pugno chi più degliStati Uniti dipende dal petrolio diquella zona. Il petrolio dell’Opec èpoco più di un terzo del consumomondiale (il 37,3% nel 2002). GliStati Uniti dipendono soprattuttoda Canada, Messico e Venezuela,per almeno due terzi da produtto-ri non-Opec. Europa e Giapponedipendono invece dal Medio Orien-te per il 30% e l’81% rispettiva-mente, mentre gli Usa ne preleva-no soltanto il 15,5%. Sullo sfondo,come si è visto, c’è la Cina, il te-muto gigante economico del XXIsecolo.
Oro nero e finanze Usa
Un quadro completo della questio-ne petrolifera impone peraltro dimettere in piena luce i legamistretti, da sempre ma ancor piùdopo il doppio aumento del 1973-1974 e del 1979 – nel primo deiquali, va ricordato, non fu estraneala mano nascosta degli Stati Unitidi Nixon e Kissinger, come chiari-scono le memorie di quest’ultimo;e forse ebbe un qualche peso l’esi-genza di creare politicamente unarecessione che iniziasse a regolarele lotte del lavoro e sociali su scalamondiale – con le dinamiche dellafinanza. È su questo molto utile untesto di Joseph Halevi non ancorapubblicato (US Imperialism, Oil
41 osservatorio

and Finance, presentato ad un se-minario del Dipartimento di Scien-ze Economiche dell’Università diBergamo il 24 febbraio), come an-che un articolo recentissimo di El-mar Altvater (La valuta dell’oronero, pubblicato sulla rivista delmanifesto di aprile).
Ricorda Halevi l’interesse dilungo termine degli Stati Uniti alpetrolio mediorientale, che va in-dietro sino all’accordo del 1928 tracompagnie statunitensi, inglesi efrancesi per lo sfruttamentodell’area. Nel 1948, quando si sco-prirono rilevanti giacimenti inArabia Saudita, gli Stati Uniti riu-scirono ad ottenere una concessio-ne esclusiva da quel paese. Ma èdalla metà degli anni settanta cheil circuito finanziario legato al pe-trolio diviene vitale per il paeseegemone, ma in crisi di egemonia.È grazie al riciclaggio dei petro-dollari a Wall Street via Londrache si riesce allora a mantenere lafiducia nel dollaro, quale che sia ilsuo corso (al rialzo o al ribasso sulmercato delle valute). E questo cir-cuito si è mantenuto in vita, ed èessenziale. Per fare solo un esem-pio: l’Arabia Saudita è stata, con ilGiappone, da qualche decenniouno dei più grandi finanziatoriesteri del debito pubblico statuni-tense. E quelle rendite vengonospese prevalentemente per arma-menti di nuovo verso la stessa de-stinazione.
La necessità di un puntelloalla fiducia nel dollaro nasce dalfatto che dalla metà degli anni ses-santa gli Stati Uniti hanno un di-savanzo di bilancia commerciale
con Germania e Giappone, e dallametà del decennio successivo undisavanzo di bilancia commercialetout court. Quest’ultimo, per nondover dar vita ad aggiustamentidrastici, deve essere finanziato daun avanzo nei movimenti di capi-tali, il che è a sua volta anche ne-cessario per poter procedere a in-vestimenti e innovazioni ben al dilà di quanto consenta il risparmiointerno: e quindi anche, ultima-mente, per poter avviare e soste-nere la new economy. E quell’avan-zo, appunto, presuppone una riba-dita fiducia nel dollaro che non puòche essere politica. Ora questo an-coraggio finanziario e politico fini-sce con il dover essere sempre piùdirettamente militare.
Il petrolio dunque – come lastessa incertezza mondiale, e quin-di le stesse guerre (che innalzanola domanda «precauzionale» di ri-serve) – è parte essenziale del mec-canismo che fa del dollaro la mo-neta mondiale, e che sostiene l’ege-monia americana. Il disavanzocommerciale statunitense, che siaggrava ormai da più di un tren-tennio, è «sostenibile» soltanto nel-la misura in cui quel paese includenel proprio circuito finanziario icapitali di tutto il mondo: la globa-lizzazione finanziaria, si sa, è sta-ta in realtà una grandiosa centra-lizzazione dei capitali negli StatiUniti. Il che determina uno statodell’economia internazionale chesempre più costantemente si trovasoggetta ad una poderosa spintaverso la «stagnazione», che contri-buisce a tener su il più possibilel’attrattività dei corsi dei titoli sta-
tunitensi sulle borse. Insomma, ladeflazione sui prezzi delle merciper poter avere l’inflazione deiprezzi sui titoli, e per costringereal tempo stesso il resto del mondoa «volere» esportare negli StatiUniti innanzi tutto merci, ma poianche capitali. Tutto ciò richiedeche sia mantenuto a tutti i costi ilprimato del dollaro, che esso ven-ga dunque comunque domandatodalle altre aree economiche, inparticolare quelle di recente indu-strializzazione o in via di sviluppo(il che chiarisce anche l’interessedegli Stati Uniti a imporre, viaFondo monetario internazionale,la c.d. «dollarizzazione» in un pae-se dopo l’altro).
In quest’ottica, la nuovaguerra in Iraq è stata fatta, oltreche per rinforzare il controllo sul-la «pompa» del petrolio e i suoi«percorsi», anche per rinsaldare ilruolo «finanziario» del petrolio nel-la attuale costituzione del sistemamonetario internazionale. Un ruo-lo a rischio. Entra qui infatti in gio-co uno dei nodi del conflitto di in-teressi tra Europa e Stati Uniti:l’Iraq aveva, da qualche tempo,iniziato a «prezzare» in euro il pe-trolio. Una mossa la cui imitazio-ne doveva essere stroncata sul na-scere, se il ruolo imperiale degliUsa, minato dall’insostenibilitàdella «nuova economia», dovevacontinuare ad essere garantito. Viè qui evidentemente una soltantodelle ragioni del contrasto tra Eu-ropa e Stati Uniti.
Qui si aggiunge l’ultimo fat-tore, l’instabilità geopolitica, percome si declina di questi ultimi
42Riccardo Bellofiore

tempi. Perché, infatti, l’Iraq, e per-ché ora? L’Arabia Saudita è damolti decenni, assieme alla Tur-chia per la sua collocazione geo-grafica, il pilastro principale dellastrategia statunitense nell’area,tanto più dopo la caduta dello Sciàin Iran. Sia nei suoi aspetti diret-tamente petroliferi (la dinastiasaudita possiede il 25% delle ri-serve petrolifere mondiali: con ilKuwait si raggiunge il 45%) che inquelli finanziari.
Geopolitica
L’Arabia Saudita è però diventataultimamente un alleato infido (ba-sti dire che 15 dei 19 attentatoridell’11 settembre vengono di lì) e sitrova in mezzo ad una acerrima elunga guerra di successione. Un al-leato sempre più dipendente dagliStati Uniti, sì, ma sempre più incrisi. Basti qualche ulteriore dato(ripreso da Wildkat-Zirkular n. 64,disponibile in rete). Nel 1981 ave-va riserve in dollari per 100 mi-liardi, ma nel 2000 il suo debito èin dollari di ben 150 miliardi, duevolte il prodotto interno lordo. Lasituazione si va ulteriormente de-gradando, con disavanzi di bilanciopubblico a ripetizione e un debitopubblico in esplosione: il che signi-fica, tra l’altro, che i sauditi hannobisogno di vendere petrolio, co-munque, ma anche che sono statistrangolati dalla lunga stagione diprezzi in riduzione degli anni no-vanta. La stessa situazione socialeè divenuta così sempre più proble-matica. Si tenga presente che da
cinque milioni di popolazioneall’inizio degli settanta si è ormaiarrivati a oltre venti milioni, di cuiil 28% stranieri, con un tasso di di-soccupazione stimato tra il 15 e il20%. A cui consegue, in modo ormaiciclico, una espulsione di immigra-ti e la saudizzazione del numeromaggiore possibile di impieghi. Ciòperò non riesce a risolvere la situa-zione interna ma si limita soltantoa esportare la contraddizione neipaesi vicini, dove la percentuale dilavoratori immigrati è altrettantoelevata (si oscilla dal 25% perl’Oman al 75% per gli Emirati Ara-bi Uniti), ma anche alcuni più lon-tani, come le Filippine (il cui 10%della popolazione lavora nel Golfo,contribuendo con le proprie rimes-se al Pil del proprio paese per l’8%).Tutti paesi, quelli mediorientali, lacui dipendenza dal petrolio è anco-ra del 60% del loro reddito nazio-nale. È su questa polveriera, e sul-la stagnazione del reddito realedell’intera area (bloccato da diecianni a poco più di 6000 dollari perabitante), oltre che sul problemapalestinese, che agisce Bin Laden.L’incertezza dinastica, politica esociale dell’Arabia Saudita, oltreche di tutta l’area, pone anche unproblema immediatamente milita-re agli Stati Uniti, oltre quelli giàricordati. Dai tempi di Reagan esino ad oggi l’area che va dal MedioOriente all’Oceano Indiano è stataimmaginata come il perno di unapresenza militare che ha il compitodi controllare lo spazio geograficoche va dai bordi dell’Europa ai bor-di dell’Est asiatico.
Osama Bin Laden non vole-
va certo buttare giù a colpi di ka-mikaze la new economy, tantomeno difendere gli oppressi delmondo o i palestinesi. Si sa che ilvero obiettivo di Osama Bin Ladenl’11 settembre con i suoi attentatiera piuttosto questo: influire –come ormai pare certo, grazie allacollaborazione, o condiscendenza,o omissione di intervento di partesignificativa dell’Amministrazio-ne politica e militare statunitense– su un cambiamento in ArabiaSaudita che, per il tramite di unasua destabilizzazione, potessesconvolgere l’intera area sinoall’Afghanistan: e in effetti gli Sta-ti Uniti sono stati ultimamente in-vitati da quel paese a smantellarela loro presenza militare. Di qui leesigenze più urgenti per gli StatiUniti: ristabilire l’ordine, prepara-re una alternativa alla possibiledefezione dell’Arabia Saudita o co-munque garantirsi la possibilità dipilotarne la dinamica politica, di-fendere il circuito finanziario lega-to al petrolio nella sua attuale for-ma. E disporre truppe in tuttol’«arco» che va da Israele alla Geor-gia, dall’Iraq al Caucaso, sinoall’Afghanistan, puntato contro ipericoli del domani.
Non è detto però che, para-dossalmente, Bush jr. non si riveli ilmiglior alleato di Osama Bin La-den, visto che l’avventurismo dellasua strategia è sempre più elevato,e i calcoli potrebbero rivelarsi sba-gliati. E vincere la guerra senza vin-cere la pace potrebbe anche avere isuoi costi economici, in una «conta-bilità» più allargata. Impressionan-te la durezza di un commento, a ri-
43 osservatorio

dosso dell’aggressione degli StatiUniti all’Iraq, dell’Editorial pageeditor di Business Week, Bruce Nus-sbaum, contro quella che chiama la«dottrina Bush» (The High Price ofBad Diplomacy, 24 marzo). Non eralì contestata la guerra a Saddam. Loera però l’isolamento diplomatico,la presunzione e il disprezzo unila-
teralista, giudicati nemici della glo-balizzazione e produttori di quel-l’incertezza che è anatema per l’in-vestimento e lo sviluppo. «Un mon-do diviso tra multilateralismo eco-nomico e politiche di sicurezza uni-laterali è un mondo più incerto e ri-schioso, che tutto fa meno che inco-raggiare crescita economica e pro-
sperità». Insomma, Bush avrebbeperso l’ante-guerra. Che vinca ildopo-guerra è tutto da vedere. Ben-ché non vi siano altre potenze ingrado di contrastarlo, potrebberosconfiggerlo, con il tempo, le con-traddizioni della propria economiae della propria politica, e il diffon-dersi della protesta sociale.
44Riccardo Bellofiore