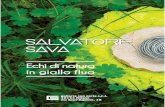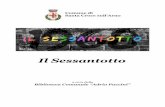ECHI DELLA POLEMICA ANTISIMONIACA NEI SECOLI XI-XII I TRE CODICI DI SANT'APPIANO IN VALDELSA
-
Upload
giuseppe-motta -
Category
Documents
-
view
232 -
download
4
Transcript of ECHI DELLA POLEMICA ANTISIMONIACA NEI SECOLI XI-XII I TRE CODICI DI SANT'APPIANO IN VALDELSA

ECHI DELLA POLEMICA ANTISIMONIACA NEI SECOLI XI-XII I TRE CODICI DI SANT'APPIANOIN VALDELSAAuthor(s): Giuseppe MottaSource: Aevum, Anno 62, Fasc. 2 (maggio-agosto 1988), pp. 198-214Published by: Vita e Pensiero – Pubblicazioni dell’Università Cattolica del Sacro CuoreStable URL: http://www.jstor.org/stable/20858299 .
Accessed: 16/06/2014 08:07
Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at .http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp
.JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range ofcontent in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new formsof scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected].
.
Vita e Pensiero – Pubblicazioni dell’Università Cattolica del Sacro Cuore is collaborating with JSTOR todigitize, preserve and extend access to Aevum.
http://www.jstor.org
This content downloaded from 195.34.79.176 on Mon, 16 Jun 2014 08:07:26 AMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions

ECHI DELLA POLEMICA ANTISIMONIACA NEI SECOLI XI-XII I TRE CODICI DI SANT'APPIANO IN VALDELSA
Nel 1965, in occasione della terza Settimana internazionale di studi medioevali del Passo della Mendola, Cinzio Violante tenne una relazione sui laici nella pataria milanese che ha segnato un momento decisivo negli studi sul piu vivace movimento riformistico a carattere prevalentemente laicale alPinterno della Chiesa durante la seconda meta del secolo XI1. Attraverso una rilettura delle fonti, il Violante individuo, con mano sicura, le motivazioni ecclesiologiche che animarono l'azione dei patarini; tra l'altro, consentendo ad una osservazione proposta in quegli stessi anni dal Mic
coli, ritenne non affatto casuale ?la corrispondenza fra la dottrina di Arialdo e Lan dolfo Cotta e quella di Umberto di Silva Candida a proposito dell'eresia simoniaca, anche perche il passo dello Pseudo-Ambrogio citato insieme con due passi di Grego rio Magno nella predica arialdina a sostegno della teoria antisimoniaca, e fondamen tale pure nel testo delYAdversus symoniacos del cardinale ?2. A conferma di questa corrispondenza tra la dottrina dei capi patarinici e quella del severo riformatore, lo stesso Violante non ritenne ? senza significato, se il nome di Umberto di Silva Candida appaia accanto a quello di Erlembaldo ? oltre che a quelli di papa Nicold II e dei due primi abati di Vallombrosa ? in un necrologio della canonica della pieve di
Sant'Appiano in diocesi di Firenze ?. Alia indicazione del codice laurenziano ? Plut. XIX dext. 5, ff. 163v-165 ? nel quale e trascritto il necrologio, lo stesso medievista, avvalendosi anche di indicazioni avute da Raffaello Volpini, faceva seguire la notizia di altri due codici della medesima canonica di Sant'Appiano, conservati nello stesso fondo laurenziano ? Plut. XIX dext. 8 e XXI dext. 12 ? osservando: ? E molto
significativo ? ai nostri fini ? che tutti e tre contenessero piccole raccolte di canoni
antisimoniache ?3.
Gli studi sulla pataria e sui problemi connessi agli avvenimenti nei quali fu pro tagonista che durante gli anni milanesi del Violante hanno conosciuto una forte
ripresa, non cessano tuttavia di richiamare l'attenzione degli studiosi sia in ordine ad aspetti specifici collegati alle posizioni assunte dai patarini, sia in rapporto agli
1 C. Violante, I laid nel movimento patarino, in I laid nella ? societas Christiana ? dei secoli XI e XII, ? Atti della terza Settimana internazionale di studio (Mendola, 21-27 agosto 1965) ?, Vita e Pensiero, Milano 1968 (Pubblicazioni dell'Universita Cattolica del S. Cuore. Contributi, ser. 3. Miscellanea del Centro di studi medioevali, 5), pp. 597-687; il saggio e stato ripubblicato in Violante, Studi sulla Cristianitd medioevale, Vita e Pensiero, Milano 19722 (Cultura e storia, 8), pp. 145-246. In seguito citero il saggio in questa ristampa che ha avuto notevole diffusione.
2 Violante, / laid, p. 226; il contributo del Miccoli al quale l'autore si riferisce (G. Mic
coli, Per la storia delta pataria milanese, ? Bullettino dell'Istituto storico italiano per il Medio Evo e Archivio Muratoriano ?, 70 (1958), pp. 43-123), e stato poi ripubblicato con qualche cor
rezione e aggiunta in Miccoli, Chiesa gregoriana. Ricerche sulla riforma del secolo XI, La Nuova
Italia, Firenze 1966, pp. 101-167. 3 Violante, / laid, p. 226 n. 287; la citazione dei tre codici va pero corretta nel modo indi
cato nel testo.
This content downloaded from 195.34.79.176 on Mon, 16 Jun 2014 08:07:26 AMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions

POLEMICA ANTISIMONIACA NEI SECC. XI-XII 199
esiti della stessa pataria4. Pertanto, ogni indicazione di nuove testimonianze che pos sano arricchire le nostre conoscenze delle fonti relative a quel movimento e, piu in generale, ai dibattiti che accompagnarono la riforma della Chiesa e della societa nella seconda meta del secolo XI, merita di essere accertata allo scopo di precisarne Forigine, la natura e la consistenza.
E quanto si vorrebbe fare con queste note a proposito dalla indicazione sui tre codici della canonica della pieve di Sant'Appiano, inserita dal Violante nel suo ro busto e ricco contributo sui laici nella pataria milanese. Questa indagine consente di
precisare quali siano veramente i testi che riguardano i problemi della riforma e da
quale ambiente provengano; tra l'altro, il ruolo di Sant'Appiano risulta ridimensio nato ? come si vedra ? in rapporto alle prime impressioni del Violante. In ogni caso, pero, le testimonianze sono preziose, perche provengono da una regione che fu coinvolta, almeno quanto la Lombardia, nelle vicende della riforma del secolo XI5.
Sulla provenienza dei tre manoscritti dalla canonica della pieve di Sant'Appiano non vi sono dubbi; e infatti esplicitamente dichiarata con una nota di appartenenza che si legge
? come gia osservo il Bandini nella descrizione dei codici laurenziani
pubblicata nel 1777 ? all'inizio di ciascun codice, scritta dalla medesima mano e in termini identici: ? Iste liber est plebani Sancti Appiani sub pignore cum quatuor aliis libris fratri Gerardo de Prato ministro Tusciae pro VIII libris florenorum par vorum ?6. Poi, nella seconda meta del Duecento, attraverso il francescano Gerardo da Prato, che fu ministro provinciale della Toscana intorno al 1270, i tre codici
passarono alia biblioteca del convento di Santa Croce di Firenze: anche questo pas saggio e confermato da una nota di proprieta che ancora si legge in questi mano scritti7.
4 Alia attivita milanese del Violante ha dedicato ampia parte del suo intervento P. Zerbi, Dalla prima alia sesta ? Settimana di studi medioevali ?, in Le istituzioni ecclesiastiche della ? societas Christiana ? dei secoli XI-XII. Diocesi, pievi e parrocchie, ? Atti della sesta Settimana internazio nale di studio (Milano, 1-7 settembre 1974) ?, Vita e Pensiero, Milano 1975 (Pubblicazioni del l'Universita Cattolica del S. Cuore. Miscellanea del Centro di studi medioevali, 8), pp. 3-17.
Una aggiornata nota bibliografica sulla pataria si deve a G. Cracco, Pataria, in Dizionario degli Istituti di perfezione, VI, Roma 1980, col. 1265-1270, cui ora si aggiunge, per l'analisi delle fonti, E. Werner, Pataria und Virginitas, ? Byzantinische Forschungen ?, 12 (1987), pp. 489-501, e,
per gli esiti della pataria, Vio:lante, Riflessioni storiche sui seppellimento e la traslazione di Arialdo e di Erlembaldo capi della pataria, in Pasqua mediaevalia. Studies voor Prof. Dr. J. M. De Smet,
University Press, Leuven 1983 (Mediaevalia Lovaniensia, ser. I. Studia, 10), pp. 66-74. Utili altresi l'antologia di testi e le indicazioni bibliografiche curate da P. Golinelli, La pataria. Lotte
religiose e sociali nella Milano del secolo XI, Europfa - Jaca Book, Novara - Milano 1984.
5 Non conosco studi specifici sulla pieve di Sant'Appiano e la sua canonica durante i secoli centrali del medioevo; riguarda gli ultimi secoli medioevali, il XIII e XIV, il saggio di O. Muzzi, Una pieve toscana nel tardo Medioevo: Sant'Appiano in Valdelsa, in Religiositd e societa in Valdelsa net basso Medioevo, ? Atti del Convegno di S. Viviano, 29 settembre 1979 ?. Societa storica della
Valdelsa, 1980 (Biblioteca della ? Miscellanea storica della Valdelsa ?, 3), pp. 75-99. Sulle vicende della riforma della Chiesa nella Tuscia rimangono fondamentali gli studi del Miccoli raccolti in
Miccoli, Chiesa gregoriana, ed anche, dello stesso autore, Pietro Igneo. Studi sulVeta gregoriana, Istituto storico italiano per il Medio Evo, Roma 1960 (Studi storici, 40-41); come pure assai ricco il saggio di S. Boesch-Gajano, Storia e tradizione vallombrosane, ? Bullettino dell'Istituto storico italiano per il Medio Evo e Archivio Muratoriano ?, 76 (1964), pp. 99-215.
6 A. M. Bandini, Catalogus codicum latinorum Bibliothecae Mediceae Laurentianae, IV, Florentiae 1777, coll. 555, 560, 604; l'indicazione dell'umcio ricoperto da Gerardo da Prato, ? ministro Tusciae ?, si legge solamente nel cod. Plut. XIX dext. 8 (Ibid., col. 560).
7 Sui francescano Gerardo da Prato, uomo dotto e forse anche maestro per qualche tempo nello studio di Tolosa, cfr. P. Peano, Gerard de Prato (-\-apres 1283), in Dictionnaire d'histoire et de geographic ecclesiastiques, fasc. 117-118, Paris 1983, coll. 786-787. Da questa sintesi risulta che soltanto un documento pervenutoci in una trascrizione settecentesca attesta che fra Gerardo
This content downloaded from 195.34.79.176 on Mon, 16 Jun 2014 08:07:26 AMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions

200 G. MOTTA
II Bandini, a suo tempo, offri dei tre codici di Sant'Appiano, finiti insieme a
gran parte del fondo di Santa Croce alia Laurenziana di Firenze, una descrizione abbastanza accurata, che tuttavia si deve ora ripercorrere per descrivere e precisare i testi ai quali il Violante ha fatto riferimento per la loro connessione con il movi
mento riformatore della seconda meta del secolo XI.
I. IL COD. LAUR. PLUT. XIX DEXT. 5
II primo codice in ordine di collocazione e il Laurenziano Plut. XIX dext. 5, che il Bandini intitola: B. Gregorii papae homiliae in Evangelia et Pauli Diaconi sermo de Assumptions b. Mariae. Sono, infatti, questi i testi che si leggono nel codice, con le opportune precisazioni gia indicate dallo stesso erudito bibliotecario del Set tecento8.
Inoltre, il Bandini avverti nei ff. 148 e 149, che interrompono il testo dell'omelia
39a, l'inserimento di alcune ? canonicas costitutiones ?, le quali corrispondono esat tamente a quella che il Violante, con maggior precisione, ha indicato come piccola collezione di canoni antisimoniaci. Si tratta di un manipolo di canoni abbastanza diffusi nelle raccolte canonistiche ? come appare dalle indicazioni che accompagna no la presente trascrizione ? il cui intento antisimoniaco e evidentissimo. Ma nel 1'insieme potrebbero altresi rivelare come l'impegno di una canonica per la condanna della simonia si estendeva oltre alle cure per le ordinazioni dei chierici anche ed una onesta amministrazione delle decime. Se, come pare per le ragioni che subito esporro, si dovra ipotizzare una diversa origine del codice, per quanto riguarda l'inserimento di questi due fogli contenenti il gruppo dei canoni antisimoniaci, si potrebbe sup porre che l'aggiunta sia stata voluta nella canonica di Sant'Appiano.
Ma l'elemento piu caratterizzante per identificare l'origine del prezioso mano
scritto, pare si debba cogliere negli ultimi fogli, esattamente dal f. 163vb al f. 165vb, rimasti in bianco dopo la trascrizione del Sermo de Assumptione beatae Mariae. Come spesso accadeva nei codici di uso piu frequente, quei fogli servirono per la trascri zione di un necrologio, veramente ricco di nomi, la cui importanza non sfuggi al Bandini che lo trascrisse nella sua descrizione dei codici laurenziani. Avverti subito, e con ragione, che il necrologio era stato scritto almeno da due mani, in due mo
menti diversi, che pero non si succedono l'una alPaltra, ma che, in certo modo, si
sovrappongono nel senso che accanto ai nomi scritti in un primo tempo se ne sono
poi aggiunti altri lungo tutti i giorni dell'anno. II fatto e cosi rilevante che il Bandini ritenne opportuno usare caratteri diversi, tondo e corsivo, per le due diverse scrit ture9.
La trascrizione del Bandini si limita a registrare i nomi senza nessuna preoccu pazione per identificare i personaggi commemorati. Si tratta pertanto di un necro
logio che merita ancora uno studio accurato per poterne capire adeguatamente le
preziose indicazioni, anche se qualche rilievo e fin d'ora possibile.
sia stato ministro provinciale della Toscana intorno al 1270; la nota di appartenenza come si
legge nel cod. Plut. XIX dext. 8 ne e preziosa conferma. Per Pappartenenza di questi tre codici
(che in origine dovevano far parte di un gruppo di cinque) al fondo antico pervenuto a S. Croce, cfr. C. Davis, The Eearly Collection of Boohs of S. Croce in Florence, ? Proceedings of the American
Philosophical Society*, 107 (1963), pp. 399-414. 8 Bandini, Catalogus, coll. 544-555.
9 Ibid., coll. 546-555; il necrologio non e pero completo: si arresta ai primi giorni di ottobre,
probabilmente per la caduta di un foglio.
This content downloaded from 195.34.79.176 on Mon, 16 Jun 2014 08:07:26 AMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions

POLEMICA AMI SIMON I AC A NEI SECC. XI-XII 201
Si e gia ricordato che il Violante noto la presenza dei nomi del patarino Erlam baldo, del cardinale Umberto di Silva Candida, di Mcolo II e degli abati di Val lombrosa e la ritenne, giustamente, significativa10; e al Davidsohn, che aveva avan zato l'ipotesi di una origine vallombrosana del codice, il maestro degli studi sulla
pataria obbietto che ?numerosi elementi concordano neH'indicare la pieve di San
t'Appiano : tutte le menzioni di persone 'istius ecclesiae' si riferiscono a canonici ?u. Ed e vero; anzi in alcuni casi si fa esplicito riferimento alia canonica della Valdelsa, come, ad esempio, nella ? memoria ? del 16 febbraio: ? Migravit Grisso subdiaconus de congregatione sancti x4piani in pace ?12. Va pero osservato che tutti i riferimenti ai canonici, alia canonica e ai chierici addetti al suo servizio, fanno parte dei nomi
aggiunti in un secondo tempo da una mano piu recente che, evidentemente, scriveva nella canonica di Sant'Appiano13. Ma l'ipotesi del Davidsohn va attentamente ri
presa in considerazione, perche i nomi scritti dalla prima mano ? sono tutti quelli indicati dal Violante e altri numerosi di abati (e, tra questi, l'antico patarino ? dom nus Andreas abbas Strumensis?, f. 164vb), abbadesse, monaci, monache e laici ? fanno invece supporre che quella parte piu antica del necrologio
? che e anche
piu omogenea a tutto il resto del codice ? sia stata scritta in un monastero, e piu precisamente in un monastero vallombrosano14. Soltanto in un secondo tempo il codice
passo a Sant'Appiano dove il necrologio fu, per cosi dire, adattato, e dove, forse, fu aggiunto anche quel ? binio ? con i canoni antisimoniaci. Ma va anche riconosciuto che quei medesimi ideali riformatori della vita del clero erano pienamente condivisi anche dal movimento vallombrosano, specialmente alle origini. Pertanto, mentre
pare certo che il codice sia passato da un monastero vallombrosano alia canonica di
Sant'Appiano, non si possono invece avanzare certezze ? almeno per ora ?
sul
momento dell'inserimento dei canoni che qui di seguito vengono ora trascritti. Sono, in ogni caso, un indice evidentissimo di convinta adesione alia riforma della Chiesa come veniva proposta nella seconda meta del secolo XI.
Sulla condanna della simonia vengono presentati testi non nuovi nella tradi zione canonistica; sono, pero, testi che ripropongono motivazioni e atteggiamenti condivisi dagli ambienti decisamente riformatori, a cominciare proprio dal primo canone (nr. 1) che invita a scacciare e a ritenere, sotto ogni aspetto, separati dalla Chiesa, sia chi riceve l'ordine sacro sia chi lo conferisce ? per pecunias ?; il testo del
concilio di Magonza dell'847, a sua voita, sancisce la deposizione di questi presbiteri indegni (nr. 18)15.
II canone ripreso dal concilio di Calcedonia (nr. 3) mette in dubbio la validita
10 Violante, / laid, p. 226 n. 287.
11 R. Davidsohn, Storia di Firenze, I, Sansoni, Firenze 1956, p. 406; Violante, I laid, p. 226 n. 287.
12 Bandini, Catdlogus, col. 548; un confronto con il codice dimostra che la nota e stata
scritta dalla seconda mano e pertanto doveva essere pubblicata in carattere corsivo. 13
L'auspicato studio sui necrologio dovra veriflcare attentamente la trascrizione del Ban dini perche anche in qualche altro caso, oltre quello sopra citato, la nota e della mano piu re cente: cosi per le note obituarie ? Obiit Azo canonicus istius ecclesiae ? (ibid., col. 553), e, per un altro omonimo, ? Obiit Azo canonicus istius ecclesiae ? (ibid., col. 554). Nel necrologio, al 13 feb braio, si legge anche una data: ?Anno Domini m.cc.xi. (in marg. add. de Luce) hie uenit Ber toldus (s.l. add. clericus) ad plebem sancti Appiani ?: pertanto si puo ritenere che almeno da
quell'anno il codice apparteneva alia canonica di Sant'Appiano. 14 Davidsohn, Storia di Firenze, p. 406, pensa che il necrologio sia appartenuto al monastero
vallombrosano di S. Maria di Coneo: di questa monastero, infatti, sono ricordati alcuni monaci ed abati.
15 Sulla lotta intrapresa dai laici contro la simonia cfr. Violante, I laid, pp. 242 ss.
This content downloaded from 195.34.79.176 on Mon, 16 Jun 2014 08:07:26 AMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions

202 G. MOTTA
deH'ordinazione conferita ?per pecuniam ?, e i brani successivi pongono l'accento
sugli effetti eontrari ? condanna subita da Simon Mago e maledizioni ? collegati con
nna amministrazione dei sacramenti macchiata di simonia16. Viene anche invocata l'autorita di san Gregorio Magno mediante alcuni brani della lettera scritta a Siagrio, vescovo di Augusta, dove ricorre l'espressione ? sacerdos non esse sed dici tantum modo inaniter concupiscit? (nr. 7) per chi ha ricevuto l'ufficio ecclesiastico attra verso il denaro17.
Anche i brani successivi insistono sulle doti di chi chiede di essere ammesso tra il clero, mentre un riferimento puntuale alle accuse che allora alcuni laici rivol
gevano ai ministri indegni si coglie nel testo pseudoisidoriano (nr. 10) dove, indi
rettamente, si conferma che solamente coloro i quali si comportano in modo cor
rispondente ai doveri del proprio stato godono della licenza ? accusandi uel testi ficandi ?18.
Gli ultimi brani (nr. 19-25) riportano i testi piu noti sulla natura delle deci
me, sull'obbligo che ne derivava per i fedeli e sulla distribuzione ? canonica ? dei
proventi di questa forma di tassazione19. Insieme alia gestione delle altre libere offerte ? se ne tratta in particolare dal nr. 22 al 25 ? rappresentano aspetti della vita ecclesiastica che potevano dar adito facilmente a pratiche simoniache o, in ogni caso, ad una cattiva amministrazione dei beni materiali che in seguito alia loro offerta a Dio dovevano essere ritenuti ? consecrata ? (nr. 19) e come tali essere trattati20.
16 Anche l'avversione ai sacramenti amministrati dai simoniaci ritenuti non soltanto in validi bensi carichi di effetti negativi, era diffusa in alcuni ambienti riformatori, cfr. ibid., pp. 178-179.
17 II brano e stato attentamente esaminafco da O. Capitani, Vinterpretazione ? pubblicistica ?
dei canoni come momento della definizione di istituti ecclesiastici (secc. XI-XII), in Fonti medievali e problematica storiografica, ? Atti del Convegno internazionale tenuto in occasione del 90? an niversaries dell'Istituto Storico Italiano, 1883-1973 ?, Istituto Storico Italiano per il Medio Evo, Roma 1976,1, pp. 265-267 (e note, pp. 280-281); sul significato del testo nella Collezione canonica di Anselmo da Lucca, cfr. G. Picasso, ? Reformatio Ecclesiae ? e disciplina canonica, in Chiesa, diritto e ordinamento della ? societas Christiana ? nei secoli XI e XII, ? Atti della nona Settimana internazionale di studio (Mendola, 28 agosto-2 settembre 1983) ?, p. 82. Sia in Ans. come nella 74T il brano e piu ampio: quel ? et post pauca ? che e premesso qui al testo successivo, nr. 8, e che non ha senso, si puo invece capire se si riferisce, come un refuso, al brano precedente, nr. 7, che di solito era piu ampio.
18 ? Ai patarini ? scrive il Violante, I laid, p. 192 ? restava il compito di denunciare alle
autorita canoniche diocesane e provinciali le colpe dei chierici e di portare ad esecuzione le dispo sizioni delle sentenze legittimamente pronunziate qualora i condannati e i loro aderenti vi si fos sero rifiutati ed opposti ?.
19 Per la diffusione di questi medesimi testi relativi alle decime, cfr. Picasso, Campagna e
contadini nella legislazione della Chiesa fino a Graziano, in Medioevo rurale. Suite tracce delta ci
vilta contadina, a cura di V. Fumagalli-G. Rossetti, II Mulino, Bologna 1980, pp. 381-397. 20 Nella descrizione di alcuni testi che si leggono in questi codici, mi avvalgo delle seguenti
abbreviazioni:
Ans. = Anselmi ep. Lucensis Collectio canonum, ed. F. Thaner, Innsbruck 1906 e 1915. Ans. ded. = Collectio Anselmo dedicata. Lib. I, ed. J. C. Besse, ? Revue de droit canonique ?, 9
(1959), pp. 207-296; per i libri successivi cfr. Besse, Collectio Anselmo dedicata. Mude et
texte, Paris 1970. Burch. = Burchardi ep. Wormatiensis Decretum, PL 140.537-1058. CCL =
Corpus Christianorum. Series latina. CCLcm =
Corpus Christianorum. Continuatio mediaevalis. Finsterwalder = Die Canones Theodori Cantuariensis und ihre Uberlieferungsformen, ed. P. W.
Finsterwalder, Weimar 1929. Grat. = Decretum Magistri Gratiani, ed. Ae. Friedberg, Lipsiae 1879. H = P. Hinscius, Decretales Pseudo-Isidorianae et Capitula Angilramni, Lipsiae 1873. Hanel = Iuliani Epistome latina novellarum lustiniani, ed. G. Hanel, Lipsiae 1873.
This content downloaded from 195.34.79.176 on Mon, 16 Jun 2014 08:07:26 AMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions

POLEMICA ANTISIMONIACA NEI SECC. XI-XII 203
Firenze, Bibl. Medicea Laurenziana, cod. Plut. XIX dext. 5, ff. 148r-149v.
1. QVOD non debeant officia ecclesiastica pecvniis obtineri.
Cap. xxx. de canonibus Apostolorum. Si quis episcopus aut presbyter aut diaconus per pecunias hanc obtinuerit dignitatem, deiciatur ipse et ordinator ems et a com munione modis omnibus abscidatur, sicut Symon Magus a Petro.
Canones Apostolorum c. 30 versio Dionysiana (PL 67.144); Cfr. Ans. ded. 2.32; Regino 1.236; 5L 1.52; Burch. 1.23bis (v. G. Fransen, Le manuscrit de Burchard de Worms conserve d la Bibliotheque municipale de Montpellier, in Melanges Boger Aubenas, Societe d'histoire du droit et des institutions des anciens pays de droit ecrit, Montpellier 1974, p. 506); 183T 18.4; Ivo D 5.75. Humbertus card., Adversus sy
moniacos, 1.28 (MGH Ldl 1.130.21-23).
2. Vt ecclesia secvlari potentia minime pervadatvr.
(Cap.) xxxi. ex eisdem. Si quis episcopus secularibus potestatibus usus ecclesiam per ipsas obtineat, deponatur et eiciantur omnes quifque] illi communicant.
Can. Apost. c. 31 (PL 67.144); Burch. 3.109; Ivo D 3.85; Grat. C.16 q.7 c.14. Humbertus card., Adversus sym., ibid., 25-29
3. QVOD non debeat episcopvs avt qvilibet ex clero per pecvnias or
dinari.
Cap. ii. ex concilio Calcedonensi. Si quis episcopus per pecuniam fecerit ordinationem et sub pretio redegerit gratiam, que non potest uendi, ordinaueritque per pecuniam presbyterum aut diaconum uel quemlibet ex his qui connumerantur in clero, aut
promouerit per pecunias dispensatorem aut defensorem uel quemquam qui subiectus est regule sub turpissimi lucri commodo, is cui hoc attemptanti probatum fuerit, proprii gradus periculo subiacebit. Et qui ordinatus est nichil ex hac ordinatione
JE, JK, JL = Ph. Jaffe, Regesta pontificum Romanorum... ed. secundam curaverunt S. Loe wenfels (JL: an. 882-1198), F. Kaltbnbeunner (JK: an. ?-590), P. Ewald (JE: an.
590-882), Leipzig 1885-1888. Ivo D = S. Ivonis Carnotensis ep. Decretum. PL 161.47-1022. Ivo P = Ivonis Carnotensis ep. Panormia, PL 161.1041-1344.
Mor = C. G. Mob, Lex Romana canonice compta, Pavia 1927.
Polyc. = U. Horst, Die Kanonessammlung Polycarpus des Gregor von S. Grisogono. Quellen und
Tendenzen, Miinchen 1980.
Regino =
Reginonis ab. Prumiensis Libri duo de synodalibus causis et disciplinis ecclesiasticis, ed. F. G. A. Wasserschleben, Lipsiae 1848.
Thiel = Epistulae Romanorum Pontificum genuinae et quae ad eos scriptae sunt a S. Hilaro usque
ad Pelagium II, ed. A. Thiel, Braunsberg 1868. Wasserschleben = Die irische Kanonessammlung, ed. H. Wasserschleben, Leipzig 18852. 5L = Collectio Canonum in V libris (I-III), ed. M. Fornasari, Brepols, Turnholti 1970 (CCLcm, 6). 74T = Diversorum patrum sententiae sive Collectio in LXXIV titulos digesta, ed. J. T. Gilchrist,
Citta del Vaticano 1973. 183T = Liber canonum diversorum sanctorum patrum sive Collectio in CLXXXIII titulos digesta,
ed. J. Motta, Citta del Vaticano 1988.
In considerazione del numero piuttosto modesto dei canoni che compongono la piccola silloge, non e possibile stabilire quali siano le fonti dei canoni, la data di composizione e F origin? della raccolta. Tuttavia pare probabile che il compilatore abbia avuto un contatto diretto con il Decreto di Bucardo; in particolare poi, se si considera che la falsa attribuzione ad Ormisda del brano nr. 4 si incontra anche e soltanto ? a quanto pare
? in 183T 18.2, si potrebbe pensare che circolasse nelle chiese della Tuscia una copia del Decreto di Burcardo con quella falsa attribuzione. Occorrerebbero pero altre conferme per irrobustire questa ipotesi.
This content downloaded from 195.34.79.176 on Mon, 16 Jun 2014 08:07:26 AMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions

204 G. MOTTA
uel promotione, que est per negotiationem facta, proficiat, sed sit alienus ea digni tate uel sollicitudine quam pecuniis quesiuit. Si quis uero mediator turpibus aut nefandis datis uel acceptis extiterit, si quidem clericus fuerit, proprio gradu decidat. Si uero laicus aut monachus, anathematizentur.
Concilium Chalcedonense a. 451 c. 2 versio Dionysiana (PL 67.171); Ans. ded. 2.14; Regino 1.237; Ans. 6.77; Polyc. 2.37.4; Grat C.l q.l c.8 cfr. Burch.
1.112; 183T 18.5; Ivo D 5.118; Ivo P 3.118, Humbertus card., Adversus sym., ibid., 31-40.
4. DE HIS qvi PRETIO SACRAM MERCATI SVNT DIGNITATEM.
Cap. x. ex epistola Ormisde pape. Quos constiterit indignos meritis sacram mercatos esse pretio dignitatem, conuictos oportet arceri, quia dantem pariter accipientemque damnatio Symonis, quam sancta lectio testatur, inuoluit.
Immo Gelasius I, ep. 14.24 (Thiel 375; JK 636); Regino 1.238; Burch. 1.22; 183T 18.2; Ivo D 5.76; Polyc. 7.7.1; Grat. C.l q.l c.6.
Humbertus card., Adversus sym., ibid., 130.42-131.2.
5. De eadem re.
Hoc itaque ad prioraa coniungimus, ne benedictio per impositionem manus, que a Deo esse creditur, pretio comparetur, quia Symon Spiritum sanctum uolens pretio mercari apostoli fuit detestatione percussus.
a) propria ms.
Hormisda. ep. 25.2.4 (Thiel 791; JK 787); Regino 1.239; Burch. 1.23; 183T 18.3.7; Ans. 6.19; Ivo D 5.77; Polyc. 2.37.5. Cfr. 5L 1.65.
6. VT INDIGNVS NON POSSIT ASSVMI AD HONOREM SACERDOTn.
Ex epistola Gregorii pape ad Siagrum episcopum Augustensem. Ab re autem non facimus, si ad arguendum rationabilium usum rerum irrationabilius colligamus. Apta itaque edificationibus de siluis ligna succiduntur, nec tamen adhuc uiridibus edificii
pondus imponitur, nisi eorum uiriditatem multorum dierum mora siccauerit et apta ad nccessarium usum fecerit. Que si obseruantia forte neglegitur, citius superimposita mole franguntur et gignit ruinam ad auxilium res prouisa. Hinc etenim medici, qui corporum cur am gerunt, quedam adiutoria recenti adhuc confectione formata in
digenti non offerunt, sed maceranda temporibus derelinquunt. Nam si inmature
quid deperit, dubium non est quia sit causa periculi res salutis. Discant itaque officio suo sacerdotes, quibus animarum credita est cura, seruare quod diuersarum artium homines docente ratione custodiunt et a precipiti se ambitione etsi non metu saltern pudore contineant. Sed ne forsitan ad hoc prime consuetudinis quisquam uelud obiectu defendere, fraternitatis tue discretio rationis eos freno coerceat et labi in illicitas non permittat, quia quicquid ultioni dignum est non ad imitationis sed potius [ad] exemplum debet correptionis adduci.
Gregorius M., Reg. 9.219 (CCL 140A.787.129-788.147 = 9.218 ed. MGH; JE 1747).
7. Item in capite epistole huius. Si in ecclesiasticis officiis quemquam habet locum pecunia, fita seculare quod sacrum est. Quicumque ergo hoc pretii studet datione percipere, sacerdos non esse, sed dici tantummodo inaniter concupiscit.
a) sit ms.
Gregorius M., Reg. 9.129 (CCL 140A. 783-25-29; JE 1747) 74T 129; Ans. 6.69.
This content downloaded from 195.34.79.176 on Mon, 16 Jun 2014 08:07:26 AMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions

POLEMICA ANTISIMONIACA NEI SECC. XI-XII 205
8. [Et post pavca.] De clerico ordinatione digno.
Non alium clericum eoncedimus consecrari, nisi eum qui et littcras scit et rectam fidem et uitam honestam habet et neque concubinam et naturales liberos habet uel habuit sed castitate preditum. Vel uxorem legitimam et ipsam unam et priniam habentem uel suam habuerit, neque uiduam neque disiunctam a marito neque aliam, nisi que legibus uel diuinis canonibus approbatur. luliani epitome 115.444.18 (Hanel 152 = Lex Romana canonice compta 6, Mor 40) 5L 1.120
9. De his qvi ad clervm creari non debeant.
Ex eadem. Neque curialis neque taxiota clericus consecretur. Quod si hoc factum
fuerit, priori conditioni restituatur, nisi forte non minus quam quindecim annos in solitaria uita peregerit. Tales enim homines consecrari iubemus, reddenda scilicet curiali legitima portione tarn curie quam publico. luliani epitome 115.448.22 (Hanel 153 = Lex Rom. can. compta 8, Mor 40) 5L 1.79
10. Vt accvsandi vel testificandi licentia criminosis non sit.
Accusandi uel testificandi licentia denegetur (his) qui christiane religionis et nominis
dignitatem et sue legis uel qui propositi normam aut regulariter prohibita neglexe rint. Transgressores enim sponte legis sue eiusque iugulatores apostate nominantur. Omnis enim apostata refutandus est ante reuersionem suam, non in accusatione recte agentium aut testimonio suscipiendus.
Ps-Anacletus, ep. 1.3 (H 68; JK+2); Ans. ded. 3.36; 74T 44; 183T 76.37; Ans. 3.10; Ivo D 5.237; Ivo P 4.60; Polyc. 5.1.3; Grat. C.3 q.4 c.2.
11. Clericos scurriles et uerbis turpibus iaculatores ab ofncio detrahendos.
Statuta ecclesiae antiqua c. 73(60) (CCL 148.178); Regino 1.154; Burch. 2.172; 183T 59.20; Ivo D 6.263; Ivo P 3.172; Grat. D.46 c.6.
Cfr. Ans. ded. 5.86.
12. Cericus3, fideiussionibus inseruiens, abiciatur
a) Clericos ms.
Canones Apostolorum c. 20 versio Dionys. (PL 67.143); Burch. 2.173; 183T 59.2; Ivo D 6.264.
13. Clericus3- qui adulationibus et proditionibus uacare deprehenditur, degra detur ad officio.
a) Clericos ms.
Stat. eccl. antiqua c. 43(56) (CCL 148.173); Burch. 2.176; Ivo D 6.267; Ivo P 3.173; Grat. D.46 c.3.
14. Vt laicalibus vesti(menti)s clerici non utantur, id est mantello uel cotto siue cappa, nec pretiosis et ineptis calceamentis et aliis nouitatum uanitatibus, sed
religiose et decenti habitu induti incedant.
Canones extravagantes cone. Triburiensi a. 895 addicti c. 8 (MGH Cap. 2.248);
Regino 1.345; Burch. 2.208; 183T 59.11; Ivo D 6.283.
This content downloaded from 195.34.79.176 on Mon, 16 Jun 2014 08:07:26 AMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions

206 G. MOTTA
15. Vnusquisque presbyter ecelesia una ad quam ordinatus est contemptus sit et nullus in duabus ecclesiis ministrare presumat.
Capitulum incertum; vide tamen Benedicti Levitae Capitularia Add. 2.10 (MGH LL 2/2.134); Begino 1.277; Burch. 3.44; 183T 31.3; Ivo D 2.48.
16. Sicut in unaquaque ecelesia presbyter debet esse, ita ipsa, que sponsalis uxor eius dicitur, non potest diuidi inter plures presbyteros, sed unum tantummodo habebit sacerdotem, qui earn caste et sincere regat. Vnde interdicimus ut nullus
presumat ecclesiam inter duos uel plures diuidere, quia ecelesia Christi uxor et
sponsa debet esse, non scortum sicut Calixtus papa testatur.
Capitulum incertum.
Begino 1.247; Burch. 3.45; Ivo D 3.49; Ivo P 2.44; Grat. C.21 q.2 c.4.
17. Ex concilio Geridensi. Dionisius Ariopagita dicit blasphemias Deo facere
qui missas offert pro malo homine. Augustinus dicit pro omnibus christianis esse faciendum, qualis ei proficit aut offerentibus aut petentibus proderit. Canones Theodori Gantuariensis 2.5.8-9 (Finsterwalder 319); Burch. 3.65; 183T 32.5; Ivo 3.67.
18. Ex concilio Mogotiensi. Quicumque presbyter per pretium ecclesiam fuerit
adeptus, quoniama contra ecclesiastice regule disciplinam agere dignoscitur, et qui aliumb presbyterum legitime ad ecclesiam ordinatum per pecuniam expulerit ea(m)que sibi taliter uindicauerit, omnimodis deponatur.
a) quomodo ms. b) aliud ms. Concilium Moguntinense a. 847 c. 12 (MGH Cap. 2.179.9-12); Begino 1.349; Burch. 3.110; Ivo D 3.86.
19. Vt cvncta qve Deo offervntvr consecrata habeantvr.
Ex concilio Aurelianensi* cap. vii. Omnia que Deo offeruntur consecrata habeantur in uineis, terris, utensilibus, vestimentis, pecoribus et reliquis possessionibus et que eccleiis sine dubio Christo, qui sponsus earum est, offeruntur.
a) inscr. marg. Aurelii pape Herardus Turonensis, Gapitula c. 65 (PL 121.768-69); Burch. 3.129; 183T 53.7; Ivo D 3.195; Polyc. 3.12.15.
20. Ex concilio Eotomagensi cap. III. Omnes decime terre siue de frugibus siue de pomis arborum Domini sunt, et illi sanctificabitur boues et oues et capre que sub pastoris uirga transeunt; quicquid decimum uenerit, sanctificabitur Domino.
Non eligetur nec malum nec bonum, ne(c) altero commutabitur. Si quis mutauerit et quod mutat et quoda mutatum est sanctificabitur Domino et non redimetur. Sed quia modo multi inueniuntur decimas dare nolentes, statuimus ut secundum Domini preceptum ammonea(n)tur semel et secundo et tertio; si non emendaueri(n)t, anathematis uinculo constringantur usque ad satisfactionem et emendationem con
gruamb.
inscr. marg. a) qui ms. b) congruum ms.
Concilium Moguntinum a. 852 c. 3 (MGH Gap. 2.186.1-8); Burch. 3.130; 183T 54.1; Ivo D 3.196; Ivo P 2.58; Grat. C.16 q.7 c.5.
This content downloaded from 195.34.79.176 on Mon, 16 Jun 2014 08:07:26 AMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions

POLEMICA ANTISIMONIACA NEI SECC. XI-XII 207
21. Item de eadem re.
Instruendi sunt presbj^teri pariterque ammonendi quatenus nouerint decimas et
oblationes, quas a fidelibus accipiunt, pauperum et hospitum et peregrinorum esse
stipendium et non quasi suis sed quasi commendatis3, uti, de quibus omnibus sciant se rationem posituros in conspectu Dei, et nisi eas fideliter pauperibus et his qui premissi sunt administrauerint, dampna passuros. Qualiter uero dispensari debeant, eanones sancti instruunt, scilicet, ut quattuor partes inde fiant: una ad ecclesie fabricam releuandam, altera [ad] pauperibus distribuenda, (tertia presbytero cum suis clericis habenda), quarta[m] episcopo reseruanda[m], ut quidquid exinde iusserit,
prudenti consilio fiat.
a) suas ... commendatas ms.
Capitulum incertum.
Regino 1.353; Burch. 3.138; Ivo D 3.204.
22. Etiam clerici uel seculares qui oblationes parentum aut donatas aut testa
mentis relictas retinere perstiterint3, aut id quod ipsi donauerint ecclesiis uel mona
steriis crediderint auferendum, sicut sinodusb santa[m] constituit, uelut necatores
pauperum eousque reddant, ab ecclesia excludant(ur).
a) prestiterint ms. b) sinodum ms.
Concilium Agathense a. 506 c. 4 (CCL 148.194); Ans. ded. 5.135, 10.70; Regino 2.389; Burch. 3.140; Ivo D 3.206; Ivo P 2.5; Grat. C.13
q.2 ell. Cfr. 5L 3.114.
23. De illis qvi Devm heredem factvnt.
Sanctus Ysidorus dicit. Augustinus dicit in libro de heredi[ti]bus: ? Noli sub imagine
pietatis augere pecuniam dicens: Filiis meis seruo has res. Quare non potius seruas
illi, qui te ex nichilo fecit, qui te pascit et fihos seruat? Nonne melius creatori tuo
thesaurizabis quam filiis? ?. Item idem: ? Qua fronte hereditatem a Christo queris, cum Christum tuam hereditatem fraudaueris, qui dixit: Thesaurizate uobis thesau rum in celo? ?.
rubr. Sanctus Ysidorus dicit de illis ... faciunt ms.
Collectio Hibernensis 32.12 (Wasserschleben 113). Burch. 3.141.
24. De fvgientibvs ad ecclesiam.
Si quis contumax uel superbus timorem Dei uel reuerentiam ecclesiarum sanctarum et fugientem seruum suum uel quern ipse persecutus fuerit, de atrio3, ecclesie uel de porticibus quomodolibet ecclesie adherentibus per uim abstraxerit, pro emunitate
dcccc. solidos componat episcopo et ipse publice penitentia iuxta iudicia episcopi multetur, ut sit honor Dei et reuerentia sanctorum et ut ecclesia Dei semper inuicta
permaneat.
a) atrium ms.
Cfr. Benedictus Levita, Capitularia 1.337 (MGH LL 2/2.66-67). Burch. 3.197; Ivo D 3.114; cfr. Grat. C.17 q.4 c.20.
25. De ecclesia a complvribvs coheredibvs obsessa.
Quecumquea ecclesia a compluribus coheredibus obsessa concordi unanimitate un
dique procuretur, ne propter aliquas disceptationes seruitium Dei minueturb et cura
This content downloaded from 195.34.79.176 on Mon, 16 Jun 2014 08:07:26 AMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions

208 G. MOTTA
populi inreligiose agatur. Si uero contingat pro ea comparticipes diffidere et sub uno presbytero nolle earn procurare et propterea iurgia et contemptiones tarn inter
ipsos quam inter clericos incipient frequentare, quia iuxta Apostolum 'Servos Dei non oportet litigare', episcopus tollat inde reliquias et sub magna cura honorifice collocet eas atque eiusdem ecclesie claudat ostia et sub sigillo signet ea, et ut sacrum
ministerium nullus celebret in ea, antequam concordi unanimitate unum omnes
eligant presbyterum, qui idoneus sit sacrosanctum locum procurare et populo Dei utiliter preesse.
a) Quicumque ms. b) minuetur ms.
Concilium Triburiense a. 895 c. 32 (MGH Cap. 2.232.13-31) ; Burch. 3.244; Ivo D 3.283.
II - IL COD. LAUR. PLUT. XIX DEXT. 8
Secondo in ordine di collocazione e il Laurenziano Plut. XIX dext. 8, al quale il Bandini ha preposto l'intitolazione: 8. Gregorii papae liber pastoralis. Anonymi Constitutiones ecclesiasticae. Infatti nel codice si distinguono nettamente queste due
opere: la ben nota Begula pastoralis di Gregorio Magno si legge nella prima parte del manoscritto, ff. l-92r; nella seconda, ff. 94v-96v, le anonime Constitutiones eccle siasticae^.
Queste, in particolare, hanno richiamato l'attenzione degli studiosi dei movi menti confraternali del Medioevo, dal Monti al Meersseman, che le hanno edite, perche rappresentano lo statuto vero e proprio di una confraternita di laici e di chierici la cui stesura puo risalire almeno al secolo XII: senz'altro e uno dei piu antichi statuti a noi noto, le cui caratteristiche di originalita e di spirituality sono state gia messe in risalto22. Occorre tuttavia notare che la attribuzione di questa confraternita alia canonica della pieve di Sant'Appiano, senz'altro accettata anche del Meersseman, in realta si basa soltanto su quella nota di appartenenza che fu
scritta nella seconda meta del seolo XIII quando il codice passo, con altri, da San
t'Appiano alia biblioteca del convento francescano di S. Croce di Firenze. Nessun elemento interno allo statuto induce a confermare questa attribuzione; anzi, alcuni termini ricorrenti come quello di 'abbas' per designare il superiore che i confratelli si
eleggono ed altre coincidenze con la Regola di san Benedetto, fanno piuttosto pen sare alia confraternita annessa ad un monastero23. Or a pero qualche serio dubbio e stato avanzato sulla appartenenza di questo statuto alia confraternita di Sant'Ap piano24: pare senz'altro di poterlo condividere.
21 Bandini, Catalogus, coll. 558-560.
22 G. M. Monti, Le confratemite medievali delValta Italia, II, Venezia 1927, pp. 140-143; G. G. Meersseman, Ordo fratemitatis. Confratemite e pieta dei laid nel Medioevo, I, Herder, Roma 1977 (Italia sacra, 24), pp. 55-65.
23 Si possono facilmente rilevare nella stessa edizione, per altro non priva di alcune impreci sion^ del Meersseman, Ordo fratemitatis, p. 58: ? Le entrambe forme di scomunica erano previste dalla Regola di san Benedetto ?; p. 60: ?In primis quando insimul congregati fuerint, eligant sibi magistrum et abbatem ?.
24 M. D. Papi, Devozione laicale e forme associative nel territorio valdelsano: la confraternita di
JSanfAppiano, in Religiosita e societa in Valdelsa, pp. 101-112. Sulla natura di questo statuto e sulla sua datazione e intervenuto ripetutamente anehe Ch. M. de La Ronciere, La place des
confreries dans V encadrement religieux du contado florentin: Vexemple de la Val d'Elsa, ? Melanges de l'Ecole francaise de Rome. Moyen Age
- Temps modernes ?, 85 (1973), pp. 31-77; La place
des confreries dans Vencadrement religieux du contado florentin au XIVe siecle. Appendices, ibid., pp. 657-665.
This content downloaded from 195.34.79.176 on Mon, 16 Jun 2014 08:07:26 AMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions

POLEMICA ANTISIMONIACA NEI SECC. XI-XII 209
Ma l'interesse del Violante per il codice deriva da due brani che si leggono tra i due testi maggiori, nei ff. 92v-94r; gia il Bandini ne avverti la presenza, e forse anche
l'importanza, ma si limito ad indicarli con questa espressione: ? Capita duo, forte ex Ivone desumpta ?25. In realta non si tratta di testi desunti dalle raccolte di Ivo. II primo, molto breve, recita: ? Aedes sacre, et que per pontificem rite Deo consecrate
sunt, nullius in bonis sunt; si vero rite consecrate non sunt, non est sacer locus, sed
profanus ?: deriva dalla Lex Bomana canonice compta, ed offre una precisa afferma zione sulla sacralita delle chiese26.
Assai piu ampio il secondo testo che, in forma di sermone, offre una testimo
nianza molto efficace della predicazione antisimoniaca. Certamente il Violante intui il significato di questo testo, per che vi si esprimono proprio le idee di Umberto di
Silva Candida, dei patarini e dei vallombrosani, sulla necessita di combattere senza
tregua la simonia, sul dovere dei sudditi di accusare i chierici e gli stessi vescovi che si fossero macchiati di questo peccato, e sugli effetti nefasti dei sacramenti am
ministrati da questi ? eretici ?27. L'autorita di san Gregorio Magno sostiene tutto il
discorso, che si avvale in generale di testi allora assai diffusi nella letteratura anti
simoniaca, come risulta pure dai riferimenti con i quali accompagno l'edizione di
questo sermone, non certo privo di significato, anche se molto probabilmente il testo non ci e pervenuto in tutta la sua interezza.
25 Bandini, Catalogus, col. 558.
26 Lex Romana canonice compta 208.8.9 (MOR 154); cfr. anehe MGH Ldl 2.360. 27 Sono tutti aspetti egregiamente studiati dal Violante, I laici, passim.
Firenze, Bibl. Medicea Laurenziana, cod. Plut. XIX dext. 12, ff. 92v-94r.
Auctoritate sancti Gregorii pape primia eompellimur& ut, si cum Symone Mago condempnari non uolumus, contra symoniacos totis uiribus repugnemus. Ipse enim
uniuersaliter omnibus ehristianis dicit: ? Quicumque ad hoc facinus symoniace ac
neophitorum heresim emendandum pro officii sui loco uehementer non arserit, cum eo sec non dubitet habere portionem, a quo prius hoc exitiale flagitium sumpsit exordium ?1. Sed dicit aliquis: ? Non ad me pertinet iudicare episcopos, presbyteros et abbates et tales quidem omnino non esse sacerdotes ?. Idem tibi beatissimus Gre
gorius respondet dicens: ? Quicumque hoc pretii studet donatione accipere, sacer dos non esse, sed dici tantum inaniter concupiscit?. Nam qui sic nititur ad altiora
conscendere, quid agit, nisi ut crescendo decrescat et ascendendo exterius, interius in profundum descendat? ?2. Preterea prepositos et episcopos, si in heresim cadant, ab omnibus etiam subditis debere accusari et increpari pene nullus ignorat, qua
a primo ms. b
compellimus ms. 0 cum eos ms.
1 Gregorius M., Reg. 12.9 (CCL 140A.981.35-57). II brano risulta presente, ad esempio,
neWEpistola Widonis ad archiepiscopum Mediolanensem (MGH Ldl 1.5.10-13) e, con varianti di scarso rilievo, in Pier Damiani, Liber gratissimus, 27 (MGH Ldl 1.57.15-18) come pure in Um berto di Silvacandida, Adversus symoniacos, 1.13 (MGH Ldl 1.121.-122). Mentre per la diffu
sione in collezioni canoniche vanno segnalate almeno 74T 132, Ans. 6.73 e 2L 1.168. 2 Gregorius M., Reg. 9.219 (CCL 140A.783.27-29, 784.38-40). II brano ? un topos della
trattatistica antisimoniaca ? risulta diffuso seppur con diver so incipit (ad esempio, ?Nuntio
siquidem apud vos. .. ?) in collezioni canoniche tipiche dell'eta gregoriana, come 74T 127, Ans. 6.69, 2L 1.263.
This content downloaded from 195.34.79.176 on Mon, 16 Jun 2014 08:07:26 AMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions

210 G. MOTTA
muis et in aliis criminibus prepositos posse accusari, ita in diuinis canonibus legatur: Quod episeopus a quocumque elerico ueraciter fuerit accusatus, potest sine dubio etiam honoris subire periculum3. Huiuscemodi certissime esse heretieos. Item tibi idem Gregorius papa dicit: ? Cum liqueat hanc heresim ante omnes radices pesti feras surrexisse atque in ipsa sui origine apostolica esse maledictione damnatam, cur non uidetur, cur non [f. 93r] perpenditur quia benedictio ilia in maledictionem conuertitur quia ad hoc, ut fiat hereticus, ordinatur? ?4.
Sed iterum dicit aliquis: ? Non euro qualis sit sacerdos; tantum oret pro me et
proderit michi, quamuis noceat sibi?, et item: ?Quia si cunctos tales sperno, pau cos istos inuenio ?5. Illorum itaque orationes et missas nequaquam adiuuare et plu rimum nocere eiusdem Gregorii sacratissima satisfacit auctoritas dicens: ?Maior
ergo metuenda est in illis locis euenire calamitas, ubi tales intercessores ad locum
regiminis adducuntur, qui magis in se Dei iracundiam prouocent quam per seme
tipsos populis placare debuerant ?6. Iterum autem apponitur quod sunt quidam tales satis religiosi et perfecti, ut
uideantur^ viri (Dei). Apostolus autem dicit: ? Quia omne quod non est ex fide
peccatum est ?7. Et idem pater Gregorius dicit: ?In sacerdotibus fides est eligenda cum uita. Si uita deest, fides meritum non habet. Cum Iacobus apostolus dicat: Fides sine operibus mortua est. Que autem opera valea(n)t esse sacerdotis, qui honore tanti misterii conuincitur optinere per premium? ?8 Subauditur: Nulla. Pre terea summopere cauendum est quod diuina uoce dicitur: ? Quia qui peccat in Spi ritu sancto non remittetur ei neque hie neque in futuro ?9. Quod dicendo remedium
penitentie non tollitur, quia non iudicat Deus bis in idipsum et in futurum nequa quam condempnatur, quisquis in hoc seculo canonice iudicatur10. Sano autem in tellectui dicitur, quia maxime peccat in Spiritu sancto qui eum uel eius gratiam uendit uel comparat, quia omnia continet, conseruat atque santificat, cum sit uile omne quod uenditur, et parui putatur^' omne quod pretio comparatur11. Vnde et Dominus cathedras uendentium columbas euertens, aperte significat quia illorum
d uidendur ms. d'
petatur ms.
e uenditur . . . emitur ms. f utique qui scripsi: uterque lectio incerta ms.
3 II brano riecheggia la rubrica del canone 28 dei Deer eta Gelasii papae, attestata nella tra dizione della Dionysio-Hadriana (PL 67.319). Va anche aggiunto che il testo gelasiano
? ma
soprattutto la rubrica ? non ha trovato, a mia conoscenza, una larga diffusione nella canoni
stica, anche se attestato in Grat., C.2 q.7 c.47. Sul dovere o sulla liceita di accusare il ? praelatus ? da parte dei sudditi la tradizione canonistica e piuttosto restrittiva. Si veda, ad esempio, Ans.
3.26-31, 3.44. 4 Gregorius M., Reg. 9.216 (CCL 140A.784.55-785.59). 5 Significativa mi pare la coincidenza concettuale che si riscontra in Bonizone, Liber ad
amieum 6 (MGH Ldl 1.592): ?In tanta enim ac innumerabili turba clericorum vix ex mille v
poterant inveniri, qui non symoniace hereseos maculis essent irretiti?. 6 Gregorius M., Reg. 9.216 (CCL 140A.778.40-43). Anche questo brano, come si e gia
rilevato per i precedenti testi gregoriani, ha conosciuto ampia diffusione, seppur con diverso
incipit (? Fertur symoniaca heresis... ?); si veda, ad esempio, 74T 126, Ans. 6.68, 2L 1.262. 7 Rom. 14.23. 8 Gregorius M., Reg. 9.216 (CCL 140A.777.17-21). Per la diffusione in collezioni canoniche
si veda supra, n. 6. 9Lc. 12.10. 10 Non mi e stato possibile individuare il riferimento biblico, tuttavia l'espressione, enun
ciata come sacra scrittura, si legge nei Canones Apostolorum, c. 25 (PL 67.143); e attestata nelle collezioni canoniche, ad esempio, in Burch. 3.189.
11 Cfr. Gregorius M., Reg. 9.214 (CCL 140A.773.32-33).
This content downloaded from 195.34.79.176 on Mon, 16 Jun 2014 08:07:26 AMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions

POLEMICA ANT ISIM ON I AC A NEI SECC. XI-XII 211
sacerdotium destruit, qui gratiam sancti Spiritus manus imponendo, per quod sacri ordines conferuntur, uendunt6 uel emunt/12. Nunquid nam presbiterum sicut et asinum duodecim solidos uenditis? An non ut gallina ita et missa uno mercatur denario? Heu confusionem uestram! Turpe est dicere et nimis terribile cogitare cum, sicut supra dictum est13, ilia benedictio in maledictionem conuertitur. Adeo ut non sacerdos sed hereticus habeatur. Quis igitur amplius heretici audiat missam, cuius non licet uel ire ad mensam? [f. 93v]. Aut quomodo licet de eius manibus carnem Christi fedelibus sumere, cum quo nec panem debent manducare, non simul
loqui, non simul orare?14 Vnde, sicut aperte cognoscitis sed nequaquam timetis, sacrii apostolorum canones terribiliter dicunt: ? Si quis episcopus, abbas, presbiter aut diaconus per pecuniam hanc obtinuerit dignitatem, deiciatur ipse et hordinator eius, et a communione sancta modis omnibus abscidatur et sit anathema sicut
Symon Magus a Petro ?15. Vnde et illud euidenter cognoscitur, quia qui anathe mate percutitur, non tantum sacerdotio cadit, sed insuper laica communione
priuatur.
Vos autem dum sententiam iuste excommunicationis effugitis, quia in hoc se culo sempre honorari et pessime ditari cupitis, secundum beati Prosperi senten
tia(m), sine causa communicatis, immo dupliciter in uos Dei iracundiam prouo eatis16. Cum si libenter canonicam uindictam et patienter susciperetis et a uestro modo honore cessaretis, non solum commissa peccata redimeretis, sed etiam pro hac ipsa humilitate et patientia sempiterna gaudia et premia caperetis, dicente Do mino : ? Quia omnis qui se exaltat humiliabitur, et qui se humiliat exaltabitur ?17.
Alioquin cum Deus discipulis dicat: ? Quodcumque ligaueritis super terram, liga tum erit et in celo ?18. Quis uos poterit a predicti anathematis soluere uinculo, quod ipsorum apostolorum ligatur eloquio? Sunt autem qui dicunt quendam Pollochro nium super hoc crimine depositum et iterum post depositionem suo hordini resti
tutum, et tamen non negant eius accusatores in eodem concilio et uera dixisse et
12 Mt. 21.12, Lc. 19.45. Tuttavia pare di poter eogliere ancora Gregorio Magno, Reg. 9.219
(CCL 140A.784.45-55). 13 v. supra, n. 4. 14 Per queste espressioni che delimitano il rapporto con l'eretico e con lo scomunicato, si
vedano i canoni attestati, ad esempio, nel libro XI del Decretum di Burcardo, e, in particolare, Burch. 11.31: ? Cum excommunicato neque orare neque loqui / neque vesci cuique liceat?; Burch. 11.33: ? Cum excommunicato nullus loquatur... ?; Burch. 11.38: ? Nullus . .. cum eis in oratione aut cibo vel potu aut osculo communicet?; cfr. anche Htjmberttts card., Adversus
symoniacos, 11 (MGH Ldl 1.116-117). 15 Canones Apostdlorum, c. 30 (PL 67.114). Per la diffusione del canone in collezioni cano
niche, vedi supra, p. 203, c. 1. 16 Ps-Prosper = Iulianus Pomerius, Be vita contemplativa, 2.7.3 (PL 59.452). Anche
le espressioni immediatamente successive sembrano mutuate a questo capitolo del De vita con
templativa. 17 Lc. 14.11, 18.14. 18 Mt. 16.19. 19 Per l'episodio di Policronio nella tradizione canonistica, cfr. 5L 2.104-105 (CCLcm 6.242
246), anche se in un contesto di ? restauratio honoris ?. E altrettanto significativo mi pare il ri
ferimento, sempre alia figura di Policronio, che si legge in Pier Damiani, Liber gratissimus, 17 17 (MGH Ldl 1.40-41), secondo cui Policronio, vescovo di Gerusalemme, e Anatolio, vescovo
di Costantinopoli ? post scelerata primordia bene conversi dignos se suis honoribus ostenderunt ?
(e la rubrica al cap. 17 dell'opera dell'avellanita). Pare che questa coincidenza tra 5L e il Liber
gratissimus aggiunga un ulteriore tassello alle fonti canonistiche di Pier Damiani, che sono state
poste nella dovuta evidenza da J. J. Ryan, St. Peter Damiani and his canonical sources, Toronto 1956.
This content downloaded from 195.34.79.176 on Mon, 16 Jun 2014 08:07:26 AMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions

212 G. MOTTA
condempnatos esse, quia quasi summum pontificem accusauerunt19. Cum beatus
Gregorius, quern docente per reuelationem saneto Spiritu, omnia sua documenta fecisse euidentissimis constat inditiis, non solum inueniatur subiectorum ueras ac cusationes accepisse, sed etiam ab accusatione se retralientes digna pena, id est honoris multasse periculo20. Et ut supra iam diximus, a quocumque clerico episco pus ueraciter fuerit aceusatus, potest sui honoris sine dubio subire periculum. Et Maximiano quidem Salonitiano episcopo, multa crimina commissa paruipendens, [f. 94r] idem sanctus papa Gregorius numquam aliter communicauerit, nisi iureiu rando firmaret symoniacam heresim non teneri21. Sed utique qui ipsius Pollochronii iactant restitutionem eius imite(n)tur conuersionem. Nam qui prius appetebat cri
mine aliena, cum magna laude pietatis pauca que sibi deposito remansera(n)t di stribuit sua. Non autem negamus poenitus restitui posse depositum22, presertim si tanta incumbat necessitas23, ut alius inueniri non possit, qui populorum possit ita retinere dominium ut ipse populus suum ualeate uitare periculum euadamus. Nam et ipse hoc Gregorius in libris moralibus testatur dicens: ? Quia cum quelibet ciuitas
igne comburitur, si portarum non patet aditus, inde se quisque precipitat ubi minor murus inuenitur ?24. Deinde sunt multi qui hac se arte defendentes decipiunt, ut dicant: ?Nos quidem pro consecratione nil dedimus et beneficia ecclesiarum (con cupiuimus) nam ipsas ecclesias comparauimus?, cum non solum comparare sed etiam concupiscere in summo sit crimine. Nam eo ipso, quo quisque magis honorem
querit, indignus est. Ita enim pecunia denotatur propter concupiscentiam, sicut gla dius9 propter cedem. Alioquim si quis gladium non habeat et tune proximum ma nibus occidat, crudelior est eo qui gladium portat.
? gladium ms.
20 Cfr. Gregoritjs M., Reg. 5.57 (CCL 140.351-353). 21
L'episodio si legge nella Vita sancti Gregorii, 4.9 (PL 75.177) di Giovanni Diacono; ma ancor piu. significativo e il fatto che anche nella 5L 2.106 (CCcm 6.247-248) l'episodio di Massimo
(e non Massimiano, come nel nostro testo) si accompagna a quello di Policronio. 22 E il problema della ? restauratio posto lapsum ? o a seguito di condanna. A titolo esem
plificativo si vedano i riferimenti di 5L 2.80-106; Burch. 19.78^80, Ans. 8.18-21, 8-32-33. 23 Anche in questo caso siamo in presenza della tematica della ? dispensatio ? o della ? di
scretio ?. Su questo importante aspetto si veda la penetrante analisi di G. M. Cantarella, Sondaggio suila ? dispensatio ?, in Chiesa, diritto e ordinamento delta ? societas Christiana ? nei secoli XI-XII, ? Atti della nona Settimana internazionale di studio (Mendola, 28 agosto-2 set tembre 1987) ?, Vita e Pensiero, Milano 1986, pp. 461-485.
24 Gregorius M., Moralia in Job, 32.20.39 (CCL 143B. 1658.77-83). II brano risulta presente anche in alcune collezioni canoniche: Burch. 12.29; 183T 164.8; Ivo D 12.84; e nella libellistica: Plactdtjs Nonant., Liber de honore ecclesiae, 132 (MGH Ldl 2.629); Algerus Leod., Liber de misericordia et iustitia, 1.16 (ed. R. Kretzschmar, Alger von Luttichs Traktat ? De misericordia et iustitia ?, Thorbecke, Sigmaringen 1985 (Quellen und Forschungen zum Reeht im Mittelalter, 2), Probabilmente a questo e al precedente brano di Gregorio Magno fece riferimento Pier Damiani, nel Liber gratissimus, 33 (MGH Ldl 1.67.13-21) :ilDe Heinemann (p. 67) dice di non averli trovati ? neque in Moralibus Job neque in aliis libris Gregorii ?.
Ill - IL COD. LAUR. PLUT. XXI DEXT. 12
II terzo codice in ordine di collocazione ? Plut. XXI dext. 12 ? e certamente
piu degli altri legato alia canonica della pieve di Sant'Appiano; nelPinsieme si con
figura proprio come nno di quei manoscritti che il Fonseca ha posto a base della sua
This content downloaded from 195.34.79.176 on Mon, 16 Jun 2014 08:07:26 AMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions

POLEMICA ANTISIMONIACA NEI SECC. XI-XII 213
ricerca sulle consuetudini canonicali d'ltalia28. Va pertanto detto subito che secondo
quella accreditata metodologia il codice di Sant'Appiano, del tutto canonicale, do vrebbe essere oggetto di una attenta descrizione in tutte le sue parti.
Intanto pero un rapido esame ci puo aiutare ad individuare la presenza di testi
significativi in ordine alia condanna della simonia, secondo l'indicazione offerta dal Violante.
All'inizio del codice (ff. lr-109r) si legge, come gia osservo il Bandini, YInstitutio canonicorum Aquisgranensis dell'816 che divenne il testo normativo maggiormente diffuso negli ambienti canonicali. In qualche caso, dopo la denuncia di Ildebrando al sinodo lateranense del 1059 a causa delle concessioni in materia di proprieta pri vata, fu anche trascritta ? come ha indicato il Fonseca ? senza alcuni capitoli giudicati con severita dai riformatori29. Nel caso del codice di Sant'Appiano si ha invece una trascrizione integrale30.
Alia Institutio segue, nei ff. 109v-116r, una serie di testi di san Gregorio Magno, ? ubi ? secondo l'espressione del Bandini ? de hereticis precipue agitur ?31. A questi testi ha inteso certamente riferirsi il Violante nella sua indicazione. In realta, in quei fogli, dopo un ?Incipit textus eiusdem Gregorii?, si leggono brani iniziali del libro terzo della Vita Gregorii Magni scritta da Giovanni diacono, dove Pautore ricorda
proprio i provvedimenti piu significativi e intransigenti presi dal papa per liberare la Chiesa da ogni pratica simoniaca, specialmente nelle ordinazioni e nella vita dei sa
cerdoti32. Ricorrono in queste poche pagine della Vita gregoriana i brani piu incisivi del suo epistolario per la condanna della simonia, quei medesimi che si leggono anche nel breve sermone conservato nell'altro codice di Sant'Appiano (Plut. XIX dext. 8) e sopra trascritto.
Questi brani gregoriani, appunto tra i piu efncaci per la condanna della simonia,
possono senz'altro riflettere la mentalita della canonica della Valdelsa, in quanto tra
gli altri testi che compongono il codice e che seguono i brani della Vita di Gregorio, vi sono anche alcune preghiere per i vari momenti della vita canonicale: in una di
queste preghiere (f. 127v) ci si rivolge proprio al santo titolare della pieve: ? Ora
28 C. D. Fonseca, Medioevo canonicale, Vita e Pensiero, Milano 1970 (Pubblicazioni del
l'Universita Cattolica del S. Cuore, Contributi, s. 3a. Scienze storiche, 12), pp. 78 ss. 29
Ibid., pp. 78, 80, 171. 30 Come si puo faeilmente rilevare eonfrontando il testo del codiee fiorentino con Institutio
canonicorum Aquisgranensis, ed. A. Werminghoff, MGH Cone. 2/1, Hannoverae et Lipsiae 1906
pp. 308-421. L'editore inserisce nell'elenco dei codici il nostro, datandolo genericamente XII, XIII secolo.
31 Bandini, Catalogue, col. 602; a questa descrizione del codice (col. 601-604) rinvio per tutti
gli altri testi. Una nuova descrizione si impone per inserire anche questa testimonianza nella
raccolta dei manoscritti in vista di una ricomposizione del 'Corpus' delle consuetudini canonicali
italiane. A questo codice fa riferimento anche H, Mordek, Kirchenrecht und Reform im Franken
reich: die Collectio Vetus Callica, die alteste systematische Kanonessammlung des frankischen Gal
lien: Studien und Edition, W. De Gruyter, Berlin-New York 1975, p. 374. 32 Joannes Diacontjs, Sancti Gregorii Magni vita 3.1-5 (PL 75.125B-132A). In realta al
f. 115v il brano di Gregorio viene troncato per la caduta di un foglio; infatti al f. 116r si riprende con un altro brano della medesima Vita di Gregorio Magno, ?IJnde Scolastico duci Campanie scribens ait: Dum de Neapolitane civitatis / refugiens civitatem ipsam, ordinationem ? (PL
75.133D), con il quale tormina, nel codice, la parte desunta appunto dalla Vita Gregorii Magni di Giovanni Diacono. Si avverta inoltre che nel medesimo manoscritto (ff. 117r-123v) si legge buona parte del De ecclesiasticis dogmatibus (capp. 1-4: PL 42.1213-1220) di Gennadio: in questo caso l'opera viene presentata come Liber sententiarum sancti Augustini episcopi contra LXXVI*
hereses.
This content downloaded from 195.34.79.176 on Mon, 16 Jun 2014 08:07:26 AMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions

214 G. MOTTA
pro nobis, beate Apiane, etc ?. Non vi sono pertanto dubbi sulla appartenenza del codice alia canonica della pieve di Sant'Appiano in Valdelsa; rinserimento delle severe condanne della simonia sono una spia per intuire come anche la Chiesa del contado sia stata, in qualche caso almeno, coinvolta nell'impegno per la riforma della ? Societas Christiana ? tra XI e XII secolo accanto ai piu intransigenti riformatori.
Giuseppe Motta
This content downloaded from 195.34.79.176 on Mon, 16 Jun 2014 08:07:26 AMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions
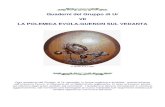






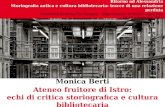







![[] IL PROGETTO FILIERA CORTA NELLEMPOLESE VALDELSA.](https://static.fdocumenti.com/doc/165x107/5542eb5d497959361e8cbc5f/-il-progetto-filiera-corta-nellempolese-valdelsa.jpg)