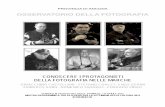[eBook - Fotografia - ITA - PDF] Conoscere le pellicole.pdf
-
Upload
adele-alba -
Category
Documents
-
view
35 -
download
3
description
Transcript of [eBook - Fotografia - ITA - PDF] Conoscere le pellicole.pdf
![Page 1: [eBook - Fotografia - ITA - PDF] Conoscere le pellicole.pdf](https://reader031.fdocumenti.com/reader031/viewer/2022020208/55cf9b14550346d033a4a702/html5/thumbnails/1.jpg)
Non si può parlare di pellicole vere e pro-prie se non dopo il 1871, quando il medi-co inglese Richard Maddox scopre la pri-ma emulsione al bromuro d’argento e ge-latina: un deciso miglioramento rispetto al-l’allora imperante collodio. Il veicolo ge-latina mantiene - a differenza dal collodio- le caratteristiche di sensibilità allo statosecco, e per lunghissimo tempo. È la svol-ta decisiva, che fa decollare la fotografia:il materiale sensibile può essere preparatodall’industria, che lo mette a disposizionedi quanti erano stati fino ad allora costret-ti a produrlo in proprio. Al tempo di Maddox il supporto era inva-riabilmente il trasparente vetro, ed è soloalla fine del secolo XIX che si rendono di-sponibili emulsioni stese su nitrocellulosa,del pari trasparente, ma molto più leggerae, soprattutto flessibile, tanto da permet-terne l’avvolgimento in rulli. Fino ad og-gi, per circa 100 anni, rulli ed emulsionegelatina-bromuro sono rimasti dei punti fer-mi della fotografia. L’esplosiva nitrocellu-losa è stata poi sostituita dall’acetilcellu-losa, più inerte e molto stabile dimensio-nalmente.Dall’inizio del secolo XX, le emulsioni al-l’AgBr-gelatina hanno subito un costante,eccezionale progresso. Le loro proprietà sidividono in due categorie: a - caratteristiche macroscopicheb - caratteristiche microscopicheAlla prima categoria appartengono: sensi-bilità, sensibilità spettrale, macrocontrasto;alla seconda: granulosità, risolvenza, niti-dezza, microcontrasto. Tali caratteristiche dipendono in qualche
modo l’una dall’altra e vengono anche in-fluenzate dall’esposizione, in relazione conil processo di trattamento del materiale. Inparticolare, nel B/N, esposizione e tratta-mento sono strettamente connessi, e per-mettono una scelta di valori diversi, in re-lazione con il tipo di soggetto. Questo ap-proccio, che è alla base della filosofia delSistema Zonale di Ansel Adams, è oggi di-verso da quello dei tempi di Ansel Adams,per le migliorate caratteristiche del mate-riale sensibile, specie in termini di ripro-ducibilità e di tolleranze, molto più ristret-te di quelle di allora.
Caratteristiche macroscopicheSono quelle che maggiormente influenza-no l’aspetto visivo immediato, che non ri-corra a un esame fine, ravvicinato, del-l’immagine. La sensibilità del materiale- specie da ripresa - è la proprietà più inte-ressante, quella che ha permesso di passa-re dai pochissimi ISO del secolo scorso,agli attuali tirati 50.000/38... un bel gua-dagno! Il progresso però non si arresta, ma proce-de anche nelle altre direzioni. La primaemulsione alla gelatina-bromuro di Mad-dox è sensibile nell’UV, nel blu e nel ver-de - poco più di 550nm - e quindi non puòrendere tutte le diverse tonalità cromatichedel soggetto in altrettanti toni di grigio, conun rapporto che riproduca con una certa fe-deltà quanto visto dall’occhio. Ai primi del ’900 si scoprono alcuni colo-ranti che permettono l’estensione al rossodella sensibilità spettrale e, successiva-mente, anche all’infrarosso vicino. Dalle
emulsioni ortocromatiche dei primi tempi,si giunge alle pancromatiche e alle super-pancromatiche, con una sensibilità spet-trale sempre più spinta verso le alte lun-ghezze d’onda. Sono recentemente riapparse le emulsioniortocromatiche, cieche al rosso, le unichedisponibili ai tempi dei primi film di Char-lie Chaplin, quando le labbra degli attoririsultavano molto più scure del lecito. Nonmi pare di particolare interesse l’uso delleemulsioni ortocromatiche; ritengo che siadi gran lunga preferibile disporre di un’am-pia sensibilità spettrale, per correggere larisposta - se lo si desidera - con opportunifiltri. Una pancromatica usata con un filtroblu - che elimina più o meno la frazionerossa - produrrà una risposta corrispondentea quella di un’ortocromatica; è questa la ra-gione per cui le maggiori case hanno ab-bandonato da tempo la produzione delleemulsioni ortocromatiche. Il mercato offrecomunque materiali a diversa sensibilitàspettrale: la Technical Pan 2415 della Ko-dak e la SFX 200 dell’Ilford per esempiosono dotate di una risposta più estesa nelrosso - i tetti delle case e le labbra delle per-sone vengono resi più chiari del normale -rispetto alle altre emulsioni, più conven-zionali. Il macrocontrasto è un elemento di estre-ma importanza, non solo creativa, ma an-che tecnica, perché permette di alterare ilrapporto tonale chiari/scuri dell’immagi-ne, e ritorniamo qui nell’ambito del Siste-ma Zonale di Ansel Adams. Sovraespo-nendo e sottosviluppando, si produce unmacrocontrasto inferiore a quello che si
CONOSCERE LE PELLICOLESensibilità, macrocontrasto, granulosità, risolvenza, nitidezza, microcontrasto:
una risposta a queste domande fondamentali.
L’ESPERTO RISPONDE
![Page 2: [eBook - Fotografia - ITA - PDF] Conoscere le pellicole.pdf](https://reader031.fdocumenti.com/reader031/viewer/2022020208/55cf9b14550346d033a4a702/html5/thumbnails/2.jpg)
avrebbe con esposizione e sviluppo nor-mali, mentre la sottoesposizione con so-vrasviluppo produce un macrocontrasto piùelevato. È bene ricordare che il sottosviluppo, quan-do si sovraespone, serve sostanzialmente aimpedire un’eccessiva densità del negati-vo, mentre il sovrasviluppo, nella sottoe-sposizione, serve a recuperare densità. Que-ste caratteristiche si riferiscono natural-mente al B/N: nel colore il macrocontrastoè sostanzialmente imposto dal soggetto edalla sua illuminazione, anche se è possi-bile una modesta influenza sul macrocon-trasto, sviluppando di più o di meno.
Caratteristiche microscopicheSi riferiscono alla struttura fine dell’im-magine, quella che può essere in genere ap-prezzata solo con l’ingrandimento anchespinto o con una lente. Sono grandezze in-timamente legate fra loro, nel senso chenon è possibile modificarne una, senza cheanche le altre subiscano una qualche alte-razione. L’atteggiamento del fotoamatore verso lagranulosità è generalmente negativo: la gra-na, come si dice di solito, viene quasi sem-pre considerata un elemento non gradito, etroppo spesso si fa di tutto per evitarla. Trop-
po spesso, perché - oltre a essere talvoltaun fattore che contribuisce favorevolmen-te all’estetica dell’immagine - i trattamen-ti del negativo che riescono a diminuirlagenerano quasi sempre una riduzione delmicrocontrasto, e quindi della nitidezza. Èil tipico caso dei rivelatori cosiddetti fine-granulanti, per esempio a base di solventidell’argento, come il Microdol-X Kodak,o di altri - fondati su altri principi - comeil vecchio Promicrol della May & Baker.Con i finegranulanti si ottiene una granamolto fine, ma il confronto con i risultatiottenibili con un bagno più convenzionalemostra chiaramente la notevole perdita didettaglio prodotta dai primi rispetto a unrivelatore classico, come ad esempio il D-76. È un ingrandimento correttamente ese-guito, solo quello che arriva a produrre tut-ta la granulosità presente sul negativo. Chinon ama la grana deve provvedere diver-samente, scegliendo un materiale di minorsensibilità; i cristalli di alogenuro più pic-coli, oltre a mostrare ovviamente una gra-na inferiore, sono meno efficienti nel rac-cogliere la luce, e quindi inducono una sen-sibilità più bassa. Un deciso miglioramen-to di questa caratteristica si è avuto con lamessa a punto dei cristalli tabulari, che han-no originato in casa Kodak i materiali T-
Max e, alla Ilford, i negativi Delta. Granulosità, risolvenza, nitidezza, micro-contrasto. Anche nel caso dei cristalli ta-bulari – pur con un netto miglioramento digrana rispetto alle emulsioni convenziona-li - il valore della granulosità è direttamenteproporzionale alla sensibilità: la 400/27 èpiù granosa della 100/21. In realtà, la for-ma piatta, a maggior superficie, dei cristallitabulari aumenta la probabilità di raccoltadei fotoni luminosi; ne consegue aumentodella sensibilità che permette, a pari sensi-bilità, di ottenere un grana più fine, e nonè un gioco di parole! La granulosità in-fluenza anche il potere risolvente e, alme-no in parte, la nitidezza. È facile capire co-me gli aggregati d’argento metallico piùpiccoli possano definire meglio il contor-no dei particolari fini, contribuendo in talmodo alla nitidezza. Sotto questo profilo sispiega anche la diminuzione di nitidezzache si lamenta quando si fa uso dei rivela-tori finegranulanti: i bordi degli aggregaticristallini più sfumati sono meno efficacinel disegnare i contorni dei particolari fi-ni. È bene riflettere su questi concetti, ca-ri amici.
Giampaolo Bolognesi



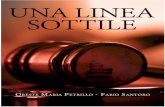



![[Megafileupload]eBook Di Fotografia Profession Ale](https://static.fdocumenti.com/doc/165x107/557201574979599169a15515/megafileuploadebook-di-fotografia-profession-ale.jpg)

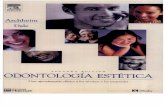



![[eBook - Fotografia - ITA - PDF] Conoscere La Luce1](https://static.fdocumenti.com/doc/165x107/557201694979599169a1838e/ebook-fotografia-ita-pdf-conoscere-la-luce1.jpg)

![[eBook - Fotografia - ITA - PDF] La Stampa Del Bianco e Nero](https://static.fdocumenti.com/doc/165x107/5571fe4e49795991699b1a83/ebook-fotografia-ita-pdf-la-stampa-del-bianco-e-nero.jpg)