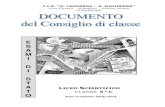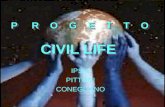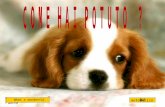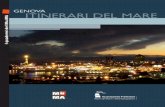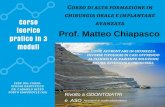E S A M I D I S T A LICEO SCIENTIFICO T CLASSE 5^C O · I.I.S. “G. Leopardi - E. Majorana”...
Transcript of E S A M I D I S T A LICEO SCIENTIFICO T CLASSE 5^C O · I.I.S. “G. Leopardi - E. Majorana”...
I.I.S. “G. LEOPARDI – E. MAJORANA” Liceo Classico – Scientifico – Scienze Umane
PORDENONE
LICEO SCIENTIFICO
CLASSE 5^C Anno scolastico 2016/2017
E S A M I
D I
S T A T O
I.I.S. “G. Leopardi - E. Majorana” Classico - Scientifico – Scienze Umane
P O R D E N O N EP O R D E N O N E
COMPOSIZIONEDELCONSIGLIODICLASSE A.S.2016-2017
5^CSCIENTIFICO
MATERIADIINSEGNAMENTO
DOCENTE
ITALIANO CESCONROBERTOLATINO DURIGONMARCOFILOSOFIA TONDOCLAUDIOSTORIA TONDOCLAUDIOINGLESE BOZZOLAGIULIAMATEMATICA PILOSIOSUSIFISICA PILOSIOSUSISCIENZE CAPPELLARICCARDADISEGNOESTORIADELL'ARTE RUSSIRENATOSCIENZEMOTORIEESPORTIVE ETRARIPAOLARELIGIONE TAGLIAPIETRAMARCO
COORDINATOREDICLASSEPILOSIOSUSI
VERBALIZZANTETAGLIAPIETRAMARCO
STUDENTIRAPPRESENTANTIDICLASSE CAPELLIVALERIA
VELLUDOFRANCESCOGENITORIRAPPRESENTANTIDICLASSE POLESFLAVIA
SETTEFRANCESCA
DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO
CLASSE VC SCIENTIFICO
a.s 2016/17
PRESENTAZIONE DELLA CLASSE
La classe VC dell’indirizzo scientifico è composta da 20 allievi (8 ragazzi e 12 ragazze), di cui uno proveniente da un altro Istituto. Nel corso del triennio le lezioni si sono svolte in un clima generalmente sereno, anche se non sono mancati momenti di tensione tra studenti e con i docenti. Se i rapporti tra insegnanti e studenti si sono mantenuti quasi sempre corretti e rispettosi delle regole della convivenza democratica, tuttavia la costruzione di un dialogo autentico è risultata complessivamente problematica per una certa rigidità e difficoltà degli alunni a ritagliarsi un ruolo attivo nelle diverse situazioni di apprendimento. Nonostante le difficoltà incontrate, tra allievi e docenti non è mai mancato il dialogo e la volontà di trovare un punto d’incontro. Dal punto di vista didattico, la classe ha incontrato numerose difficoltà soprattutto nel passaggio dal biennio al triennio, dovute sia alla complessità dei programmi svolti sia alla necessità di acquisire un metodo di studio più
costante ed efficace. Nel corso degli anni gli insegnanti hanno modificato approcci e strategie per coinvolgere gli studenti, renderli più attivi e partecipi all’attività didattica e per sollecitare un metodo di studio più critico ed efficace; in alcuni casi sono stati limitati gli interventi didattici finalizzati ad approfondimenti e all’esame critico di alcuni nuclei tematici. Gli allievi hanno capito le difficoltà che le diverse discipline implicano e si sono in genere adoperati per lavorare in modo migliore in classe e interagire in modo più costruttivo con gli insegnanti. La capacità di consolidare un metodo di studio critico ed efficace, costante e approfondito, migliorando l’autonomia operativa attraverso la pianificazione del proprio impegno, è stato uno degli obiettivi perseguiti nel corso dell’intero triennio. Da sottolineare che durante quest’ultimo anno scolastico anche gli allievi più fragili o meno motivati hanno via via migliorato il loro metodo di lavoro e cercato di sfruttare adeguatamente le proprie potenzialità per raggiungere una preparazione culturale adeguata ad affrontare l’Esame di Stato. Il raggiungimento delle conoscenze e delle competenze disciplinari può ritenersi complessivamente soddisfacente ma piuttosto eterogeneo a causa
dei diversi livelli della preparazione di base e di un metodo di lavoro non sempre adeguato, condizionato dal diverso grado di interesse e d’impegno nelle singole discipline. All’interno di un quadro complessivamente positivo, vanno perciò segnalati percorsi individuali di eccellenza e altri caratterizzati invece da alcune difficoltà. Accanto da un piccolo gruppo di alunni che dimostra una conoscenza esauriente e ben organizzata dei temi e dei fenomeni studiati, oltre a una discreta capacità critica, permane un gruppo di studenti che risulta ancora piuttosto fragile nei contenuti e nelle competenze acquisite, soprattutto nelle materie scientifiche. Nella classe è presente un allievo BES. In allegato la documentazione riservata. OBIETTIVI EDUCATIVI E DIDATTICI COMUNI
Gli obiettivi comuni che gli insegnanti avevano concordato all’inizio dell’anno scolastico sono stati mediamente raggiunti dagli studenti, anche se con diverse gradualità:
favorire la convivenza proficua all’interno della classe e della scuola, educando al rispetto verso le persone e l’ambiente che ci circonda, alla tolleranza e alla collaborazione
consolidare un atteggiamento responsabile e attivo nelle diverse situazioni di apprendimento
consolidare un metodo di studio critico ed efficace, costante e approfondito, migliorando l’autonomia operativa attraverso la pianificazione del proprio impegno e l’autovalutazione del proprio profitto
consolidare la capacità di analizzare e interpretare testi e risolvere problemi
migliorare la ricchezza lessicale e le capacità espressive in genere, anche con l’uso di un linguaggio appropriato e specifico per le diverse discipline
stimolare e migliorare la capacità di operare collegamenti tra le varie discipline
favorire l’interesse per tematiche culturali e problematiche della realtà contemporanea
METODOLOGIE DI LAVORO
Proprio per stimolare un atteggiamento responsabile e attivo degli studenti nelle diverse situazioni di apprendimento, è stato dato spazio, accanto alla lezione tradizionale ad attività che hanno visto coinvolti attivamente gli studenti: lezioni dialogate, lavori di gruppo o di cooperative learning,
presentazione di approfondimenti personali, ricerche bibliografiche e in rete, uso dei laboratori, uso degli strumenti informatici e audiovisivi, partecipazione a conferenze e ad attività extrascolastiche. Le attività di recupero sono state svolte per quanto possibile nell’orario curriculare; anche le interrogazioni e le correzioni delle verifiche hanno rappresentato momenti significativi per la revisione ed il chiarimento degli argomenti svolti. Sono stare inoltre svolte alcune ore di matematica e inglese e un corso di approfondimento di Matematica, in vista della preparazione della seconda prova dell’Esame di Stato. In vista dell’Esame di Stato sono state fornite alla classe indicazioni su come fare e strutturare una ricerca e scrivere una tesina; i docenti si sono resi disponibili a seguire gli studenti nella stesura dei loro lavori. Il Consiglio di classe ha messo in atto strategie di didattica inclusiva.
CRITERI DI VERIFICA E DI VALUTAZIONE
Le verifiche sono state costanti ed in congruo numero. Sono state articolate in forma diversa a seconda della disciplina, tenendo conto anche delle tipologie previste per l’Esame di Stato. In particolare, nel corso dell’anno, sono state svolte: - due simulazioni di Prima Prova dell’Esame di Stato, comuni a tutte le quinte scientifico - tre simulazioni di Seconda Prova dell’Esame di Stato, comuni a tutte le quinte scientifico - due simulazioni di Terza Prova (tipologia B, tre quesiti a risposta singola). Ciascun insegnante ha comunicato agli studenti argomenti e tipologie delle verifiche, esplicitando i criteri di valutazione. Si è evitato, di norma, la coincidenza di più verifiche scritte nella stessa giornata, indicando in anticipo il calendario delle prove scritte sul registro di classe. Nell’assegnazione del voto conclusivo in ciascuna disciplina si terrà conto anche del diverso peso e della diversa difficoltà delle varie prove. La valutazione finale si baserà sui risultati delle prove di verifica, tenendo conto anche dei lavori di approfondimento personale, dell’interesse, della partecipazione alle diverse attività didattiche, dell’impegno profuso sia in classe che nello studio pomeridiano e dei miglioramenti ottenuti nel corso dell’anno in base al livello di partenza.
PROGETTI DIDATTICI ED EDUCATIVI La classe è stata coinvolta in diverse attività educative annoverate dal PTOF d’Istituto, su iniziativa dei singoli insegnanti: Attività di Pordenone-Legge Progetto Voce donna, sulla violenza sulle donne Progetto educativo De Gasperi: “Il coraggio di costruire” Visita al reparto di Radioterapia del CRO e conferenza su “L’uso delle radiazioni elettromagnetiche in campo medico” Visita all’Ecomuseo delle acque del Gemoneto Uno studente ha partecipato alla Summer School di Filosofia e Teoria Critica alcuni studenti hanno partecipato alle attività del Parlamento Europeo Uno studente ha partecipato ad uno Stage presso l’Università di Trieste di Fisica (mese di Settembre); alcuni studenti hanno partecipato ad alcune conferenze di Fisica presso l’Università di Trieste Corso di yoga di 4 lezioni (svolto con insegnante esperta esterna) Progetto "Keep the beat" sulla rianimazione cardiopolmonare (svolto per 2 ore da tutta la classe) più l'utilizzo del defibrillatore (altre 3 ore svolto da 10 alunni) Progetto "Ti voglio donare" sulla donazione del sangue (a cui hanno aderito 6 alunni) Visita didattica nel territorio di Gemona, con un geologo (per approfondire tematiche legate alla sismicità del territorio) e un architetto (per analizzare le diverse modalità di ricostruzione messe in pratica a Gemona e a Venzone dopo il terremoto del 1976) Viaggio d’istruzione in Grecia Da segnalare inoltre che: - diversi studenti hanno svolto attività sportive, che li hanno impegnati in diversi giorni della settimana - tre allievi hanno seguito per 5 anni i corsi pomeridiani IGCSE (inglese potenziato in ambito scientifico) e quest’anno hanno sostenuto gli esami di matematica e biologia - diversi studenti hanno seguito i corsi di approfondimento di biologia organizzati dalla nostra scuola, in vista dei test di ammissione all’Università - diversi studenti hanno seguito i corsi di ECDL; diversi studenti hanno seguito i corsi e sostenuto gli esami di certificazione linguistica inglese (PET, FIRST e uno studente IELTS) e spagnola (DELE) - alcuni studenti hanno svolto il corso per la certificazione BLSD.
ATTIVITA’ CLIL - La classe ha aderito in parte al progetto “GTL MIT”. Gli studenti, durante il mese di gennaio hanno partecipato ad una conferenza sulla robotica, tenuta da uno studente tirocinante di madrelingua inglese proveniente dal M.I.T. di Boston – USA - Alcune attività con metodologia CLIL sono state svolte durante le ore di educazione fisica del Primo Quadrimestre, grazie alla presenza di due ragazze americane che frequentavano la nostra scuola. -La classe ha partecipato all’attività organizzata dal Parlamento Europeo Giovani "Understanding Europe"
La coordinatrice di classe Prof.ssa Pilosio Susi
ITALIANO Prof. ROBERTO CESCON
SITUAZIONE DELLA CLASSE
Si rimanda alle indicazioni generali e alle competenze trasversali della Premessa. Si evidenzia inoltre che la classe:
· ha acquisito una conoscenza più che sufficiente delle linee essenziali di storia letteraria, con riferimento agli autori e ai testi più significativi;
· è in grado di leggere e interpretare in modo adeguato i testi letterari proposti durante l’anno;
· sa contestualizzare i testi letterari, ponendoli a confronto con opere dello stesso autore, ambito culturale, genere letterario, con esiti diversificati e mediamente sufficienti;
· sa esporre oralmente gli argomenti studiati con esiti differenziati, ma pressoché discreti;
· conosce le caratteristiche delle tipologie di testo scritto previste dalla prima prova d’esame e sa produrre abbastanza corretti nella forma, ma con una sintassi non sempre pianificata, non molto esaurienti nelle argomentazioni e in qualche caso poco appropriati nel lessico.
PIANO DEL LAVORO SVOLTOEDUCAZIONE LETTERARIA
Moduli e unità didattiche Testi
ELEMENTI DI POESIA DELL’OTTOCENTOIl Decadentismo La visione del mondo: r i f iuto del posi t iv ismo, c o r r i p o n d e n z e , p a n i s m o , maledettismo. La poetica: estetismo, rivoluzione del linguaggio poetico (musicalità, analogia, simbolismo, sinestesia). Il rapporto tra l’artista e il pubblico.
B a u d e l a i r e , L ’ a l b a t r o s , Corrispondenze, Spleen. Rimbaud, Vocali, Il battello ebbro; Lettera del veggente. Verlaine, Languore, Canzone d’autunno, Arte poetica.
D’ANNUNZIO. La vita come opera d’arte, le Laudi, i l panismo, le innovazioni musicali.
La sera fiesolana; La pioggia nel pineto; Le stirpi canore.
PASCOLI. Biografia e visione politico-sociale. Il fonosimbolismo e la poetica del fanciullino, il sublime delle piccole cose, la tematica della morte, il nido e i l s ign i f ica to de l naz ional ismo pascoliano.
Lettura da Il fanciullino; Da Myricae: Lavandare; X Agosto; L’assiuolo; Novembre; Temporale; Il lampo; Il tuono. Dai Canti di Castelvecchio: Il gelsomino notturno; Da Primi poemetti: Italy. Da Nuovi poemetti: La vertigine.
IL ROMANZO NELL’OTTOCENTOIl Naturalismo francese e il verismo italiano. Il contesto storico-culturale e la poetica: progressismo, positivismo e darwinismo. GIOVANNI VERGA . La tecnica narrativa (eclisse dell’autore, la regress ione, lo s t ran iamento) . L’ideologia (il pessimismo, l’ideale dell’ostrica, il conservatorismo). I rappor t i con i l pos i t i v i smo, i l darwinismo sociale, la fiumana del progresso. La produzione: dai romanzi pre-veristi alla svolta di Rosso Malpelo al progetto dei Vinti. I Malavoglia: il con f l i t t o ‘N ton i -padron ‘N ton i , modernità e tradizione, la struttura narrativa bipolare (il coro di Aci Trezza tra valori puri e cinismo). Mastro don Gesualdo : i l self made man e l’interiorizzarsi del conflitto valori-economicità.
Lettura da Il romanzo sperimentale di Zola. Lettera dedicataria a Salvatore Farina [ne L’amante di Gramigna]; Rosso Malpelo; La roba; Prefazione a I Malavoglia.
Il romanzo decadente: D’Annunzio, l ’ es te t i smo e l a pa rabo la de l superuomo; il romanzo psicologico e l’indiretto libero.
IL RAPPORTO TRA L’IO E LA REALTÀ NELLA POESIA DELLA PRIMA METÀ DEL NOVECENTOLa crisi dei fondamenti culturali e scientifici, il contesto storico.
Le avanguardie: la frattura con il pubblico e con la tradizione, l’arte come attività di gruppo, il ruolo delle riviste, il rapporto con la politica, l’autonomia del linguaggio, l’interartisticità.
Crepuscolarismo: la definizione di Borgese, contenuti e forme dimesse, il kitsch, il grado zero della scrittura, le innovazioni metriche, la parodia delle mitologie dannunziane. CORAZZINI, M O R E T T I e G O Z Z A N O , PALAZZESCHI, CARDARELLI.
Corazzini, da Piccolo libro inutile: Desolazione del povero poeta sentimentale; Moretti, da Poesie scritte col lapis: Piove; Gozzano, da I col loqui : La signorina Felicita; Cardarel l i : Autunno, Attesa, Passato, Abbandono, Rimorso; Palazzeschi, da L’incendiario: Lasciatemi divertire; Chi sono?
I l Futurismo : la veloci tà e la m a c c h i n a , i l n a z i o n a l i s m o e l’esaltazione della guerra, il rifiuto dei valori del passato, la distruzione della s i n t a s s i , i l p a r o l i b e r i s m o e l’immaginazione senza fili, l’analogia, le soluzioni grafiche l’ossessione della materia.
Govoni, Il palombaro; Il manifesto del Futurismo; Il manifesto tecnico del Futurismo; Marinetti, da Zang Tumb Tuum.
L’esperienza della neo-avanguardia negli anni Sessanta: il rapporto con le avanguardie storiche, il mutamento del contesto storico-politico, la critica del linguaggio, le tematiche principali.
E. PAGLIARANI, brano da La ragazza Carla; E. SANGUINETI, Piangi Piangi; Questo è il gatto con gli stivali.
UNGARETTI. Vita di un uomo. La guerra e la poesia. Il porto sepolto, la ricerca della purezza originaria della parola. La poetica dell’attimo e dell’analogia. Autobiografismo e unanimismo.
Da L’allegria: Il porto sepolto, Commiato, I fiumi, San Martino del Carso, Mattina, Fratelli, Veglia, Sono una creatura, Allegria di naufragi. Da Il dolore: Non gridate più, Giorno per giorno. Da La terra promessa: Cori descrittivi dello stato d’animo di Didone.
MONTALE. Il correlativo oggettivo, il male di vivere, la divina indifferenza, il varco, la poesia come conoscenza in negativo, il relativismo, lo stoicismo etico. La poetica delle cose. L’allegoria moderna. Il tema della memoria. La figura femminile.
Da Ossi di seppia: Non chiederci la parola, I limoni; Meriggiare pallido e assorto, Spesso il male di vivere, Cigola la carrucola del pozzo; Da Le occasioni: A Ljuba che parte, Casa dei doganieri; Da La bufera e altro: Piccolo testamento; L’anguilla; D a S a t u r a : L’ a l l u v i o n e h a sommerso il pack dei mobili; Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale.
L’ERMETISMO. La contrazione della parola e la concentrazione sull’io. Il paesaggio mitico. L’analogia. Il rifiuto della storia.
Quasimodo, Vicolo, Ed è subito sera, Alle fronde dei salici.
S A B A e l a p o e s i a o n e s t a , l’antinovecentismo, il Canzoniere, il doloroso amore per la vita, il poeta everyman.
Ulisse, Amai, Il borgo, La capra, A mia moglie.
PAVESE: l ’antinovecentismo, la poesia-racconto e la realtà simbolica. L’inappartenza e il bisogno di identità nel paesaggio.
Da Lavorare stanca: I mari del Sud; Lo steddazzu, Ulisse; Lettura del capitolo I da La luna e i falò.
PERCORSI SUL ROMANZO DEL NOVECENTOAutori e temi della narrativa europea e internazionale: Kafka (l’allegorismo vuoto, l’assurdo, il padre) , Joyce e i l f lusso d i coscienza, Proust e il ruolo della memoria.
K a f k a , D a v a n t i a l l a l e g g e ; Confusione di ogni giorno.
Il disagio della civiltà e la disgregazione del romanzo nel Novecento
METODOLOGIE E STRUMENTI
Si sono alternate diverse tecniche didattiche: lezione frontale o dialogata, discussione guidata, attività a carattere laboratoriale (analisi testuale, esercizi di scrittura), utilizzo di materiale multimediale, ricerche ed esposizioni individuali, interrogazioni. La varietà e la diversità dei metodi utilizzati è stata finalizzata a stimolare la motivazione degli studenti, contribuendo alla partecipazione e al loro coinvolgimento.
I contenuti sono stati organizzati cercando di muoversi all’interno dei generi e dei nuclei tematici intertestuali.
Si è cercato di stimolare l’intervento degli alunni, presentando in modo problematico gli argomenti.
Si sono utilizzati i seguenti strumenti: lavagna, lavagna luminosa, audiovisivi, fotocopie, testi, computer (Internet, Word e Power Point), manuali in adozione.
VERIFICHE
Le interrogazioni sono sempre impostate sull’intero programma, al fine di indurre gli studenti ad un costante ripasso degli argomenti.
Durante l’anno scolastico si sono svolte cinque prove scritte, strutturate secondo le tipologie d’esame.
SVEVO. Biografia. Idee e influenze culturali. Il percorso narrativo da Una vita, a Senilità, a La coscienza di Zeno . La storia del la malatt ia, l ’ inettitudine, l ’ inattendibil ità del narratore, l’ironia, il tempo misto, il relativismo strutturale, malattia e sanità, la guarigione e la catastrofe finale.
La coscienza di Zeno.
PIRANDELLO. Biografia. La visione del mondo e la poetica: il vitalismo e la forma, la persona e la maschera, la frantumazione dell’io, la trappola, l’eroe forestiere della vita, molteplicità del reale e relativismo, l’umorismo. Le novelle. I romanzi. Il teatro del grottesco, il metateatro e i miti.
Vita e forma (pp. 848-849); L’umorismo (p. 851). Da Uno, nessuno, centomila: Moscarda è nessuno (p. 892); Da Il fu Mattia Pascal: Il caso strano e diverso (p. 930-931); Il cielo strappato (pp. 933); Mattia Pascal divenuto “fu” (pp. 943-944). Da Novelle per un anno: Il treno ha fischiato; La carriola.
CRITERI DI VALUTAZIONE Si è tenuto conto della qualità dell’esposizione scritta e orale
dell’allievo, oltre che della progressione nell’apprendimento rispetto al livello di partenza e in relazione agli obiettivi prefissati.
Inoltre sono anche state valutate la continuità del lavoro svolto, l’impegno e la responsabilità nell’assunzione dei propri doveri, la frequenza regolare e attiva alle lezioni.
TESTO DI RIFERIMENTO
B. PANEBIANCO-C. PISONI-L. REGGIANI-M. MALPENSA, Testi e scenari, voll. 4-5-6-7, Zanichelli, 2009.
Pordenone, 2 maggio 2017
CLASSE VCS – A.S.2016-2017 IIS G.LEOPARDI - E.MAJORANA
MATERIA: Latino
INSEGNANTE: Marco Durigon
SITUAZIONE DELLA CLASSE
L’approccio della classe al Latino è stato da subito piuttosto problematico, a
causa di carenze accumulate durante il biennio nelle conoscenze
morfosintattiche della lingua, ma anche per lacune più generali e più profonde
(accumulate probabilmente alle scuole medie) nell’analisi logica e del
periodo. In terza si è cercato di avviare un percorso di recupero almeno delle
regole fondamentali della lingua, ma proprio il terzo si è rivelato essere in
assoluto l’anno più difficile: la classe ha faticato molto ad acquisire quella
continuità di studio e quel metodo di lavoro indispensabili per affrontare nel
modo giusto il triennio; in particolare ha palesato evidenti difficoltà nel gestire
al meglio lo studio di più discipline e le relative verifiche. Generalmente, a
torto o a ragione, ha scelto di favorire le materie scientifiche e di trascurare
discipline non di indirizzo. A partire dalla quarta la classe è sembrata perdere
fiducia nelle possibilità di recupero, manifestando un atteggiamento di
rinuncia a priori, nella convinzione che il Latino fosse ormai una “materia
persa”, impossibile da recuperare. Di fronte a questa situazione, l’unica
soluzione possibile da parte del docente è stata quella di abbassare gli
obiettivi da raggiungere, rassegnandosi a richiedere lo studio del manuale in
adozione e ad affrontare i testi di letteratura in traduzione italiana.
Il programma proposto per il quinto anno ha ovviamente tenuto conto della
“storia” della classe e quindi della situazione di partenza: per ogni autore che
si è scelto di affrontare, si è optato per una lettura-analisi dei testi in
traduzione italiana, concentrandosi solo su pochi significativi brani in lingua
latina. La classe, in un clima comunque più sereno e disteso rispetto agli anni
precedenti, ha affrontato gli argomenti proposti con serietà e impegno
complessivamente costanti.
Gran parte degli alunni si mostra al momento piuttosto a suo agio
nell’esposizione del pensiero e delle tematiche degli autori dell’età imperiale;
ed è giusto sottolineare che un ristretto gruppo di allievi si distingue dal resto
della classe, anche nell’analisi, comprensione e traduzione del testo latino.
CLASSE VCS – A.S.2016-2017 IIS G.LEOPARDI - E.MAJORANA
OBIETTIVI E STRUMENTI
Per quanto riguarda gli obiettivi e le competenze a cui si è puntato nel corso
dell’anno, si rimanda in generale a quanto previsto dal P.T.O.F. per l’ultimo
anno di studi.
Conoscenze:
consolidare la conoscenza delle strutture morfosintattiche del latino
conoscere in modo sufficiente generi e opere della letteratura latina
dell’età imperiale
ampliare la conoscenza delle tematiche e dei valori della civiltà latina
riconoscendone i rapporti con la cultura moderna e contemporanea
Competenze:
sviluppare la capacità di comprensione, traduzione e interpretazione del
testo latino in modo progressivamente autonomo
Gli strumenti utilizzati sono stati il manuale in adozione, materiale audiovisivo,
fotocopie e altri documenti forniti dall’insegnante.
METODOLOGIA E VERIFICHE
Le lezioni sono state prevalentemente frontali: alla presentazione generale
degli argomenti, è seguita la lettura e analisi più o meno approfondita dei testi
letterari; si è quindi lasciato agli allievi il compito di rielaborare quanto emerso
in classe, integrando gli appunti con lo studio del manuale in adozione.
Le verifiche sono state orali (colloquio, traduzione e analisi di brani d’autore,
esercizi di comprensione dei testi, interventi personali e dibattiti in classe) e
scritte (questionari, esercizi di comprensione e traduzione del testo latino).
La valutazione ha tenuto conto soprattutto dei seguenti elementi:
conoscenza delle strutture morfo-sintattiche del latino
capacità di comprensione autonoma dei testi
capacità di traduzione
capacità di esporre gli argomenti di letteratura e civiltà latina in modo
chiaro e con proprietà lessicale
impegno profuso dall’allievo nel lavoro svolto a casa
assiduità nella presenza e della partecipazione attiva alle lezioni
CLASSE VCS – A.S.2016-2017 IIS G.LEOPARDI - E.MAJORANA
CONTENUTI
LUCIO ANNEO SENECA
L’età giulio-claudia e il difficile rapporto dell’intellettuale con gli imperatori.
Seneca e il suo rapporto con Caligola, Claudio e Nerone. L’esperienza
dell’esilio, il suicidio.
L’eclettismo filosofico e l’adesione allo stoicismo (caratteri dello stoicismo:
provvidenzialismo, panteismo, materialismo, atarassia).
Le opere: le consolationes; le Epistulae ad Lucilium; il De providentia; il De
clementia; il De brevitate vitae; l’Apokolokyntosis; le tragedie.
Il genere delle consolationes nella tradizione letteraria. I Dialoghi e i trattati.
Le tragedie: l’importanza dei monologhi e del coro; lo stile tragico. La satira
menippea. L’Apokolokyntosis come parodia dell’apoteosi romana.
I temi della produzione di Seneca: il tempo; il saggio di fronte al male e alla
morte; l’humanitas e il ruolo degli schiavi a Roma; il percorso verso la
sapientia. Gli spettacoli gladiatori a Roma: il giudizio di Seneca e dei primi
autori cristiani.
Approfondimento: la condizione dello schiavo a Roma.
Approfondimento: gli spettacoli gladiatori a Roma.
Testi letti e analizzati:
Sul tema della humanitas: Ad Lucilium 7, 47 (1-5 lat; 6-21).
Sul tema del male e della teodicea: De providentia I, 5-6 (lat); IV, 1-6.
Sul tema del tempo: De brevitate vitae 1-2; 8; 10; Ad Lucilium 1, 12.
Sul tema della felicità: Ad Lucilium 59.
Sul tema della morte e del suicidio: Ad Lucilium 70, 107.
Sul tema della folla e degli spettacoli gladiatori: Tertulliano, De spectaculis 1-
7; Sant’Agostino, Confessiones VI, 8.13.
Apokolokyntosis: 1 - 4,1; 14-15.
Tyrstes: 920-969
LA FIGURA DI NERONE ATTRAVERSO LE FONTI STORICHE E LA
RIABILITAZIONE DELLA STORIOGRAFIA MODERNA
Il ritratto di Nerone attraverso le parole di Svetonio.
Il quinquennio felice e il difficile rapporto con Agrippina, Seneca e Burro.
Il raporto con Ottavia, Atte e Poppea.
CLASSE VCS – A.S.2016-2017 IIS G.LEOPARDI - E.MAJORANA
La “degenerazione” di Nerone: il matricidio, il rapporto con Tigellino, la
congiura dei Pisoni; il suicidio.
La rivalutazione della politica neroniana: la pace; la riforma monetaria; le
iniziative a favore del popolo; i giochi e il dirozzamento della mentalità
romana. La domus aurea e la riforma urbanistica.
L’incendio e le persecuzioni: processo a Nerone attraverso le fonti.
La difficile interpretazione delle fonti: Svetonio, Tacito, Cassio Dione e gli
autori cristiani.
La riabilitazione della storiografia moderna.
Testi letti e analizzati:
Svetonio, Vite dei Cesari 6, 26, 34, 51-57
Seneca, De clementia I, 1-4
Tacito, Annales XIII, 45-55 (lat), XIV, 2-10; 63-64; XV, 38-42
Brani tratti da Nerone: 2000 anni di calunnie, di M.Fini.
Video “Il grande incendio di Roma” (Rai)
Video “La Domus Aurea” (National Geographic)
PETRONIO
Vicende biografiche: la “questione petroniana”; il ritratto di Petronio negli
Annales di Tacito.
Il Satyricon: origine del nome, trama, frammenti rimasti, “la questione” del
genere letterario, struttura e modelli. Il realismo di Petronio tra comicità e
amarezza: la cena di Trimalchione.
L’autore nascosto e il narratore mitomane.
La figura del lupo mannaro nella letteratura e nella società romana (analisi
antropologica).
La mimesis linguistica nell’opera di Petronio.
Testi letti e analizzati:
Tacito, Annales XVI, 18-19 (il ritratto di Petronio)
Satyricon: Nicerote racconta una storia di licantropia (61,6 - 62,14); Una
novella: la matrona di Efeso (111-112); La vendetta di Priapo (132,9-133,3); Il
naufragio e l’arrivo a Crotone (116,1-9 lat). L’ingresso di Trimalchione (31,3 –
33,8); La lingua dei liberti (41,9-12); Il testamento di Trimalchione (71-72).
CLASSE VCS – A.S.2016-2017 IIS G.LEOPARDI - E.MAJORANA
APULEIO
Vicende biografiche: Apuleio filosofo, mago, conferenziere e viaggiatore.
L’accusa di magia e il processo.
I culti misterici a Roma; il culto di Iside.
Le opere minori: L’apologia.
Le Metamorfosi: titolo e struttura dell’opera; la questione delle fonti. La
contaminazione dei generi. Romanzo di formazione e di denuncia, romanzo
autobiografico: le possibili interpretazioni dell’opera. La colpa della curiositas.
Carattere allegorico della favola di Amore e Psiche.
Approfondimento storico-lessicale: culti tradizionali e culti misterici nell’antica
Roma.
Testi letti e analizzati:
Apologia: “I pesci di Apuleio” (29-30); “La difesa di Apuleio” (90-91).
Metamorfosi: “Lucio assiste alla metamorfosi di Panfila” (III, 21-22); “Il lieto
fine: Lucio iniziato al culto di Iside” (XI, 29-30);
“Una nuova Venere” (IV, 28 lat); Il matrimonio funerale (IV, 22-25; V, 1);
“Psiche sposerà un mostro crudele” (IV, 32; 33,1-33,2 lat; 33,3). “Lo sposo
misterioso” (V, 21ss.)
LUCANO E GLI SVILUPPI DELL’EPICA
Il genere epico: definizione, finalità, sviluppi. L’epica latina dall’Odusia di Livio
Andronico all’Eneide di Virgilio (evoluzione del genere).
Vicende biografiche: l’amicizia con Nerone e la rottura del rapporto; il
coinvolgimento nella congiura di Pisone e la condanna.
Il Bellum civile: la genesi e il progetto dell’opera; “l’AntiEneide”: novità e
caratteri del poema; la guerra civile e la violazione delle norme sociali e
religiose; Cesare “eroe nero”; le personalità di Catone e Pompeo. Il macabro
e l’orrido nell’opera di Lucano: la stregoneria e le pratiche negromantiche.
Testi letti e analizzati:
Bellum civile: proemio (I, 1-14 lat; 15-32); La terribile Erichto e la scena di
necromanzia (VI, vv.507-569; 654-718); La profezia del soldato (VI, vv.776-
820). Cesare passa il Rubicone (I, 183-227). Un Enea sfortunato: la morte di
Pompeo (VIII, vv.610-635)
CLASSE VCS – A.S.2016-2017 IIS G.LEOPARDI - E.MAJORANA
GIOVENALE
Le origini della satira: le caratteristiche e le finalità del genere; modelli di
riferimento.
La protesta sociale di Giovenale. Vicende biografiche; il difficile rapporto con
il potere.
Le Saturae: il corpus delle satire; pessimismo, indignatio e impotenza
dell’intellettuale: la critica alla dissoluzione dei costumi; la satira contro le
donne e l’ostilità verso i costumi stranieri.
Approfondimento: il culto del corpo a Roma.
Testi letti e analizzati:
E’ difficile non scrivere satire (Saturae I,1-80); Uomini che si comportano da
donne (Saturae II, 65-109); La pudicizia non vive più sulla terra (Saturae VI,
1-20 lat); Eppia la gladiatrice e Messalina augusta meretrix (Saturae VI, 82-
132); I riti della Bona Dea capovolti (Saturae VI, 314-334); La satira tragica
(Saturae VI, 627-661);
MARZIALE
Vicende biografiche: gli studi in Spagna e il trasferimento a Roma; la vita del
cliente; la produzione di epigrammi; il definitivo ritorno in Spagna.
Le opere: una lettura realistica e satirica della società romana; peculiarità del
genere “epigramma”.
Il Liber de spectaculis, Xenia, Apophoreta, Epigrammata.
Lo stile di Marziale e il fulmen in clausola.
Testi letti e analizzati:
Epigrammi: La bellezza di Maronilla (Ep.I,10 lat); Scrittori (Ep. VII 3 lat);
Ciechi (Ep. III 8 lat); La moglie di Candido (Ep.3,26 lat); Un mondo di oscenità
(Ep.I, 35); Per la piccola Erotion (Ep. V,34); Ingannatrice (Ep.II,25); Il
faccendone (Ep.II,7); Bellus homo (Ep.III,63); Il Greco a letto (Ep.X,68);
Valerio Marziale saluta il suo Prisco (Ep.XII,18).
Il realismo di Marziale e i suoi limiti (Luciano Perelli, Storia della letteratura
latina).
CLASSE VCS – A.S.2016-2017 IIS G.LEOPARDI - E.MAJORANA
LUCIO ANNEO TACITO
Vicende biografiche: origine e posizione sociale; la formazione retorica e
giuridica; il matrimonio con la figlia di Giulio Agricola; gli anni del regno di
Domiziano; il ritiro a vita privata e la morte.
Il corpus tacitiano: Il Dialogus de oratoribus; le opere monografiche ( Agricola,
Germania). Caratteristiche comuni delle opere storiografiche: Historiae,
Annales.
La riflessione sul principato e il pensiero politico: il principato come necessità
e l’ideale della virtus. Il pessimismo tacitiano. Il metodo storiografico di Tacito.
I difficili rapporti fra Roma e i Germani: la battaglia di Teutoburgo
(ricostruzione storica).
La strumentalizzazione razzista delle parole di Tacito: cenni alle teorie
razziste del XIX secolo (Joseph-Arthur De Gobineau e il Saggio sulla
diseguaglianza delle razze umane; Houston Stewart Chamberlain e I
fondamenti del XIX secolo).
La figura di Nerone attraverso gli Annales di Tacito.
Approfondimento storico-lessicale: l’organizzazione dell’esercito a Roma.
Testi letti e analizzati:
I Britanni (Agricola 11-12,4); Il discorso di Calgaco (Agricola 30-32); La
sincerità genetica dei Germani (Germania 4.1-4.3 lat); Il valore militare dei
Germani (Germania 6; 14); La selva della memoria (Annales I, 60,3 - 61,4
lat.; 62); La descrizione di Poppea, (Annales 13, 45 ss. lat); La morte di
Poppea (Annales, 14, 63-64); Il suicidio di Seneca (Annales, 15, 62-64); il
ritratto di Petronio (Annales 16, 18-19); L’uccisione di Ottavia (Annales 14,
63-64); L’incendio di Roma e la costruzione della domus aurea (Annales XV,
38-42); Nerone fa uccidere Agrippina (Annales 14, 2-10).
Pordenone, 15 maggio 2017
L’insegnante
MARCO DURIGON
MATERIA: FILOSOFIA
DOCENTE: CLAUDIO TONDO
SITUAZIONE FINALE DELLA CLASSE
Gli interventi didattici effettuati hanno consentito di ottenere dei progressi – in alcuni casi, costanti e soddisfacenti – nell’acquisizione di conoscenze e competenze proprie della disciplina. A conclusione dell’anno scolastico, in base alle osservazioni svolte in aula, alla qualità degli interventi e ai risultati delle prove di verifica, la situazione della classe può essere sintetizzata come segue. Nonostante permangano alcune situazioni caratterizzate da incertezze logico-linguistiche e comunicative, da fragilità nell’approccio ai problemi astratti e da condizioni motivazionali (attenzione in aula e continuità nelle attività di studio pomeridiane) non sempre favorevoli all’apprendimento, il gruppo classe nel suo insieme ha dimostrato di aver assimilato le strategie metacognitive e di possedere le risorse cognitive e operative necessarie allo studio della filosofia. Alcuni studenti hanno partecipato al dialogo educativo spontaneamente e costruttivamente, denotando interesse verso alcuni dei temi e dei problemi filosofici proposti. Un discreto numero di studenti ha progressivamente consolidato il proprio metodo di lavoro, che si è rivelato maggiormente organizzato, autonomo ed efficace. Con riferimento al gruppo classe, l’evoluzione nell’assimilazione dei contenuti e nell’acquisizione delle abilità consente di considerare conseguiti (anche se in alcuni limitati casi solo parzialmente) o pienamente conseguiti gli obiettivi specifici di apprendimento definiti in sede di pianificazione.
OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO
L’attività didattica è stata finalizzata all’acquisizione della terminologia specifica, dei problemi, dei concetti e delle teorie filosofiche nella loro evoluzione storica e in alcuni nuclei tematici fondamentali. Nel corso dell’anno, con riferimento alle Indicazioni nazionali per il liceo scientifico e agli obiettivi definiti nel Piano di lavoro di filosofia, l’insegnante ha curato l’acquisizione delle seguenti conoscenze e competenze: § comprendere correttamente i contenuti della sezione manualistica del
libro di testo;
§ esporre in modo organico una teoria filosofica nei suoi aspetti globali e nei suoi tratti specifici;
§ comprendere il lessico filosofico e saperlo impiegare in modo appropriato in relazione al contesto;
§ analizzare i testi filosofici, individuandone gli aspetti teorici essenziali, la struttura logico-argomentativa e il genere testuale specifico;
§ stabilire rapporti di correlazione tra concetti e teorie filosofiche appartenenti a momenti storici e ad autori diversi;
§ individuare in modo critico le relazioni esistenti tra teorie e pratiche filosofiche, forme di sapere e conoscenza scientifiche, pratiche dell’agire individuale e collettivo;
§ riconoscere, a partire dal manuale, le diverse interpretazioni critiche riconducibili a un problema, a un autore, a una scuola o a un periodo storico-filosofico particolari.
STRATEGIE DIDATTICHE
L’attività didattica ha avuto come momenti centrali la lezione e la socializzazione delle conoscenze apprese dal gruppo classe. In particolare, l’insegnante ha strutturato i propri interventi didattici nell’ambito di ciascun modulo secondo le seguenti modalità: § delineazione delle tematiche filosofiche a partire dall’analisi e dalla
interpretazione dei testi; § illustrazione delle situazioni problematiche suscitate dall’indagine
filosofica; § illustrazione degli elementi linguistici e concettuali di base; § spiegazione dei percorsi attraverso cui si è evoluta una problematica
attraverso il pensiero di diversi filosofi; § spiegazione dei percorsi secondo cui si è snodato, si è evoluto e si è
articolato il pensiero di un singolo filosofo; § costruzione quadri sintetici e riassuntivi finalizzati a delineare argomenti e
temi considerati secondari.
STRUMENTI DIDATTICI
Nel corso dei diversi interventi, l’insegnante si è avvalso dei seguenti strumenti didattici:
§ testo adottato: sezione manualistica e raccolta antologica di testi; strumenti editoriali e didattici di supporto al manuale;
§ selezione di brani di storiografia filosofica, finalizzati all’acquisizione delle diverse interpretazioni critiche;
§ mappe concettuali, diagrammi e documenti iconici; § strumenti audiovisivi e multimediali, sequenze cinematografiche e
audiovisive; § Partecipazione, su base volontaria, a conferenze e incontri di interesse
filosofico.
STRUMENTI DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE
Per valutare il raggiungimento degli obiettivi, si sono utilizzati i seguenti strumenti di verifica: § indagini informali in itinere; § prove strutturate finalizzate alla verifica dell’acquisizione di competenze e
abilità specifiche; § simulazioni d’esame della Terza prova scritta (tipologia B – Quesiti a
risposta singola);
Per la valutazione degli apprendimenti si è tenuto conto dei seguenti criteri: raggiungimento degli obiettivi minimi prefissati in termini di conoscenze, competenze e capacità; progressione e ritmi di apprendimento; attenzione, impegno e interesse; autonomia ed efficacia nel metodo di lavoro; partecipazione al dialogo educativo.
PROGRAMMA SVOLTO Nel corso dell’anno si sono approntati gli opportuni interventi didattici finalizzati all’indagine dei seguenti nuclei tematici. A conclusione di ciascun nucleo, si sono realizzati, inoltre, degli approfondimenti relativi ad alcune questioni aperte della filosofia del Novecento. Tutti i brani citati, tranne quelli con diversa indicazione bibliografica, sono tratti dai volumi N. ABBAGNANO, G. FORNERO (con la collaborazione di GIANCARLO BURGHI), L’ideale e il reale. Dall’Umanesimo a Hegel, Pearson-Paravia, Milano-Torino 2013, vol. 2; Id., L’ideale e il reale. Da Schopenhauer agli sviluppi più recenti, cit., vol. 3; F. CIOFFI, G. LUPPI, A. VIGORELLI, E. ZANETTE, A. BIANCHI, S. O’BRIEN, Il discorso filosofico. L’età moderna – Dall’illuminismo a Hegel, Bruno Mondadori, Milano, 2012, vol. 2, t. b; M. DE
BARTOLOMEO e V. MAGNI, Filosofia. Dall’Illuminismo all’Idealismo, Atlas, Bergamo, s.d., vol. 2, t. 4; Id., Filosofia. Filosofie contemporanee, cit., vol. 3, t. 5. Nell’elenco che segue, i diversi volumi sono indicati rispettivamente con le sigle Id-Re3, Dis-Fil2b, Fil4 e Fil5.
1. L’etica kantiana e la questione dell’illuminismo
Contenuti. Etiche descrittive ed etiche prescrittive. - “Che cosa devo fare?”: autonomia morale ed etica del dovere. - Massime e imperativi. - L’imperativo categorico. - Il dualismo tra virtù e felicità e i “postulati della ragion pratica”. - Il primato della ragion pratica. - Progresso e illuminismo - L’uscita dallo “stato di minorità”. - L’età dell’illuminismo. - Ragione ed emancipazione.
Testi “Il cielo stellato e la legge morale”, in I. KANT, Critica della ragion pratica, Laterza, Bari, 1974, pp. 197-198. Risposta alla domanda: Che cos’è l’Illuminismo, in Fil4, pp. 363-365.
Approfondimento tematico: I “limiti” dell’Illuminismo nella filosofia contemporanea
Testi. “Scienza, tecnica, dominio”, in M. HORKHEIMER – T. W. ADORNO, Dialettica dell’illuminismo, Einaudi, Torino, 1966, pp. 11-13, 17. Opere artistiche e film. F. Goya, Il sonno della ragione genera mostri (acquaforte, 1797). “L’alba dell’uomo”, in 2001: Odissea nello spazio, di Stanley Kubrick (Gran Bretagna, 1968).
2. L’idealismo di Hegel
Contenuti. - La ragione e la storia. - La ragione e la dialettica dell’Assoluto. - La Fenomenologia dello spirito: coscienza e autocoscienza; il desiderio di riconoscimento; Signoria e Servitù; origine e fine della storia. - La Ragione dialettica e i suoi momenti (astratto, dialettico e speculativo). - La filosofia dello Spirito. - La filosofia della storia e la “coscienza della libertà”. - Lo Spirito Assoluto (arte, religione e filosofia).
Testi La storia come progresso della coscienza della libertà, in Fil4, testo 6, pp. 375-376. La coscienza servile e il lavoro, in Dis-Fil2b, FG, testo T2, pp. 136-137.
“Signoria e Servitù, storia universale e fine della storia. Alexandre Kojève interprete di Hegel”, in A. KOJÈVE, Introduzione alla lettura di Hegel, a cura di G. F. Frigo, Adelphi, Milano, 1996, pp. 223-224.
Approfondimento tematico: Benjamin: un visione alternativa della storia
Testi. “L’angelo della storia”, in W. BENJAMIN, Tesi di filosofia della storia, in Angelus Novus. Saggi e frammenti, Einaudi, Torino, 1962, p. 80. Opere artistiche. Paul Klee, Angelus Novus (1920).
3. Feuerbach e la “Sinistra hegeliana”
Contenuti. - Sinistra e Destra hegeliane. - Feuerbach: l’alienazione religiosa; l’hegelismo come teologia; l’umanismo come filosofia dell’avvenire.
4. Marx tra filosofia e analisi economica della società
Contenuti. - Filosofia e rivoluzione. - Critica dell’hegelismo, alienazione e emancipazione umana. - La concezione materialistica della storia. - Dalla filosofia all’economia politica: Il Capitale (valore d’uso e valore di scambio; merci, lavoro, denaro; le origini del profitto). - Capitalismo, socialismo, comunismo. - La dottrina dello Stato. - La “filosofia della tecnica”.
Testi L’alienazione, in Id-Re3, testo T1, pp. 111-113. L’ideologia, in Fil5, testo 10, pp. 507-510. “La concezione materialistica della storia”, in K. MARX, Prefazione a Per la critica dell’economia politica, in Il capitale. Critica dell’economia politica, Libro primo, Appendici, Einaudi, Torino, 1978, vol. II, pp. 956-958. Dal Manifesto del partito comunista, in Fil5, testo 11A, p. 511. Il ruolo rivoluzionario della borghesia, in Fil5, testo 11B, pp. 512-513. Le macchine, in Fil5, testo 10, pp. 698-699.
Approfondimento tematico: Marx anticipatore dei processi di globalizzazione
Testi. “Globalizzazione e capitalismo”, in K. MARX – F. ENGELS, Manifesto del Partito Comunista, Einaudi, Torino, 1998, pp. 10-11. “Impero britannico e globalizzazione nel secondo Ottocento”, in DANDHYAM, British Imperial Century, citato in P. KENNEDY, Ascesa e declino delle grandi potenze, Garzanti, Milano, 1989. “Globalizzazione e vita quotidiana”, in R. WILLIAMS, citato in J. TOMLINSON, Sentirsi a casa nel mondo. La cultura come bene globale, Feltrinelli, Milano, 2001, pp. 136-137. “Globalizzazione e sistemi di
comunicazione”, in A. GIDDENS, Il Mondo che cambia. Come la globalizzazione ridisegna la nostra vita, Il Mulino, Bologna, 2000, pp. 23-24.
5. Nietzsche e la critica della razionalità
Contenuti. - Un pensiero critico, negativo e anticipatore. - La nascita della tragedia: spirito dionisiaco e spirito apollineo; arte, filosofia e decadenza. - La critica della scienza e della storia. - La distruzione della metafisica, l’annuncio della “morte di Dio” e il nichilismo. - Oltre-uomo, eterno ritorno, volontà di potenza. - Dall’Übermensch allo Human Enhancement. - Prospettivismo ed ermeneutica.
Testi “L’uomo folle”, in F. NIETZSCHE, La gaia scienza, Einaudi, Torino 1979, af. 125, pp. 123-124. “Il nichilismo”, in F. NIETZSCHE, La volontà di potenza, a cura di M. Ferraris e P. Kobau, Bompiani, Milano, 1995, pp. 3-9; Frammenti postumi 1887-1888, in Opere, a cura di G. Colli e M. Montinari, Adelphi, Milano, 1971, vol. VIII, II, fr. 11 (119), p. 266. “Come il «mondo vero» finì per diventare favola”, in F. NIETZSCHE, Crepuscolo degli idoli, Adelphi, Milano, 19893, pp. 46-47. “Il peso più grande”, in F. NIETZSCHE, La gaia scienza, cit., af. 341, p. 197. “La verità è un mobile esercito di metafore”, in F. NIETZSCHE, Su verità e menzogna in senso extramorale, in Su verità e menzogna, a cura di F. Tomatis, Bompiani, Milano, 2006, pp. 91; 95. “Tutto è interpretazione”, in F. NIETZSCHE, Frammenti postumi 1885-1887, in Opere, a cura di G. Colli e M. Montinari, Adelphi, Milano, 1971, vol. VIII, I, fr. 7 (60), p. 299.
Approfondimento tematico: Nichilismo, tecnica ed etica nel mondo contemporaneo
Testi. “La «morte di Dio» nell’interpretazione di Heidegger”, in M. HEIDEGGER, La sentenza di Nietzsche «Dio è morto», in Sentieri interrotti, La Nuova Italia, Firenze, 1968, pp. 198-199. “Tecnica, etica e responsabilità”, in H. JONAS, Dalla fede antica all’uomo tecnologico, Il Mulino, Bologna, 1991, pp. 41-54. “Il nichilismo nel mondo contemporaneo”, in F. VOLPI, Il nichilismo, Laterza, Roma-Bari, 1996, pp. 115; 117. U. GALIMBERTI, Come trovare un’etica moderna, in “la Repubblica”, 12 agosto 2004.
6. Il problema della demarcazione tra scienza e metafisica nella riflessione epistemologica contemporanea: Wittgenstein e Popper
Contenuti. - Il “primo” Wittgenstein: linguaggio e mondo; senso e non-senso; tautologie e contraddizioni; dicibile e indicibile; la filosofia come critica del linguaggio. - Popper: la critica all’induzione; - la logica della ricerca scientifica: “congetture e confutazioni”. - Verificazionismo (Wittgenstein e il Circolo di Vienna) e falsificazionismo (Popper) come criteri di demarcazione tra scienza e metafisica.
CONTRIBUTO DELLA DISCIPLINA ALLE ATTIVITÀ PLURIDISCIPLINARI
1. Approfondimenti individuali degli studenti (“Tesine”)
In vista della prova orale d’esame, agli studenti che ne hanno fatto richiesta, sono stati forniti materiali (saggi, film, documenti audiovisivi), indicazioni bibliografiche, riferimenti a siti internet e suggerimenti al fine di fornire gli essenziali strumenti filosofici per l’approfondimento delle tematiche individuate. L’insegnante ha dato inoltre la propria disponibilità per la revisione dei testi e delle eventuali presentazioni multimediali.
2. Partecipazione a progetti, iniziative culturali e concorsi
Nel corso dell’anno scolastico, la classe o singoli studenti su base volontaria hanno partecipato ai seguenti progetti e iniziative a carattere culturale:
a. Pordenonelegge Dimmi come comunichi e ti dirò chi sei, incontro con Ilvo Diamanti e Marino Niola.
b. Olimpiadi di Filosofia Partecipazione di tre studenti alla Fase di Istituto delle Olimpiadi di Filosofia.
c. Summer School di Filosofia e Teoria Critica Partecipazione di uno studente alla Summer School di Gorizia, promossa dalla Rete Regionale per la Filosofia e gli Studi Umanistici, su La psicoanalisi di Freud e il pensiero del Novecento.
MATERIA: STORIA
DOCENTE: CLAUDIO TONDO
SITUAZIONE FINALE DELLA CLASSE
Gli interventi didattici effettuati hanno consentito di ottenere alcuni progressi nell’acquisizione di conoscenze e competenze proprie della disciplina. A conclusione dell’anno scolastico, in base alle osservazioni svolte in aula, alla qualità degli interventi e ai risultati delle prove di verifica, la situazione della classe può essere sintetizzata come segue. Nonostante permangano alcune situazioni caratterizzate da incertezze comunicative, da fragilità nell’operare con metodologie e strumenti propri della disciplina e da un atteggiamento motivazionale (attenzione in aula e continuità nelle attività di studio pomeridiane) non sempre favorevole all’apprendimento, il gruppo classe nel suo insieme ha dimostrato di aver acquisito le strategie metacognitive e di possedere le risorse cognitive e operative necessarie allo studio della storia. La partecipazione al dialogo educativo, se si escludono alcuni casi individuali motivati nei confronti delle discipline storiche, ha richiesto una costante attività di stimolo da parte dell’insegnante. Per un discreto numero di studenti il metodo di lavoro si è rivelato organizzato, autonomo ed efficace. Con riferimento al gruppo classe, l’evoluzione nell’assimilazione dei contenuti e nell’acquisizione delle abilità consente di considerare conseguiti (anche se in alcuni limitati casi solo parzialmente) o pienamente conseguiti gli obiettivi specifici di apprendimento definiti in sede di pianificazione.
OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO
L’apprendimento ha riguardato la terminologia specifica della disciplina, le nozioni di fonte storica e interpretazione storiografica, gli eventi, i processi, le strutture, i concetti connessi allo studio della storia contemporanea. Al di là della successione diacronica degli eventi, lo studente ha appreso ad analizzare anche da un punto di vista sincronico la complessa rete di relazioni esistenti tra le diverse dimensioni e i diversi tempi delle formazioni storiche esaminate. Nel corso dell’anno, con riferimento alle Indicazioni nazionali per il liceo scientifico e agli obiettivi definiti nel Piano di lavoro di filosofia, l’insegnante ha curato l’acquisizione delle seguenti conoscenze e competenze:
§ collocare spazio-temporalmente un evento o un fatto storico complesso nel contesto di riferimento al fine giungere ad una valutazione significativa e pertinente della sua rilevanza storica;
§ stabilire e spiegare i rapporti di correlazione e di dipendenza causale tra eventi e dimensioni del divenire storico, individuandone analogie e differenze, continuità e fratture;
§ conoscere, analizzare e comparare le diverse istituzioni sociali, culturali, economiche e politiche nella loro evoluzione storica;
§ comprendere e impiegare i termini specifici in modo appropriato al contesto;
§ leggere e interpretare dati statistici, grafici, carte tematiche e storiche; § distinguere, comprendere e interpretare le diverse fonti storiche per
delineare le caratteristiche significative di un periodo, individuandone le informazioni rilevanti, la struttura logico-argomentativa e la tipologia testuale specifica;
§ distinguere, a partire da brani selezionati, le diverse interpretazioni storiografiche essenziali alla comprensione di un evento storico;
§ utilizzare conoscenze, concetti e metodologie propri delle scienze sociali per comprendere la multidimensionalità del sapere storico;
§ condurre autonomamente un approfondimento su un determinato argomento, utilizzando materiali e strumenti diversi, per produrre testi scritti, esposizioni orali e presentazioni multimediali.
STRATEGIE DIDATTICHE
L’attività didattica ha avuto come momenti centrali la lezione e la socializzazione delle conoscenze apprese dal gruppo classe. In particolare, l’insegnante ha strutturato, in costante rapporto dialogico con gli studenti, i propri interventi didattici nell’ambito di ciascun modulo secondo le seguenti modalità: § esposizione sintetica e problematica delle caratteristiche salienti del
periodo storico esaminato; § lettura, analisi, contestualizzazione e interpretazione di fonti storiche e
brani storiografici; § illustrazione degli elementi linguistici e concettuali di base; § modellizzazione delle relazioni tra fatti storici e schematizzazione dei
principali nodi teorico-concettuali;
§ costruzione di quadri sintetici, riassuntivi e di collegamento tra aspetti centrali ed aspetti secondari riferiti ad una formazione storico-sociale o alla successione di momenti diversi della dinamica storica;
§ individuazione di materiali e riferimenti bibliografici per eventuali approfondimenti individuali o di gruppo degli studenti.
STRUMENTI DIDATTICI
Nel corso dei diversi interventi, l’insegnante si è avvalso dei seguenti strumenti didattici: § testo in adozione (M. MANZONI, F. OCCHIPINTI, Storia. Scenari Documenti
Metodi. Dalla seconda metà del Seicento all’Ottocento, Einaudi Scuola, Torino 2012, vol. 2; Id., Storia. Scenari Documenti Metodi, Il Novecento e la storia contemporanea, cit., vol. 3: sezione manualistica, raccolta di documenti e selezione di testi storiografici;
§ mappe concettuali e diagrammi; § dati statistici, carte storiche, testi letterari, documenti iconografici,
strumenti audiovisivi (film, documentari, conferenze) e multimediali; siti Internet.
STRUMENTI DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE
Per valutare il raggiungimento degli obiettivi, si sono utilizzati i seguenti strumenti di verifica: § indagini informali in itinere; § prove strutturate finalizzate alla verifica dell’acquisizione di competenze e
abilità specifiche; § esposizioni (individuali o di gruppo) su tematiche storiche concordate, con
l’eventuale ausilio di strumenti multimediali; § simulazioni d’esame della Terza prova scritta (tipologia B – Quesiti a
risposta singola).
Per la valutazione degli apprendimenti si è tenuto conto dei seguenti criteri: raggiungimento degli obiettivi minimi prefissati in termini di conoscenze, competenze e capacità; progressione e ritmi di apprendimento; attenzione, impegno e interesse; autonomia ed efficacia nel metodo di lavoro; partecipazione al dialogo educativo.
PROGRAMMA SVOLTO
Nel corso dell’anno si sono approntati gli opportuni interventi didattici finalizzati all’indagine dei seguenti nuclei tematici, relativi al tardo Ottocento e al Novecento. Gli argomenti relativi al secondo dopoguerra sono stati affrontati in modo sintetico a partire dall’introduzione al volume di Eric J. Hobsbawm, Il Secolo Breve. 1914/1991, Rizzoli, Milano 1994. Dell’indagine storiografica di Hobsbawm, si è tenuto conto in particolare per la periodizzazione del “Secolo Breve”, utilizzando, per una lettura complessiva del Novecento, la tripartizione cronologica proposta dall’autore: Età della catastrofe (1914-1945), Età dell’oro (1946-1973), La Frana (1974-1989/91).
1. L’età dell’imperialismo: aspetti economici e politico-ideologici
- Periodizzazione e contesto politico-economico. - La competizione coloniale. - Localizzazione ed estensione degli imperi coloniali. - Le cause dell’imperiali-smo. - Colonialismo e imperialismo.
2. La seconda rivoluzione industriale e la società di massa
- Periodizzazione. - Gli stati e le economie trainanti. - Le nuove risorse energetiche e le innovazioni scientifiche e tecniche - Le nuove forme di organizzazione del lavoro (taylorismo e fordismo). - I processi di concentrazione industriale (trust e cartelli). - Concorrenza, oligopolio e monopolio. - Capitalismo finanziario e capitalismo industriale. - Dal capitalismo familiare al capitalismo manageriale. - La divisione internazionale del lavoro. - La società di massa: conseguenze economiche, politiche e culturali. - I nuovi luoghi del consumo e dell’intrattenimento. - La “folla” secondo Gustave Le Bon.
3. L’età giolittiana: svolta liberale e decollo industriale
- La crisi di fine secolo (1896-1901). - La svolta liberale (1901-1903). - L’età giolittiana (1903-1914): i conflitti tra capitale e lavoro; il suffragio universale maschile; il nazionalismo e la guerra di Libia. - I Cattolici italiani e la politica: dal non expedit al patto Gentiloni. - Il decollo industriale: precondizioni, localizzazione, settori industriali, i dati della crescita, conseguenze sociali della modernizzazione, il divario con i paesi europei avanzati. - Flussi migratori e arretratezza del Mezzogiorno.
4. La prima guerra mondiale
- Il sistema delle alleanze. - Le cause del conflitto (“occasionale”, economiche, politiche). - La strategia militare tedesca e le prime fasi del conflitto (fronti orientale e occidentale). - L’allargamento del conflitto. - Il patto di Londra e l’intervento dell’Italia. - Il dibattito tra neutralisti e interventisti. - La guerra di trincea e le nuove tecnologie militari. - La mobilitazione totale. - La svolta del 1917: rivoluzione russa e intervento degli Stati Uniti. - L’Italia e la “rotta” di Caporetto. - L’ultimo anno di guerra e la sconfitta degli Imperi centrali. - La conferenza di pace di Versailles e la nuova carta d’Europa. - La Società delle Nazioni.
5. La rivoluzione russa
- La caduta dello zar e la rivoluzione di febbraio. - La rivoluzione d’ottobre. - La guerra civile e la vittoria bolscevica. - La costruzione dello stato e dell’economia socialista.
6. Il dopoguerra in Italia: dalla crisi dello stato liberale al fascismo
- I caratteri dello Stato liberale. - Il dopoguerra in Italia: l’economia, la società, la fragilità delle strutture politiche e statali. - La crisi della classe dirigente liberale. - Cattolici, socialisti e fascisti. - La “vittoria mutilata” e l’impresa fiumana. - Il biennio rosso (1919-1921). - Le elezioni politiche del 1919. - Il governo Giolitti. - L’occupazione delle fabbriche e la nascita del Partito comunista d’Italia. - Il fascismo agrario e le elezioni del 1921. - L’agonia dello Stato liberale e la marcia su Roma. - Il delitto Matteotti, l’Aventino e la costruzione del regime fascista. - I Patti lateranensi.
7. La crisi economica del 1929 e il “New Deal” rooseveltiano
- Gli Stati Uniti prima della crisi. - Il “grande crollo” del 1929. - La crisi in Europa. - Il “New Deal” rooseveltiano e il nuovo ruolo dello stato nell’economia.
8. L’età dei totalitarismi: fascismo, nazionalsocialismo e stalinismo
L’Italia fascista. - La nozione storiografica di Fascismo. - Fascismo come totalitarismo imperfetto: la monarchia, la Chiesa e la cultura. - La costruzione del consenso. - La politica economica: dal liberismo al protezionismo; lo Stato corporativo, la “battaglia del grano”, “quota novanta”. - La risposta del Fascismo alla crisi del 1929: l’intervento dello stato nell’economia e
l’Autarchia. - La politica estera del fascismo: impresa etiopica e alleanza con la Germania hitleriana. - Le leggi razziali.
La Germania nazionalsocialista. - L’iperinflazione tedesca (1922-1923). - La crisi della Repubblica di Weimar e l’avvento del nazismo. - L’ideologia nazionalsocialista (il Mein Kampf). - Stato e Partito. - La macchina repressiva e la propaganda. - Razzismo, antisemitismo e leggi di Norimberga. - Il dirigismo economico e la politica di riarmo.
L’Unione Sovietica di Stalin. - Il socialismo in un solo Paese. - La dittatura di Stalin. - La pianificazione economica. - La repressione del dissenso: i Gulag.
L’Europa verso la catastrofe. - La guerra civile spagnola. - L’espansionismo nazista e l’Anschluss. - La questione dei Sudeti e la conferenza di Monaco. - Il Patto d’Acciaio. - Il Patto Molotov-Ribbentrop.
9. La seconda guerra mondiale
- Le cause del conflitto. - La distruzione della Polonia. - L’attacco a occidente, l’occupazione della Francia e il regime di Vichy. - L’intervento dell’Italia. - L’attacco all’Unione Sovietica. - L’aggressione giapponese e l’intervento degli Stati Uniti. - “Nuovo ordine” nazista, resistenza e collaborazionismo. – La “soluzione finale” e lo sterminio degli ebrei. - La caduta del fascismo e l’8 settembre. - La resistenza italiana. - Le offensive sovietiche e lo sbarco in Normandia. - La conferenza di Yalta e la fine del Terzo Reich. - La bomba atomica e la resa del Giappone. - Il dopoguerra: la guerra fredda, la divisione dell’Europa, il mondo bipolare.
10. L’Italia repubblicana
- Le forze politiche. - Dalla liberazione alla repubblica. - La Costituzione repubblicana. - La rottura dell’unità antifascista, le elezioni del 1948 e la sconfitta delle sinistre.
Al fine di fornire delle nozioni storiografiche finalizzate alla comprensione di fenomeni storici complessi, relativi alla prima meta del Novecento e al secolo nel suo complesso, si sono effettuati degli specifici interventi didattici dedicati ai seguenti temi: - La guerra civile europea (1914-1945); - Il secolo breve (1914-1991); - Capitalismo e processi di distruzione creatrice: da Marx a Schumpeter; - Il potere carismatico; - Interpretazioni dello Sterminio (Primo Levi ed Ernst Nolte).
CONTRIBUTO DELLA DISCIPLINA ALLE ATTIVITÀ PLURIDISCIPLINARI
1. Approfondimenti individuali degli studenti (“Tesine”)
In vista della prova orale d’esame, agli studenti che ne hanno fatto richiesta sono stati forniti materiali (saggi, film, documenti audiovisivi), indicazioni bibliografiche, riferimenti a siti internet e suggerimenti al fine di fornire gli essenziali strumenti storici e storiografici per l’approfondimento delle tematiche individuate. L’insegnante ha dato inoltre la propria disponibilità alla revisione dei testi e delle presentazioni multimediali.
2. Partecipazione a progetti, iniziative culturali e concorsi
Nel corso dell’anno scolastico, la classe o singoli studenti hanno partecipato su base volontaria ai seguenti progetti e iniziative a carattere culturale:
a. Mostra De Gasperi. Il coraggio di costruire, a cura della Fondazione De Gasperi.
b. Teatro No. Storia di un rifiuto, di e con Giacomo Vallozza – prodotto dal Teatro Stabile d’Abruzzo.
c. Progetto “Popoli in fuga: alla ricerca della pace, alla ricerca di un tetto” Visita di istruzione a Trieste: Centro Raccolta Profughi (CRP) di Padriciano e Civico Museo della Guerra per la Pace Diego de Henriquez, in collaborazione con Eupolis.
d. Conferenza storica promossa dall’Esercito – Caserma “Pietro Mittica” Lorenzo Cadeddu e Arturo Pellizon, La Grande Guerra. Guerra di trincea.
ISIS Leopardi Majorana
PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 5CS
DISCIPLINA: INGLESE Docente: Giulia Bozzola
La classe ha lavorato nel corso dell’anno essenzialmente intorno a tre progetti, di cui il secondo ha occupato larga parte dell’anno scolastico.
“From the Big Bang to... yesterday morning”
Il primo progetto ha visto il coinvolgimento di sette classi dell’istituto, ed è nato dalla considerazione delle difficoltà spesso riscontrate nelle varie classi nel localizzare eventi e personaggi storici e collocarli nel giusto periodo di appartenenza.
Il lavoro di creazione della timeline è stato suddiviso tra le varie classi (alla classe in questione è spettato il compito di lavorare al secondo cinquantennio del ventesimo secolo, e fino ai giorni nostri), ed è stata realizzata una prima versione cartacea (della lunghezza totale di circa venti metri, visibile nell’aula n.29 dell’istituto).
Il lavoro è stato poi condiviso con tutta la scuola, con possibilità per docenti e studenti di aggiungere altri eventi alla timeline, tramite esposizione delle stessa nei locali della scuola e post-it forniti all’uopo.
Il prodotto cartaceo è stato poi sottoposto a scannerizzazione fotografica, suddivisione in sezioni, con creazione di un template da fornire a ogni classe partecipante per riprodurre infine la timeline in versione digitale.
L’assemblaggio di tutte le parti in un unico file, e la produzione della versione digitale della timeline è stato quindi affidato a due studenti della classe parallela, che hanno realizzato dalla stessa una app scaricabile per sistema operativo android.
Il secondo progetto, dal titolo:
“The Kennedys: a Shakespearian tragedy?”
è nato dall’idea di cancellare le normali lezioni frontali, trasformando la classe in una redazione giornalistica che lavori ad un’inchiesta e che produca articoli sulla stessa, dove tutti siano responsabili del proprio lavoro nei confronti degli altri per arrivare ad una scrittura finale di un volume che risponda al quesito posto dal titolo del progetto. Le lezioni si sono infatti svolte intorno a un grande tavolo centrale, una specie di “sala riunioni”.Il progetto si è prefisso di insegnare agli studenti a ricercare informazioni ed elaborarle in maniera appropriata tramite i siti governativi, gli archivi dei giornali, la ricerca di foto e filmati, ognuno seguendo le proprie attitudini e capacità specifiche, coordinando il proprio lavoro con quello degli altri.
La prima parte del lavoro, viste le elezioni americane tenutesi nel novembre dello scorso anno, ha avuto come tema il dibattito intorno ai candidati, con un’analisi del sistema elettorale d’oltreoceano.
Per un’analisi più accurata del lavoro svolto, si rimanda alla premessa al volume realizzato, allegato alla documentazione della classe.
Competenze coinvolte:
• Progettare, comunicare, collaborare e partecipare; • Risolvere problemi; • Individuare collegamenti e relazioni; • Acquisire e interpretare l’informazione • Competenze digitali (con particolare attenzione al problem solving e al
saper comunicare in maniera corretta, efficace ed efficiente)
Il terzo (e ultimo) progetto in esame,
“My portfolio”
ha previsto la realizzazione di un portfolio personale da parte di ogni studente, che contiene:
• Un CV redatto in base agli standard europei; • Una cover letter di presentazione a un’università, o a un datore di lavoro
stranieri; • La presentazione di due romanzi contemporanei a scelta del candidato; • Un argomento a piacere, che abbia possibilmente un riferimento con le
scelte di studio future del candidato.
Per quanto riguarda la preparazione alla prova scritta, si sono svolte adeguate esercitazioni secondo i modelli delle terze prove previsti dal Ministero, favorendo la tipologia B, nella modalità dell’accertamento linguistico non direttamente collegato coi contenuti analizzati durante l’anno, ma piuttosto con somministrazione di brevi articoli di attualità e domande inerenti agli stessi, che dimostrino la capacità del candidato di esprimere il proprio pensiero su argomenti normalmente condivisi sull’ambiente, il costume, le ricerche scientifiche, le scoperte tecnologiche o le tendenze della nostra società. A titolo esemplificativo, le prove scritte durante l’anno hanno avuto per tema articoli sui seguenti argomenti:
- More people die from selfies than shark attacks - Healthiest hearts in the world found - IR8, the rice that saved India from famine - Samsung: don’t use dangerous Galaxy note - New store lets you shop, walk out and pay later - Sheep are not stupid after all
Strutturando la prova in tre domande, due di comprensione del testo, e una di opinione sull’argomento, attribuendo un punteggio più alto all’ultima domanda, dalla quale più chiaramente si può evincere la capacità di espressione autonoma del candidato.
Criteri di verifica e valutazione
Si è tenuto conto, oltre che della pura valutazione delle abilità linguistiche e delle conoscenze specifiche, anche dell’impegno, della partecipazione e della
progressione nell’apprendimento e non sono state sottovalutate condizioni personali, ambientali o familiari particolari.
L’insieme di queste osservazioni unito con i risultati conseguiti nelle prove di verifica sommativa ha determinato la valutazione quadrimestrale.
Attività di recupero
Sono state svolte alcune ore di sportello pomeridiano per piccoli gruppi in preparazione alla prova scritta.
Pordenone, 3 maggio 2017
RELAZIONE FINALE Insegnante: PILOSIO SUSI Classe VC scientifico Anno scolastico 2016/2017
MATEMATICA RELAZIONE SULLA CLASSE E OBIETTIVI RAGGIUNTI La classe ha seguito con attenzione le lezioni e quasi tutti gli studenti hanno partecipato attivamente all’attività didattica, con interventi e domande pertinenti, lavorando in modo proficuo durante le esercitazioni in classe. Molti alunni non sono stati però capaci di consolidare l’attività svolta a scuola con un costante e adeguato impegno personale, concentrandosi invece alternativamente nello studio di una delle due discipline, matematica o fisica, soprattutto in prossimità delle prove di verifica. Questo atteggiamento ha compromesso, per alcuni alunni, il recupero delle lacune pregresse e il pieno raggiungimento degli obiettivi prefissati. Risultano diversificate sia la conoscenza dei contenuti disciplinari sia la capacità di applicarli nello studio di una funzione reale in una variabile reale, nella risoluzione di problemi di geometria e di analisi e nel calcolo integrale. Un gruppo di alunni ha portato avanti, nel corso dell’intero triennio, il lavoro scolastico con impegno, costruendosi così una preparazione personale adeguata, raggiungendo gli obiettivi cognitivi specifici di questa disciplina con risultati nel complesso più che sufficienti e in alcuni casi buoni. Solo qualche studente ha acquisito una certa autonomia nella scelta delle strategie risolutive e nella rielaborazione personale dei contenuti. Gli allievi più fragili o meno motivati hanno incontrato diverse difficoltà nell’affrontare il programma previsto; nonostante un maggior impegno nel corso del secondo quadrimestre, la conoscenza degli argomenti trattati è ancora globalmente poco precisa e diversi allievi evidenziano difficoltà, anche gravi, nell’applicare correttamente le relazioni note alla risoluzione degli esercizi. METODI DIDATTICI, VERIFICHE, ATTIVITÀ DI RECUPERO E APPROFONDIMENTO La metodologia, i criteri di verifica e valutazione sono stati coerenti con quanto previsto nel Piano di Lavoro. I nuovi argomenti sono stati introdotti sfruttando principalmente la lezione frontale, con vari esempi esplicativi ed applicativi; sono stati poi approfonditi con numerosi e vari esercizi, stimolando il ricordo dei necessari prerequisiti. Nel corso dell’anno sono stati risolti diversi problemi e quesiti assegnati nei precedenti Esami di Stato.
Vista la nuova tipologia dell’Esame di Stato, nel corso del secondo quadrimestre si è dato spazio sia alla risoluzione di problemi legati alla realtà, associati agli argomenti curricolari svolti in questi ultimi tre anni di liceo, sia alle applicazioni di derivate, integrali ed equazioni differenziali a problemi di fisica. Le attività di recupero sono state svolte in itinere, prevalentemente durante l’orario curricolare o con alcune ore di sportello. Nel corso del secondo quadrimestre ho svolto un corso di approfondimento di matematica durante il quale sono stati rivisti gli argomenti svolti durante l’anno scolastico, risolti numerosi problemi legati alla realtà e gli esercizi presenti nelle simulazioni ministeriali e nelle prove d’esame di matematica degli ultimi anni scolastici. Le verifiche sono state articolate in forma diversa, tenendo conto anche della tipologia della seconda prova scritta dell’Esame di Stato; sono state svolte verifiche scritte (sia per la valutazione scritta che per quella orale) ed orali. Nel corso del secondo quadrimestre, gli allievi di tutte le quinte scientifico hanno svolto tre simulazioni di seconda Prova d’Esame (la terza sarà svolta dopo la metà di maggio). CONTENUTI CURRICOLARI Nozioni di topologia su R Intervalli; intorni di un numero o di un punto; punti isolati o di accumulazione; estremo inferiore, superiore, massimo e minimo di un insieme di numeri reali. Funzioni reali di variabile reale Richiami sul concetto di funzione; insieme di esistenza di una funzione ( ripasso su equazioni, disequazioni e risoluzioni grafiche); grafico di una funzione (ripasso sui grafici deducibili). Funzioni biunivoche, pari o dispari, monotone, periodiche, limitate; estremi inferiore e superiore, massimo e minimo di una funzione. Inversa di una funzione: legge e grafico. Simmetrie rispetto a punti e rette. Limiti delle funzioni reali di variabile reale Definizione di limite di una funzione reale di una variabile reale; limite finito ed infinito per una funzione con x che tende ad un punto o all’infinito; limite destro e sinistro di una funzione. Teoremi sui limiti: di unicità, di permanenza del segno, del confronto. Operazioni sui limiti e relativi teoremi. Infiniti e loro proprietà. Successioni e loro proprietà; progressioni aritmetiche e geometriche. Limite di una successione. Funzioni continue Funzioni continue in un punto ed in un intervallo. Proprietà delle funzioni continue in un intervallo chiuso e limitato: teoremi di Weierstrass, dei valori
intermedi, d'esistenza degli zeri. Limiti notevoli: 1(senx/x) lim
0
x
(con dimostrazione) e e1/x)(1 x
lim x
e loro applicazioni.
Forme indeterminate nel calcolo di un limite e tecniche fondamentali per risolverle. Punti di discontinuità per una funzione: classificazione. Asintoti di una funzione. Grafico probabile. Ripasso di geometria analitica dello spazio Coordinate cartesiane di un punto nello spazio: distanza tra punti e punto medio di un segmento. Equazione, parametrica e cartesiana, di un piano; condizione di parallelismo e di perpendicolarità tra piani. Equazione, parametrica e cartesiana, di una retta. Distanze tra punti, rette e piani; angolo tra rette e piani Equazione di una superficie sferica; piano tangente ad una sfera. Derivata di una funzione Rapporto incrementale e suo significato geometrico; derivata di una funzione reale di variabile reale e suo significato geometrico; derivate fondamentali. Teoremi sulle derivate: della somma, del prodotto, del quoziente; derivate delle funzioni composte e delle funzioni inverse (senza dimostrazione). Derivate d'ordine superiore. Derivabilità e continuità di una funzione. Punti di non derivabilità: punti angolosi, flessi verticali, cuspidi. Applicazione delle derivate: equazione della retta tangente e normale ad una curva. Curve tangenti. Applicazione delle derivate alla fisica. Differenziale di una funzione e suo significato geometrico. Teoremi sulle funzioni derivabili Teorema di Rolle, di Lagrange e corollari. Teorema di Cauchy .Regola di De l’Hopital. Problemi di massimo e minimo. Problemi di geometria piana e solida. Ripasso di geometria analitica, geometria solida e trigonometria. Studio del grafico di una funzione Asintoti orizzontali, verticali e obliqui. Crescenza e decrescenza, massimi e minimi relativi e assoluti di una funzione: definizioni e teoremi. Concavità, convessità e flessi di una funzione: definizioni e teoremi. Studio del grafico di una funzione. Integrali Definizione d'integrale indefinito e suo significato geometrico; calcolo degli integrali indefiniti immediati. Regole d'integrazione: per scomposizione, per sostituzione, per parti; integrazione di funzioni razionali fratte e di alcune funzioni irrazionali. Definizione d'integrale definito e suo significato geometrico. Proprietà dell’integrale definito. Teorema della Media e Teorema fondamentale del
calcolo integrale. Area di una regione piana; calcolo dei volumi dei solidi di rotazione. Funzione integrale. Integrali impropri e generalizzati. Applicazioni del calcolo integrale alla fisica. Equazioni differenziali Equazioni differenziali del primo ordine del tipo y’ = f(x), a variabili separabili e lineari. Equazioni differenziali del secondo ordine del tipo y’’= f(x) e omogenee a coefficienti costanti Problemi con equazioni differenziali del primo e del secondo ordine e condizioni al contorno. Applicazioni delle equazioni differenziali alla fisica Le distribuzioni di probabilità Ripasso sul calcolo combinatorio e sulla probabilità. Teorema di Bayes e Bernulli. Variabile casuale discreta e continua, distribuzione di probabilità: valor medio, deviazione standard e varianza. Funzione di ripartizione Distribuzione di probabilità: distribuzione uniforme discreta, distribuzione binomiale, formula di Bernoulli, distribuzione di Poisson Variabili casuali standardizzate Variabili casuali continue; funzione densità di probabilità: distribuzione uniforme continua, distribuzione normale o gaussiana Fonti utilizzate:
- M.Bergamini, G.Barozzi, A.Trifone “Matematica.blu.2.0” vol 5
(Zanichelli)
- M.Bergamini, G.Barozzi “Verso la seconda prova di matematica”
(Zanichelli)
- Testi e soluzioni delle Prove di Stato assegnate negli anni scolastici
precedenti (online.scuola.zanichelli.it)
Pordenone, 3 Maggio 2017 prof.ssa Pilosio Susi
RELAZIONE FINALE Insegnante: PILOSIO SUSI Classe VC scientifico Anno scolastico 2016/17
FISICA
RELAZIONE SULLA CLASSE E OBIETTIVI RAGGIUNTI La maggior parte degli studenti ha seguito con attenzione l’attività didattica, ma solo una parte della classe ha partecipato attivamente alle lezioni, con interventi e domande pertinenti. Nel corso del secondo biennio la gran parte degli studenti non è stata però capace di consolidare l’attività svolta in classe con un costante e adeguato impegno personale, concentrandosi invece alternativamente nello studio di una delle due discipline, matematica o fisica, privilegiando per lo più la prima. Questo atteggiamento ha compromesso, per alcuni alunni, una adeguata assimilazione dei contenuti sviluppati e il pieno raggiungimento degli obiettivi prefissati: diversi studenti sono stati promossi dopo aver avuto il debito in fisica. Nel corso di quest’anno scolastico, forse per la preoccupazione di avere Fisica come seconda prova d’esame, anche gli allievi più fragili o meno motivati hanno via via migliorato il loro metodo di studio e la loro preparazione; non tutti gli studenti sono stati però in grado di recuperare le lacune pregresse e raggiungere pienamente gli obiettivi prefissati. Le competenze disciplinari appaiono perciò differenziate, legate ai diversi livelli della preparazione di base, ma soprattutto all’impegno personale e all’accuratezza dello studio. La conoscenza degli argomenti svolti è per molti studenti adeguata; tuttavia vi sono ancora studenti che, pur conoscendo in modo sufficientemente preciso i contenuti del programma svolto, non sempre riescono ad organizzalo in una esposizione chiara ed efficace. Differenziata appare anche la capacità di impostare e risolvere varie tipologie di problemi. Diversi allievi evidenziano ancora delle difficoltà nell’applicare le conoscenze acquisite alla risoluzione di semplici problemi; solo qualche allievo è in grado di collegare e rielaborare autonomamente i contenuti appresi. METODI DIDATTICI, VERIFICHE, ATTIVITÀ DI RECUPERO E APPROFONDIMENTO La metodologia, i criteri di verifica e valutazione sono stati coerenti con quanto previsto nel Piano di Lavoro. I nuovi argomenti sono stati introdotti utilizzando soprattutto la lezione frontale e applicando quindi il metodo deduttivo, con vari esempi esplicativi ed applicativi; le definizioni ed i teoremi
sono stati enunciati in modo formale e le “dimostrazioni” state rigorose e particolareggiate. La trattazione teorica di diversi argomenti è stata quasi sempre affiancata dalla risoluzione di varie tipologie di problemi, tratti dal testo scolastico in adozione e da altri testi di scuola superiore. Nel primo quadrimestre (relativamente agli argomenti dell’induzione elettromagnetica e delle Equazioni di Maxwell) sono stati risolti numerosi esercizi tratti dagli Esami di Stato assegnati negli anni scolastici precedenti nel corso di studi PNI e da alcune Simulazioni fornite dal Ministero. Nel corso del secondo quadrimestre viste le caratteristiche della classe sopra evidenziate, ho privilegiato la trattazione teorica degli argomenti di Relatività Ristretta e di Fisica moderna: sono stati perciò svolti semplici esercizi applicativi degli argomenti svolti. In diversi momenti dell’anno scolastico sono stati svolti esercizi di fisica e dimostrazioni con l’uso di derivate, integrali ed equazioni differenziali. Le verifiche sono state articolate in forme diverse, tenendo conto anche delle simulazioni di Seconda Prova e delle tipologie previste per la Terza Prova dell’Esame di Stato. Ci sono state alcune verifiche scritte con risoluzione di problemi, quesiti a risposta breve o aperta, ed almeno due verifiche orali in ogni quadrimestre. Nel corso del secondo quadrimestre è stata svolta anche una simulazione di Terza Prova; la prova di fisica è stata strutturata con tipologia B. L’attività di recupero è stata svolta in classe, in itinere, e ha dato risultati soddisfacenti solo per gli studenti che si sono adeguatamente impegnati nello studio personale. MODULO CLIL
- Gli alunni hanno assistito ad una conferenza “Robotics" tenuta da uno studente del Mit di Boston
CONTENUTI CURRICOLARI
Induzione elettromagnetica
Ripasso sul campo elettrostatico e magnetico: teoremi di Gauss e teoremi
sulla Circuitazione, per i campi elettrostatici e magnetici. Leggi di Ohm ed
Effetto Joule.
Circuito RC alimentato a tensione continua: analisi qualitativa e quantitativa,
risoluzione dell’equazione differenziale e analisi di come variano carica, ddp
sulle piastre del condensatore e l’intensità di corrente.
Esperienze di Faraday sulle correnti indotte: analisi qualitativa e quantitativa
del fenomeno dell’induzione elettromagnetica: fem indotta, flusso
concatenato, legge di Faraday-Neumann (con dimostrazione); bilancio
energetico e Legge di Lenz.
Autoinduzione elettromagnetica; calcolo (dimostrazione) dell’induttanza di un
solenoide; legge di Faraday-Neumann per l’autoinduzione. Correnti parassite.
Circuito RL alimentato a tensione continua: analisi qualitativa e quantitativa,
risoluzione dell’equazione differenziale e calcolo dell’extracorrente di chiusura
e di apertura di un circuito. Bilancio energetico di un circuito RL.
Calcolo dell’energia intrinseca della corrente (con l’integrale definito) e della
densità di energia di un campo magnetico (dimostrazione nel caso di un
campo magnetico uniforme, all’interno di un solenoide).
Generatori elettrici di corrente alternata. Circuito ohmico in corrente alternata,
corrente efficace. Potenza assorbita nei circuiti in corrente alternata.
Circuito LC (con R=0): analisi qualitativa e quantitativa; analisi delle leggi che
esprimono come variano la carica q, la corrente i e l’energia elettromagnetica,
dedotte per analogia dall’analisi del moto armonico di un sistema massa-
molla in assenza di attrito.
Esercizi sull’induzione, autoinduzione, alternatore e circuiti ohmici in corrente
continua e alternata ( solo resistivo).
Le Equazioni di Maxwell e le onde elettromagnetiche
Prima e seconda equazioni di Maxwell (senza dimostrazione-dal programma
svolto in IV).
Campo elettrico indotto e Legge di Faraday-Neumann; dimostrazione della III
equazione di Maxwell.
Il paradosso della legge di Ampère per il campo magnetico, corrente di
spostamento e campo magnetico indotto; dimostrazione della IV equazione di
Maxwell.
Onde elettromagnetiche: genesi e propagazione. Energia trasportata: densità
di energia, intensità e quantità di moto di un’onda elettromagnetica. Lo
spettro elettromagnetico.
La polarizzazione della luce: Legge di Malus.
Esercizi su campi elettrici e magnetici indotti; esercizi sull’energia trasportata
da un’onda elettromagnetica e sulla luce polarizzata.
Einstein e la relatività ristretta.
I Postulati della relatività galileiana e le trasformazioni di Galileo; spazio e
tempo assoluti. Grandezze assolute e leggi di composizione delle velocità
classiche.
Le equazioni di Maxwell e il problema dell’etere. Illustrazione dell’esperimento
di Michelson e Morley e interpretazione dei risultati sperimentali. I postulati
della relatività ristretta e le trasformazioni di Einstein-Lorentz, ricavate come
conseguenza di tali postulati.
La critica di Einstein al concetto di simultaneità: l’esperimento “mentale” di
Einstein del treno. Analisi di eventi simultanei, sia nel piano di Minkowski sia
con l’uso delle trasformazioni di Lorentz-Einstein.
La relatività del tempo: dimostrazione della formula di dilatazione dei tempi
utilizzando l’orologio a luce.
La relatività dello spazio: dimostrazione della formula della contrazione delle
lunghezze utilizzando l’orologio a luce.
Evidenze sperimentali: il decadimento dei mesoni; il paradosso dei gemelli.
Il nuovo concetto di spazio-tempo; l’invariante spazio-temporale.
Leggi di composizione delle velocità relativistiche.
Relatività e gravitazione: materia e curvatura dello spazio-tempo.
Massa e quantità di moto relativistica: loro confronto con le corrispondenti
grandezze della fisica classica. Nuovo enunciato del Secondo Principio della
Dinamica.
E=mc2 energia relativistica: energia a riposo, energia cinetica relativistica.
Principio di conservazione della massa energia: dimostrazione ed esempi
esplicativi: difetto di massa, il decadimento beta, la produzione di coppia,
annichilamento elettrone e positrone.
Dimostrazione del legame tra energia totale e quantità di moto di un corpo.
Particelle a massa nulla, i fotoni: energia e quantità di moto di un fotone.
Sono stati svolti semplici esercizi applicativi .
La crisi della fisica classica: il “quanto” di Planck
La radiazione termica di un corpo nero. Lo spettro di emissione del corpo
nero: analisi dei risultati sperimentali; legge di Kirchhooff, legge di Stefan-
Boltzman, legge di spostamento di Wien e Legge di Rayleigh-Jeans. Ipotesi
di Planck: i fotoni. Interpretazione del problema del corpo nero da parte di
Planck
Effetto fotoelettrico: confronto fra le ipotesi teoriche classiche e i risultati
sperimentali; interpretazione di Einstein.
Effetto Compton: analisi dei risultati sperimentali. Legge e lunghezza d’onda
di Compton.
Sono stati svolti semplici esercizi applicativi .
Verso la fisica quantistica
I modelli atomici: modello di Thomson, modello di Rutherford. Dimostrazione
della formula che esprime il raggio delle possibili orbite dell’atomo di idrogeno
e dell’energia totale del suo elettrone nel modello di Rutherford.
Analisi dei risultati sperimentali non adeguatamente spiegati dal modello di
Rutherford: stabilità dell’atomo e spettri di emissione e di assorbimento
discreti
L’atomo d’idrogeno secondo il modello di Bohr: quantizzazione dei raggi delle
orbite e dell’energia (con dimostrazione). Sono stati svolti semplici esercizi
applicativi
Cenni ai numeri quantici; Principio di Esclusione di Pauli.
La natura ondulatoria della materia: le onde associate agli elettroni di De
Broglie; l’equazione d’onda di Schrodinger
Elettroni e fotoni: dualismo onda particella. Analisi dell’ esperimento della
interferenza con due fenditure con sorgenti che emettono singoli elettroni.
Principio di Complementarietà. Principio di Indeterminazione Heisemberg
Fisica nucleare
Il nucleo atomico; le forze fondamentali presenti in natura; La stabilità del
nucleo e le cause della radioattività. I processi di decadimento radioattivo:
alfa, beta, gamma e per cattura elettronica; cause e caratteristiche; le
radiazioni ionizzanti e non ionizzanti. Potere di penetrazione.
La legge del decadimento radioattivo, tempo di dimezzamento, attività di un
radionuclide.
La radioattività ambientale; effetti delle radiazioni sul corpo umano.
Sono stati svolti semplici esercizi applicativi
Approfondimento:
- visita al CRO di Aviano: uso delle radiazioni elettromagnetiche in campo
medico: raggi X, TAC, PET.
- energia di legame in funzione dei nucleoni; cenni su fissione e fusione
nucleare, vantaggi e svantaggi.
FONTI UTILIZZATE
-Libro adottato: “Fisica e realtà.blu” , vol 3°, Claudio Romeni (Zanichelli)
-Esercizi su Induzione elettromagnetica ed Equazioni di Maxwell tratti anche
dal testo: “Fisica” vol 3°, J.S. Walker (Zanichelli)
-Temi assegnati agli esami di stato PNI
-Dispense fornite dall’insegnante per “Einstein e la relatività ristretta”
-Presentazioni ppt sulla crisi delle scienze, fisica atomica e fisica nucleare,
fornite dall’insegnante.
Pordenone, 3 Maggio 2017 prof.ssa Pilosio Susi
DISCIPLINA: SCIENZE Docente : Cappella Riccarda La classe si presenta alquanto eterogenea, parte di essa si è dimostrata interessata alle tematiche proposte, ha partecipato in modo attivo alla lezione curricolare, studiato con costanza ed in modo approfondito ottenendo così buoni risultati, la restante si è applicata in modo discontinuo e poco rigoroso, con esiti alterni nelle prove di verifica e profitti, in molti casi, non adeguati alle proprie potenzialità. In ogni caso tutti gli alunni hanno acquisito le conoscenze e le competenze previste dal piano di studi, pur se in modo molto diversificato. Gli obiettivi indicati nel piano di lavoro sono stati sufficientemente raggiunti dalla totalità degli allievi, pochi spiccano per le competenze e le abilità che hanno acquisito. La classe ha partecipato ad una uscita didattica nel territorio di Gemona.
L’attività ,divisa in due parti , ha visto coinvolti un geologo e un architetto . Il
primo per approfondire tematiche legate alla sismicità del territorio, il secondo
per spiegare le diverse modalità di ricostruzione messe in pratica a Gemona
e a Venzone dopo il terremoto del 1976.
Programmazione per competenze: Competenze Contenuti
Fare propri i principi fondamentali sui quali si basa la chimica del carbonio. Acquisire le regole della nomenclatura
Idrocarburi alifatici e aromatici Isomeria Tipi di reazioni Nomenclatura IUPAC Polimeri e loro utilizzo
Comprendere il ruolo della chimica organica nei processi biologici
Biomolecole e loro funzione Glicolisi e demolizione del glucosio
Svolgere le reazioni caratteristiche Respirazione cellulare, tappe fondamentali del ciclo di Krebs Fermentazione Fotosintesi
Comprendere l’importanza e l’applicazione della genetica
DNA , replicazione semiconservativa Codice genetico Sintesi proteica Mutazioni
Analizzare fenomeni legati ai flussi di Fenomeni endogeni, onde sismiche
materia e di energia e vulcanesimo
Interno della Terra
Saper individuare nella tettonica a placche la teoria unificante dei fenomeni geologici
Tettonica a zolle Teoria e movimenti delle placche
Strumenti di verifica Strumenti di verifica sono stati prove a risposta chiusa e prove a risposta aperta, interrogazioni orali. Per gli argomenti di biochimica è stato utilizzato un opuscolo riportante le principali reazioni. Criteri di verifica e valutazione La valutazione formativa è stata attuata mediante prove oggettive strutturate e prove scritte non strutturate. La valutazione ha prestato attenzione all'uso della terminologia specifica, alla chiarezza e correttezza espositiva, all'interesse, alla partecipazione, alla puntualità e alla continuità nell'impegno manifestato dall'allievo
PROGRAMMA SVOLTO
Chimica organica
Proprietà dell’atomo di carbonio, gruppi funzionali
Alcani : isomeria , nomenclatura , proprietà fisiche, reazioni
Alcheni: isomeria, nomenclatura, reazioni, regola di Markovnikov
Alchini : isomeria, reazioni, dieni, cicloalcani : cenni generali
Benzene: struttura, nomenclatura di alcuni derivati del benzene, sostituzione
elettrofila, nitrazione del benzene, alogenazione del benzene,
Alcoli: nomenclatura, proprietà fisiche e chimiche, reazioni caratteristiche (
ossidazione, disidratazione)
Eteri: nomenclatura, preparazione
Isomeria e stereoisomeria: chiralità,
Aldeidi e chetoni: nomenclatura, reattività del gruppo carbonilico, reazione di
addizione nucleofila,
Acidi carbossilici: nomenclatura, acidi grassi, formazione di sali
Esteri: preparazione
Ammine: proprietà chimico-fisiche
Chimica dei polimeri: caratteristiche chimiche fondamentali, polimeri per
poliaddizione
Biochimica
Fotosintesi : reazione luce e ciclo di Calvin .
Respirazione cellulare : glicolisi, fermentazione, ciclo di Krebs , fosforilazione
ossidativa.
Duplicazione del DNA.
Sintesi proteica . Codice genetico.
Scienze della Terra
Dinamica endogena, gradiente geotermico, radioattività naturale, magma,
cristallizzazione frazionata , eruzione vulcanica, materiali piroclastici,
morfologia degli edifici vulcanici, forma secondaria dell’attività magmatica,
distribuzione dei vulcani sulla Terra. Diversi tipi di pieghe e di faglie. Onde
sismiche : onde P, onde S, onde R, onde L. Intensità e magnitudo di un
terremoto. Interno della Terra. Distribuzione dei terremoti. Tettonica delle
placche. Deriva dei continenti : prove. Paleomagnetismo. Margini divergenti,
convergenti , conservativi. Punti caldi.
RENATO RUSSI
Materia: DISEGNO E STORIA DELL’ARTE
Anno scolastico 20016/2017
CLASSE 5C Scientifico
La classe, ha seguito complessivamente con un certo interesse il
percorso didattico presentato nel corso dell’anno scolastico. Una
buona parte degli allievi ha dimostrato disponibilità al dialogo
nell’affrontare gli argomenti trattati anche attraverso un confronto
costante e costruttivo con l’insegnante.
Per comprendere più approfonditamente le tematiche dei vari
periodi artistici sono state proiettate opere in CD, Power Point e
visionati film e filmati su opere e autori appartenenti ai periodi
trattati.
In particolare si e’affrontato l’ architettura come evoluzione dello
spazio dell’uomo e della tipologia edilizia analizzando la teoria ed
alcune opere dei maestri quali Adolf Loos, W.Gropius, G.Terragni,
Le Corbusier, L. Kahn, Aldo Rossi, Renzo Piano.
Gli obiettivi principali raggiunti riguardano l’acquisizione della
terminologia e la capacità di utilizzare un lessico specifico; la
capacità di riconoscere le opere d’arte , lo stile, il periodo e l’autore;
la capacità di mettere a confronto più opere dello stesso periodo.
In merito alla valutazione, durante tutto l’anno scolastico, sono
state effettuate verifiche attraverso test scritti ed elaborati grafici
per quanto concerne il disegno tecnico con il progetto di una casa
unifamiliare e la sua rappresentazione con piante, sezioni, prospetti,
assonometrie e prospettive.
Durante il secondo periodo dell’anno scolastico non è stato
possibile avere a disposizione il numero di ore preventivate,
eseguendo così dei tagli agli argomenti previsti dal piano annuale
di lavoro.
PROGRAMMA SVOLTO
1- I presupposti, l’Art Nouveau e l’Architettura
• Guimard: Stazione del metro;
• Gaudi: Casa Milà;
• Hoffmann Palazzo Stoclet;
• Klimt: Giuditta I, Danae;
• Olbrich: Palazzo della Secessione;
• Loos: Casa Scheu.
2- I Fauves , L’Espressionismo
• Matisse: La stanza rossa, La danza;
• Munch: Il grido, Pubertà. Il bacio
3- Il Novecento delle avanguardie storiche, il Cubismo
• Picasso: Les demoiselle’s d’Avignon, Guernica.
4- La stagione italiana del Futurismo, Marinetti
• Boccioni: La città che sale, Stati d’animo gli addii, Rissa in
galleria;
• Sant’Elia: La città nuova;
• Balla: Velocità d’automobile, Dinamismo di un cane al guinzaglio;
5- La Metafisica
• G. De Chirico: L’ enigma dell’ora, Le Muse inquietanti;
• C. Carra’: La musa metafisica;
6- Il Dada
• Hausmann: Lo spirito del nostro tempo;
• Duchamp: Ruota di bicicletta, Fontana, LHOOQ;
• Man Ray: Cadeau, Le violon d’Ingres.
7- Surrealismo
• Max Ernst: La puberte’ proche ( o le pleiadi), il Pianeta
disorientate;
• Mirò: Pittura e collage preparatorio, Il carnevale di Arlecchino,
Blu III;
• Dalì: Sogno causato dal volo di un’ape.
• Magritte: Le passewggiate di Euclide, L’impero delle luci, l’uso
dellaparola I;
8- Astrattismo, Der Blaue Reiter
• Kandinskij: Alcuni cerchi, Paesaggio estivo, Composizione VI;
• Mondrian: L’Albero rosso,Composizione 10;
• Rietveld: Sedia rosso blu, casa Schroder;
• P. Klee: Monumenti a G.
9- Il Razionalismo in architettura – Bauhaus
• Mies van der Rohe: Padiglione della Germania;
• Grophius: Nuova sede della Bauhaus;
• Le Corbusier: Chaise longue, Villa Savoie, Unita’ di abitazione;
• F.Lloyd Wright: Casa sulla cascata, Guggenheim Museum a New
York.
10- Architettura fascista
• E42 – il manifesto urbanistico dell’era fascista.
• G. Terragni: Ex casa del fascio
11- Verso il Contemporaneo
• Moore: Madre sdraiata e drappeggiata con bambino;
12- Pop Art
• Andy Warhol: Marylin, Minestra in scatola Campbell’s.
13 - L’Espressionismo Astratto in America
• Pollock: Pali blu;
14- Architettura anni Sessanta e Settanta
• Louis Kahn: Biblioteca e mensa della Phillips Accademy;
• Oscar Niemeyer: Sede Mondadori.
15- Architettura di fine Millennio
• R. Piano: Centro nazionale d’arte a Parigi; Città della Musica
Roma
• Gehry: Museo Guggenheim Bilbao;
• Aldo Rossi: Teoria: Il concetto di “architettura analoga ed il
Frammento” , Principali edifici costruiti.
Testo in uso:
- Il Cricco Di Teodoro, Itinerario nell'Arte vers. gialla vol. 4,
ZANICHELLI
- Il Cricco Di Teodoro, Itinerario nell'Arte vers. gialla vol. 5,
ZANICHELLI
Il Docente: Renato Russi
Liceo "G. Leopardi - E. Majorana" Classico Scientifico Sociopsicopedagogico
Scienze Motorie e Sportive
Classe: 5^ C Scientifico Insegnante: Etrari Paola Anno Scolastico 2016-17
Relazione sull’attività svolta La classe, pur presentando una composizione molto diversificata per abilità pregresse e competenze motorie acquisite, ha dimostrato un discreto interesse nei confronti di questa materia e una certa disponibilità all’apprendimento. In quasi tutte le proposte è stato privilegiato l’approccio pratico, di movimento, di ricerca del gesto tecnico, rispetto a quello più specificatamente teorico. La scelta delle proposte didattiche è stata influenzata anche dalla disposizione logistica in cui si è venuti ad operare. Obiettivi educativi Consolidamento della consapevolezza della propria motricità Raggiungimento di un’autonomia di lavoro attraverso l’approfondimento
e la gestione di alcune attività motorie vicine ai propri interessi Acquisizione di una maggiore sensibilità rispetto al proprio stato di
salute psico-fisico Promozione di una cultura motoria intesa come stile di vita, anche in
relazione alle possibilità offerte dal territorio Obiettivi cognitivi Conoscenza degli elementi e dei comportamenti che intervengono nella
conservazione dello stato di salute Ed. alla prevenzione e alla sicurezza – rianimazione cardio-polmonare.
Obiettivi operativi Miglioramento delle qualità fisiche:
• Resistenza • Forza • Velocità Affinamento delle funzioni neuro-muscolari:
• Destrezza generale, coordinazione, abilità • Miglioramento equilibrio statico e dinamico • Elaborazione delle informazioni spazio-temporali Acquisizione di capacità sportive e/o motorie
• Acquisizione delle competenze tecniche di almeno una specialità sportiva individuale e di due sport di squadra
• Saper praticare tali attività secondo le proprie attitudini e caratteristiche Metodi didattici
Il metodo principalmente utilizzato è stato quello globale, alternato a quello analitico durante le attività di potenziamento fisiologico, nei momenti di pratica sportiva e dove necessario. Il lavoro è stato svolto attraverso esercitazioni individuali, a piccoli gruppi, a gruppi di interesse o con l’intero gruppo-classe, privilegiando l’approccio di tipo partecipativo. Si è cercato di offrire una gamma di proposte diversificate in modo da stimolare gli interessi e rispondere alle esigenze di ogni allievo/a e della classe in generale. Contenuti proposti • Test di ingresso e di uscita: addominali; salto in lungo da fermi; piegamenti
sugli arti superiori; Harre test, corsa a navetta, rapidità degli arti inferiori, lancio della palla medica, prova di elevazione.
• Corsa continuata a ritmo e durata progressivamente crescenti. Test di resistenza - conteggio della distanza percorsa. - Attività all’aperto.
• Percorsi misti con ex di destrezza e abilità; andature di coordinazione – Circuit training: invenzione di esercizi a coppie con piccoli attrezzi.
• Attività con la musica: country dance. • Yoga: approccio alla disciplina. Il ruolo della respirazione. Rilassamento,
allungamento, tenuta ed equilibrio. Sequenza di "asana". Il saluto al sole. • Conoscenza e utilizzo di una sala attrezzi: esercizi specifici e gruppi
muscolari coinvolti. • Arrampicata sportiva: conoscenza e utilizzo di una sala boulder: movimenti
base, equilibrio e tenuta. Esecuzione di semplici passaggi in successione • Pallavolo: controllo, palleggio e bagher. Il servizio e la ricezione. L’alzata e
il colpo di attacco. Il muro. Costruzione di un'azione tipo di attacco-difesa con alzatore al centro. Regolamento e partite.
Dopo il 15 maggio • Test di uscita: salto in lungo da fermi, prova di elevazione, addominali,
piegamenti sugli arti sup, prova di rapidità, test di coordinazione • Uscita al campo di golf: conoscenza e pratica di questa disciplina. Modulo Clil: lezioni di pallavolo proposte da alunna americana. Attività extracurricolari: progetto “Keep the beat”: utilizzo del defibrillatore Torneo interno di calcio a 5. Firme studenti: ________________________________________________ ________________________________________________ Pordenone, 4 maggio 2017
RELIGIONE CATTOLICA
Classe V Cs Prof. Tagliapietra Marco
La classe, composta da 15 alunni che si avvalgono dell’insegnamentodell’ora di religione, ha dimostrato un buon interesse e impegno. Ilclima in classe è stato positivo, sereno e da parte della maggior partedegli alunni costruttivo. Lo svolgimento delle lezioni è stato regolare epiacevole. La classe ha dimostrato di apprezzare i momenti di confronto e didialogo; diversi alunni hanno partecipato attivamente al dialogo e alconfronto. Solo pochi alunni, pur seguendo con interesse, sonointervenuti poco in modo attivo e spontaneo, privilegiando unatteggiamento di ascolto.L’atteggiamento e il comportamento in classe sono stati corretti.
Obiettivi complessivamente raggiunti
Avere un’attenzione agli avvenimenti di attualità, conoscerli e saperliaffrontare criticamente, con particolare attenzione alle questioni eticheed antropologiche. Riflettere e prendere consapevolezza del valore dellavita. Saper riconoscere il valore della libertà e il ruolo della coscienzanelle scelte della vita. Conoscere la proposta di un Dio che è amore edona amore. Prendere consapevolezza del rapporto diritti-doveri.Conoscere il pensiero della Chiesa rispetto ad alcune questioni etiche.Prendere consapevolezza dell’importanza della coerenza ai propri idealie alla propria fede religiosa. Conoscere gli avvenimenti e i contenutiprincipali del Concilio Vaticano II. Conoscere alcune linee di fondo delladottrina sociale della Chiesa e gli impegni per la pace, la giustizia e lasalvaguardia del creato.
Contenuti trattati
Il Giubileo straordinario della misericordia. Il comportamento umano e i valori morali. L’insegnamento etico della Chiesa sulla vita, il matrimonio e la famiglia.La dottrina sociale della Chiesa: la persona, il lavoro, i beni e le scelteeconomiche, l’ambiente e la politica. Coscienza, libertà e responsabilità;l’obiezione di coscienza. La persona umana fra le novità tecnico-scientifiche e le ricorrenti
domande di senso. Il Concilio Vaticano II: storia, documenti, effetti nella Chiesa e nelmondo. Il rapporto della Chiesa con il mondo contemporaneo, con riferimento aitotalitarismi del Novecento e al loro crollo, ai nuovi scenari religiosi, allaglobalizzazione e migrazione dei popoli.
Strategie didattiche utilizzate
Lezione frontale; lezione dialogata; lavori di gruppo; lettura di fonti, testi edarticoli; schematizzazione concetti; visione critica di film o documentari;riflessione personale e di gruppo orale o scritta; ricerca personale di materialia tema; brainstorming.
LICEO “LEOPARDI-MAJORANA” – PORDENONE Piazza Maestri del Lavoro n. 2 - Tel. 0434 27206 – Fax 0434 523664
e-mail: [email protected] – www.leomajor.gov.it