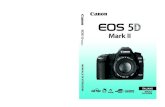DOCUMENTO PREDISPOSTO DAL CONSIGLIO DELLA CLASSE 5D · presenza e il valore nella società odierna....
Transcript of DOCUMENTO PREDISPOSTO DAL CONSIGLIO DELLA CLASSE 5D · presenza e il valore nella società odierna....
1
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Istituto d’Istruzione Secondaria Superiore di II^ Grado
LICEO ARTISTICO “A. FRATTINI” Via Valverde, 2 - 21100 Varese
tel: 0332820670 fax: 0332820470 e-mail: [email protected] [email protected]
COD.MIN.:VASL040006 C.F.:80016900120
DOCUMENTO PREDISPOSTO DAL CONSIGLIO DELLA CLASSE 5D
INDIRIZZO ARTI FIGURATIVE
15/05/2015
2
Risultati di apprendimento dei distinti percorsi liceali
LICEO ARTISTICO
“Il percorso del liceo artistico è indirizzato allo studio dei fenomeni estetici e alla pratica artistica.
Favorisce l’acquisizione dei metodi specifici della ricerca e della produzione artistica e la padronanza dei linguaggi e delle tecniche relative.
Fornisce allo studente gli strumenti necessari per conoscere il patrimonio artistico nel suo contesto storico e culturale e per coglierne appieno la
presenza e il valore nella società odierna. Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità e a maturare le
competenze necessarie per dare espressione alla propria creatività e capacità progettuale nell’ambito delle arti” (art. 4 comma 1).
Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento comuni, dovranno:
conoscere la storia della produzione artistica e architettonica e il significato delle opere d’arte nei diversi contesti storici e culturali anche in relazione agli indirizzi di studio prescelti;
cogliere i valori estetici, concettuali e funzionali nelle opere artistiche;
conoscere e applicare le tecniche grafiche, pittoriche, plastico-scultoree, architettoniche e multimediali e saper collegare tra di loro i diversi linguaggi artistici;
conoscere e padroneggiare i processi progettuali e operativi e utilizzare in modo appropriato tecniche e materiali in relazione agli indirizzi prescelti;
conoscere e applicare i codici dei linguaggi artistici, i principi della percezione visiva e della composizione della forma in tutte le sue configurazioni e funzioni;
conoscere le problematiche relative alla tutela, alla conservazione e al restauro del patrimonio artistico e architettonico.
3
Indirizzo Arti figurative
Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, dovranno:
aver approfondito la conoscenza degli elementi costitutivi della forma grafica, pittorica e/o scultorea nei suoi aspetti espressivi e comunicativi e acquisito la consapevolezza dei relativi fondamenti storici e concettuali; conoscere e saper applicare i principi della percezione visiva;
saper individuare le interazioni delle forme pittoriche e/o scultoree con il contesto architettonico, urbano e paesaggistico;
conoscere e applicare i processi progettuali e operativi e utilizzare in modo appropriato le diverse tecniche della figurazione bidimensionale e/o tridimensionale, anche in funzione della necessaria contaminazione tra le tradizionali specificazioni disciplinari (comprese le nuove tecnologie);
conoscere le principali linee di sviluppo tecniche e concettuali dell’arte moderna e contemporanea e le intersezioni con le altre forme di espressione e comunicazione artistica;
conoscere e saper applicare i principi della percezione visiva e della composizione della forma grafica, pittorica e scultorea.
COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE
LETTERATURA ITALIANA Prof.ssa BOLLINI Alessandra
STORIA Prof. BRUSAIOLI Enrico
STORIA DELL'ARTE Prof.ssa NICODEMI Francesca
FILOSOFIA Prof. BRUSAIOLI Enrico
INGLESE Prof. DE BONIS Gianna
MATEMATICA E FISICA Prof. LUCIANI Filomena
DISCIPLINE PITTORICHE Prof. CORTI Emilio
LABORATORIO FIGURAZ. Prof. CORTI Emilio
DISCIPLINE PLASTICHE Prof. CAMPAGNA Ignazio
LABORATORIO FIGURAZ. Prof. CAMPAGNA Ignazio
EDUCAZIONE FISICA Prof.ssa BONA Viviana
RELIGIONE Prof. CARENZO Franco
4
PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 5^D indirizzo figurativo
L’attuale 5^D si è costituita nell’A.S. 2012-2013, attraverso l’inserimento di alunni che avevano scelto l’indirizzo figurativo; il gruppo iniziale era di
trenta elementi, tra i quali otto ripetevano la classe.
Nel corso di tale A.S. e di quello successivo, il numero degli alunni si è ridotto a ventiquattro, in seguito alle non ammissioni o al ritiro di alcuni di
loro.
All’inizio dell’attuale A.S. sono stati inseriti nella classe due nuovi elementi: il primo non era stato ammesso all’Esame di Stato precedente; per la
seconda si tratta di una ragazza proveniente da un percorso di studi all’estero..
I rapporti fra gli alunni – tranne qualche occasione episodica di dissidio – sono in genere improntati alla cordialità, ed anche, fra singoli o gruppi,
ad un senso di viva amicizia, cementato anche grazie alle esperienze formative che essi hanno vissuto negli anni precedenti: prima fra tutte
quella dell’Alternanza Scuola-Lavoro, svoltasi durante la Terza e la Quarta presso il MAGA di Gallarate.
Dopo un avvio di triennio in cui emergevano diversi problemi (tenuta della disciplina; rispetto delle regole; difficoltà a concentrarsi sull’attività
scolastica ed infine – in qualcuno – una certa demotivazione allo studio) il gruppo classe è gradualmente maturato, imparando a superare i limiti
iniziali.
L’interesse per le materie di indirizzo è tuttavia sempre stato vivace, e costante l’applicazione alle attività ad esse correlate. Meno evidente era
invece quello per le altre discipline; ma anche in questo caso si è messo in luce, soprattutto in quest’anno scolastico, un approccio più maturo e
consapevole da parte di quasi tutti gli alunni. Fra loro poi spicca un gruppo di elementi (circa un quarto della classe) che si sono sempre distinti
per i risultati positivi.
In particolare, si segnalano le difficoltà che la classe ha dovuto affrontare per Matematica e Fisica: esse sono legate soprattutto al percorso di
Terza e Quarta, caratterizzato purtroppo da un avvicendamento di insegnanti diversi, con anche qualche momento di assenza di docenti.
Si segnala, infine, la presenza di un alunno con DSA, per il quale sono state sempre adottate le misure compensative e dispensative più idonee,
nel rispetto della L. 170/2010.
5
RESOCONTO ATTIVITA' INTEGRATIVE
26/11/2014: visita didattica al Museo Messina e Museo del Novecento
3/12/15Gemonio, Museo Bodini, mostra del pittore/scalatore Fasana
25/3/15 Varese, Museo di Masnago – Mostra “Ad arte per l'arte” durante la visita di questa mostra è stata effettuata una lezione pratica
sull'acquaforte (dalla preparazione della lastra, all'incisione, alla stampa al torchio).
15/04/2015: visita didattica a Basilea, Fondazione Beyeler – Gauguin
16/04/15: Partecipazione a seminario “Arte e Territorio: le radici della creatività” – Progetto Giovani Pensatori – Università dell’Insubria
29/4/15 Visita ai cantieri dei marmisti della Veneranda Fabbrica del Duomo di Milano e successivamente alla Galleria d’Arte Moderna.
6
PROGRAMMI SVOLTI DELLE SINGOLE DISCIPLINE
ITALIANO - Docente Prof.ssa BOLLINI Alessandra
PROGRAMMA SVOLTO
N.B. Le ore indicate s’intendono di solo svolgimento degli argomenti.
1_DANTE ALIGHIERI, LA DIVINA COMMEDIA, PARADISO (15 ore)
Il Paradiso: la struttura del cosmo dantesco
Lettura, parafrasi e analisi dei seguenti canti:
* Canto I, vv. 1-15; 43-143.
* Canto III, per intero
* Canto XVII, vv. 13-142
* Canto XXXIII, vv. 1-66; 115-145
2_GIACOMO LEOPARDI (12 ore) ………………………………… da p. 2 vol. 4
La biografia
Il pensiero: il pessimismo storico; il pessimismo cosmico
La teoria del piacere
La poetica del vago e dell’indefinito
Lo Zibaldone: cenni appunti
7
L’ultimo Leopardi: linee generali.
I Canti: ……………………………………………………………..… p. 20
* L’infinito …………………………………………………………….. p. 42
* Alla luna ……………………………………………………………. p. 48
* A Silvia …………………………………………………………….. p. 53
* Canto notturno di un pastore errante dell’Asia ………………… p. 63
* La quiete dopo la tempesta ……………………………………… p. 69
Le Operette morali: ………………………………………………… p. 94
* Dialogo della natura e di un islandese ………………………… p. 105
* Dialogo di un venditore di almanacchi e di un passeggere …. p. 112
3_SVILUPPI DEL ROMANZO NEL 1800 (18 ore)
Il romanzo realista: linee generali ………………………………… appunti
Il Naturalismo: letteratura, scienza e osservazione della realtà …. p. 248
E. Zola, L’Ammazzatoio: la trama ………………………………… p.261
* Cap. I: “L’attesa di Gervasia” …………………………………… p. 261
* Cap. XII (parte) …………………………………………………… in fotoc.
Il Verismo: la grande stagione del verismo siciliano …………… p. 264
G. Verga: …………………………………………………………….. da p. 270
- La biografia
- Il pensiero e la poetica
I Malavoglia: ………………………………………………………… p. 302
* Cap. I (per intero) …………………………………………………. testo individuale
* Cap. XI: “Non voglio più farla questa vita” ……………………… p. 323
8
* Cap. XV (per intero) ………………………………………………. testo individuale
Mastro don Gesualdo: (trama e linee generali) …………………… p. 349
Il Decadentismo: ……………………………………………………. da p. 384
- Coscienza della crisi e rinnovamento
- Generi e correnti del Decadentismo europeo
G. D’Annunzio: ……………………………………………………… da p. 508
- La biografia
- La produzione di carattere narrativo (linee generali)
- I romanzi del superuomo (linee generali)
Il piacere: …………………………………………………………….. p.525
* L. I, cap. II: “Andrea Sperelli” ……………………………………… p. 528
* L. III, cap. III (parte) ………………………………………………… in fotoc.
4_POESIA NELL’ETÀ DEL DECADENTISMO (10 ore)
Decadentismo e Simbolismo ………………………………………. p. 384
Qualche esempio dalla letteratura francese:
* Ch. Baudelaire, Corrispondenze ………………………………… p. 397
* P. Verlaine, Ars poetica ………………………………………… p. 404
* A. Rimbaud, Vocali ……………………………………………… p. 410
G. Pascoli: ……………………………………………………………. da p. 432
- La biografia
- La produzione poetica (linee generali)
- La poetica del fanciullino
- Il linguaggio e lo stile
9
Myricae: ……………………………………………………………… p. 448
* Arano ………………………………………………………………. p. 455
* L’assiuolo …………………………………………………………. p. 461
Canti di Castelvecchio: ……………………………………………… p. 464
* Nebbia ……………………………………………………………… p. 468
* Il gelsomino notturno ……………………………………………… p. 470
Il fanciullino: “E dentro di noi un fanciullino…” …………………… p. 490
G. D’Annunzio: ……………………………………………………… da p. 508
- Le Laudi (linee generali) …………………………………………… appunti
- Alcyone: …………………………………………………………….. p. 539
* La pioggia nel Pineto ……………………………………………… p. 546
* Meriggio …………………………………………………………….. in fotoc.
5_ IL ROMANZO DEL ‘900: SVEVO E PIRANDELLO (10 ore)
L. Pirandello: ………………………………………………………… in fotoc.
- La biografia
- Il relativismo pirandelliano
- La poetica dell’umorismo
- L’itinerario delle opere
Il fu Mattia Pascal: …………………………………………………… p. 714
* Cap. I Premessa …………………………………………………… in fotoc.
* Cap. XII: “Uno strappo nel cielo di carta” ………………………. p. 716
* Cap. XVIII (parte) …………………………………………………. in fotoc.
Dalle Novelle per un anno:
10
I. Svevo: ……………………………………………………………… da p. 786
- La biografia
- La dissoluzione del romanzo ottocentesco
La coscienza di Zeno: ……………………………………………… p. 812
* Cap. III: “Il fumo” …………………………………………………. p. 815
* Cap. VIII: “La catastrofe finale” …………………………………. p. 839
6_ POESIA NEL PRIMO NOVECENTO (7 ore)
Le avanguardie storiche: …………………………………………… da p. 44 vol. 5
- I tratti comuni
- Il Futurismo italiano
* F.T. Marinetti, Manifesto del Futurismo …………………………. p. 52
* F.T. Marinetti, Manifesto tecnico della letteratura futurista ……. p. 55
G. Ungaretti: ………………………………………………………… in fotoc.
- La biografia
- La produzione poetica
L’Allegria: ……………………………………………………………. p. 108
* Veglia ……………………………………………………………… p. 115
* Fratelli …………………………………………………………….. p. 117
* Sono una creatura ………………………………………………. p. 118
* I fiumi ………………………………………………………………. p. 119
* Mattina ……………………………………………………………... p. 127
* Soldati ……………………………………………………………… p. 128
E Montale: ……………………………………………………………. in fotoc.
- La biografia
11
- La produzione poetica (linee generali)
Ossi di seppia: ……………………………………………………… p. 232
* I limoni …………………………………………………………….. p. 235
* Non chiederci la parola …………………………………………… p. 241
* Meriggiare pallido e assorto ……………………………………… p. 242
* Spesso il male di vivere …………………………………………… p. 244
*
7_E. LUSSU, UN ANNO SULL’ALTIPIANO (2 ORE)
Un anno sull’altipiano: lettura individuale dell’intera opera
Osservazioni generali: ……………………………………………… appunti
* L’autore
* Genesi dell’opera
* I temi principali
*
METODOLOGIA
Lezioni frontali dialogate (per l’inquadramento dei contenuti), nelle quali sollecitare la partecipazione degli alunni attraverso domande,
ragionamenti deduttivi, ripresa di concetti chiave etc.;
Utilizzo di strumenti informatici (applicazione PowerPoint; Tablet in dotazione agli alunni);
Lettura guidata di testi, finalizzata alla comprensione e all’analisi dei contenuti.
VALUTAZIONE
Almeno due verifiche scritte e due orali, queste anche in forma di test, per ogni quadrimestre;
12
Verifiche scritte basate sulle tipologie dell’Esame di Stato, valutate secondo la griglia inserita nel presente Documento.
Test per domande aperte e parafrasi di versi poetici. (livello di sufficienza delle prove: 60% del punteggio complessivo);
Verifiche orali: valutazione secondo la scala offerta dal POF del Liceo.
MATERIALI UTILIZZATI
Manuale: R. Antonelli, M.S. Sapegno, Il senso e le forme, voll. 4-5, La Nuova Italia
Dante, Divina Commedia, Paradiso: testo liberamente scelto dagli alunni
Fotocopie
Edizioni di testi in formato E-book
Filmati pubblicati su Youtube.
File in formato PowerPoint
13
STORIA - Docente Prof. BRUSAIOLI Enrico
La II rivoluzione industriale: caratteri fondamentali. (1ora a)
La società di massa:il concetto di massa, l’istruzione, i partiti di massa; il nuovo nazionalismo: il culto della nazione e il razzismo, il
colonialismo; l’imperialismo: età e motivazioni, il caso dell’Africa. (1 ora b)
Storia russa di fine Ottocento: il decollo industriale, bolscevichi e menscevichi, la rivoluzione del 1905, le riforme di Stolypin. (1 ora a)
La crisi di fine secolo in Italia: la forbice dello sviluppo, anarchici e socialisti, l’eccidio di Bava Beccaris. (1 ora b)
La belle epoque: stati nazioni imperi, liberalismo e democrazia, revanscismo e irredentismo. (1 ora)
L’età giolittiana. (2 ore)
La Grande guerra: cause, clima politico-culturale, strategie, avvenimenti bellici principali, l’inizio del secolo breve. (2 ore)
La Grande guerra in Italia: neutralisti e interventisti, avvenimenti bellici principali. (2 ore)
La Russia: rivoluzione e guerra civile: le radici della rivoluzione, la rivoluzione del febbraio 1917, i soviet, Lenin e le Tesi di aprile,
Kerenskij e la crisi del governo provvisorio, la rivoluzione d’ottobre, i decreti del governo bolscevico; la pace di Brest-Litovsk, la guerra
civile, il comunismo di guerra. (2 ore)
Le paci della Grande guerra: i 14 punti di Wilson, il trattato di Versailles, la nascita dell’Europa delle nazioni, la Società delle nazioni. (1
ora)
Gli USA negli anni ’20:la produzione di massa, il fordismo, il boom americano, la crisi borsistica del 1929. (1 ora)
Le tensioni del dopoguerra italiano: la crisi economica, le lotte sociali del 1919-1920, massimalismo e il minimalismo socialista, nascita
del fascismo, l’impresa fiumana. (2 ore)
Il fascismo al potere. (1 ora)
Il concetto di totalitarismo e lo Stato etico. (1 ora)
Il regime fascista. (3 ore)
La Repubblica di Weimar: i problemi economici, politici e sociali, l’esordio di Hitler e il putsch di Monaco, l’ideologia nazionalsocialista: la
comunità di popolo, lo spazio vitale, la razza, antisemitismo e antibolscevismo, le strutture paramilitari; la crisi di Weimar e l’ascesa di
Hitler al governo. (2 ore)
14
Il regime nazista. (2 ore)
Nascita dell’Unione Sovietica e l’ascesa di Stalin. (1 ora)
Il regime staliniano. (2 ore)
L’Asia fra le due guerre: l’india di Gandhi, la crescita del Giappone (cenni), l’unificazione della Cina (cenni). (1 ora)
Gli Stati Uniti fra le due guerre: il New deal. (1 ora a)
L’Europa negli anni Trenta: il caso austriaco, la guerra civile spagnola. (1 ora b)
Verso la Seconda guerra mondiale: le radici della guerra, un conflitto ideologico, l’azione politica di Hitler contro Versailles, il 1936,
l’Anschluss austriaco, la conferenza di Monaco, il patto d’acciaio, il patto Molotov-Ribbentrop. (1 ora)
La Seconda guerra mondiale: informazioni schematiche sugli avvenimenti bellici, la Shoah, la conclusione della guerra. (1 ora)
La guerra parallela italiana, la campagna d’Africa (cenni), la campagna di Russia (cenni). (1 ora)
La guerra civile italiana dalla caduta del fascismo alla liberazione. (2 ore)
Il secondo dopoguerra: la nascita dell’ONU, le sfere d’influenza in Europa, il modello statunitense e il modello sovietico, la guerra di
Corea. (1 ora)
Gli anni ’60: dalla guerra fredda alla distensione, Chruscev e la destalinizzazione, Kennedy e la politica della nuova frontiera, l’Europa
divisa in due: l’Europa orientale sotto l’influenza sovietica – Budapest e Praga - , l’Europa occidentale e l’avvio dell’integrazione europea;
il caso della Germania e il Muro di Berlino. (2 ore)
Il 1968: tensioni razziali, la contestazione giovanile, il femminismo. (1 ora)
L’Italia repubblicana: situazione politica, il referendum istituzionale e le elezioni per la Costituente, le elezioni del 1948, il centrismo, il
miracolo economico degli anni ’60 e la svolta politica del centro-sinistra,gli anni di piombo . (2 ore)
Il decolonialismo: caratteri generali. (1/2 ora)
Il mondo contemporaneo: Gorbacev e il tentativo di riforma dell’URSS, la nascita della Unione Europea, il crollo del muro di Berlino, la
fine della Prima repubblica in Italia, la fine del Secolo breve (1991). (1 ora)
Cittadinanza e costituzione: il perché dell’Europa
Testo in adozione: Fossati – Luppi – Zanette, Le città della storia, Voll, II e III, Pearson.
15
STORIA DELL’ARTE- Docente Prof.ssa NICODEMI Francesca
PROGRAMMA SVOLTO
1) IL ROMANTICISMO EUROPEO (Ore 11)
GERMANIA:
* Friedrich “Abbazia nel querceto”- “Il mare di ghiaccio”- “Monaco in Riva al mare”- “Viandante sopra il mare di nebbia”
FRANCIA:
* Gericault “Alienata con monomania dell’invidia” – “Alienato Con monomania del furto” - “Zattera della Medusa”- “Membra tagliate”
* Delacroix “Donne di Algeri nella loro stanza”- “Libertà che guida il Popolo”- “Massacro di Scio”- “La barca di Dante”
* L’ “Orientalismo magico”
INGHILTERRA:
* Turner “Pace ed esequie in mare”- “Il mattino dopo il diluvio”- “Pioggia, vapore velocità”
ITALIA:
* Hayez “Il Bacio”- “La congiura dei Lampugnani” –
SPAGNA:
* Goya “3maggio 1808”- “Famiglia di Carlo IV”- “Il parasole” – “Saturno che divora uno dei suoi figli”- “Il sonno della ragione crea mostri” –
“Maya desnuda” – “Maya vestida”- “Cane interrato nella sabbia”
2) L’ETA’ DEL REALISMO (Ore 14)
REALISMO FRANCESE:
* Courbet “Gli spaccapietre”- “Seppellimento ad Ornans”- “Atelier del pittore”
16
* Daumier “Vagone di terza classe”- “La lavandaia”
* Millet “L’Angelus”- “Spigolatrici”- “Il seminatore”
* Il fenomeno del “Giapponismo”: cenni
IMPRESSIONISMO FRANCESE:
* Manet “Colazione sull’erba” – “Olympia” –“Ritratto di Emile Zola”- “Il bar delle Folies-Bergeres”
* Morisot “La culla”_ “Donne alla toilette”_ “Sul balcone”- “Lavandaie che stendono il bucato”
* Monet “Impressione: Levar del sole” - “Cattedrale di Rouen” - “Donna con il parasole” – “Ninfee” - “Regate ad Argentuil”
* Degas “Assenzio”- “Classe di danza” – “Due stiratrici”_
* “Orchestra” - “La famiglia Bellelli”- “La modista”- “L’etoile”
* Renoir “Ballo al Moulin de la Galette” – “Nudo,effetto al sole” – “Palco”-
* La ricerca di Cezanne “Casa dell’impiccato” – “Giocatori di carte” – “Donna con caffettiera”- “Natura morte con mele e arance” - “Grandi
bagnanti”- “Montagna Sainte Victoire”-
I MACCHIAIOLI:
* Fattori “Campo italiano dopo la battaglia di Magenta” – “In vedetta” - “La rotonda di Palmieri”- “La cugina Argia”- “Diego Martelli”
* Signorini “Sala delle agitate al Bonifacio di Firenze”
* Lega “La visita” – “Pergolato”
LE ESPOSIZIONI UNIVERSALI - Paxton “ Crystal Palace”
3) IL LABORATORIO DELLA FINE ‘800 - INIZIO ‘900 (Ore 29)
PUNTINISMO: Seurat “Le modelle”- “Domenica alla Grande Jatte
FIGURE ISOLATE:
* Gauguin “Il Cristo giallo” -“Visione dopo il sermone” -“Da dove veniamo, chi siamo,
17
dove andiamo?” – “Ia orana Maria” –
* Van Gogh “Camera da letto” – “Girasoli” – “Iris”- “Terrazza del caffè ad Arles - “Autoritratto con il cappello di feltro” – “Autoritratto
dedicato a Paul Gauguin”- “Autoritratto”- “Mangiatori di patate” – “Notte stellata”
* H.T. Lautrect “Moulin Rouge”- “La toilette”
* Rousseau “Il Sogno”
DIVISIONISMO e SIMBOLISMO ITALIANO:
* Segantini “Ave Maria a trasbordo” – “Le due madri” – “Le cattive madri”
* Previati “Maternità”
* Morbelli “Per ottanta centesimi” – “Il Natale dei rimasti”
* Pellizza da Volpedo “Ambasciatori della fame” – “Fiumana” -“Quarto Stato”
MODERNISMO:
* Art Noveau ( le tematiche e i morfemi in generale)
* L’architettura di Gaudì “Casa Batllò” – “Casa Milà” – “Parco Guell” – “La Sagrada Familia”
SECESSIONISMO:
* Klimt “Il Bacio” –“Fregio di Beethoven” – “Giuditta I”- “Giuditta II” -“Le tre età della donna”- “Danae”
* Ensor “Autoritratto con cappello fiorito” – “Entrata di Cristo a Bruxelles nel 1889”- “Scheletri che si riscaldano alla stufa”- “I vecchi
Mascherati”
* Munch “Bambina malata” – “Madonna” – “Il bacio” – “Pubertà” -“Urlo”- “Sera sulla via
Karl Joahann”- “Disperazione” – “Angoscia”
ESPRESSIONISMO:
* I Fauves: Matisse “La danza” – “La gioia di vivere” – “La musica” – “La tavola imbandita”1897 – “La tavola imbandita”1908 -
“Lusso, calma, voluttà”- “Icaro”
18
* Il Die Brucke:
Kirchner “Marcella” –“Cinque donne nella strada”
Schiele “La famiglia” – “La morte e la fanciulla” – “L’abbraccio”
Kokoschka “Autoritratto” – “La sposa del vento”
4) LA PRIMA META’ DEL ‘900 (Ore 22)
A) Le avanguardie pre-belliche:
CUBISMO:
* Picasso “Madre e figlio” – “Poveri in riva al mare” – “La famiglia di saltimbanchi”- “Les
demoiselles d’Avignon” – “Ritratto di Ambroise -“Natura morta con sedia impagliata”–
Vollard”– “Due donne che corrono lungo la spiaggia” – “Il sogno” -“Guernica” - “Las
Meninas”
FUTURISMO ITALIANO:
* Boccioni “Nudo di spalle”-“Forme uniche della continuità nello spazio”- “La città che
sale”- “Materia” – “ La strada che entra nella casa”-“Rissa in galleria” – “Stati d’animo:
gli Addii” –
* Balla “Lampada ad arco” – “Bambina che corre sul balcone” – “La mano del violinista”-
“Dinamismo di un cane al guinzaglio”
* Sant’Elia “La città nuova” – “Stazioni di aeroplani e treni…”-
19
ASTRATTISMO:
* Kandinskij “Vecchia Russia” – “La vita variopinta” –“ Il Cavaliere azzurro”- “Primo
acquarello astratto”- “Diversi cerchi”- “Composizione VIII”-
* Klee “Case rosse e gialle a Tunisi” – “Luogo colpito”- “Nuova armonia” - “Strada principale e strade secondarie”
B ) Le avanguardie durante il periodo bellico:
METAFISICA :
De Chirico “Ritratto di artista per se stesso” -“L’enigma dell’ora” – L’Enigma dell’oracolo”-“Ettore e Andromaca” –“Le Muse Inquietanti”
DADAISMO:
* Duchamp “Fontana” – “L.H.O.O.Q.” – “Nudo che scende le scale” – “Ruota di bicicletta”
* Man Ray “Il violino di Ingres” – “L’oggetto da distruggere”
C ) Le avanguardie del primo dopo-guerra:
SURREALISMO:
* Mirò “Arcobaleno e poetessa” - “Paesaggio catalano (Il cacciatore)”
* Dalì “Sogno causato dal volo di un’ape”- “La persistenza della memoria”- “Il grande masturbatore”“Venere di Milo a cassetti”
* Magritte “L’Impero delle luci II” – “Golconde”- “Gli amanti”- “Il modello rosso” - “L’uso della parola”
20
PROGRAMMAZIONE
OBIETTIVI E COMPETENZE
1) Esposizione = L’alunno presenta gli argomenti in modo coerente ed articolato
2) Analisi = L’alunno sa leggere ed enucleare gli aspetti fondamentali dell’autore o dell’opera o della scuola
3) Sintesi = L’alunno sa trarre le opportune conclusioni sulle novità artistiche evidenziate
4) Contestualizzazione =
a) L’alunno sa confrontare gli aspetti evidenziati con altri artisti coevi cogliendone analogie e differenze.
b) L’alunno sa collocare le tematiche nel contesto storico- culturale-filosofic
5) Rielaborazione = L’alunno sa proporre giudizi personali
METODO OPERATIVO
1) Lezione frontale
2) Ricerche e documentazione
3) Confronti guidati
4) Uso del libro di testo
VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE
- Al termine di ogni modulo è stato fatto un test di tipologia B
- Un’interrogazione al quadrimestre
- Il criterio di valutazione ha valutato l’acquisizione delle sopraddette competenze
21
FILOSOFIA - Docente Prof. BRUSAIOLI Enrico
- HEGEL (8 ore)
I capisaldi del sistema: il concetto di Assoluto, il rapporto tra finito e infinito, ragione e realtà, la funzione della filosofia; la dialettica; la
Fenomenologia dello Spirito : l’autocoscienza (signoria e servitù, stoicismo, scetticismo,la coscienza infelice); la schema del Sistema; la Logica:
caratteri generali; la filosofia della Natura: caratteri generali; lo Spirito oggettivo: caratteri generali;
lo Spirito oggettivo: moralità, eticità(famiglia,società civile, Stato); la filosofia della storia; l’astuzia della ragione; lo Spirito assoluto: arte,
religione, filosofia.
- DESTRA E SINISTRA HEGELIANA (1 ora)
La religione e la politica.
- FEUERBACH (2 ore)
La critica a Hegel;la tematica del rovesciamento dei rapporti di predicazione: ‘soggetto e predicato’; l’antropologia capovolta, alienazione e
ateismo; l’umanismo e il filantropismo.
- MARX (5 ore)
La critica del misticismo logico di Hegel; la critica della civiltà moderna e all’economia borghese; la problematica dell’alienazione; il distacco da
Feuerbach; la concezione materialistica della storia (ideologia, scienza, struttura e sovrastruttura); il Manifesto: l’analisi della funzione storica
della borghesia, la storia come lotta di classe, la critica ai falsi socialismi; Il Capitale: merce, lavoro, plusvalore (origine del plusvalore, capitale
variabile e capitale costante); tendenze e contraddizioni del capitalismo (il bisogno capitalistico del profitto,le vie per aumentare il profitto, le crisi
cicliche di sovrapproduzione, la scissione della società); rivoluzione e dittatura del proletariato
22
- SCHOPENHAUER (4 ore)
Il mondo come volontà e rappresentazione: le radici culturali ; il fenomeno e il velo di Maya; la volontà di vivere; il pessimismo (dolore, piacere,
noia); il pessimismo cosmico; l’illusione dell’amore; la critica alle varie forme di ottimismo (storico, cosmico, sociale); le vie di liberazione dal
dolore : arte, etica della pietà, ascesi.
- KIERKEGAARD (3 ore)
Il rifiuto dell’hegelismo e la verità del ‘singolo’; gli stadi dell’esistenza: vita estetica, etica, religiosa; il sentimento dell’angoscia; la disperazione e
la fede.
- IL POSITIVISMO (1 ora)
Le tesi generali del positivismo.
- COMTE (3 ore)
La legge dei tre stadi: teologico, metafisico, positivo; la sociologia.
- NIETZSCHE (5 ore)
Filosofia e malattia; nazificazione e denazificazione; La nascita della tragedia: l’apollineo e il dionisiaco, l’arte come strumento della filosofia; il
rapporto con Schopenhauer e Wagner; il rapportarsi alla storia; il periodo illuministico: la filosofia del mattino, la morte di Dio e la fine delle
illusione metafisiche; Cosi parlò Zarathustra: l’oltreuomo, l’eterno ritorno dell’uguale; l’ultimo Nietzsche: la critica della morale e la tra
svalutazione dei valori, la volontà di potenza; il problema del nichilismo
23
- FREUD (1 ora)
Dagli studi sull’ipnosi alla psicoanalisi; la realtà dell’inconscio e la tecnica psicoanalitica; la scomposizione psicoanalitica della personalità(la
prima e la seconda topica); l’interpretazione dei sogni; la teoria della sessualità e il complesso edipico.
- L’ESITENZIALISMO (1 ora)
Caratteri generali culturali
- L’ESISTENZIALISMO COME FILOSOFIA (1 ora)
Cronologia e tematiche fondamentali.
- LA MEDITAZIONE SULL’AGIRE POLITICO (1 ora)
La crisi della democrazia nella società di massa e la ridefinizione della politica.
Testo in adozione: Nicola Abbagnano – Giovanni Fornero, Percorsi di filosofia, voll. 2 e 3, Paravia
.
24
INGLESE - Docente Prof. DE BONIS Gianna
Il programma si è basato principalmente sull'analisi del testo letterario inserito nel suo contesto storico-sociale.
CONTENTS:
THE ROMANTIC AGE
The age of Revolutions
ART LINK
* Turner : turbulent landscapes
* Constable : nature in its elements
LITERATURE IN THE ROMANTIC AGE
HOTLINK
Music: Lieder : the lost music of longing
Philosophy : the sublime
ROMANTIC POETRY
* William Blake The lamb
The tyger
London
* William Wordsworth Lyrical ballads -The Preface
25
She Dwelt among Untrodden Ways
I Wandered Lonely as a Cloud
Lines composed a few miles above Tintern Abbey, on revisiting the Banks of the Wye during a tour. July
13,1798 .* (ll 1-8)
* Samuel Taylor Coleridge The Rime of the Ancient Mariner (1st part)
* Percy Bysshe Shelley Ozymandias
THE NOVEL IN THE ROMANTIC AGE
* Walter Scott
* Jane Austen Pride and Prejudice
(The plot)
* Mary Shelley Frankenstein: What was I?
(The plot – Interpretations)
THE VICTORIAN AGE
The Age of Empire
ART LINK
Victoria: the business of Empire
- THE VICTORIAN NOVEL
26
* Charles Dickens Hard times : A man of realities
(The plot - Features) The Key-note *
Oliver Twist:
(The plot - Features) Jacob’s island
* Robert Louis Stevenson The Strange Case of Dr.Jekyll and Mr.Hyde:
Dr Jekyll ‘s first experiment
(The plot - Features)
- THE AESTHETICISM
* Oscar Wilde The Picture of Dorian Gray : The Preface
(The plot - Features) I would give my soul for that!
HOTLINK
Pre-Raphaelite poets and artists
Art in and out of the factory
- THE AGE OF MODERNISM
A time of war
Modern literature
Modernism and the novel
HOTLINK
Cultural studies : Modernism and the convergence of the arts
Philosophy: Bergson and la durée
27
* James Joyce Dubliners : Eveline *
(Features) The Dead – His riot of emotions
Ulysses : I was thinking of so many things
(Features)
- CONTEMPORARY DRAMA
The theatre of the absurd
* Samuel Beckett Waiting for Godot: All the dead voices
(The plot - Features)
Testo adottato: Literary Hyperlinks Concise
Thomson - Maglioni
Black cat
Dei brani contrassegnati da asterisco, non presenti nel testo in adozione, è stata fornita copia agli alunni.
28
FINALITA’ FORMATIVE
- L’insegnamento della L2 in 5° si prefigge di contribuire alla formazione umana, sociale e culturale mediante la conoscenza dei fenomeni
socio-culturali della lingua straniera studiata; di offrire l’occasione di conoscere in modo specifico la propria lingua, cultura e civiltà
mediante l’analisi comparativa con la lingua e civiltà straniera trattata.
OBIETTIVI
Gli obiettivi minimi raggiunti riguardano:
L’approfondimento del corpus linguistico acquisito negli anni precedenti ad un livello di conoscenza almeno “intermedio”.
La capacità di accedere alla lettura di testi non complessi senza ricorrere frequentemente all’uso del dizionario. L’alunno dovrà essere in grado
di leggere e comprendere, almeno nelle linee essenziali, le testimonianze letterarie di maggior rilievo proposte nel programma.
La capacità di produrre testi brevi di carattere generale o specifico.
La capacità di produrre in modo autonomo e non mnemonico il commento ( critical appreciation ) dei brani antologici trattati. In particolare
costruirà l’analisi del testo sviluppando i seguenti punti:
1. il tema generale (general theme)
2. il contenuto in dettaglio (detailed theme)
3. il genere letterario di appartenenza e la struttura dell’opera (frame)
4. il messaggio dell’autore (message)
5. le caratteristiche stilistiche utilizzate dall’autore per esprimere il messaggio (technical devices)
Non è richiesta la traduzione dei passi antologici in Italiano.
Nel corso delle prove scritte è consentito l’uso del dizionario bilingue e/o monolingue.
29
TEMPI
Nel periodo compreso tra Settembre e Dicembre sono state trattate le problematiche del Romanticismo (40 ore di lezione); da Gennaio a Marzo
quelle relative all’Età Vittoriana (30 ore); da Aprile a Maggio il Modernismo (20 ore).
CRITERI DIDATTICI
Il 1° approccio al testo è stato sempre guidato, mai totalmente autonomo e individuale. Si è proceduto ad una verifica immediata solitamente
non valutata e all’assegnazione dello studio e consolidamento a casa.
VERIFICHE E VALUTAZIONI
Per la valutazione si è utilizzata l’intera scala decimale e/o la scala in quindicesimi dei voti valutando in base ai criteri di conoscenza,
competenza e capacità.
Per conoscenza si intenda il bagaglio di informazioni relative alla lingua e letteratura (es. le strutture base apprese al triennio utili per
esprimersi in lingua; il lessico di almeno 1500 parole; le informazioni e i fatti letterari sui periodi, gli autori le opere proposte).
Per competenza si intenda l’abilità di esprimere con correttezza e proprietà le conoscenze apprese.
Per capacità, infine, l’abilità di comprendere e interpretare i testi , deducendo, astraendo, operando collegamenti, rielaborando
autonomamente.
Tenuto conto di tali criteri si costruisce la seguente griglia di valutazione in decimi:
Voti:
* 1-2 per i responsi nulli dovuti a totale mancanza di conoscenze
* 3-4 per i responsi insufficienti e quelli fuori tema per poche conoscenze, scarsa competenza linguistica e mancanza di capacità
* 5 per i responsi accettabili per conoscenze di base ma non adeguatamente corretti e comprensibili per poca competenza e capacità.
* 6-7 per i responsi sufficienti per conoscenze, espressi con accettabile competenza e con qualche indicazione di rielaborazione
autonoma.
30
* 8-9-10 per i responsi pienamente soddisfacenti per conoscenze, espressi con buona competenza e accettabili capacità di autonomia e
rielaborazione.
Il docente precisa che tale griglia è da considerarsi uno strumento di riferimento indicativo, nella convinzione che sia impossibile utilizzare a
pieno schemi valutativi in modo rigido ed inflessibile.
Per le prove di simulazione della terza prova si è utilizzata la griglia in quindicesimi allegata al documento.
31
MATEMATICA E FISICA- Docente Prof. ssa LUCIANI Filomena
LIBRI DI TESTO:
P. Baroncini, R. Manfredi, I. Fragni – Lineamenti.math azzurro 5 - Ghisetti e Corvi
A. Caforio, A. Ferilli – FISICA! Le leggi della natura 3 – Le Monnier Scuola
OBIETTIVI DIDATTICI
- Acquisire i termini del linguaggio delle discipline
- Possedere i contenuti previsti dal programma e saperli applicare nella risoluzione di semplici esercizi e problemi
- Saper individuare i nodi concettuali di un argomento
MODALITA’ DI LAVORO
- Lezioni frontali e dialogate. Lezioni applicative (con esercizi svolti alla lavagna sia dal docente che dagli alunni). Lezioni aggiuntive
dedicate al recupero di argomenti fondamentali del programma di matematica degli anni scolastici precedenti.
Sono stati assegnati esercizi da svolgere a casa e poi corretti alla lavagna
STRUMENTI DI LAVORO
- Libri di testo, appunti presi dagli alunni durante la spiegazione, schemi scritti alla lavagna dal docente
-
TIPOLOGIA DI VERIFICA
- Interrogazioni, verifiche scritte sia teoriche che applicative
32
ARGOMENTI SVOLTI
MATEMATICA ( I Quadrimestre)
- TOPOLOGIA DELLA RETTA REALE. FUNZIONI
Intorni di un punto e di infinito. Insiemi numerici limitati. Funzioni e successioni. Proprietà delle funzioni. Dominio delle funzioni matematiche.
Insieme di positività di una funzione.
- LIMITI DELLE FUNZIONI
Il concetto di limite. Le quattro fondamentali definizioni di limite e relative applicazioni, limiti destro e sinistro, casi particolari, approccio grafico
alle definizioni di limite, asintoti orizzontali, asintoti verticali
- FUNZIONI CONTINUE E CALCOLO DEI LIMITI
Continuità. Teoremi sul calcolo dei limiti. Limiti delle funzioni razionali. Funzioni composte. Singolarità di una funzione. Grafico approssimato di
una funzione.
MATEMATICA (II Quadrimestre)
- DERIVATA DI UNA FUNZIONE
Definizioni e nozioni fondamentali: rapporto incrementale e suo significato geometrico, definizione di derivata, la funzione derivata, significato
geometrico della derivata, punti notevoli del grafico di una funzione. Derivate fondamentali. L’algebra delle derivate. Derivate delle funzioni
composte. Derivate di ordine superiore.
- MASSIMI, MINIMI E FLESSI
Ricerca dei massimi e dei minimi. Concavità di una curva e punti di flesso
- RAPPRESENTAZIONE GRAFICA DELLE FUNZIONI
33
Asintoti obliqui. Studio del grafico di una funzione: grafici delle funzioni razionali intere, razionali fratte, irrazionali
FISICA (I quadrimestre)
- LA CORRENTE ELETTRICA
La conduzione elettrica nei metalli, agitazione termica e moto di deriva, la corrente elettrica, i generatori elettrici, la forza elettromotrice. La
resistenza elettrica, prima e seconda legge di Ohm, resistività nei metalli. La potenza elettrica, l’effetto Joule
- IL MAGNETISMO
Campo magnetico e sua rappresentazione, campo magnetico uniforme, campo magnetico terrestre. I campi magnetici delle correnti( Oersted),
interazioni magnetiche fra correnti elettriche: legge di Ampère. L’induzione magnetica. Campo magnetico di alcune distribuzioni di corrente: filo
rettilineo( legge di Biot-Savart), spira circolare, solenoide. La forza di Lorentz. Le correnti microscopiche di Ampère
- L’INDUZIONE ELETTROMAGNETICA
La corrente indotta. La legge di Faraday-Neumann e la legge di Lenz
34
DISCIPLINE PITTORICHE E LABORATORIO DELLA FIGURAZIONE Docente Prof. CORTI EMILIO
- Primo esercizio grafico : copia dal vero di modelli in gesso di figure intere.
La tavola è stata eseguita a matita o con semplici tecniche grafiche a secco ed ha avuto come obiettivo lo studio della proporzionalità e
della resa volumetrica attraverso il chiaroscuro.
- Copia dal vero della modella: nel corso dell'anno sono state realizzate alcune tavole a matita, pastello, acrilico o olio, aventi per soggetto la
figura umana intera.
- Esercizi di approfondimento: copia dal vero dei compagni (schizzi a matita di figure intere in varie posizioni, con particolare attenzione allo
studio del ritratto). Elaborazione a inchiostro o acquerello.
- Analisi di opere d'arte del '900 e realizzazione di composizioni personali ispirate alle caratteristiche espressive dei Movimenti Artistici
trattati:
- il Cubismo e il Futurismo
- la Metafisica ed il Surrealismo
- l'Espressionismo in Europa
- il Realismo e l'Astrattismo
- Sono state proposte tre simulazioni di prova d'esame ( alcune ridotte per contenuti e tempi di realizzazione, l'ultima più articolata e negli
stessi tempi esecutivi previsti nell'esame reale).
- Su proposta del Museo Bodini di Gemonio, sono state realizzate composizioni libere ispirate alla montagna: gli elaborati ,assieme a quelli di
altre classi della scuola, saranno esposti in una mostra nel museo stesso.
- Sono state effettuate le seguenti visite didattiche;
- Milano, Museo del Novecento
- Gemonio, Museo Bodini, mostra del pittore/scalatore Fasana
35
- Basilea, Fodazione Beyeler – Gauguin
- Varese, Museo di Masnago – Mostra “Ad arte per l'arte”
durante la visita di questa mostra è stata effettuata una lezione pratica sull'acquaforte (dalla preparazione della lastra, all'incisione, alla
stampa al torchio).
Nel Laboratorio Artistico sono state proposte esperienze operative strettamente collegate agli argomenti affrontati in Discipline Pittoriche. Gli
alunni hanno realizzato gli stessi elaborati nel corso delle due discipline.
E' stato approfondito l'uso dei seguenti materiali grafici e pittorici: matita, pastello, pastello ad olio, colori acrilici, acquerelli, colori ad olio.
36
DISCIPLINE PLASTICHE LABORATORIO DELLA FIGURAZIONE DI DISCIPLINE PLASTICHE - Docente Prof. CAMPAGNA IGNAZIO
DISCIPLINE PLASTICHE E SCULTOREE
- Il lavoro scolastico portato avanti dalla classe si è concretizzato attraverso diverse unità didattiche. Il primo lavoro ha messo in campo un
progetto per la realizzazione di una Fontana con la ricerca di elementi significativi inerenti al tema dell'Acqua che la storia ricorda. La
tavola è stata impostata fin dai primi bozzetti con una rielaborazione personale fino ad arrivare al progetto personale definitivo e
originale. Gli elaborati tridimensionali sono stati realizzati con materiali diversi tra cui argilla, gesso, legno, plastica, carta e ferro. Come
seconda unità didattica si è studiato il Ritratto in tutti i suoi aspetti sia femminile che maschile. Il metodo di studio ha tenuto conto di una
tavola di progetto preparatoria e una seconda fase quella della realizzazione tridimensionale. La ricerca del ritratto ha avuto anche
l'ausilio di un approfondimento in loco presso il Museo Francesco Messina a Milano dove gli studenti hanno avuto modo di vedere e di
ritrarre graficamente i ritratti del maestro, opere in gesso in cera e in bronzo. Gli elaborati a tutto tondo sono stati realizzati prima in
gesso con l'aiuto di una piccola struttura portante e poi con la copertura di cera vergine calcando il procedimento che seguirono già
Edgar Degas, Medardo Rosso e Francesco Messina. Come ultima unità didattica si è approfondito il tema del Cavallo ma visti i tempi
troppo lunghi per i lavori precedenti il tema del cavallo è stato affrontato solo per la fase progettuale e grafica.
LABORATORIO DELLA FIGURAZIONE
- La Superficie tridimensionale è stato il tema dove gli studenti hanno lavorato progettando elementi tridimensionali concavi e convessi,
positivi e negativi in maniera che le forme analizzate risultassero complementari. Partendo da una superficie bidimensionale si doveva
trovare una soluzione plastica tridimensionale con sviluppo di forme verticali e orizzontali. I materiali utilizzati finali utilizzati sono stati
argilla, polistirolo e gesso. Come ultime tecniche di lavorazione nel campo della scultura si sono studiate quella del Marmo e del Bronzo
la Fusione a cera persa. Sono state espletate simulazioni di seconda e terza prova in previsione dell'Esame di Maturità
VIAGGI ITINERANTI
Visita presso il Museo Francesco Messina di Milano
Visita presso il Museo del '900 con mostra di Yves Kline
37
Scienze Motorie e Sportive - Docente Prof.ssa BONA Viviana
FINALITA’ DELL’INSEGNAMENTO
a) Armonico sviluppo corporeo e motorio attraverso il miglioramento delle qualità fisiche e neuromuscolari
b) Sviluppo delle capacità cognitive e della personalità attraverso gli strumenti propri delle attività motorie e sportive
c) Ricerca e consolidamento dell’autonomia individuale e in forme associate mediante attività nelle quali il confronto con se stessi e con gli altri,
favorisca capacità critiche trasferibili negli aspetti della vita sociale
Conoscenza del corpo
Consapevolezza delle proprie capacità e dei propri limiti
Educazione alla volontà
Rafforzamento delle capacità di autocontrollo
Acquisizione della fiducia in se stessi
Pratica sportiva
d) Coscienza sociale attraverso il linguaggio del corpo e dello sport
Consolidamento del carattere, del senso civico e della solidarietà
Rispetto degli altri e delle cose
Rispetto di regole e compiti
Educazione alla socializzazione, collaborazione e comunicazione
e) Tutela della salute
Acquisizione di una cultura delle attività di moto e sportive che tenda a promuovere la pratica motoria come consuetudine nella
consapevolezza dell’importanza che essa assume sul miglioramento della qualità della vita
Correzione dei vizi di portamento
Abitudini igieniche
METODOLOGIA DIDATTICA
38
Il raggiungimento degli obiettivi fissati è stato permesso dall’approfondimento di strategie concrete in un percorso che ha evidenziato:
L’intenzionale appropriarsi delle conoscenze attraverso momenti teorici, pratici e di approfondimento personale
Il gestire un cambiamento mediante 1) il riconoscimento-correzione di comportamenti, situazioni errori; 2) la scelta individuale di strategie
diverse 3) l’utilizzo di adeguati gradi di sollecitazione
L’elaborazione di momenti di analisi facenti perno su osservazioni, ascolto e sperimentazione
Lo stimolare la ricerca di soluzioni e il progettare
L’applicazione diretta “sul campo” di precedenti esperienze pratiche, sulla base di elementi acquisiti a livello di sensibilità neuro-muscolare,
memorie motorie, regole, tatticismi.
La partecipazione attiva nel provare, praticare e sperimentare in prima persona quanto proposto, spiegato e/o dimostrato utilizzando
positivamente l’errore in quanto fonte di informazione
L’utilizzo di metodologie tradizionali, da applicare in base alle caratteristiche del gruppo, quali: 1) il trasmettere in modo frontale 2) il mettere
in situazione 3) l’utilizzo di adeguati gradi di sollecitazione
MODALITA’ DI VERIFICA E PROVE DI VALUTAZIONE
Per la specificità della materia la verifica nella fase di apprendimento è stata continua ed immediata consentendo così l’istantanea
individuazione delle difficoltà e le relative correzioni.
Al termine delle fasi di apprendimento gli elementi di analisi, di misura delle competenze acquisite e di rilevazione degli obiettivi raggiunti hanno
consentito di effettuare la valutazione tenendo conto:
- Dei risultati ottenuti misurati tramite test, prove oggettive, esercitazioni pratiche, ecc.
- Dei progressi dal livello di partenza
- Dalla specificità nella partecipazione e nell’impegno dimostrati durante le lezioni
- Dalla capacità di gestirsi nell’ambiente palestra e spogliatoio
- Dalla capacità di autogestire momenti della lezione seguendo od elaborando le metodologie acquisite
CONTENUTI
39
Parte pratica
- Potenziamento fisiologico: miglioramento delle capacità condizionali ( resistenza,
forza, velocità, mobilità articolare) e coordinative ( ritmo, oordinazione, agilità)
- Streetching
- Test di resistenza. Velocità : 20m
- Esercizi a corpo libero a carico naturale
- Esercizi coi piccoli e grandi attrezzi
- Esercizi a coppie e in gruppo
- Esercizi per il potenziamento generale
- Esercizi per la percezione del corpo e del suo movimento nello spazio
- Il linguaggio del corpo: esperienze a coppie
- Percorsi di destrezza e agilità
- Piramidi Umane
- Yoga
- Verticale con ricaduta sul materassone
- Rincorsa, battuta sulla pedana, salto giro in volo
- Cavallina a coppie
- Pallavolo
- Basket
- Badminton
- Palla Tamburello
Parte teorica
Le ginnastiche dolci Le dipendenze
40
RELIGIONE CATTOLICA O ATTIVITA’ ALTERNATIVA Docente Prof. CARENZO Franco
Introduzione alla morale : Enciclica Veritatis Splendor
- LA FEDE
Elementi dell’atto di fede
Evoluzione religiosa degli adolescenti
Varie tipologie religiose degli adolescenti
- IL SENSO DELLA VITA
Differenza tra “sogno” ed “aspirazione”
Il senso della vita come missione, servizio, progetto
- LA DIMOSTRAZIONE DELL’ESISTENZA DI DIO NEL PENSIERO NEOSCOLASTICO
Il rapporto fede – ragione
1. nuove versioni della prova cosmologica
2. dal problema dell’origine dell’universo ad un Creatore dell’universo stesso
3. dall’organizzazione dell’universo ad un Intelligenza organizzatrice
4. dalla bellezza presente nella natura ad un Artista supremo
5. dall’origine della vita ad un Supremo datore della vita
nuova versione della prima via di S. Tommaso
1. dal divenire ad un Assoluto inteso come Atto puro
- LA DIMOSTRAZIONE DELL’ESISTENZA DELL’ANIMA SPIRITUALE NEL PENSIERO NEOSCOLASTICO
dalla differenza qualitativa tra uomo e animali all’affermazione dell’esistenza, nell’uomo, dell’anima spirituale
41
Esami di Stato Criteri di valutazione prima prova scritta
INDICATORI DESCRITTORI PUNTI Max. 15
Nu
llo
/
Gra
ve
m.
Ins
uff
.
Ins
uff
.
Su
ffic
.
Bu
on
o
Ott
imo
Attinenza con la traccia
Tipologie A) e B): attinenza con l’argomento proposto e rispetto delle
convenzioni della tipologia scelta (tipo testuale, scopo, destinatario, destinazione editoriale, ecc.).
Tipologie C) e D): attinenza con la traccia proposta.
0 0,5 1 1,5 2
Caratteristiche del contenuto
Tipologia A): comprensione ed interpretazione del testo proposto e capacità
di contestualizzazione.
Tipologia B): comprensione dei materiali forniti e loro utilizzo efficace;
capacità di argomentazione.
Tipologia C) e D): ampiezza della trattazione e padronanza delle conoscenze
in proprio possesso; capacità di contestualizzazione e di argomentazione.
Per tutte le tipologie: capacità critiche; significatività e originalità degli
elementi informativi, delle idee e delle interpretazioni.
0/0,5 1/1,5 2/2,5 3 4
Capacità di organizzazione del
testo
Per tutte le tipologie:
articolazione chiara e organica del testo; equilibrio fra le parti; coerenza (assenza di contraddizioni e ripetizioni).
0/0,5 1/1,5 2 2.5 3
Competenze lessicali
Tipologia B): uso di un registro adeguato alla tipologia testuale, al
destinatario, ecc.
Per tutte le tipologie: proprietà e ricchezza lessicale.
0/0,5 1/1,5 2 2.5 3
Competenze morfosintattiche
Per tutte le tipologie:
correttezza ortografica; correttezza grammaticale e sintattica; punteggiatura.
0/0,5 1/1,5 2 2.5 3
MISURAZIONE - VALUTAZIONE
42
Esami di Stato Criteri di valutazione seconda prova scritta
Indirizzo Figurativo Discipline Pittoriche- Discipline Plastiche
Indicatori Descrittori Punti Max
Misuratori Punti assegnati
Pertinenza Ricerca iconografica e informativa
Attinenza degli elaborati rispetto alla richiesta del tema Adeguata ricerca iconografica e documentaria
2 Articolata e pienamente pertinente 2 Appropriata 1,5 Sufficiente 1 Insufficiente 0,5 Nettamente insufficiente 0
Ideazione (coerenza e originalità dell'iter ideativo)
Elaborazione e sviluppo delle idee mediante appunti, schizzi e studi grafici preliminari.
4 Esauriente e originale 4 Apprezzabile 3,5 Accettabile 3 Carente 2 Nettamente insufficiente 1
Correttezza e completezza del percorso operativo
Presentazione ordinata, corretta e organizzata degli elementi costitutivi l'intero progetto : bozzetti - ipotesi di ambientazione (se richieste) -prove colore e/o campionature di materiali - didascalie – modello di un dettaglio significativo ( nel caso in cui la tecnica di realizzazione sia dissimile da quella impiegata nell'elaborato esecutivo). Esauriente relazione illustrativa sulle scelte di progetto.
5 Organico, corretto ed efficace 5 Corretto e ordinato 4,5 Soddisfacente con lievi inesattezze o mancanze 4 Complessivamente accettabile 3.5 Parzialmente corretto 3 Confuso 2,5 Gravemente lacunoso 2 Totalmente scorretto e disorganizzato 1
Realizzazione Qualità grafico-pittorica o grafico-plastica dell'esecutivo ed eventualmente del particolare definitivo. Padronanza di tecniche, mezzi e metodi espressivi
4 Ottima 4 Buona 3,5 Discreta 3 Sufficiente 2,5 Scarsa 2 Nettamente insufficiente 1
43
Esami di Stato Griglia di valutazione terza prova Sono state effettuate durante l’a.s. due simulazioni di terza prova, il; una terza si svolgerà dopo il 15 maggio. Il Consiglio di classe ha deciso che tutte le simulazioni venissero effettuate con la tipologia B: (4 discipline, tre
domande per ogni disciplina; tempo di effettuazione 150 minuti).
OBIETTIVO DESCRITTORE INDICATORI DI LIVELLO/PUNTI I Punti II Punti III Punti
Prova in bianco in bianco o evidentemente manomessa 1 1 1
Prova fuori traccia Svolta ma senza alcuna attinenza con la consegna 2 2 2
Conoscenza dei contenuti specifici e relativi al
contesto
- Il candidato conosce gli argomenti richiesti
1. In modo gravemente lacunoso
2. In modo generico, con lacune e scorrettezze
3. In modo approssimativo e con alcune imprecisioni
3,5. In modo essenziale ma sostanzialmente corretto
4. In modo apprezzabile anche se non sempre esauriente
4.5 In modo completo
5. In modo approfondito e dettagliato.
....../15
....../15
....../15
Competenze linguistiche e/o specifiche
(correttezza formale, uso del lessico
specifico
* metodo risolutivo e calcolo)
Il candidato si esprime:
- applicando le proprie conoscenze ortografiche, morfosintattiche, lessicali e di lessico specifico
Applicando la teoria alla pratica
1. In modo gravemente scorretto tale da impedirne la comprensione/in modo scorretto,* metodo e calcolo errati
2. In modo scorretto/con una terminologia impropria,* metodo o calcolo errati
3. In modo non sempre corretto ma globalmente comprensibile * metodo e calcolo complessivamente corretti
3,5 In modo accettabile e sostanzialmente corretto * metodo e calcolo corretti
4. In modo chiaro, generalmente appropriato,
pur con qualche inadeguatezza espressiva * metodo e calcolo chiari e corretti
4.5.In modo chiaro e appropriato,nonostante
alcune lievi improprietà’ occasionali * metodo o calcolo chiari, corretti e motivati
5. In modo chiaro, corretto, scorrevole e con ricchezza lessicale/in modo completo e preciso* metodo e calcolo chiari, corretti e motivati
....../15
....../15
....../15
Sintesi Logiche Sintesi Logiche
Capacità di rielaborazione
1. nessi logici assenti, sintesi impropria
2. nessi logici appena accennati, sintesi poco efficace
3. nessi logici non del tutto esplicitati e poco coerenti,sintesi incompleta
3,5 nessi logici esplicitati in modo semplice, sintesi non del tutto esauriente e/o rielaborazione meccanica
4. nessi logici appropriati e sviluppati,
sintesi efficace e apprezzabile rielaborazione
5. coerenza logica,sintesi efficace e appropriata, rielaborazione critica e personale
....../15
....../15
....../15
PUNTEGGIO PARZIALE
....../15
.
...../15
....../15
PUNTEGGIO TOTALE ________________/15