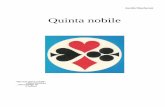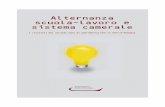DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE QUINTA LICEO … · In particolare, tra le tante attività, gli...
Transcript of DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE QUINTA LICEO … · In particolare, tra le tante attività, gli...

LICEO CLASSICO E LINGUISTICO ‘C. COLOMBO' ANNO SCOLASTICO 2017/18
DOCUMENTO DEL CONSIGLIO
DI CLASSE
QUINTALICEO CLASSICO
SEZIONE C
GENOVA - 15 MAGGIO 2018

CONSIGLIO DI CLASSE
PROF.SSA PATRIZIA SERRAItaliano ……………………………
PROF.SSA SILVIA VIGITELLOGreco e Latino ……………………………
PROF.SSA GABRIELLA PAGANINIStoria e Filosofia ……………………………
PROF.SSA ENRICA MARAGLIANOMatematica e Fisica ……………………………
PROF.SSA ALMA FAUCCIInglese ……………………………
PROF.SSA ROMANELLA MORICONIScienze ……………………………
PROF.SSA LUISA CAVALLAROStoria dell’arte ……………………………
PROF. MAURIZIO BUSANAEd. Fisica ……………………………
PROF. ANDREA VILLAFIORITAReligione ……………………………
PROF. ENRICO BADODIRIGENTE SCOLASTICO …………………………….
2

OBIETTIVI DIDATTICI E FORMATIVI
Fatti salvi gli obiettivi specifici delle singole discipline (per cui si fa riferimento ai relativi documentidisciplinari) si riconoscono come comuni per tutte le discipline i seguenti obiettivi:
Obiettivi comportamentali- affettiviLo studente: instaura un rapporto equilibrato con docenti e compagni; discute le proposte in modo positivo, collaborando e utilizzando i contributi altrui ; osserva le regole dell'Istituto e quelle che la classe ha, eventualmente, voluto darsi; rispetta i tempi di consegna dei lavori assegnati; consegna un lavoro finito, pertinente e corretto nell'esecuzione; procede in modo autonomo nel lavoro.
Obiettivi formativo- cognitivi esprimersi in modo chiaro, logico e pertinente, utilizzando un lessico appropriato alla situazione comunicativa e di contenuto; comprendere un testo e individuarne i punti fondamentali; procedere in modo analitico nel lavoro e nello studio; avere capacità di sintesi a livello di apprendimento dei contenuti; cogliere la coerenza all'interno dei procedimenti; relativizzare fenomeni ed eventi; interpretare fatti e fenomeni ed esprimere giudizi personali; documentare adeguatamente il proprio lavoro.
ATTIVITÀ INTEGRATIVE viaggio di istruzione a Napoli e Pompei (marzo 2018) partecipazione a conferenze sia di ambito scientifico che umanistico spettacoli teatrali Olimpiadi Italiano selezione Olimpiadi Classiche attività Orientamento Università (stage, ALMADIPLOMA, simulazione Alpha test) Giochi di Archimede partecipazione alla “Notte dei Licei Classici” Attività di Alternanza Scuola Lavoro (formazione, laboratori in classi di scuola primaria e
dell'infanzia, catalogazione e presentazione pubblica della collezione Durazzo di Palazzo Reale, accoglienza e animazione al Festival della Scienza)
3

ATTIVITÀ CLIL
Con la disponibilità della docente di Scienze e con l'approvazione del Consiglio di Classe si è scelto di attuarel'insegnamento di un argomento della programmazione di Scienze con metodologia CLIL. L'argomentoscelto è stato “Discovering DNA”. Per i dettagli si rimanda al documento di Scienze.
FISIONOMIA DELLA CLASSE
La classe, esigua per numero di alunni (sette maschi e nove femmine), ha mantenuto la composizione deidue anni precedenti (con solo un’alunna in meno). Nel primo biennio gli studenti erano più numerosi e la fisionomia del gruppo-classe decisamente diversa:prevaleva una situazione conflittuale e fortemente disomogenea che si è andata attenuando nel tempo, finoa scomparire del tutto a partire dal secondo biennio.Questo si è potuto verificare sia grazie al lavoro intenso e concorde dei docenti del primo biennio, siaperché gli studenti più problematici si sono ritirati o sono stati fermati.All'inizio del terzo anno si sono aggiunti alcuni alunni da un'altra classe che era stata smembrata.Ne è risultato un gruppo non numeroso ma molto valido, con elementi decisamente positivi, talvolta ancheeccellenti, che sono via via maturati e cresciuti durante gli ultimi tre anni di scuola.Il dialogo educativo è stato sempre proficuo, pur in presenza di personalità differenti: alcune piùestroverse e propositive, altre più riservate, ma comunque non meno attente al rapporto con i docenti ele relative discipline. Gli studenti hanno sempre mostrato un atteggiamento corretto, responsabile e collaborativo,evidenziando un buon grado di autonomia nella partecipazione alle diverse iniziative. In particolare, tra le tante attività, gli alunni si sono distinti durante il percorso di Alternanza ScuolaLavoro per un progetto dello scorso a.s. relativo a studio e presentazione di un palazzo storico della città edelle sue collezioni, sia partecipando brillantemente alla “Notte del Liceo Classico” con letture di brani dipoesia e prosa. In queste ed altre attività si sono prodigati con generosità ed entusiasmo al di là delnumero di ore da raggiungere.Dal punto di vista del rendimento la situazione non presenta in generale aspetti problematici: un buongruppo di alunni risulta dotato di ottime capacità, messe a frutto attraverso un lavoro costante; una fasciaintermedia ha ottenuto sempre risultati buoni, pur con qualche flessione in alcune discipline; pochialunni, pur con qualche fragilità, hanno raggiunto risultati comunque positivi grazie all’impegno.
4

LA VALUTAZIONE
Il Consiglio si attiene ai criteri e alla griglia inserita nel PTOF.
Conoscenze Competenze Capacità Comportamenti Voto indecimi
Nessuna Nessuna NessunaPartecipazione: di disturbo
Impegno: nulloMetodo: disorganizzato
1-2
Frammentarie egravemente lacunose
Solo se guidato arriva adapplicare le conoscenze
minime;commette gravi errori
anche nell’eseguire sempliciesercizi
Comunica in mododecisamente stentato e
improprio;ha difficoltà a cogliere iconcetti e le relazioni
essenziali che legano tra loro ifatti anche più elementari
Partecipazione: opportunisticaImpegno: debole
Metodo: ripetitivo3 - 4
Incerte ed incomplete Applica le conoscenzeminime, senza commetteregravi errori, ma talvolta con
imprecisione
Comunica in modo nonsempre coerente e proprio; ha
difficoltà a cogliere i nessilogici e quindi ha difficoltà adanalizzare temi, questioni e
problemi
Partecipazione: dispersivaImpegno : discontinuoMetodo : mnemonico
5
Complessivamenteaccettabili;
ha ancora lacune, ma nonestese e /o profonde
Esegue semplici compitisenza errori sostanziali;
affronta compiti piùcomplessi con incertezza
Comunica in modo semplice,ma non del tutto adeguato;
coglie gli aspetti fondamentali,ma le sue analisi sono
lacunose
Partecipazione: da sollecitareImpegno : accettabile
Metodo : non sempre organizzato 6
Conosce gli elementiessenziali, fondamentali
Esegue correttamentecompiti semplici;
affronta compiti piùcomplessi pur con alcune
incertezze
Comunica in modo adeguato,anche se semplice;
non ha piena autonomia, ma èun diligente ed affidabile
esecutore;coglie gli aspetti fondamentali,
ma incontra difficoltà neicollegamenti interdisciplinari.
Partecipazione: recettivaImpegno: soddisfacente
Metodo: organizzato7
Sostanzialmentecomplete
Affronta compiti anchecomplessi in modo
accettabile
Comunica in maniera chiaraed appropriata ha una
propria autonomia di lavoro;analizza in modo
complessivamente corretto ecompie alcuni collegamenti,
arrivando a rielaborare inmodo abbastanza autonomo
Partecipazione: attivoImpegno: notevole
Metodo: organizzato8
Complete, conapprofondimenti
autonomi
Affronta autonomamenteanche compiti complessi,
applicando le conoscenze inmodo corretto e creativo
Comunica in modo proprio,efficace ed articolato; è
autonomo ed organizzato;collega conoscenze attinte da
ambiti pluridisciplinari;analizza in modo critico, conun certo rigore ;documenta il
proprio lavoro;cerca soluzioni adeguate per
situazioni nuove
Partecipazione : costruttivaImpegno: notevole
Metodo : elaborativo9 -10
N.B. il voto attribuito può essere il risultato della combinazione di diversi livelli di conoscenze, competenze, capacità e comportamenti
5

DATI STATISTICI
INSEGNANTI nel TRIENNIO
STUDENTI
StudentiInizio anno Fine anno
Da classe precedente
Ripetenti TOTALE
Promossi Non promossi Ritirati
Senzasospensione
Con sospensione
III LICEO 17 - 17 14 3 - -IV LICEO 17 - 17 16 1 - 1V LICEO 16 - 16 -
6
MateriaMateria Secondo biennio Secondo biennio
primo annoprimo annoSecondo biennioSecondo biennio
secondo annosecondo anno Quinto annoQuinto anno
ITALIANO GALLI SERRA SERRALATINO VIGITELLO VIGITELLO VIGITELLOGRECO VIGITELLO VIGITELLO VIGITELLOSTORIA GARDELLA GARDELLA PAGANINIFILOSOFIA GARDELLA GARDELLA PAGANINIARTE CAVALLARO CAVALLARO CAVALLAROINGLESE FAUCCI FAUCCI FAUCCIMATEMATICA MARAGLIANO MARAGLIANO MARAGLIANOFISICA MARAGLIANO MARAGLIANO MARAGLIANOSCIENZE MORICONI MORICONI MORICONIED.FISICA BUSANA BUSANA BUSANARELIGIONE VILLAFIORITA VILLAFIORITA VILLAFIORITA

RISULTATI SCRUTINIO FINALE classe III liceo
n° studenti con voto
Materia
10 9 8 7 6 giudiziosospeso
ITALIANO - 3 4 5 4 1LATINO - 1 2 7 6 1GRECO - 1 2 6 7 1STORIA - 1 5 9 2 -FILOSOFIA - 4 3 8 2 -INGLESE - 6 4 2 5 1ARTE 2 6 4 1 4 -MATEMATICA 1 3 3 6 2 2FISICA - 3 4 3 7SCIENZE 3 - 5 3 3 3ED. FISICA 3 5 3 4 2
RISULTATI SCRUTINIO FINALE classe IV liceo
n° studenti con voto
Materia
10 9 8 7 6 giudiziosospeso
ITALIANO - 6 4 5 2 -LATINO - 6 4 5 5 -GRECO - 4 4 5 4 -STORIA - 1 8 3 5 -FILOSOFIA - 2 7 4 4 -INGLESE 2 5 3 5 2 -ARTE 1 8 3 4 1 -MATEMATICA 1 4 5 2 4 1FISICA - 3 3 7 3 1SCIENZE 3 4 2 3 5 -ED. FISICA 3 9 3 1 1 -
7

TEMPI DEL PERCORSO FORMATIVO DELL’ANNO SCOLASTICO IN CORSO
materia Moduli (50') annualiprevisti
Moduli (50’) annuali svolti
svolti fino al15/05/2013
previsti dopo il15/05/2013
Totale
Italiano 140+35 aggiuntivi 127 14 141
Latino 140 96 15 111
Greco 105 88 15 103
Storia 105 76 20 96
Filosofia 105 76 20 96
Matematica 70+18 aggiuntivi 69 9 78
Fisica 70+17 aggiuntivi 63 9 72
Inglese 105 79 11 90
Scienze 70 58 8 66
Storia Dell'arte 70 53 7 60
Educazione Fisica 70 51 8 59
SIMULAZIONI PROVE SCRITTE
11 maggio 2018: simulazione di prima prova uguale in tutte le quinte liceali della scuola
(durata 6 ore)
15 maggio 2018: simulazione di seconda prova uguale in tutte le quinte liceali della scuola
(durata 4 ore)
CALENDARIO SIMULAZIONI TERZA PROVA
MATERIE
1° SIMULAZIONEORE 8.40 – 12.30
Venerdì 16-03 - 2018Fisica Scienze Inglese Filosofia
2° SIMULAZIONEORE 8 – 11
Mercoledì 02 -05 -2018Scienze Storia Matematica Inglese
Le simulazioni della terza prova sono state così impostate:
Prima simulazione: tipologia A con una domanda per ognuna delle quattro materie coinvolte e unmassimo di 20 righe a domanda.
Seconda simulazione: tipologia B con tre domande per ognuna delle quattro discipline prescelte eun massimo di 8-10 righe a domanda.
Tempo a disposizione per lo svolgimento sempre tre ore.
8

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA SCRITTA
INDICATORI PUNTI CORRISPETTIVO INDICATORI-VALUTAZIONE
LIVELLOSUFFICIENZA
PUNTEGGIO
Rispetto delle consegne(tip. A,B,C,D) 0-3
0. mancato rispetto consegne1. rispetto parziale delleconsegne2. rispetto sufficiente delleconsegne3. rispetto esauriente delleconsegne
2
Conoscenza dei contenutie/o comprensione deitesti
A.(comprensione deltesto, risposta ai quesitiproposti)B.(comprensione deitesti, uso delladocumentazione)C. (conoscenza delquadro storico diriferimento, conoscenzadel fenomeno storico neisuoi aspetti)D. (conoscenzedell’argomento proposto,livello di informazionerelativo all’argomento)
1-6
1. evidenti mancanze e/oincongruenze.2. comprensione e/o risposte,conoscenze e/o uso delladocumentazione e/o livello diinformazione gravementeinsufficienti3. comprensione e/o risposte,conoscenze e/o uso delladocumentazione e/o livello diinformazione insufficienti4. comprensione e/o risposte,conoscenze e/o uso delladocumentazione e/o livello diinformazione sufficienti5. comprensione e/o risposte,conoscenze e/o uso delladocumentazione e/o livello diinformazionebuone6. comprensione e/o risposte,conoscenze e/o uso delladocumentazione e/o livello diinformazione complete
4
Uso della lingua(tip.A,B,C,D) correttezzamorfo-sintattica,proprietà lessicali
0-4
Uso della lingua:0.completamente scorretto1.parzialmente scorretto2. quasi corretto3. corretto4. corretto con ricchezzalessicale
3
Approfondimenti (A,B,C,D)
0-2 0. inesistenti1. limitati2.ampi
1
Totale punti
9

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA SCRITTA
INDICATORI
Comprensione del testo
Ampiamente lacunoso o frainteso per 2/3
1 Diverse lacune e/o frainteso per oltre la metà
2 Poche lacune e/o compreso per almeno la metà
3 Compreso peralmeno 2/3
4 Compreso peralmeno 3/4
5 Globalmente compreso
6
Correttezza Moltissimi errori gravi
Totalmente scorretto
1
0
Molti errori gravi
2 Diversi errori gravi
3 Alcuni errori anche gravi
4 Pochi errori 5 Pochissimi errori onessun errore significativo
6
Resa in italiano Gravi e diffuseimproprietà
0 Improprietà anche nelle parti ben comprese
1 Limitate improprietà nelle parti ben comprese
2 Scelte lessicali nel complesso appropriate/ resa efficace e scorrevole
3
Assol. insuff.1-3
Grav. insuff.4-7
Insufficiente 8-9
Sufficiente 10-11
Discreto 12
Buono 13-14
Ottimo 15
Totale punti
N.B. La quantificazione degli errori corrispondenti ai coefficienti numerici (per quanto riguarda la correttezza) è stata stabilita di volta in volta in relazione alla lunghezza e alla difficoltà del testo proposto
10

GRIGLIA DI VALUTAZIONE TERZA PROVA
Criteri per la valutazione della Terza Prova - tipologia A/B (4 discipline)Sono previsti 4 indicatori per la valutazione della prova: per ognuno delle 4 discipline è stato attribuito un punteggio da 0 a 8, che tiene conto delle conoscenze, competenze e capacità acquisite, anche in relazione alla capacità di utilizzare e integrare conoscenze e competenze relative alle altre materie (come previsto dal D.M. 429/2000).
Per la Lingua Straniera il punteggio sarà attribuito sulla base delle conoscenze, competenze e capacità acquisite dall’alunno, anche in relazione alla correttezza ortografica, grammaticale, lessicale e sintattica. Il punteggio massimo sarà attribuito in presenza di risposte corrette e pertinenti, esposte senza errori ortografici, grammaticali, lessicali, sintattici di particolare rilievo. Il punteggio corrispondente alla soglia di sufficienza sarà attribuito in presenza di risposte valutate neilimiti dell’accettabilità sotto i vari profili (correttezza e pertinenza delle risposte, correttezza ortografica, grammaticale, lessicale e sintattica).
Per le discipline di area linguistico-storico-filosofica (così come definite dal D.M. 319/2015) il punteggio sarà attribuito sulla base delle conoscenze, competenze e capacità acquisite, valutate globalmente in relazione alla correttezza e alla pertinenza delle risposte, alla forma espositiva e alla capacità di sintesi. Il punteggio massimo sarà attribuito in presenza di risposte corrette e pertinenti, ben sintetizzate in relazione allo spazio a disposizione ed esposte in modo appropriato. Il punteggio corrispondente alla soglia di sufficienza sarà attribuito in presenza di risposte valutate nei limiti dell’accettabilità sotto i vari profili (correttezza e pertinenza delle risposte, forma espositiva e capacità di sintesi).
Per le discipline di area scientifica, (così come definite dal D.M. 319/2015) il punteggio sarà attribuito sulla base delle conoscenze, competenze e capacità acquisite, valutate globalmente in relazione alla correttezza e alla pertinenza delle risposte, all’organizzazione logica e alla capacità di argomentazione. Il punteggio massimo sarà attribuito in presenza di risposte corrette e pertinenti, ben argomentate e ben strutturate da un punto di vista logico, in relazione allo spazio a disposizione. Il punteggio corrispondente alla soglia di sufficienza sarà attribuito in presenza di risposte valutate nei limiti dell’accettabilità sotto i vari profili (correttezza e pertinenza delle risposte, organizzazione logica e capacità di argomentazione).
I punteggi saranno attribuiti sulla base dei seguenti descrittori
8 : conoscenze, competenze e capacità buone (punteggio massimo); 6 : conoscenze, competenze e capacità soddisfacenti; 4 : conoscenze, competenze e capacità nei limiti dell’accettabilità (soglia di sufficienza); 2 : conoscenze, competenze e capacità decisamente insufficienti;
0 : conoscenze, competenze e capacità nulle (punteggio minimo)
Eventuali punteggi intermedi (interi o decimali) indicheranno il grado di scostamento dai livelli sopraindicati.
Si calcola poi la somma dei punteggi attribuiti e, qualora essa non sia intera, la si arrotonderà all’intero più vicino, secondo le usuali convenzioni matematiche. Si otterrà un punteggio in 32-esimi, che sarà convertito in 15-esimi, secondo la seguente griglia di conversione:
Sommapunteggi 0 1 2 3
4-5
6-8
9-
11
12-
14
15-
17
18-
19
20-
21
22-
25
26-
28
29-
32Valutazione
3° prova 1 2-3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
11

QUESITI PRIMA SIMULAZIONE DI TERZA PROVA – tipologia A
SCIENZE:
Descrivi la struttura anatomica e istologica del cuore, il meccanismo di contrazione e la sua regolazione.
INGLESE :
The theme of the double has always been present in the world’s literature. In the Great Britain of the
19th century, it strikes at the core the Victorian Compromise and the age’s moral standards.
In 20/25 lines illustrate how the authors you have studied dealt with this theme.
FISICA:
Il candidato spieghi il significato di flusso di un campo vettoriale attraverso una superficie analizzando, in
particolare, le situazioni di flusso del campo elettrico e di quello magnetico attraverso superfici chiuse.
(max. 25 righe)
FILOSOFIA:
Confronta il modo in cui si configura il rapporto tra la filosofia e le scienze in Hegel, Comte e Bergson.
Risultati:
12

QUESITI SECONDA SIMULAZIONE DI TERZA PROVA – tipologia B
MATEMATICA 1) Cosa afferma il teorema del confronto? Il candidato, dopo avere enunciato il teorema, evidenziandone ipotesi e tesi, produca un esempio del suo utilizzo e ne verifichi le ipotesi. (max. 10 righe)2) Cosa è una “forma indeterminata”? Il candidato, dopo aver illustrato brevemente il concetto, produca unesempio di limite di una forma indeterminata determinandone la soluzione (max. 10 righe)3) Cosa si intende per “punto di non derivabilità”? Il candidato fornisca la definizione richiesta, esemplifichi anche graficamente il concetto e produca un esempio di funzione che abbia in un punto x0 un punto di non derivabliltà (max. 10 righe)
INGLESE1) What was the Aesthetic Movement? What aspects of Aestheticism are to be found in the life and works of Oscar Wilde?2) Can you explain the different vision of the war in the “War Poets” we have studied?3) Refer to the relationship between Joyce and his family and country. Why did he go into voluntary exile?
SCIENZE1) Almeno 6 ormoni sono coinvolti nella regolazione del glucosio: individuali, associali alla ghiandola produttrice e descrivene brevemente l'azione.2) Cos'è la corteccia cerebrale e come viene suddivisa?3) Quali sono le caratteristiche del tessuto connettivo?
STORIA1) Qual è l’importanza della Conferenza di Monaco del ’38?2) Spiega come e quando inizia la Guerra civile spagnola, come si schierano le potenze europee e perché può essere considerata una prova generale della Seconda Guerra Mondiale?3) Spiega quali eventi rendono il ’41 un anno cruciale per la Seconda Guerra Mondiale?
Risultati:
13

ITALIANO
Docente: Patrizia Serra
PRESENTAZIONE DELLA CLASSE:La classe V C, da me seguita negli ultimi due anni del corso, presenta una natura estremamente curiosa e quasi sempre tendente ad approfondire gli argomenti. Tale curiosità spesso porta gli alunni ad un approccio abbastanza disciplinato e, pur senza vivaci discussioni, si sono avuti anche i migliori momenti di crescita della coscienza critica individuale. Molti quindi sono gli elementi di spicco, che hanno dimostrato per la materia particolare propensione ed interesse. In taluni sporadici casi l’atteggiamento è rimasto un po’ passivo.
Obiettivi didattici generali: Consolidamento del metodo di lavoro ed approfondimento dei contenuti. Potenziamento delle capacità di analisi e sintesi Potenziamento e consolidamento delle capacità di organizzare un discorso su tutti gli
argomenti proposti, articolato in diverse direzioni, volto a comprendere opportunamente leconoscenze acquisite nelle varie aree disciplinari.
Perfezionamento delle capacità espressive e dell’uso si lessico specifico. Capacità di rielaborare in modo personale e critico i contenuti proposti.
Obiettivi didattici specifici: Comprensione di un testo attraverso i vari piani di lettura. Contestualizzazione di un testo ed individuazione delle coordinate spazio - temporali. Interpretazione personale di un testo, in rapporto alle altre produzioni dell’autore Riconoscimento delle principali strutture stilistiche, proprie di un autore o di una corrente. Capacità di produrre scritti che rivelino pertinenza alla traccia proposta, coesione, coerenza
ed originalità.
METODOLOGIEPremettendo, come criterio generale, la preponderante attenzione ai testi , alla loro lettura diretta,all’analisi e all’interpretazione delle loro strutture, più nello specifico si è cercato di:
Fornire i contenuti essenziali mediante la classica lezione frontale Favorire il coinvolgimento degli alunni nell’attività didattica, stimolandone osservazioni
personali e critiche. Operare pause di riflessione, qualora la situazione lo abbia richiesto, per riorganizzare
contenuti acquisiti, approfondirli e collegarli, correggere ed adeguare il lavoro agli obiettivi.
VERIFICHEUn congruo numero di verifiche scritte, come simulazione degli scritti d’esame, è stato proposto agli alunni durante l’anno. In particolare sono stati svolti tre scritti nel primo quadrimestre e quattro nel secondo. L’ultimo scritto è prova comune a tutte le classi quinte e si svolge per l’intera mattinata, come da prassi consolidata. E' stato proposto anche un questionario sui più importanti temi letterari e un'interrogazione su alcuni canti del Paradiso dantesco, per abituare gli alunni alle risposte brevi e centrate, come si richiede nella Terza Prova e nel Colloquio d'esame. Le interrogazioni sono state numerose e sui singoli argomenti, sfruttando l'ora di potenziamento assegnata alla disciplina.
14

MOTIVAZIONE DELLA SCELTA DEGLIAUTORI:
-sono quelli indicati dalla critica come emblematici per la conoscenza delle fasi più significative della storia letteraria italiana degli ultimi due secoli;
-sono quelli presenti da decenni nella prassi scolastica.
MOTIVAZIONE DELLA SCELTA DEI TESTI:
-si prestano particolarmente alla illustrazione documentata della poetica dei singoli autori;
-sono collegati ad un percorso di storia letteraria tradizionalmente disposto in ordine cronologico masono altresì utili per lo svolgimento di argomenti pluridisciplinari da concordarsi nell’ambito dei consigli di classe ;
-consentono di esercitare lo studente all’analisi dei testi in prosa ed in poesia come si evince dalla indicazione degli obiettivi.
ELEMENTI “IRRINUNCIABILI” DESUNTI DAI PROGRAMMI TRADIZIONALIQuadro di orientamento sui grandi movimenti letterari con riferimento alle maggiori personalità -Romanticismo- Verismo- Decadentismo- Prosa e Poesia del ‘900Analisi e contestualizzazione di testi
METODIIL PERCORSO FORMATIVO DELLA DISCIPLINA E’ STATO TRATTATO CON METODO STORICISTICO E SECONDO IL TRADIZIONALE ASSE CRONOLOGICO PREVISTO DAI PROGRAMMI MINISTERIALI.Gli alunni sono stati invitati a supportarlo con manuali in loro possesso. per quanto riguarda i testi,essi sono stati anche forniti in fotocopia.
PROGRAMMA DI LETTERATURA ITALIANABologna , Rocchi – Rosa fresca aulentissima, Loescher vol. 4IL GUSTO ROMANTICORomanticismo in Italia (p.144)
GIACOMO LEOPARDI (p. 264)dai CANTI (p. 289)
Ultimo canto di Saffo (p. 299)L'infinito (p. 305)La sera del dì di festa (313)A Silvia (322)Le ricordanze (329)Canto notturno di un pastore errante ((338)La quiete dopo la tempesta (346)Il passero solitario (305)Il sabato del villaggio (350)A se stesso (354)
15

La ginestra (358)dalle OPERETTE MORALI (373)
Dialogo della Natura e di un Islandese (392)Dialogo di un venditore di almanacchi.. (410)
Bologna , Rocchi – Rosa fresca aulentissima, Loescher vol. 5
GIOSUÈ' CARDUCCI (46)da ODI BARBARE
Alla stazione in una mattina d'autunno (60)Nevicata (64)
da RIME NUOVEDavanti San Guido (fotocopia)Funere mersit acerbo (fotocopia)
IL ROMANZO EUROPEO cenni. (88)
IL VERISMO E GIOVANNI VERGA (242)VITA DEI CAMPI
Rosso Malpelo (270)NOVELLE RUSTICANE
La roba (294)I MALAVOGLIA
La famiglia Malavoglia (305)La tempesta (325)L'addio (328)
MASTRO DON GESUALDOLa morte di Gesualdo (348)
IL DECADENTISMOLA POESIA DEL DECADENTISMO (398)CHARLES BAUDELAIREda I FIORI DEL MALE
L'albatro (409)Corrispondenze (410)
PAUL VERLAINEArte poetica (414)
ARTHUR RIMBAUDLe vocali (418)
GABRIELE D'ANNUNZIO (442)dal PIACERE
L'attesa (460)La conclusione (fotocopia)
dalle LAUDI – ALCYONE
16

La sera fiesolana (505)La pioggia nel pineto (509)Meriggio (in fotocopia)Nella belletta (in fotocopia)I pastori
GIOVANNI PASCOLI (536)da MYRICAE
Lavandare (561)L'assiuolo (563)X Agosto (563)Temporale (in fotocopia)Il lampo (in fotocopia)Il tuono (568)Novembre (in fotocopia)
Da CANTI DI CASTELVECCHIOLa mia sera (579)Il gelsomino notturno (574)
da POEMETTIItaly, (589) e fotocopiaDigitale purpurea (585)
da POEMI CONVIVIALIAlexandros (597)L'ultimo viaggio (594)
Bologna , Rocchi – Rosa fresca aulentissima, Loescher vol. 6LE AVANGUARDIE STORICHEF:T: MARINETTI
Primo Manifesto del Futurismo (79)
LA PROSA ITALIANA DEL PRIMO '900
LUIGI PIRANDELLO (530)da L'UMORISMO (543)
da NOVELLE PER UN ANNOIl treno ha fischiato (558)
da IL FU MATTIA PASCALPrima premessa e seconda premessa (574)Lo strappo nel cielo di carta (586)Il Fu Mattia Pascal (591)
da SEI PERSONAGGI IN CERCA D'AUTOREL'ingresso dei Sei Personaggi (630)
da ENRICO IVPreferii restare pazzo (639)
17

ITALO SVEVO (456)Da SENILITA'
Amalia (486)
da LA COSCIENZA DI ZENOLa prefazione (497)Preambolo (499)Il fumo (502)Lo schiaffo del padre (514)Un matrimonio sbagliato (516)Il finale (520)
I CREPUSCOLARI GUIDO GOZZANO (181)
La signorina Felicita ovvero la felicità (189)Totò Merumeni (202)l'amica di nonna Speranza
GIUSEPPE UNGARETTIda L'ALLEGRIA
Notte di maggio (252)In memoria (253)Il porto sepolto (255)I fiumi (262)San Martino del Carso (265)Veglia (257)Sono una creatura (260)Commiato (270)Mattina (273)Soldati (274)
da SENTIMENTO DEL TEMPOL'isola (in fotocopia)Sentimento del tempo
da IL DOLOREGiorno per giorno (287)Non gridate più (291)
UMBERTO SABA (378)da IL CANZONIERE
A mia moglie (390)La capra (395)Trieste (397)Favoletta (404)Amai (412)Ulisse (413)
18

Città vecchia (415)Teatro degli Artigianelli (in fotocopia)
SALVATORE QUASIMODO E L'ERMETISMOda ED E' SUBITO SERA
E' subito sera (425)Vento a Tidari (426)Ride la gazza (in fotocopia)
da GIORNO DOPO GIORNOAlle fronde dei salici (431)Milano, agosto 1943
EUGENIO MONTALEda OSSI DI SEPPIA
In limine (317)I limoni (319)Non chiederci la parola (324)Meriggiare pallido e assorto (326)Spesso il male di vivere (329)Falsetto (in fotocopia)Forse un mattino andando (fotocopia)Portami il girasole (373)Gloria del disteso mezzogiorno (330)Cigola la carrucola del pozzo (332)
da LE OCCASIONIDora Markus (343)Lo sai debbo riperderti (346)Addii, fischi nel buio, cenni, tosse (347)Non recidere forbice (351)La casa dei doganieri (352)
da LA BUFERALa primavera hitleriana (359)L'anguilla (362)Piccolo testamento (fotocopia)
da SATURAHo sceso dandoti il braccio (369)
CENNI SULLA POESIA DEL SECONDO NOVECENTOCENNI SULLA PROSA DEL SECONDO NOVECENTO
DANTE – PARADISOI, III, VI, XI, XV, XVII, XXVII ( vv.1-66), XXXIII
19

LATINO E GRECO
Docente: Silvia Vigitello
OBIETTIVI DISCIPLINARI
A. Competenze linguistiche e di traduzione:- consolidare e approfondire le strutture morfo-sintattiche della lingua- ampliare il lessico di base- sviluppare la capacità di analisi morfo-sintattica dei testi- sviluppare la capacità di comprensione del significato dei testi- sviluppare la capacità di traduzione in italiano corretto
B. Competenze letterarie - conoscere la letteratura latina di età imperiale e quella greca di età ellenistica e romana in relazione al contesto
storico, ai generi letterari, agli autori, alle opere più significative- conoscere la concezione, la poetica, le tematiche, le caratteristiche stilistiche di ogni autore preso in esame- sviluppare capacità di analisi, sintesi, confronto, collegamento, rielaborazione critica- sviluppare capacità di esposizione corretta scritta e orale
C. Competenze di analisi testuale- saper tradurre i testi di autori greci e latini esaminati in classe - saper analizzare la struttura morfosintattica dei testi- saper contestualizzare i testi nell’ambito dell’opera e della produzione dell’autore- saperne individuare i temi - saper analizzare i testi dal punto di vista stilistico
CONTENUTI E MODALITÀ DI LAVORO
L’attività didattica è stata articolata in:1. studio della lingua2. studio della letteratura3. lettura, analisi e commento di testi letterari
Tuttavia, là dove possibile, si è cercato di superare una rigida suddivisione di ambiti per adottare un’impostazionemodulare, alternando la trattazione storico-letteraria alla lettura e al commento dei testi in lingua e all’esercizio ditraduzione.
1. Lo studio della lingua è stato focalizzato sul consolidamento delle strutture morfo-sintattiche e sull’ampliamentodel lessico e si è prevalentemente effettuato attraverso la traduzione in classe e/o a casa di brani d’autore, concadenza settimanale. Sono stati proposti passi di argomento storico, filosofico e retorico, tratti in linea di massima daautori appartenenti ai programmi di letteratura. Nel fornire indicazioni metodologiche per la traduzione, si è insistito inmodo particolare sulla necessità di coniugare, ad una corretta analisi morfo-sintattica, la riflessione sul significato deltesto stesso e l’attenzione alla resa in italiano, onde evitare traduzioni “meccaniche” e povere di senso.
2. Lo studio della letteratura latina ha compreso la trattazione del contesto storico, dei generi letterari, degli autori edelle opere più significative dell’età imperiale, accompagnata dalla lettura in classe e dal commento di testi antologiciin traduzione. Non è stato possibile affrontare in modo sistematico la letteratura cristiana e ci si è limitati ad alcunibrevi cenni su Agostino, con particolare riferimento alla trattazione sul tempo in Confessiones XIPer quanto riguarda la letteratura greca, nei primi mesi è stato completato lo studio dell’età classica, già intrapreso loscorso anno, con la trattazione della storiografia di Tucidide e del teatro comico di Aristofane. Successivamente è stataaffrontata la letteratura di età ellenistica attraverso l’inquadramento di alcuni autori fondamentali e la lettura in classedi testi in traduzione. L’età greco-romana viene trattata solo nell’ultimo mese, in modo più sintetico e affidando agliallievi gran parte delle letture antologiche.
3. Autori latini: sono stati affrontati alcuni passi dell’Eneide di Virgilio, alcune poesie di Orazio, brani di Seneca e diTacito, in concomitanza con lo studio di tali autori nella storia letteraria. L’attività didattica svolta in classe ha compreso
20

la traduzione dei testi, la comprensione del loro significato, la riflessione sulle tematiche culturali, politiche, filosoficheinerenti, l’analisi delle caratteristiche linguistiche e stilistiche.Autori greci: si è proposta la lettura di alcuni brani dell’Apologia di Platone e delle Baccanti di Euripide. Per quanto riguarda il dialogo platonico, si è cercato di presentare il contenuto e il significato dell’opera e diindividuare alcuni punti fondamentali dal punto di vista concettuale, affidando agli studenti la lettura del testo intraduzione. La tragedia è stata letta e commentata integralmente in classe in italiano e tradotta dal greco per un totale di 421versi, attraverso una scelta di passi significativi. E’ stata effettuata la lettura metrica delle parti in trimetro giambico,senza tuttavia richiederla in modo obbligatorio agli allievi. Anche per gli autori greci si è tentato di coniugare, all’analisilinguistica rigorosa, una riflessione sulle valenze contenutistiche ed espressive dei testi.
VERIFICA E VALUTAZIONE
La verifica delle conoscenze, capacità e competenze acquisite è avvenuta mediante prove scritte di traduzione per lavalutazione scritta e colloqui orali, questionari o prove strutturate per la valutazione orale. Le prove scritte sono state quattro in tutto per latino, sei per greco, consistenti nella traduzione in italiano di passi perlo più di carattere storico, retorico e filosofico. Per la valutazione si è utilizzata la griglia approvata dal Gruppodisciplinare di latino e greco.Per la valutazione dell’orale, in ciascun periodo gli alunni hanno sostenuto un colloquio e una o più prove scritte diautori e/o letteratura valevoli per l’orale. Come parametri valutativi si è tenuto conto dei seguenti elementi:- possesso delle conoscenze linguistiche, storiche, letterarie, culturali;- capacità logiche, espressive, critiche; - competenze nella traduzione, nella contestualizzazione e nell’analisi stilistica dei testi.
Si sono considerati requisiti minimi per il raggiungimento della sufficienza il possesso di conoscenze storico-letterariebasilari , la capacità di contestualizzare correttamente i testi studiati, di saperli tradurre in modo consapevole e diaverne compreso il significato fondamentale.
RISULTATI OTTENUTI
La classe, in tutti gli ambiti dell’attività didattica, ha dato prova di interesse e impegno regolare nello studio,raggiungendo un soddisfacente livello di rendimento. Alcuni alunni presentano ancora alcune fragilità nella traduzionescritta, costantemente compensate, tuttavia, da un’apprezzabile applicazione nello studio della letteratura e degliautori; un gruppo ha conseguito risultati senz’altro buoni sia nello scritto che nell’orale; all’interno di questo emergonoalcuni studenti che hanno dimostrato profondo interesse e spiccate qualità per le discipline classiche.
PROGRAMMA SVOLTO DI LATINO
Testi di riferimento: Bettini Maurizio, La cultura latina, voll.2 e 3, La Nuova Italia Lentano M., Autori latini, voll. 2 e 3, La Nuova Italia
Storia della letteratura, letture antologiche in traduzione e in latino
VirgilioTesti tradotti dall’Eneide (Autori latini vol. 2):
- T8 La passione di Didone (Aen. IV, 1-5; 68-89) pag. 37- T10 “Non si può ingannare un amante”: Enea di fronte a Didone (Aen. IV., 296-332), pag.42
OrazioVita EpodiSatire: modelli e caratteriOdi: modelli, temi, stileEpistole: il libro I; il libro II e l’Ars poeticaStile
Letture in traduzione (da La cultura latina 2):
21

- T1 Fuggire dalla guerra civile (Epodo 16), pag. 124- T3 Il seccatore (Sat. I, 9), pag.132- T4 Hoc erat in votis (Sat. II, 6), pag. 136- T9 Per la morte di Cleopatra (Odi I, 37), pag. 150- T12 L’immortalità (Odi III, 30), pag. 156
Testi in latino (da Autori latini 2, salvo diversa indicazione)- T3 Paesaggio invernale (Carm. I, 9), pag.76- T4 Carpe diem (Carm. I, 11), pag.79- T8 Cloe la cerbiatta in fuga (Carm. I, 23), La cultura latina 2, pag. 149- T6 La linea e il cerchio (Carm. IV, 7), pag. 82- T16 All’amico Tibullo (Ep. I, 4), pag. 124- La depressione (Ep. I, 8), pag. 127
L’età Giulio-Claudia: quadro storico e culturale
SenecaVita e opereLe ConsolationesL’ApokolokyntosisIl periodo di collaborazione con Nerone e il De clementiaIl ritiro dalla vita politica e il De otioLa concezione del tempo e il De brevitate vitaeLe Epistulae ad LuciliumLe tragedieStile
Testi in latino (da Autori latini 3)- T2 L’otium: un bene per l’individuo (De otio 3,1-5), pag.7- T3 Ogni uomo ha due patrie (De otio 4,1-2), pag.10- T8 Ostaggi nel regno di Fortuna (Consolatio ad Marciam 10,1-4), pag.29- T10 Riflessione sul tempo ( Epistulae ad Lucilium 1), pag. 37- T12 “Servi sunt”. Immo homines (Epistulae ad Lucilium 47, 1-5), pag. 45- Dal De brevitate vitae: I veri vivi (14,1-3), pag.83
LucanoVitaIl Bellum civile: argomento, genere letterario, modalità compositive, personaggiLetture in traduzione (da La cultura latina 3):
- T3 Proemio e lodi di Nerone (Bellum civile I, 1-66) pag. 113- T4 Catone (Bell. civ. II, 380-391) pag. 115- T5 La scena della necromanzia (Bell. civ. VI, 624-725), pag. 117 -
PetronioIl problema dell’autoreIl contenuto dell’operaIl problema del genere letterarioIl realismo del SatyriconLa Cena TrimalchionisLa parodia nel Satyricon
Letture in traduzione (da La cultura latina 3):- T1 La corruzione dell’eloquenza (Sat. 1-2) pag. 138- T2 Uova con… sorpresa (Sat. 33) pag. 140- T3 La larva meccanica di Trimalcione (Sat. 34, 4-10) pag. 143- T6 Ritratto di “signora” (Sat. 67), pag. 150
22

- T7 La matrona di Efeso (Sat. 111-112), pag.152
L’età dei Flavi: quadro storico e culturale
Plinio il Vecchio Vita La Naturalis historia
QuintilianoVitaInstitutio oratoriaLetture in traduzione (da La cultura latina 3):
- T1 I vantaggi dell’apprendimento collettivo (Inst. or. I,2), pag. 192- T2 E’ necessario anche il gioco (Inst. or. I, 3, 8-12), pag. 193- T6 Il giudizio su Seneca (Inst. or. X, 1, 125-131), pag. 200
MarzialeVitaEpigrammi: la poetica e le caratteristiche formaliLetture in traduzione (da La cultura latina 3):
- T1 La bellezza di Maronilla (I,10), pag. 213- T3 Un mondo di oscenità (I,35), pag. 214- T4 In morte della piccola Erotion, (V,34), pag.216
L’età di Nerva e Traiano: quadro storico e culturale
Plinio il GiovaneVitaIl PanegiricoLe Epistole
Letture in traduzione (da La cultura latina 3):- T2 La morte di Plinio narrata da suo nipote (VI, 16), pag. 234- T3 Plinio di fronte alle comunità cristiane (X,96), pag. 237
La satira sotto il principatoCenni su PersioGiovenaleVitaSatireLetture in traduzione (da La cultura latina 3):
- T1 Perché scrivere satire (1, 1-80), pag. 292- T2 Pregiudizi razzistici (3, 60-153), pag. 294- T5 Eppia la “gladiatrice”, Messalina Augusta meretrix (6, 82-132), pag. 299
TacitoVitaOpereIdeologia politicaCaratteristiche della storiografia tacitianaStileLetture in traduzione (da La cultura latina 3):
- T1 Il discorso di Calgaco (Agricola 30-32) pag. 258- T4 Eloquenza e libertà (Dialogus de oratoribus 36) pag. 265- T10 L’incendio di Roma e la costruzione della domus aurea (Annales XV, 38-42), pag. 276
Testi in latino (da Autori latini 3)- T2 Placide quiescas (Agricola 46, 1-4), pag. 116
23

- T4 La “sincerità” genetica dei Germani (Germania 4,1), pag.122- T18 L’ultima battaglia di Seneca (Annales XV, 62-64), pag.173- T19 Vita e morte di un libertino (Annales XVI, 18-19), pag. 177
L’età di Adriano e degli Antonini: quadro storico e culturale
ApuleioVita e opereLe Metamorfosi: contenuto e strutturaLa favola di Amore e PsicheSignificato allegorico dell’operaStileLetture in traduzione (da La cultura latina 3):
- T3 Lo sposo misterioso (Metamorphoses V,21,5-23), pag. 366- T4 Il sogno di Lucio, (Metamorphoses XI, 3-5), pag. 367
Letteratura cristiana (cenni)Agostino (cenni)T7 Dio e il tempo (Confessiones XI, 15-17), pag.501
PROGRAMMA SVOLTO DI GRECO
A. Storia della letteratura e letture antologicheTesto di riferimento: Casertano – Nuzzo, Storia e testi della letteratura greca, Voll. II e III, Palumbo Editore
Dal volume IITucidideVita e ideologiaLe StorieCarattere e metodo della storiografia tucidideaLetture in traduzione dalle Storie
- T4 Il metodo (1, 21-22), pag. 471- T6 Atene “scuola dell’Ellade” (2,34;36-41;43-46), pag. 477- T7 Profilo di Pericle (2,65), pag. 481- T11 La spietata logica della forza (5,89; 91,2; 92-103), pag. 493- T12 Fine del dialogo (5, 104-114; 5, 116, 3-4), pag. 500
La Commedia atticaAristofaneVita e ideologiaTrama e temi delle commedieStruttura e caratteri della commedia aristofanescaLettura integrale in traduzione di una commedia a scelta
Dal volume IIIMenandro e la Commedia NuovaEvoluzione del genere comicoCaratteristiche della Commedia Nuova Menandro: vita e opereCaratteri e mondo concettuale della commedia menandreaLetture in traduzione:
- T1 Un caratteraccio (Il misantropo, 1-188), pag. 37- T7 Un uomo in crisi (L’arbitrato, 558-611), pag. 60
La civiltà ellenisticaStoria del termine “Ellenismo”Quadro storico-politico: i regni ellenisticiI luoghi di produzione della culturaIndividualismo e cosmopolitismoFilosofia, scienza, religione
24

La linguaLa nuova letteratura e i principali generi letterari
CallimacoVitaPoeticaOpere: Aitia, Giambi, Ecale, Inni, epigrammiAttività filologicaLetture in traduzione:Dagli Aitia
- T1 Contro i Telchini (Aitia, fr. 1 Pfeiffer, vv. 1-38), pag. 83 - T3 La storia di Acontio e Cidippe (Aitia, fr. 75 Pfeiffer, vv. 1-49), pag. 88
Dagli Inni- T8 Artemide bambina (Inno ad Artemide, 1-86), pag. 97- T9 L’accecamento di Tiresia (Per i lavacri di Pallade, 70-142), pag. 104
Dagli Epigrammi- T10.4 Vita e arte (XXVIII), pag. 108- T11.1 Oltre la morte (II), pag. 109
Apollonio Rodio VitaLe Argonautiche: contenutoGli elementi di novità dell’operaLa centralità del III libro e la figura di MedeaLetture in traduzione dalle Argonautiche:
- T4 Il rapimento di Ila (1, 1207-1272), pag. 134- T7 Il sogno di Medea (3, 616-664), pag. 145- T8 Tormento notturno (3, 744-769; 802-824), pag. 147- T11 L’uccisione di Apsirto (4, 445-481), pag.158
Teocrito VitaProduzione poeticaIl significato del termine “idillio” e la sua evoluzione semanticaGli Idilli bucoliciI mimi cittadiniGli epilliLetture in traduzione dagli Idilli:
- T1 Le Talisie (Idillio VII), pag. 184- T3 Il Ciclope (Idillio XI), pag. 194- T4 L’ incantatrice (Idillio II), pag. 201- T5 Le Siracusane (Idillio XV), pag. 206- T6 Ila (Idillio XIII), pag. 213
L’epigramma Evoluzione del genere in età ellenisticaCaratteristicheLe raccolte“Scuole” dell’epigrammaLetture in traduzione:Anite
- T1 I giocattoli di Mirò ( A.P. 7,190), pag. 242- T5 Pietosa illusione (A.P. 7,649), pag. 243
Leonida- T14 Appello ai topi (A.P. 6, 302), pag. 247- T15 Doppia sepoltura ( A.P. 7,506), pag. 247- T17 Miseria umana (A.P. 7, 472), pag. 248
Asclepiade - T18 Il male di vivere (A.P. 12,46), pag. 252
25

- T21 Breve il giorno (A.P. 12,50), pag. 253- T22 Tradito dal vino (A.P. 12,135, pag. 254)
Cenni sulla storiografia ellenisticaPolibioVitaLe Storie: contenuto Caratteri della storiografia polibianaLa teoria delle cause nel proemio del libro IIILa teoria delle costituzioni nel libro VILetture in traduzione dalle Storie:
- T1 Utilità e caratteri dell’opera polibiana: pragmaticità e universalità (1, 1-4), pag. 295 - T3 Il “secondo proemio” e l’analisi delle cause (3, 6-7), pag. 302- T8 “La costituzione di uno stato determina il successo o il fallimento in ogni vicenda” (6, 2-5;7-10), pag. 315
Quadro generale dell’età greco-romana Il trattato Sul sublimeT2 Le fonti del sublime (Sul sublime,7, 2-4; 8; 9, 1-3), pag. 386
Luciano e la Seconda SofisticaDa Dialoghi dei morti:
- T9.2 Fugacità della bellezza umana (Menippo ed Ermete), pag. 421
Plutarco- T1.1 Storia e biografia (Vita di Alessandro, 1, 1-3), pag. 446
B. AutoriTesti di riferimento:Euripide, Baccanti, a cura di Roberta Sevieri, PrincipatoPlatone, Apologia di Socrate, a cura di Laura Suardi, PrincipatoEuripideBaccantiLettura integrale in traduzioneTraduzione e commento del testo greco: Prologo, vv. 1-63Parodos, vv. 64-87; 135-169Primo episodio, vv. 170-285 Secondo episodio, vv.434-518Quarto episodio, vv. 912-976Esodo, vv. 1259-1297
PlatoneApologia di SocrateLettura integrale in traduzioneTraduzione, analisi e commento del testo greco:28e- 32e (L’attività e il messaggio di Socrate, da pag. 100 a pag. 114)
26

STORIA
Docente: Gabriella Paganini
FINALITÀ’
1) Ricostruire la complessità del fatto storico2) Scoprire la dimensione storica del presente3) Affinare la sensibilità alle differenze
OBIETTIVI
1) Utilizzare conoscenze e competenze acquisite nel corso degli studi per orientarsi nella molteplicità delleinformazioni
2) Adoperare concetti e termini storici in rapporto agli specifici contesti storico-culturali3) Ripercorrere, nello svolgersi di processi e fatti esemplari, le interazioni tra i soggetti singoli e collettivi4) Usare modi appropriati per inquadrare, comparare, periodizzare diversi fenomeni storici5) Possedere gli elementi fondamentali che testimoniano la complessità dell’epoca studiata
METODOLOGIA DIDATTICA
Strumenti usati: lezioni frontali e dialogate; lettura in classe commentata di brani storiografici;schematizzazioni; presentazioni power point, documenti video, approfondimenti attraverso lapresentazione alla classe da parte degli alunni di opere lette integralmente in modo autonomo. A partire dalsecondo dopoguerra, la storia è stata affrontata per nuclei tematici, esaminati diacronicamente, con alcuniapprofondimenti esemplificativi.
VERIFICHE
Sono stati adottati i seguenti tipi di verifiche: colloqui per accertare la padronanza complessiva dellamateria; domande scritte a risposta aperta e trattazioni sintetiche di argomenti circoscritti. Elementi daaccertare: conoscenza dei fatti storici; capacità di individuare nessi causali contingenti e strutturali;definizione di concetti storici e uso del linguaggio specifico..
CRITERI DI VALUTAZIONE (validi per entrambe le discipline)
Ci si è attenuti ai criteri indicati dal PTOF; la valutazione conclusiva ha tenuto conto anche dell’assiduitàdella frequenza, dell’impegno e costanza nello studio, dei miglioramenti registrati nel corso dell’anno, dellarisposta agli stimoli di riflessione emersi durante le lezioni.
PROGRAMMA SVOLTO
1) La seconda rivoluzione industriale e la questione sociale2) La Grande Depressione: dal capitalismo della libera concorrenza al capitalismo monopolistico3) Gli Stati Uniti dalla Guerra di Secessione al predominio economico mondiale; fordismo e
taylorismo; la nascita del Giappone moderno.4) La Germania di Bismarck 5) L’Italia tra liberalismo e spinte autoritarie: l’età crispina e l’età giolittiana. (politica interna ed estera). I
cattolici e lo stato liberale (dalla legge delle Guarentigie alla Rerum Novarum). La svolta doganale del 1887 e il decollo industriale. La crisi di fine secolo.
6) Colonialismo e imperialismo: cause economiche e politiche.7) Venti di guerra: la politica estera aggressiva della Germania di Guglielmo II; le crisi marocchine
27

e le guerre balcaniche.8) La prima guerra mondiale. Interventisti e neutralisti in Italia9) La rivoluzione russa10) I trattati di pace, in particolare quello di Versailles. I 14 punti di Wilson e la Società delle
Nazioni11) La Germania di Weimar. Stresemann al potere: fine della resistenza passiva; il piano Dawes e il
boom dell'economia tedesca; lo spirito di Locarno e la distensione internazionale degli anni '20.12) La crisi del ’29 e il New Deal rooseveltiano.13) L’età dei fascismi e dei totalitarismi: il concetto di totalitarismo.14) Il crollo dello stato liberale in Italia e l'avvento del fascismo. Le leggi fascistissime e la
costruzione del regime totalitario. Il Concordato. Il sistema corporativo e la politica economica del fascismo. La politica estera: dall'opera di mediazione alla guerra d'Etiopia.
15) Il regime nazista: la creazione dello stato totalitario; aggressioni naziste e politica dell'appeasement di Francia e Inghilterra. Il patto di Monaco e il patto Ribbentrop-Molotov.
16) Il regime staliniano: pianificazione dell'economia, collettivizzazione forzata della terra e industrializzazione; le “grandi purghe”.
17) La guerra di Spagna.18) La seconda guerra mondiale. Le conferenze di Teheran, Yalta e Potsdam. Lo sbarco in Sicilia, il
crollo del fascismo, l'8 settembre, la repubblica di Salò.19) Auschwitz e Hiroshima: due punti di non ritorno20) La Resistenza italiana.21) L'Italia dalla liberazione alle elezioni del '48; la Costituzione italiana; i principi fondamentali e
le idee su cui si basano.
22) I rapporti internazionali nel secondo dopoguerra: dalla Guerra fredda alla crisi di Cuba
La rottura della grande alleanza (1945-1947)Lo strapotere economico degli USA ; il sistema monetario internazionale di Bretton Woods; il piano Marshalle la ricostruzione dell’Europa occidentale.La Guerra fredda (1947-1962): La formazione dei blocchi contrapposti; la Germania al centro della “guerrafredda” e la prima crisi di Berlino; la guerra di Corea; la corsa agli armamenti; guerra fredda e coesistenzapacifica: il XX congresso del PCUS; le crisi di Suez e di Ungheria; la transizione verso la distensione ( laseconda crisi di Berlino e la crisi di Cuba).
23) Decolonizzazione e Terzo mondo.
La prima decolonizzazione, in particolare: la nascita di Israele, l’indipendenza dell’India e dell’Indocina (dallaguerra contro i Francesi ella fine della guerra del Vietnam).La seconda decolonizzazione (in particolare la guerra d’Algeria e l’indipendenza del Congo).Il conflitto arabo-israeliano: dal '48 agli accordi di Camp David del 1978. Il Terzo Mondo sulla scena internazionale: il non allineamento; sviluppo e sottosviluppo 24) L’Italia dopo il '48
Egemonia democristiana e democrazia bloccata.Il centrismo e il programma di cauto riformismo.
28

FILOSOFIA
Docente: Gabriella PaganiniFINALITÀ’
1. Sollevarsi dal senso comune e addentrarsi con consapevolezza nella complessità del mondodell’uomo.
2. Imparare a giustificare con argomentazioni valide le proprie affermazioni.3. Acquisire strumenti per prendersi cura di sé e costruire autonomi stili di vita e autonome “verità”
sul senso dell’esistere.
OBIETTIVI
1. Conoscere gli elementi di fondo dei diversi stili di pensiero dei filosofi affrontati2. Saper leggere un testo filosofico e seguire le argomentazioni nel loro svolgimento, cogliendone i
nessi3. Adoperare correttamente termini e concetti filosofici in relazione ai contesti a cui si riferiscono4. Saper confrontare diverse posizioni filosofiche in relazione a singoli problemi
METODOLOGIA DIDATTICA
Strumenti usati: lezione frontale e lezione dialogata; video; lettura e commento in classe di testi antologicirelativi alle opere degli autori studiati. Il programma è stato affrontato adottando una combinazione tradisposizione cronologica e tematica; all’interno dei moduli diacronici il pensiero dei singoli filosofi è statoinserito nel contesto storico-culturale di appartenenza.
VERIFICHEColloqui per accertare la padronanza complessiva della materia; domande scritte a risposta aperta etrattazioni sintetiche di argomenti circoscritti. Elementi da accertare, nell’ordine: la conoscenza del pensierodei filosofi affrontati, la capacità di confrontare le varie risposte ad uno stesso problema, la capacità distrutturare il discorso in modo logico e argomentato e l'uso del linguaggio specifico.
PROGRAMMA SVOLTO
I. KANT: La Critica della ragion pratica: l’etica dell’intenzione. Imperativo categorico e postulati della ragion pratica.La Critica del giudizio: giudizio determinante e giudizio riflettente; giudizio teleologico ed estetico, il bello eil sublime.
IDEALISMO E CRISI DEL KANTISMOIl dibattito sulla “cosa in sé” kantiana: cenni essenziali.L'idealismo soggettivo di Fiche e l'idealismo oggettivo di Schelling, visti nella prospettiva hegeliana.F. HEGEL: vita, opere e contesto storico-culturaleIl periodo di Jena e la Fenomenologia dello spirito: il senso dell’opera e la sua la struttura; Coscienza eAutocoscienza.La dialetticaDalla Fenomenologia al “sistema”: l’Enciclopedia delle scienze filosofiche in compendioLa Scienza della logica: caratteri generaliLa filosofia della natura: caratteri generaliLa filosofia dello spirito: cenni sullo spirito soggettivo; lo spirito oggettivo e la sua articolazione dialettica;l’eticità e la sua articolazione dialettica; lo spirito assoluto e la sua articolazione dialettica.
29

LA DISSOLUZIONE DELL’HEGELISMO NELLA SOCIETA’ INDUSTRIALE
IL MATERIALISMO POST-HEGELIANOFEUERBACH: la critica ad Hegel e l’essenza della religioneK. MARX: vita, opere e contesto storico-culturaleIl rovesciamento della filosofia hegelianaI Manoscritti economico-filosofici del ’44: la critica all’economia classica e il concetto di alienazioneIl materialismo storico: struttura, sovrastruttura, ideologia.Il metodo dell’analisi economica: Il capitale. I concetti di merce, pluslavoro e plusvalore, profitto
IL MATERIALISMO POSITIVISTICOCaratteri generali del PositivismoA. COMTE: vita, opere e contesto storico-culturale La legge dei tre stati La classificazione delle scienze. La sociologiaJ. S. MILLOn liberty: analisi dei concetti principale dell’opera (la libertà, i limiti del potere dello Stato, l’importanzadell’individuo, la tirannia dell’opinione pubblica, lo Stato e l’educazione).
Approfondimento: filosofia, scienze della natura e scienze storico-socialiBERGSONFilosofia e scienzaIl tempo e la durataMemoria, coscienza, inconscioIntelligenza e intuizioneIL CIRCOLO DI VIENNA I protagonisti e il programma: criteri di demarcazione tra metafisica e scienza, il criterio di significanza.Il principio di verificazione e il problema delle proposizioni universali.K. POPPERContro la logica induttivaIl criterio di falsificabilitàScienze e pseudoscienzeM. WEBERIl problema del senso dell’attività scientifica.Le scienze storico-sociali: relazione al valore e avalutatività.Il carattere individuale della causa nella storia. I tipi ideali.Razionalizzazione e disincantamento del mondo. Il politeismo dei valori.Weber e il materialismo storico: etica calvinista e spirito del capitalismo.ESISTENZA CONTRO ESSENZAKIERKEGAARD: vita e opereLa polemica di un solitario contro Hegel La dialettica esistenziale e gli stadi della vitaPossibilità, angoscia, disperazione e fede.
L’IRRAZIONALISMO E IL PENSIERO NEGATIVOA. SCHOPENHAUER: vita e opereIl mondo come rappresentazione e il mondo come volontàLa quadruplice radice del principio di ragion sufficiente.La volontà cosmica e il dolore del vivere
30

La conoscenza della volontà attraverso l’arteLa liberazione dalla volontà: compassione e ascesiF. NIETZSCHE: vita, opere e contesto storico-culturaleUna filosofia antisistematicaPessimismo greco, estetica e ricerca della verità: La nascita della tragediaLa storia e il presente: storia monumentale, antiquaria, criticaLa filosofia come scuola di sospetto: il periodo “illuminista”; la scienza e lo “spirito libero”.I valori come “sintomi” della vita: le origini della morale; i concetti di bene e male.Il cristianesimo e la morale del risentimento. Morale dei signori e morale degli schiavi.La morte di Dio e l’avvento del superuomo: nichilismo passivo e nichilismo attivo; la trasvalutazione deivalori; la filosofia di Zarathustra.Volontà di potenza ed eterno ritornoS. FREUD E LA PSICOANALISI La nascita della psicoanalisi La scoperta dell’inconscio Sogno e nevrosi La teoria della sessualità e la struttura della psiche. Il complesso di Edipo tra psicologia e antropologiaPrincipio di piacere e principio di realtà: il disagio della civiltà
Ogni alunno ha letto integralmente uno dei seguenti testi proposti:
H. Arendt, La banalità del male, FeltrinelliK. Jaspers, La questione della colpa, Raffaello Cortina editoreE. Traverso, A ferro e fuoco. La guerra civile europea 1914-1945, Il MulinoE. Traverso, Il passato: istruzioni per l'uso, Ombre corteN. Revelli, Le due guerre, EinaudiF. Fanon, I dannati della terra, EinaudiJ. Stuart Mill On liberty, Il SaggiatoreW. Sheridan Allen, Come si diventa nazisti, EinaudiM. Weber, La scienza come professione, MondadoriM, Weber, La politica come professione, MondadoriH. Jonas, Il concetto di Dio dopo Auschwitz, Il MelangoloH. Arendt, La banalità del male, FeltrinelliA. Gibelli, L’officina della guerra, Bollati BoringhieriJ. Stuart Mill On liberty, Il SaggiatoreM, Weber, La politica come professione, MondadoriM, Weber, La scienza come professione, Mondadori
Testi adottati: STORIA: GIARDINA, SABBATUCCI, VIDOTTO MONDI DELLA STORIA, VOLL. II-III, LATERZA SCOLASTICA FILOSOFIA: GUIDETTI, MATTEUCCI, LE GRAMMATICHE DEL PENSIERO, VOLL. II–III, ZANICHELLI
31

MATEMATICA
Docente: Enrica Maragliano
OBIETTIVI
Conoscenza del concetto di funzione e delle caratteristiche principali di una funzione (monotonia,periodicità, simmetrie rispetto all’asse y o all’origine, asintoti verticali, orizzontali ed obliqui,invertibilità) Capacità di determinare campo di esistenza e segno di una funzione Conoscenza del concetto di limite, di infinito, di infinitesimo Conoscenza del concetto di derivata come limite del rapporto incrementale, delle regole diderivazione, delle condizioni per stabilire la crescenza e della decrescenza di una funzione e di quelleper conoscerne la concavità e della convessità Capacità di manipolazione formale di funzioni usando le regole studiate Capacità di studiare funzioni razionali intere e fratte, e semplici funzioni irrazionali e trascendenti Competenza nell'uso del lessico specifico Capacità di utilizzare le conoscenze specifiche della disciplina in ambiti differenti che ne faccianouso
Tali obiettivi sono stati raggiunti da quasi tutti gli studenti e le studentesse, alcuni dei quali hanno ottenutorisultati estremamente apprezzabili.
METODI-MEZZI-STRUMENTI DI VALUTAZIONE
Gli argomenti, esposti e trattati con lezione frontale e talvolta con l’utilizzo da parte della docente disupporti multimediali, sono stati oggetto di verifiche orali e scritte nonché di una simulazione della terzaprova d'esame. Tali prove sono state valutate seguendo gli orientamenti del POF e le indicazioni concordatedurante le riunioni del gruppo disciplinare.Il libro di testo in adozione è:Bergamini, Trifone, Barozzi – Matematica.azzurro vol. 5S – Zanichelli.Tutte le volte che è stato possibile, infine, sono stati messi in evidenza i legami interdisciplinari della Matematica conaltre discipline sia scientifiche (Fisica in particolare) sia umanistiche (Storia, Filosofia).
OSSERVAZIONI SULLA CLASSE
La classe ha mostrato partecipazione attiva e costruttiva verso la disciplina ed i risultati finali ottenuti sonostati globalmente apprezzabili, confermando l'interesse e l'impegno con cui gli studenti hanno seguito ilcorso di studi, non solo nell'ultimo anno, ma durante tutto il ciclo di studi.Il programma è stato svolto in modo completo secondo quanto concordato in sede di gruppo disciplinare.Nell'ultima parte dell'anno scolastico si è preferito consolidare i concetti già affrontati in modo dapermettere a tutti una migliore assimilazione dei contenuti.Nel corso sono stati svolti 5 moduli di lezione settimanale da 50 minuti ciascuno di Matematica e Fisica,scegliendo se utilizzare il modulo aggiuntivo su una disciplina o l'altra in base alle esigenze didattiche.
32

LISTA DEI CONTENUTI
Modulo 1: Le funzioni e le loro proprietà
Ripasso su definizione e classificazione di funzioni, funzioni iniettive, suriettive e biiettive, funzioni crescenti e decrescenti, periodiche, pari e dispari, composte e inverse.Passi iniziali per lo studio di funzione:
dominio simmetrie ed eventuale periodicità intersezione con gli assi segno
Modulo 2: I limiti ed il calcolo dei limiti
Intervalli. Intorni di un punto. Intorni di infinito.Definizione di limite finito di una funzione in un punto e significato geometrico. Verifica di limiti finiti di funzioni in un punto.Limite destro e limite sinistro.Limite infinito di una funzione in un punto. Verifica di limiti infiniti di funzioni in un punto. Asintoti verticali.
Limite finito di una funzione per x che tende ad ∞ . Asintoti orizzontali.
Limite infinito di una funzione per x che tende ad ∞ .Teorema dell'unicità del limite.Teorema della permanenza del segno.Teorema del confronto.Operazioni sui limiti: somma, differenza, prodotto, potenza, funzione reciproca, quoziente.
Forme indeterminate: + ∞ - ∞ , 0⋅∞ , ∞∞ ,
00 .
Limiti notevoli:
senxx=1 ¿
(con dimostrazione)
1−cosxx
=0 ¿ (con dimostrazione)
1−cosx
x2=
12¿
(con dimostrazione)
(1+ 1x)x
=ex ¿(senza dimostrazione)
ln (1+x )x
=1 ¿(senza dimostrazione)
ex−1x
=1¿(senza dimostrazione)
Infiniti ed infinitesimi: definizione, confronto di infiniti ed infinitesimi simultanei. Esempi applicativi. Definizione di funzione continua in un punto e in un intervallo. Esempi di funzione continue. Continuità a destra ed a sinistra. Continuità della funzione composta.Definizione di punto di massimo e minimo assoluto e relativo di una funzione.Teorema di Weierstrass (enunciato): applicazione, esempi e controesempi .Teorema di esistenza degli zeri (enunciato).Teorema dei valori intermedi (enunciato).Punti di discontinuità di una funzione: classificazione.Asintoti: ricerca di asintoti orizzontali e verticali. Asintoti obliqui e loro ricerca.Grafico probabile di una funzione.
33

Modulo 3: La derivata di una funzione
Introduzione al concetto di derivata e suo significato geometrico. Rapporto incrementale.Derivata di una funzione costante, di una funzione lineare e di una funzione quadratica.Derivata destra e sinistra.Funzioni non derivabili in un punto. Punti di non derivabilità: flessi a tangente verticale, cuspidi e punti angolosi.
Calcolo delle derivate di funzioni notevoli (in particolare xn ,ax,e x ,ax ,lnx,loga x,senx,cosx
)Punti stazionari. Ricerca della equazione della tangente ad una funzione in un punto.Regole di derivazione (funzione per costante, somma, prodotto, reciproco, quoziente).Derivata della funzione composta.Cenni alla derivata della funzione inversa.Derivate di ordine superiore al primo.Applicazioni delle derivate alla Fisica (velocità, intensità di corrente elettrica).Teorema di Lagrange (enunciato) e corollari.Teorema di Rolle (enunciato).Teorema di De l'Hospital (enunciato).
Modulo 4: Lo studio di funzione
Funzioni crescenti e decrescenti e derivate: teorema del valore della derivata prima per funzioni crescenti o decrescenti (enunciato).Esempi di funzioni crescenti e decrescenti e calcolo degli intervalli di crescenza e decrescenza.Punti di massimo e minimo assoluto e relativo. Punti stazionari e derivata prima.Ricerca di punti di massimo e minimo di funzioni (per funzioni ovunque derivabili) con la derivata prima.Concavità (definizioni ed interpretazione geometrica).Flessi e studio del segno della derivata seconda.Lo studio di funzione: dall’equazione di una funzione alle sue caratteristiche e al suo grafico.Studio di funzioni polinomiali, razionali fratte, irrazionali. Esempi di studio di funzioni trascendenti (esponenziali, logaritmiche, goniometriche).
FISICA
Docente: Enrica Maragliano
OBIETTIVI
Conoscenza delle leggi fondamentali che spiegano i fenomeni fisici elettromagnetici, delle grandezzefondamentali dell'elettromagnetismo e delle loro unità di misura, della costante dielettrica del vuoto,della costante di permeabilità magnetica nel vuoto
Capacità nella manipolazione formale delle formule Competenza nell’uso del lessico specificoTali obiettivi sono stati raggiunti da quasi tutti gli studenti e le studentesse, alcuni dei quali hanno ottenutorisultati estremamente apprezzabili.
METODO-MEZZI-STRUMENTI
Gli argomenti, trattati prevalentemente mediante lezioni frontali, sono stati oggetto di verifiche orali escritte e 1 simulazione di terza prova d'esame. Tali prove sono state valutate seguendo gli orientamenti delPOF e le indicazioni concordate durante le riunioni del gruppo disciplinare.Quando possibile sono stati usati filmati che illustrassero i concetti e le esperienze che hanno confermato le
34

teorie che ne hanno permesso la scoperta e la definizione.Il libro di testo in adozione è: C.Romeni – Fisica: i concetti, le leggi, la storia – Elettromagnetismo, Relativitàe quanti – Zanichelli. Sono stati, inoltre, distribuiti appunti integrazione del libro, usati soprattutto per laparte relativa allo studio del magnetismo.Tutte le volte che è stato possibile, infine, sono stati messi in evidenza i legami interdisciplinari della Fisica con altrediscipline sia scientifiche (Matematica) sia umanistiche (Storia, Filosofia).
OSSERVAZIONI SULLA CLASSE
La classe ha mostrato interesse e partecipazione attivi e costruttivi verso la disciplina ed i risultati finaliottenuti sono stati globalmente apprezzabili, confermando l'interesse e l'impegno con cui gli studenti haseguito il corso di studi, non solo nell'ultimo anno, ma durante tutto il triennio.Il programma è stato svolto in modo completo in base a quanto concordato a livello di gruppo disciplinare.Nell'ultima parte dell'anno scolastico si è preferito consolidare i concetti già affrontati in modo dapermettere a tutti una migliore assimilazione dei contenuti.Nel corso sono stati svolti 5 moduli di lezione settimanale da 50 minuti ciascuno di Matematica e Fisica,scegliendo se utilizzare il modulo aggiuntivo su una disciplina o l'altra in base alle esigenze didattiche.
LISTA DEI CONTENUTI
(in riferimento al libro di testo e agli appunti distribuiti)
Modulo 1: Forze elettriche e campi elettriciMetodi di elettrizzazione.Polarizzazione.Legge di Coulomb: forza elettrica e analogie con la forza gravitazionale.Principio di sovrapposizione. Conservazione della carica elettrica.Forza elettrica nei dielettrici.Definizione di campo elettrico. Campo elettrico generato da più cariche. Linee di forza per il campo elettrico generato da una carica puntiforme, da un conduttore cavo carico, da un dipolo elettrico.Condensatori. Condensatori piani e loro caratteristiche (andamento del campo elettrico all'interno e sul bordo).Campo elettrico all'interno di un conduttore all'equilibrio elettrostatico.Potere dispersivo delle punte. Parafulmini.Teorema di Gauss per il campo elettrico, sue implicazioni, sua generalizzazione.
Modulo 2: Energia potenziale elettrica e potenziale elettrico
L'energia potenziale elettrica: definizione ed analogie con l'energia potenziale gravitazionale. Lavoro e variazione di energia potenziale elettrica. Energia potenziale di un sistema di cariche.Potenziale elettrico e differenza di potenziale. Teorema di Gauss e superfici equipotenziali. Linee di forza e superfici equipotenziali.Differenza di potenziale in un condensatore piano.Derivazione del campo elettrico dal potenziale.Circuitazione del campo elettrico.Condensatori: definizione di capacità di un condensatore, capacità di un condensatore piano, capacità di condensatori in serie ed in parallelo. Energia immagazzinata in un condensatore.
Modulo 3: Circuiti elettrici
Introduzione ai circuiti elettrici (conduzione elettrica nei metalli, componenti di un circuito).Definizione di corrente elettrica. Velocità di deriva e moto di agitazione termica. Unità di misura della corrente elettrica.
35

Generatore. Forza elettromotrice.Resistenza elettrica. I e II legge di Ohm. Resistività dei materiali. Dipendenza della resistività dalla temperatura. Superconduttori.Potenza. Energia termica dissipata per effetto Joule. Resistori in serie e in parallelo. Resistenza interna di un generatore.Leggi di Kirchhoff.
Modulo 4: Interazioni magnetiche e campo magnetico
Introduzione al campo magnetico. Esperienza di Oersted. Esperienza di Ampère. Caratteristiche dei magneti. Analogie e differenze fra campo magnetico e campo elettrico. Campo magnetico terrestre.Campo magnetico uniforme.Campo magnetico generato da un filo percorso da corrente.Definizione operativa di Ampere e Coulomb.Intensità del campo magnetico. Forza magnetica che agisce su un filo percorso da corrente.Legge di Biot-Savart.Unità di misura del campo magnetico.Valore del campo magnetico al centro di una spira e all'interno di un solenoide percorsi da corrente: considerazioni qualitative.Regole della mano destra (filo percorso da corrente e spira percorsa da corrente).Teorema di Gauss per il magnetismo.Teorema di Ampère e sue conseguenze.Forza di Lorentz: grandezze coinvolte, confronto con la forza del campo magnetico su un filo percorso da corrente, moto di una particella carica che entra in un campo magnetico con velocità costante e perpendicolare al campo.Spettrometro di massa (con selettore di velocità).Momento magnetico (definizione). Costante di permeabilità magnetica relativa. Modello dell'atomo come spira percorsa da corrente. Campo magnetico indotto. Sostanze diamagnetiche, paramagnetiche, ferromagnetiche. Domini di Weiss.
Modulo 5: Induzione elettromagnetica
Induzione magnetica.Legge di Faraday-Neumann-Lenz.Legge di Lenz e conservazione dell'energia.Autoinduzione.Alternatore e corrente alternata.
Induttanza di un solenoide. Corrente alternata e f.e.m. che varia secondo la legge f (t )=f 0 senωt . Potenza ed effetto Joule nel caso della corrente alternata. Corrente efficace e f.e.m. efficace.
Modulo 6: Le equazioni di Maxwell e le onde elettromagnetiche
Equazioni di Maxwell nel caso di E e B variabili nel tempo. Dimostrazione dell'equivalenza fra circuitazione diE e f.e.m. indotta. Teorema di Ampère generalizzato. Corrente di spostamento.Le onde elettromagnetiche. Il profilo spaziale dell’onda. La propagazione delle onde elettromagnetiche e la loro variazione in funzione del tempo.Lo spettro elettromagnetico.Polarizzazione di onde elettromagnetiche.
36

LINGUA E LETTERATURA INGLESELINGUA E LETTERATURA INGLESE
Docente: Alma Faucci
OBIETTIVI AFFETTIVIFavorire un atteggiamento di interesse per l’apprendimento della LINGUA2 e di motivazione ad usare questalingua, ricercandone possibili occasioni.Sviluppare interesse per la cultura e civiltà di un altro popolo e, quindi, di apertura e tolleranza verso aspettidiversi dalla nostra cultura.
OBIETTIVI SPECIFICI DEL LICEOComprendere e reagire con naturalezza ad un messaggio orale.Cogliere le informazioni di un testo scritto o un messaggio orale.Rispondere a domande scritte od orali relative a testi proposti.Dedurre informazioni date in modo non esplicito.Narrare in modo coerente sia sul piano grammaticale che su quello logico,Esporre da diversi punti di vista.Scrivere in modo grammaticalmente e ortograficamente corretto.Familiarizzare con alcune microlingue, prima fra tutte quella relativa alla storia, alla cultura e allaletteratura.Comprendere ed analizzare il contenuto di brani letterari di vario genere e di diverse epoche.Contestualizzare un brano in relazione al periodo storico, stilistico e all’autore di appartenenza.Esporre contenuti studiati in inglese.Utilizzare per lo studio e l’approfondimento di altre discipline nozioni ricavate da testi in lingua.
CRITERI, METODOLOGIE E STRUMENTI DIDATTICIIl lavoro scolastico è stato interamente dedicato allo studio della lingua attraverso lo studio letterario,privilegiando l’aspetto testuale rispetto a quello strettamente nozionistico.Si è affrontato lo studio della letteratura inglese con un approccio cronologico prospettando, in primo luogo,il panorama dei principali avvenimenti storici e culturali e, infine, i movimenti letterari delineandone lecaratteristiche generali.In tale contesto sono stati inseriti i singoli autori di cui sono state individuate le tematiche, l’apporto datoallo sviluppo della letteratura e i collegamenti con altri autori e, ove possibile, con altre discipline. L’analisidei testi letterari si è svolta in classe attraverso un’ampia gamma di esercizi. Gli studenti sono stati stimolatia discutere le tematiche presenti nelle varie opere, a confrontarle con quelle del loro tempo e a trarreconclusioni personali.Per quanto riguarda la vita e la produzione letteraria complessiva di ogni autore, si è fatto soprattuttoriferimento a quegli eventi e a quei dettagli che hanno avuto un’influenza significativa sul pensierodell’autore.Gli eventi storici del periodo preso in esame sono stati svolti in modo sintetico, concentrando l’attenzionesugli avvenimenti particolarmente rilevanti per i testi letterari analizzati.Il libro di testo è stato integrato, ove necessario, con fotocopie. L’uso della lingua inglese è statopredominante in qualsiasi attività, al fine di consolidare la competenza linguistica degli alunni.
STRUMENTI DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONESi sono svolte regolari verifiche scritte e interrogazioni orali formulate sul modello delle prove dell’Esame diStato. Nelle verifiche scritte si sono proposti quesiti a risposte aperte relativi agli argomenti di letteraturasvolti e simulazioni di terza prova condotte in concomitanza con altre discipline.Nelle verifiche scritte e nelle simulazioni di terza prova è stato consentito l’uso del dizionario monolingue.Nelle prove orali si sono svolti colloqui sugli argomenti di letteratura trattati.
37

Per la valutazione delle prove si è tenuto conto della conoscenza degli argomenti e della rielaborazionepersonale, della correttezza formale e della competenza linguistica, della pertinenza e adesione alla tracciae della scelta dei contenuti.La valutazione dell’orale ha tenuto conto dei seguenti fattori: espressione linguistica (correttezzagrammaticale e sintattica, pronuncia, impiego di un lessico adeguato), della conoscenza e completezza deicontenuti e della capacità di rielaborazione critica.La valutazione finale ha tenuto conto non soltanto del profitto conseguito, ma anche delle seguenticomponenti: partecipazione degli studenti al dialogo educativo, percorso individuale intrapreso nelprocesso di apprendimento, assiduità nello studio degli argomenti trattati.
OBIETTIVI REALIZZATIGli obiettivi prefissati sono stati globalmente raggiunti da tutti gli alunni della classe, seppure in manieradifferenziata. Alcuni alunni hanno mostrato durante l’anno qualche incertezza espositiva, evidentesoprattutto nella lingua scritta, ma hanno cercato di superarla mostrando impegno e volontà di migliorare ilprofitto.Un altro gruppo ha, invece, evidenziato una buona padronanza della lingua abbinata a capacità critiche, ilche ha permesso loro di conseguire ottimi risultati.Libro di testo: “Performer Heritage” Vol 2.From the Victorian age to the present ageDi Spiazzi - Tavella – Layton (Zanichelli Editore)
NODO A. THE VICTORIAN AGESocial and historical backgroundThe Nineteenth centuryTHE VICTORIAN NOVEL- Charles DickensFrom “Hard Times”:
- Coketown pag. 49-50 - The definition of a horse PhotocopyFrom “A Christmas Carol” - Scrooge’s Christmas PhotocopyFrom “Oliver Twist”: - Oliver wants some more pag. 42-43 - Robert Louis Stevenson From “The Strange Case of Dr. Jekyll and Mr Hyde”
- Jekyll’s Experiment pag. 115-116THE AESTHETIC MOVEMENT- Oscar Wilde From ”The Importance of Being Earnest”
- The interview pag. 137-138 From “The Picture of Dorian Gray”:
- The preface pag. 127- Dorian's death pag. 131-133
NODO B. THE MODERN AGESocial and historical background.The Twentieth century.The WAR POETS - Rupert Brooke: “The Soldier” pag. 189 - Wilfred Owen: “Dulce et Decorum Est” pag. 191 - Isaac Rosenberg: “Break of Day in the Trenches” photocopy - Siegfried Sassoon: “Glory of Women” pag. 193
38

MODERN FICTION- James JoyceFrom “Dubliners”
- Eveline pag. 253-255From The Dead: “Gabriel’s epiphany” pag. 257-258- Virginia Woolf
- Orlando (only plot) photocopyFrom “Mrs Dalloway”:
- Clarissa and Septimus pag. 268-269- Clarissa’s party pag. 271-272
- George OrwellFrom “Animal Farm”:
- The Execution photocopyFrom “Nineteen Eighty-Four”:
- Big Brother is watching you pag. 278-279MODERN POETRY-Thomas Stearns EliotFrom “The Waste Land”:
- The Burial of the Dead pag. 206THE THEATRE OF THE ABSURD- Samuel BeckettFrom “Waiting for Godot”:
- Waiting pag. 377
Visione dei film:- “A Christmas Carol ”- “The Importance of Being Earnest”- “The picture of Dorian Gray”
Lettura integrale di:- “Animal farm” di George Orwell
39

SCIENZE
Docente: Romanella Moriconi
Libro di testo: Helena Curtis, N. Sue Barnes, Invito alla biologia, voll. A e B, ZANICHELLI.
PRESENTAZIONE GENERALE DELLA CLASSEHo assunto la titolarità della cattedra di scienze a partire dal primo anno di liceo, in prima abbiamo affrontato lo studio delle scienze della terra, in seconda e in terza quello della chimica e negli ultimi due anni quello della biologia. Il tempo a disposizione è sempre stato di due moduli da 50 minuti tranne in seconda dove i moduli erano tre. Nel corso degli anni gli allievi si sono mostrati, in generale, curiosi, piuttosto interessati alla disciplina e molto attenti durante le lezioni, con partecipazione attiva al dialogo disciplinare. L'approccio allo studio individuale, per quanto ovviamente diversificato per i singoli alunni, è stato generalmente positivo e costante. Si è evidenziata la presenza di situazioni di eccellenza o di livello medio-alto, che hanno confermato quanto già era emerso lungo i cinque anni di liceo. Qualche carenza si è manifestata per alcuni, nella gestione e nella restituzione delle informazioni apprese a causa di uno studio non sempre puntuale e adeguato.In generale, l'impegno nello studio ha permesso a quasi tutti gli allievi di ottenere nel complesso esiti positivi e, per alcuni, anche decisamente soddisfacenti.
LISTA OBIETTIVI FORMATIVI GENERALI
attivazione negli allievi di adeguato spirito motivazionale attraverso la scelta di opportuni contenuti acquisizione di metodologie di studio e di lavoro adeguate alla scuola superiore, di un linguaggio
semplice, chiaro e contemporaneamente rigoroso, di capacità di analisi e di sintesi. capacità di correlare nozioni tra materie
OBIETTIVI FORMATIVI SPECIFICI DELLE SCIENZE applicazione del metodo induttivo e del metodo deduttivo capacità di osservare, porre problemi, formulare ipotesi capacità di discriminare tra osservazioni, fatti, teorie capacità di utilizzare, costruire modelli, riconoscere i limiti dei modelli attivazione negli allievi del rispetto per le diverse forme di vita attraverso la comprensione dei
rapporti tra organismi ed il ruolo unico dell’uomo, rispetto per l’individuo, le comunità e l’ambiente collocazione dei saperi biologici nell’insieme dei problemi umani sviluppo di sensibilità per le implicazioni etiche, filosofiche, politiche della biologia.
OBIETTIVI FORMATIVI SPECIFICI DELLA BIOLOGIA sviluppare concetti fondamentali quali:
il carattere sistemico dei fenomeni biologici la complessità e “modularità” dei fenomeni biologici
sviluppare abilità fondamentali orientate alla: ricostruzione storica dei fenomeni costruzione delle conoscenze su base empirica scomposizione dei sistemi complessi per isolare e controllare le variabili che li influenzano ricostruzione dei sistemi in termini di processi.
PERCORSO FORMATIVOL’itinerario didattico è partito dalla rivisitazione del “dogma centrale” della biologia in modo più analitico (NODO A), è poi proseguito con lo studio dell’anatomia e della fisiologia dei principali apparati umani (NODO B). Nel corso del primo trimestre ho svolto 18 moduli con metodologia CLIL che hanno riguardato la scoperta del DNA e la definizione della sua struttura da parte di Watson e Crick. L’esposizione dei contenuti
40

ha utilizzato testi originali, riassunti, filmati e presentazioni in PP, intervallati da discussioni tra gli studenti. METODI- MEZZI- STRUMENTI
Lezione frontale e dialogata con uso di materiali multimediali e diapositive elaborate dal docente Lettura di fonti primarie (abstract e papers), testi e video in inglese Discussioni in classe
VERIFICA E VALUTAZIONELa valutazione degli allievi ha utilizzato gli indicatori presenti nel PTOF e allegati alla parte generale del documento del consiglio di classe.Le tecniche di verifica utilizzate sono state:
Interrogazioni orali Prove scritte semi - strutturate simulazioni di terza prova
NODO A – il dogma centrale
Dogma centralecontenuti obiettiviIl DNA: modello di Watson e Crick
Timeline of DNA : Miescher and “nuclein”: use of pus from bandages; Griffith’s experiment :smooth strain bacteria pneumoniae and rough strain bacteria .Levene’s work, Chargaff’s ratio From protein to DNA: Hershey and Chase : viruses confirm DNA as the genetic material; Reading the abstract Readings: Molecular structure of nucleic acids: Nature, April 25, 1953, Final Task: The students are expected to give a well-documented, effective and maximum 5 minutes speaking about the scientists’ discoveries. They also are expected to write a short essay- 140,190 words- about DNA discovering.
Duplicazione del DNA illustrare il meccanismo di duplicazione e il ruolo degli enzimi coinvolti spiegare il significato dei frammenti di Okazaki comprendere il ruolo dei telomeri spiegare il meccanismo della PCR
Gli RNA distinguere tra DNA e RNA distinguere struttura e funzioni tra RNAm, RNAt e RNAr
Trascrizione spiegare il processo
Codice genetico spiegare significato di codone e legarlo al numero corretto di basi descrivere e spiegare l’esperimento di Niremberg e Matthaei comprendere la ridondanza e l’universalità del codice genetico
Traduzione descrivere il meccanismo della sintesi proteica nelle sue fasi di inizio, allungamento e termine nei procarioti
collegare la struttura del RNAt alla sua funzione
Mutazioni spiegare perché uno scambio di basi può causare malattia(caso anemia falciforme) definire una mutazione puntiforme distinguendo tra delezione, inversione e inserzione distinguere tra mutazione di senso non senso e silente
Il DNA negli eucarioti distinguere tra eucromatina ed eterocromatina distinguere tra introni ed esoni spiegare il meccanismo di maturazione del RNAm negli eucarioti descrivere l’azione dei virus a DNA e a RNA
NODO B – ANATOMIA E FISIOLOGIA
I sistemi muscolare e scheletricoContenuti obiettivi
I tessuti del corpoa. Elencare le diverse tipologie di tessuto epiteliale specificandone le rispettive funzionib. Spiegare la funzione della matrice extracellulare del tessuto connettivoc. Elencare i principali tipi di tessuto connettivo descrivendone le funzioni e differenziandoli tra lorod. Distinguere tra muscolo liscio, striato e cardiaco, mettendo ogni tipo di muscolo in relazione alla sua efficienza
e al tipo di controlloe. Descrivere la struttura di un neurone
41

f. Elencare le diverse tipologie di neuroni
Il sistema muscolarea. Distinguere tra tendini e legamenti specificando le loro rispettive funzionib. Descrivere la struttura delle fibre del muscolo scheletrico, spiegando le varie parti che costituiscono un
sarcomeroc. Spiegare il processo della contrazione muscolare, esplicitando il consumo di ATP e il ruolo dello ione Ca++
d. Descrivere il sistema di comunicazione tra cellula nervosa e fibra muscolare
Il sistema scheletricoa. Descrivere la struttura dello scheletro umano distinguendo tra assile e appendicolare posizionando
correttamente i nomi delle principali ossab. Spiegare le differenze strutturali tra le ossa lunghe, piatte e brevic. spiegare la struttura dell’osteone e distinguere tra osteoclasti osteoblasti e osteociti
Il sistema circolatorioContenuti Obiettivi
Il sistema circolatorioa. Elencare le parti costitutive del sistema cardiovascolareb. Distinguere tra circolazione sistemica e polmonarec. distinguere tra vasi
Il sanguea. Distinguere i costituenti del sangueb. Spiegare la funzione del plasma, elencare le sostanze in esso disciolte associandole alla funzionec. Descrivere i globuli rossi e mettere in relazione la loro funzione con il sistema respiratoriod. descrivere e spiegare la funzione dei globuli bianchie. individuare gli eventi che partecipano alla coagulazione del sangue
I vasi sanguignia. Descrivere la struttura e la funzione di arterie, vene e capillarib. Spiegare come avvengono, a livello dei capillari, gli scambi delle sostanze utili alle cellule e dei rifiuti metabolicic. Descrivere le principali malattie che colpiscono i vasi sanguigni
Il cuorea. Descrivere la struttura del cuore umano usando la terminologia specificab. Descrivere il ciclo cardiaco evidenziando il ruolo delle valvole durante la diastole e la sistolec. Spiegare le modalità di propagazione dello stimolo che provoca la contrazione delle cavità cardiached. Descrivere le principali malattie che riguardano il cuore e la frequenza del suo battito
Il sistema endocrinoContenuti ObiettiviI due sistemi di comunicazione
a. Individuare analogie e differenze tra il controllo nervoso e quello endocrinob. Spiegare perché si può far riferimento a un unico sistema neuroendocrino
Anatomia e fisiologia del sistema endocrino
a. Distinguere tra ghiandola esocrina ed endocrinab. Descrivere la funzione e le vie di comunicazione del sistema endocrinoc. Spiegare le categorie di ormoni e le due modalità di ingresso nelle celluled. Spiegare il meccanismo di controllo
L’ipofisia. Distinguere tra adenoipofisi e neuroipofisi e tra ormoni ipotalamici e ipofisarib. Descrivere l’azione dell’ormone della crescita e le patologie a esso associate ,spiegare la funzione della
prolattina e il suo meccanismo di controllo, spiegare la funzione degli ormoni tropici e il loro ruolo di regolazione, rilevare ruolo endorfine
c. spiegare il ruolo di ossitocina e vasopressinaL’ipotalamo a. Spiegare che cosa sono i fattori di rilascio ipotalamici e quale funzione svolgono
b. Mettere in relazione le funzioni dell’ipotalamo con quelle dell’ipofisi
La tiroide e le paratiroidi
a. Individuare la particolarità dell’ormone tiroxinab. Comprendere le funzioni della calcitonina e dell’ormone paratiroideo e spiegare come interagisconod. Descrivere gli effetti di ipo e ipertiroidismo
Le ghiandole surrenalia. Distinguere tra corticale surrenale e midollare surrenaleb. Spiegare la funzione del cortisolo mettendola in relazione alle richieste dell’organismoc. Mettere in relazione la secrezione di aldosterone sia con l’escrezione di acqua sia con il controllo della
pressione arteriosae. Descrivere le funzioni delle catecolamine
Il pancreasa. Spiegare la struttura e la funzione del pancreasb. Spiegare il meccanismo di regolazione della glicemiac. Distinguere tra diabete insipido e diabete mellitod. Comprendere la differenza tra le cause del diabete mellito di tipo I e quelle del diabete di tipo II
La ghiandola pineale a. Analizzare come varia la produzione di melatonina nel corso della giornata
42

b. Mettere in relazione gli effetti della melatonina con il sonno e descriverne l’influenza sulla regolazione dei ritmi circadiani
Prostaglandine a. Evidenziare le differenze rispetto agli ormonia. Spiegarne gli effetti sulla muscolatura liscia
Gonadia. Distinguere tra ormoni maschili e femminilib. spiegare ruolo e regolazione testosteronec. Descrivere il meccanismo d’azione di estrogeni e progesterone e distinguere tra ciclo ovarico e uterino
Il sistema nervosoContenuti Obiettivi
Struttura del sistema nervoso
a. Distinguere tra sistema nervoso centrale e periferico, tra somatico e autonomo, tra simpatico e parasimpaticob. Descrivere la funzione dei diversi tipi di neuronic. Spiegare la funzione delle cellule gliali, distinguere i gangli dai nucleid. Distinguere tra sostanza bianca e sostanza grigiag. Spiegare la struttura e la funzione dell’arco riflessoh. Comprendere le differenze funzionali tra sistema nervoso somatico e sistema nervoso autonomoi. Comprendere le differenze strutturali e funzionali tra sistema nervoso autonomo simpatico e sistema nervoso
autonomo parasimpatico
L’impulso nervosoa. Descrivere l’impulso nervoso come un potenziale elettricob. Descrivere le situazioni statiche e dinamiche che permettono il mantenimento delle concentrazioni ioniche
caratteristiche dell’assone in stato di riposoc. Spiegare il significato di soglia e di periodo refrattariod. Spiegare le variazioni ioniche che inducono la polarizzazione e la depolarizzazione della membrana assonicae. Individuare il ruolo dell’iperpolarizzazione
La sinapsia. Spiegare la modalità di trasmissione dell’impulso in una sinapsi elettricab. Analizzare le fasi della trasmissione sinapticac. Distinguere tra sinapsi eccitatorie e inibitoried. Spiegare le funzioni dei vari neurotrasmettitori e dei neuromediatori, nonché la loro specificità e modalità
d’azionee. Elencare i principali tipi di psicofarmaci associando ciascuno di essi alle modalità d’azione
L’encefaloa. descrivere le parti che costituiscono l’encefalo e la funzione delle meningib. localizzare e spiegare talamo e ipotalamoc. distinguere le diverse funzioni del tronco cerebrale e del cervellettod. descrivere la struttura dei due emisferi, evidenziando lobi e solchi, corteccia sensoriale e motoria e aree del linguaggiof. descrivere le principali patologie a carico del sistema nervoso(SLA, Parkinson, encefalopatie spongiformi, Alzheimer, autismo)
La percezione sensoriale
a. acquisire informazioni sulle diverse tipologie dei recettori sensorialib. comprendere le dinamiche di percezione del gusto e dell’olfattoc. comprendere la struttura anatomica dell’occhio e il meccanismo di messa a fuoco, distinguere tra coni e bastoncellid. comprendere come le onde sonore siano trasformate in impulsi nervosi , descrivere l’anatomia dell’orecchio e distinguere le funzioni tra orecchio esterno, medio e interno.f. Distinguere tra udito ed equilibrio
Il sistema riproduttore
Contenuti Obiettivi
Il sistema riproduttore maschile
a. Descrivere la struttura dei testicoli mettendola in relazione con la spermatogenesib. Elencare le ghiandole annesse al sistema riproduttore maschile descrivendone anche le relative funzionic. Seguire il percorso di formazione dello sperma associando ai vari tratti le modificazioni che esso subisced. Mettere in relazione la spermatogenesi con gli ormoni che la regolanoe. Mettere in relazione la produzione degli ormoni testicolari con la liberazione di ormoni ipofisari
Il sistema riproduttore femminile
a. Elencare, descrivendole, la diverse parti del sistema riproduttore femminileb. Seguire il percorso dell’oocita nel caso di una mancata fecondazionec. Mettere in relazione la struttura dell’utero con la sua funzioned. Mettere in relazione l’oogenesi con gli ormoni che la regolanoe. Mettere in relazione la produzione degli ormoni ovarici con la liberazione di ormoni ipofisari e con le
modificazioni che si verificano a livello follicolare e uterinoLe malattiea trasmissione sessuale
a. Descrivere le diverse malattie a trasmissione sessuale, distinguendo tra quelle batteriche e quelle viralib. Spiegare le conseguenze delle diverse malattie a trasmissione sessuale e le possibili cure
43

Lista contenutiNODO ADogma centrale: identificazione del DNA, risultati di Miescher, esperimento di Griffith, ipotesi di Levene, esperimento di Hershey e Chase, risultati di Chargaff, contributi di Pauling e Franklin, sintesi e modello di Watson e Crick; duplicazione del DNA e ruolo degli enzimi coinvolti (polimerasi, elicasi, girasi, primasi, ligasi), proofreading, frammenti di Okazaki e telomeri, Mullis e la PCR, struttura RNA, trascrizione del DNA, codice genetico, esperienza di Matthaei e Nirenberg, degenerazione del codice, sintesi proteica, struttura RNAt, traduzione:inizio, allungamento e fine, mutazioni puntiformi(di senso, non senso, silenti) introni ed esoni,eu ed eterocromatina, maturazione RNAm con splicing, virus a DNA e a RNA.
NODO BOrganizzazione corporea mammiferi, il tessuto epiteliale, i tessuti connettivi, il tessuto osseo, osteone, sistema scheletrico, formazione osso, tessuto muscolare: liscio, striato e cardiaco, unità funzionale: sarcomero, meccanismo di contrazione, ruolo Ca++troponina e tropomiosina, placca neuromuscolare, tessuto nervoso, struttura del neurone e tipi di neuroni.Sistema circolatorio: evoluzione del sistema cardiovascolare, le due circolazioni, il sangue(parte liquida e parte corpuscolare), i vasi sanguigni e la loro struttura, patologie dei vasi(aneurisma, varici) struttura del cuore (anatomia e fisiologia) pressione sanguigna.Sistema endocrino: meccanismo d’azione degli ormoni (recettori intracellulari e di membrana) e loro natura chimica, meccanismo di regolazione del sistema, ipotalamo, ipofisi, tiroide e paratiroidi, surrene, pancreas, epifisi, prostaglandine, gonadi.Sistema nervoso: divisioni del sistema, SNC (encefalo e midollo) SNP, arco riflesso, sistema nervoso somaticoe autonomo, simpatico e parasimpatico, natura dell’impulso nervoso, potenziale a riposo, potenziale d’azione e propagazione, ruolo della guaina mielinica, sinapsi elettriche e chimiche, neurotrasmettitori e loro azione, cenni a farmaci e droghe che influenzano i neurotrasmettitori, suddivisioni dell’encefalo: prosencefalo (diencefalo e telencefalo), mesencefalo e romboencefalo, le meningi, corteccia cerebrale e suesuddivisioni, area di Broca e di Wernicke, cenni alle patologie neurodegenerative e disturbi mentali. Apparato sensoriale: meccanocettori, chemiocettori, fotocettori, termocettori, nucicettori. Recettori del gusto, olfatto, anatomia occhio e visione, udito e equilibrio.Sistema riproduttore: anatomia dell’apparato maschile, percorso degli spermatozoi, ormoni maschili e loro ruolo, principali malattie a carico dell’apparato, anatomia dell’apparato femminile, ciclo ovarico e uterino, malattie a trasmissione sessuale(clamidia, gonorrea, papilloma virus, herpes genitale, sifilide, candida, AIDS).
44

STORIA DELL’ARTEDocente: Luisa Cavallaro
Fisionomia della classeIl percorso di Storia dell’Arte è cominciato a partire dal secondo biennio fino al quinto anno, con due moduli settimanali. Nonostante il monte ore esiguo la maggior parte degli studenti si è mostrata molto interessata alla disciplina, con partecipazione e impegno costante nello studio. In particolare alcuni alunni si sono distinti per un’attitudine specifica, raggiungendo livelli di eccellenza. Nell’a.s. 2016/2017 la classe ha partecipato a un progetto di Alternanza Scuola Lavoro relativo proprio alla Storia dell’Arte, con studio, catalogazione e presentazione al pubblico della Collezione Durazzo di Palazzo Reale a Genova, ricostruita nella facies originaria comprendente anche i pezzi attualmente nelle collezioni sabaude di Torino. In questo ambito gli studenti hanno mostrato ottime capacità e grande disponibilità in tutte le fasi del lavoro, suscitando vivo apprezzamento da parte di tutor esterni, docenti e pubblico.
ObiettiviConoscenze: - movimenti artistici e personalità di spicco dei secoli XIX e inizi XX secolo.Competenze/capacità:- conoscere e riconoscere le principali tecniche artistiche;- uso corretto di un linguaggio tecnico specifico per la descrizione del testo figurativo;- lettura e decodificazione di un testo figurativo conosciuto (I liv.) ;- individuazione delle coordinate storico culturali dell'opera d'arte;- percezione dei nessi interdisciplinari ;- lettura e decodificazione di un testo figurativo non conosciuto ma all'interno di un ambito storico culturalegià affrontato (II liv.);
Metodi e strumentiLezione frontale dell'insegnante, discussione guidata, con riferimento costante alla lettura dell'immagine e al suo contesto storico d'origine ; è stato spesso proposto il confronto diretto dell'opera d'arte con altri testi figurativi per evidenziare i differenti caratteri stilistici. Il manuale è stato integrato da altri testi, talora anche specialistici, sia per quanto riguarda i contenuti, sia per l'apparato figurativo; per quanto riguarda le immagini, inoltre, si sono usati anche mezzi audiovisivi, in particolare CD rom, DVD o immagini scaricate da siti web.
Strumenti di verifica e valutazioneColloqui orali, esercitazioni scritte (in entrambi i casi è stata richiesta un'analisi del testo figurativo e la sua ricollocazione nel quadro storico culturale d'appartenenza); simulazione di terze prove.Nella valutazione si è tenuto conto della progressione nell'apprendimento e della serietà del lavoro personale.Requisiti per il livello di sufficienza:a) conoscenza completa - anche se non sicura - dei contenuti, unita a capacità di lettura e decodificazione del testo figurativo già noto con possesso di un lessico tecnico adeguato;b) capacità di individuare le coordinate storico-culturali dell'opera d'arte già nota.Il livello andrà via via elevandosi qualora si rafforzino i requisiti sopra citati e ad essi si aggiunga:
- capacità di orientarsi in modo autonomo e critico entro il panorama storico-culturale dell'opera d'arte, con riferimenti puntuali ad altri ambiti disciplinari;
- capacità di lettura, decodificazione e inserimento nel relativo quadro storico culturale di opere d'arte sconosciute al candidato (sempre appartenenti ad un ambito storico-artistico già affrontato).
45

Contenuti e programma svolto
- Il Romanticismola pittura in Inghilterra (J.H. Füssli, W. Blake, J. Constable, W.Turner);la pittura in Germania (C.D. Friedrich);la pittura in Francia (T. Géricault, E. Delacroix);
- Il Romanticismo in Italia (panoramica)F. Hayezla Scapigliatura lombarda.
- Il Realismola scuola di Barbizon, C. Corot, J.F. Millet;H. Daumier, G. Courbet
- Riflessi del Realismo in EuropaItalia: i MacchiaioliInghilterra: i Preraffaelliti
- L'Impressionismoun anticipatore: E. Manet;i pittori del gruppo impressionista (C. Monet, A. Renoir ; E. Degas ; A. Sisley ; C. Pissarro)architettura strutturalista;il Neoimpressionismo (G. Seurat ; P. Signac)
- Figure dell'area post impressionistaP. Cézanne; V. Van Gogh
- Il Simbolismo e il clima simbolista in EuropaG. Moreau; O. RedonE. Munch
- Il Divisionismo italianoSegantini, Previati, Pellizza da Volpedo
- Le avanguardie storichel'Espressionismo (i Fauves; Die Brücke)il Cubismoil Futurismo
- Picasso (dagli anni giovanili a Guernica)
- L'astrattismoDer Blaue Reiter
Libro di testoG.NIFOSI', L'arte svelata, Ottocento, Novecento, XXI secolo, vol. 3, editori Laterza
46

SCIENZE MOTORIE
Docente: Maurizio Busana
Quest’anno l’attività di Scienze Motorie era stata programmata prevedendo un’ora di teoria ed un’ora di pratica allasettimana. L’ora di teoria principalmente verteva su argomenti inerenti all’alimentazione, per una migliorconsapevolezza della salute, ogni alunno ha presentato una relazione in merito con eventuale coinvolgimento dellaclasse. Sono stati elaborati concetti sviluppati negli ultimi tre anni.
Conoscenza e pratica delle Attività Sportive
Lista dei CONTENUTI:1) Conoscenza dello “Spirito” dell’attività pratica svolta.2) Conoscenza delle regole principali di almeno due giochi sportivi scelti.3) Conoscenza gestuale sportiva.4) Difesa ad uomo e a zona.5) Conoscenza del fitwalking, del nordic walking e del trekking.6) Conoscenza del badminton e tennistavolo.7) Conoscenza delle principali specialità dell’atletica leggera.8) Conoscenza del pattinaggio su ghiaccio.9) Conoscenza e concetti dello “Spirito” del Tai Chi, conoscere i concetti di yin e yiang, conoscere il significato del Dan
Tian, conoscere “I Cinque Tibetani”.10) Conoscenza delle Qualità Motorie (principalmente da che strutture anatomiche dipendono, come si allenano o
addestrano, e come si “testano” (da pag. 123 a pag. 161 del libro di testo).11) Differenza tra allenamento ed addestramento.12) Accenni sull’effetto del movimento e dell’allenamento sul corpo umano.13) Accenni sull’effetto del non movimento.14) Accenni anatomici su articolazioni, apparato cardio-circolatorio e respiratorio.15) Accenni sul sistema nervoso.16) Conoscenza della struttura muscolare e dell’Unità Motrice (da pag. 72 a pag. 83 del libro di testo).17) Conoscenza delle tipologie di contrazione: isometrica, concentrica, eccentrica, pliometrica.18) Conoscenza del significato: muscolo agonista, antagonista, fissatore, sinergico.19) Meccanismi bioenergetici: aerobico, anaerobico alattacido, anaerobico lattacido (da pag. 74 a pag. 76 del libro di
testo).
Lista delle PRESTAZIONI attese:1) Saper riconoscere i diversi ruoli di squadra di due sport.2) Riuscire a “marcare” ed a “smarcarsi” (in difesa: mettere in “ombra” l’avversario rispetto alla palla, e in attacco
mettersi in “luce”).3) Saper identificare le varie situazioni di gioco.4) Saper praticare un ruolo di sport di squadra.5) Saper praticare il nordic walking, il fitwalking e trekking.7) Saper praticare il badminton ed il tennistavolo.8) Saper riconoscere i fondamentali individuali di due sport.9) Saper impostare un lavoro sui fondamentali.10) Saper eseguire dei test sulle Qualità Motorie.11) Saper riconoscere le Qualità Motorie peculiari della disciplina sportiva conosciuta.12) Saper organizzare un lavoro sul miglioramento delle Qualità Motorie.13) Saper arbitrare una partita di almeno due attività sportive.14) Saper praticare “I Cinque Tibetani” e dei movimenti propedeutici al Tai Chi.
47

Tutela della Salute prevenzione degli infortuni
Lista dei CONTENUTI: 20) Accenni sull’apparato cardio-circolatorio e respiratorio (da pag. 56 a pag.65, e da pag. 66 a pag.71 del libro di
testo).21) Anatomia del torace con punti di “repere” (processo xifoideo dello sterno).22) Primo soccorso all’arresto dell’apparato cardiorespiratorio (da pag. 78 a pag. 80 del libro di testo).18) Anatomia dei polsi arteriosi: (brachiale, carotideo, sternale, inguinale).23) Fisiologia: conoscere la frequenza cardiaca nei vari stadi della crescita, conoscere la frequenza degli atti respiratori in un minuto.24) Effetti del movimento nella tutela della salute.25) Stretching tre teorie: da “freddo”, dopo il riscaldamento, con la facilitazione propriocettiva neuromuscolare.26) Concetto di “Educazione permanente”.27) Accenni sull’importanza di una sana alimentazione (da pag. 352 a pag. 383 del libro di testo).28) Concetto di “Educazione dinamica” (da pag. 8 a pag. 10 del libro di testo).29) Doping (da pag. 399 a pag. 402 del libro di testo).30) Conoscere i principali “Dimorfismi” e “Paramorfismi” e loro differenziazione (da pag. 37 a pag. 38 del libro di
testo).Lista delle PRESTAZIONI attese:15) Saper distinguere un accidentato tra: svenuto, asfittico, sincopato.16) Saper sistemare l’accidentato in modo adeguato.17) Sapersi muovere con sicurezza nelle manovre di ricerca dei punti anatomici di “repere”.18) Saper eseguire le manovre di massaggio cardiaco e di respirazione artificiale in modo efficace.19) Saper eseguire correttamente le 3 teorie dello Stretching, svolte durante il corso degli studi.20) Saper impostare una attività aerobica valida a compensare un quadro di deterioramento psicofisico connesso ad
un lavoro “sedentario”.21) Saper individuare le norme alimentari più salutari.22) Saper individuare quando l’assunzione di sostanze può essere considerato “Doping”.23) Saper eseguire gli esami morfologici per individuare una probabile situazione: di scoliosi, di dorso curvo, di
iperlordosi lombare, di scapole alate, di piede piatto.
Attività Espressive
Lista dei CONTENUTI:31) Classificazione dei vari tipi di linguaggio (motorio, verbale, grafico, visivo, musicale).32) Componenti del linguaggio motorio: atteggiamento, gestualità, mimica, movimento.33) La gestualità codificata sportiva.34) Il linguaggio non verbale negli sport di squadra.35) Conoscenza tra ballo e danza.Lista delle PRESTAZIONI:24) Saper identificare i vari tipi di linguaggio.25) Saper riconoscere i vari aspetti del linguaggio motorio: l’atteggiamento, la gestualità, la mimica.26) Saper riconoscere i significati dei gesti sportivi codificati.27) Saper decifrare ed eseguire il linguaggio sportivo non codificato.28) Saper eseguire un riscaldamento a tempo di musica.
METODOLOGIEIl lavoro e stato svolto in modo soprattutto propositivo e non direttivo, con metodi deduttivi, induttivi e misti.
VALUTAZIONELa valutazione si è basata soprattutto sulla osservazione sistematica durante tutto il lavoro svolto, su l’esposizione di una ricerca personale in merito all’alimentazione, nonché su l’atteggiamento tenuto dagli allievi, verso la materia, nel corso degli studi. Libro di Testo: In perfetto equilibrio; di P.L. Del Nista, J. Parker, A. Tasselli; editrice G. D’Anna.
48