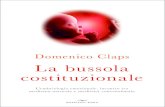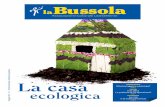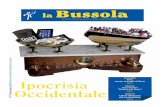DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE - ipsiarenzofrau.gov.it · • La Legge naturale iscritta nel...
Transcript of DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE - ipsiarenzofrau.gov.it · • La Legge naturale iscritta nel...
DOCUMENTO DEL
CONSIGLIO DI CLASSE
A. S. 2016-2017
CLASSE 5°
Manutenzione ed assistenza tecnica opzione
apparati, impianti e servizi tecnici industriali e civili
sede di San Ginesio
Documento del 15 maggio 5º MAT 1
1) Presentazione della classe pag. 02
2) Situazione della classe pag. 03
3) Candidati esterni pag. 04
4) Programmazione degli obiettivi pag. 04
5) Programmazione disciplinare pag. 06
• Matematica pag. 07
• Insegnamento della Religione cattolica pag. 08
• Lingua e letteratura italiana pag. 09
• Storia pag. 11
• Lingua e cultura inglese pag. 12
• Scienze motorie e sportive pag. 13
• Laboratori tecnologici ed esercitazioni pag. 14
• Tecnologie e tecniche di installazione e manutenzione pag. 15
• Tecnologie meccaniche e applicazioni pag. 16
• Tecnologie elettrico-elettroniche e applicazioni pag. 17
6) Area professionalizzante pag. 18
7) Valutazione pag. 20
7.1) Valutazione durante l’anno pag. 22
7.2) Prospetto di valutazione della prima prova scritta pag. 24
7.3) Prospetto di valutazione della seconda prova scritta pag. 25
7.4) Prospetto di valutazione della terza prova scritta pag. 26
7.5) Tabella conversione punteggio grezzo in voto in 15/esimi pag. 27
7.6) Prospetto di valutazione del colloquio pag. 28
8) Simulazione prove scritte pag. 30
9) Tesine pag. 37
10) Attività integrative alla didattica svolte nel biennio post-qualifica pag. 38
11) Consiglio di classe pag. 39
Appendice A: testi simulazione prima prova
Appendice B: testi simulazione seconda prova
INDICE
Documento del 15 maggio 5º MAT 2
GLI ALUNNI
1 Cardinali Lorenzo
2 De Paolis Luca
3 Marani Martino
4 Morè Manolo
5 Nori Michael
6 Pesaresi Luca
7 Porfiri Cristian
8 Tardella Luigi
9 Virgili Matteo
I DOCENTI: AREA COMUNE
Docente Materia Continuità didattica triennio
Sauro Contratti Matematica 3º, 4º e 5º anno
Marcello Lambertucci Religione 3º, 4º e 5º anno
Sandro Princiotta Storia 5º anno
Sandro Princiotta Lingua e lettaratura italiana 5º anno
Lisa Soravito Lingua e cultura inglese 5º anno
Claudio Eleuteri Scienze motorie e sportive 5º anno
Maria Luisa Petracci Sostegno 5º anno
Matteo Polci Sostegno 3º, 4º e 5º anno
I DOCENTI: AREA PROFESSIONALE
Docente Materia Continuità didattica triennio
Aldo Biondi Laboratorio tecnologico ed esercitazioni
4º e 5º anno
Paolo Giuseppe Marchetti I.T.P. Aldo Biondi
Tecnologie e tecniche di installazione e manutenzione
4° e 5º
Paolo Giuseppe Marchetti I.T.P. Aldo Biondi
Tecnologia meccanica ed applicazioni 4° e 5º
Pucci Vittorio I.T.P. Ciabocco Francesco
Tecnologie elettrico- elettroniche e applicazioni 3º, 4º e 5º anno
1. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE
Documento del 15 maggio 5º MAT 3
La classe quinta indirizzo manutenzione ed assistenza tecnica è composta da nove alunni,
che hanno seguito le materie di area comune insieme ai sette alunni dell’indirizzo arredo e
forniture di interni, costituendo pertanto una classe articolata. La classe ha accresciuto nel
corso degli anni scolastici la propria coesione, conseguendo buoni rapporti interpersonali.
Dal punto di vista del comportamento, nel complesso gli alunni hanno instaurato un
rapporto abbastanza sereno e corretto con i docenti ma la classe presenta un
atteggiamento non sempre accettabile e dimostra di possedere desiderio di
apprendimento appena sufficiente. L’impegno domestico è modesto e deve essere
migliorato. Per quanto attiene al profitto, solo alcuni elementi si sono distinti per interesse,
attitudine ed applicazione ottenendo buoni risultati, mentre per il resto della classe la
valutazione può comunque ritenersi sufficiente, con conseguente acquisizione degli
obiettivi cognitivi minimi stabiliti dal consiglio di classe. E’ emerso per questi ultimi un
senso di responsabilità ancora non completamente maturato, come dimostrato dalla
frequenza saltuaria delle lezioni, dalle entrate in ritardo e dalle numerose assenze.
Evidenti sono anche le carenze riconducibili a lacune pregresse. Per quanto attiene le
attività svolte in laboratorio, gli alunni hanno dimostrato maggior interesse ed applicazione
rispetto al lavoro che li ha coinvolti da un punto di vista teorico. Va segnalato come nel
corrente anno scolastico i continui trasferimenti di sede (ben tre), l'inagibilità dell'officina
meccanica prima e l'indisponibilità di spazi idonei poi, hanno reso quasi impossibile
svolgere le esercitazioni pratiche in officina meccanica. Relativamente all’alternanza
scuola lavoro gli alunni hanno partecipato durante il quinto anno agli stages aziendali per
due settimane maturando nell’ultimo triennio un totale di 320 ore. I risultati conseguiti sono
stati di buon livello.
Si rimanda agli allegati del presente documento
2. SITUAZIONE DELLA CLASSE
ALUNNI CON DIFFERENTI ABILITÀ’
Documento del 15 maggio 5º MAT 4
Non presenti
OBIETTIVI EDUCATIVI
Rispetto delle persone X
Rispetto dell'ambiente X
Conoscenza del Regolamento scolastico X
Partecipazione attiva e responsabile all'attività scolastica X
Rispetto della puntualità X
Rispetto della disciplina X
Rispetto della precisione X
Saper lavorare individualmente ed in gruppo X
Saper riconoscere le situazioni di rischio per se e per gli altri X
Saper accrescere la propria responsabilità ed individualità X
OBIETTIVI DIDATTICI
Potenziamento del lessico X
Riconoscere termini e concetti chiave X
Prendere appunti in modo chiaro e corretto X
Studiare in modo autonomo X
Schematizzare problemi e situazioni usando un linguaggio scientifico X
Lavorare individualmente ed in gruppo X
3. CANDIDATI ESTERNI
4. PROGRAMMAZIONE DEGLI OBIETTIVI
Documento del 15 maggio 5º MAT 5
Acquisire un metodo di studio personale e proficuo X
Fare collegamenti interdisciplinari X
Sviluppo di capacità logiche e di sintesi X
Acquisizione di linguaggi specifici X
Possedere con sicurezza le principali tematiche culturali e tecnico-scientifiche X
Sapersi orientare di fronte a nuove situazioni problematiche e proporne le soluzioni X
Saper rielaborare le conoscenze con un apporto personale X
Saper esporre con proprietà, correttezza e coerenza logica sia negli elaborati scritti
che nelle comunicazioni orali X
Saper formulare giudizi e valutazioni X
Saper applicare le conoscenze acquisite X
STRATEGIE
Dedicare maggior attenzione agli alunni più carenti X
Controllo dei compiti X
Stimolo alla lettura X
Controllo continuo del comportamento corretto a scuola X
Stimolo ad una esposizione corretta sia nel contenuto che nella forma X
Predisposizione dei percorsi didattici di avvicinamento alla maturità X
Proficuo contatto con le famiglie X
Documento del 15 maggio 5º MAT 6
Seguono le schede compilate dai singoli docenti relative alla programmazione disciplinare.
5. PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE
Documento del 15 maggio 5º MAT 7
MATEMATICA
Docente Prof. Sauro Contratti
Libro di testo Nuova matematica a colori vol. 4, Sasso, Ed. Pedrini
CONTENUTI DISCIPLINARI SVILUPPATI
DISEQUAZIONI
• Disequazioni di 1° grado . • Disequazioni di 2° grado . • Sistemi di disequazioni. • Disequazioni fratte .
LE FUNZIONI
• Concetto di funzione. • Classificazione delle funzioni . • Campo di esistenza o dominio delle funzioni. • Calcolo del dominio di funzioni razionali , irrazionali ,
esponenziali . • Funzioni crescenti , decrescenti , costanti , periodiche. • Funzioni pari e dispari. • Grafico delle funzioni elementari e dominio :costante , retta
, parabola, seno , coseno , tangente
LIMITI E CONTINUITA'
• Concetto di limite di una funzione. • Limite finito per una funzione in un punto, limite infinito per
una funzione in un punto,limite finito per x che tende all’infinito , limite infinito per x che tende all’infinito
• Limite destro e sinistro in un punto. • Calcolo dei limiti delle funzioni razionali intere e fratte. • Forme indeterminate . • Definizione di asintoto. • Asintoti verticali ed orizzontali. • Grafico probabile di una funzione razionale fratta.
DERIVATE
• Derivata della funzione in un punto. • Derivate di alcune funzioni fondamentali . • Derivata della somma , del prodotto , del quoziente , della
potenza • Esempi di calcolo delle derivate. • Funzioni crescenti e decrescenti in un intervallo. • Calcolo di massimi e minimi assoluti e relativi. • Concavità , convessità . Punti di flesso.
Documento del 15 maggio 5º MAT 8
RELIGIONE CATTOLICA
Docente Prof. Marcello Lambertucci
Libro di testo “Tutti i colori della vita” Solinas, Sei
Ore di lezione 28/33
CONTENUTI DISCIPLINARI SVILUPPATI
MODULO 1
• La proposta cristiana (dei giusti e santi) di contrapporre all'odio e alla corruzione la logica dell'amore e del perdono.
• La crisi di senso e l'aumentare di devianze specie tra i giovani. • La Legge naturale iscritta nel nostro cuore come grande “bussola”
delle nostre scelte. • Giusto dialogo tra ragione e fede pur nella distinzione dei ruoli e degli
obiettivi
MODULO 2
• L'Idea di uomo formulata dalle religioni rivelate. • La centralità della persona e della famiglia come “luogo” voluto da
Cristo per rinnovare l'umanità. • Il valore autentico della sessualità oltre i luoghi comuni. • Le principali Encicliche sociali dei Pontefici.
MODULO 3
• La via della non violenza per la vera promozione dei popoli. • La prospettivi cristiana della vita eterna. • La risposta personale di vivere in conformità alla propria vocazione. • Il senso del vivere e il realizzarsi nel servizio, anche nelle situazioni
più difficili.
OBIETTIVI RAGGIUNTI
La classe si è mostrata impegnata in modo soddisfacente nella proposta formativa. Le tematiche avanzate, in particolare quelle di tipo morale e sociale, hanno trovato buona partecipazione.
METODOLOGIA
L’insegnamento della religione Cattolica proposto come dialogo sereno ed aperto, ha stimolato l’attenzione e l’interesse degli alunni, aiutandoli a riscoprire ciò che c’è di profondo nel messaggio cristiano come risposta ai problemi del realizzarsi nel vivere di ogni giorno.
STRUMENTI E SPAZI DI LAVORO
• Lezione frontale con uso del libro di testo “Tutti i colori della vita” Solinas, Sei.
• Dialogo aperto. • Sussidi audiovisivi. • Film:”Lo scafandro e la Farfalla” la sofferenza che non ferma l’uomo .
“Dio esiste e vive a Bruxelles” per recuperare il giusto senso del vivere e del morire.
STRUMENTI DI VALUTAZIONE ADOTTATI
• Attenzione; • Dialogo; • Riflessioni.
Documento del 15 maggio 5º MAT 9
LINGUA E LETTERATURA ITALIANA
Docente Prof. Sandro Princiotta
Libro di testo La letteratura ieri, oggi, domani. Vol. 3. Dall’Italia postunitaria al primo Novecento, G. BALDI, S. GIUSSO, M. RAZETTI, G. ZACCARIA, Paravia, Milano, 2016.
CONTENUTI DISCIPLINARI SVILUPPATI
Modulo 1 Giacomo Leopardi
• Vita, poetica e opere (elementi fondamentali) • Analisi dei testi “L’Infinito”, “A Silvia” (da Canti); “Dialogo della
Natura e di un islandese” (da Operette morali).
Modulo 2 I movimenti letterari
• Il Positivismo e il Naturalismo (elementi fondamentali). • Il Verismo (elementi fondamentali). • Il Simbolismo (elementi fondamentali). • Il Decadentismo europeo: analisi del brano di Charles Baudelaire
“L’albatro” (da I fiori del male)
Modulo 3 Il Verismo: Giovanni Verga
• Vita, poetica e opere (elementi fondamentali). • I romanzi I Malavoglia e Mastro don Gesualdo.
Analisi del testo “Rosso Malpelo” (da Vita dei campi)
Modulo 4 Il Decadentismo: Giovanni Pascoli
• Vita, poetica e opere (elementi fondamentali). • Analisi dei testi “X Agosto”, “L’assiuolo” (da Myricae),
“Gelsomino notturno” (da Canti di Castelvecchio). • Analisi del testo “Una poetica decadente” (da Il fanciullino, passi
scelti).
Modulo 5 Il Decadentismo: Gabriele d’Annunzio
- Vita, poetica e opere (elementi fondamentali). - Analisi del testo “La pioggia nel pineto” (da Alcyone).
Modulo 6 Le avanguardie
• Cenni storici sul Futurismo e le avanguardie. • Analisi del testo “Manifesto del Futurismo” di Filippo
Tommaso Marinetti.
Modulo 7 Italo Svevo
• Vita, poetica e opere (elementi fondamentali). • Analisi del testo “Il fumo” (da La coscienza di Zeno).
Modulo 8 Luigi Pirandello
• Vita, poetica e opere (elementi fondamentali) • La poetica pirandelliana: la maschera e l’umorismo. Analisi
del testo “Un’arte che scompone il reale” (da l’Umorismo, passi scelti).
• I romanzi: L’esclusa, Il fu Mattia Pascal, Uno nessuno centomila, I quaderni di Serafino Gubbio operatore.
• Le novelle: La giara, La patente, la carriola, La signora Frola e il signor Ponza, suo genero.
• Il teatro pirandelliano (cenni).
Documento del 15 maggio 5º MAT 10
• Analisi del testo “Viva la macchina, che meccanizza la vita!” (da Quaderni di Serafino Gubbio operatore).
Modulo 9 L’articolo di giornale e il saggio breve
• l linguaggio giornalistico. Le cinque W. La struttura di un articolo. Il titolo. L’articolo di cronaca. Testate e articoli a confronto. Lettura di quotidiani in classe.
• Il linguaggio del testo argomentativo. Le tecniche dell’argomentazione. La struttura di un testo argomentativo. I connettivi testuali. Lettura in classe di saggi e testi argomentativi.
Documento del 15 maggio 5º MAT 11
STORIA
Docente Prof. Sandro Princiotta
Libro di testo Il tempo e le cose, vol. 3, Storia dal Novecento ad oggi, M. MONTANARI, editori Laterza
CONTENUTI DISCIPLINARI SVILUPPATI
Modulo 1. L’unità d’Italia. Destra e Sinistra Storica.
- Caratteristiche ed eventi (elementi fondamentali) - I principali protagonisti.
Modulo 2. L’età giolittiana.
- Caratteristiche ed eventi (elementi fondamentali) - I principali protagonisti
Modulo 3. La grande guerra.
- Caratteristiche ed eventi (elementi fondamentali): le cause, le fasi della guerra, la conclusione
- I principali protagonisti.
Modulo 4. La rivoluzione russa.
- Caratteristiche ed eventi (elementi fondamentali) - I principali protagonisti.
Modulo 5. Tra le due guerre.
- Caratteristiche ed eventi (elementi fondamentali) - I principali protagonisti. - La crisi del ’29. - I totalitarismi: fascismo, nazismo, stalinismo.
Modulo 6. La seconda guerra mondiale.
- Caratteristiche ed eventi (elementi fondamentali): le cause, le fasi della guerra, la conclusione
- I principali protagonisti.
Modulo 7. Il secondo dopoguerra.
- Caratteristiche ed eventi (brevissimi cenni agli elementi fondamentali).
Documento del 15 maggio 5º MAT 12
INGLESE
Docente Prof.ssa Lisa Soravito
Libro di testo M. Cammareri , A. Dawson “LIVING ENGLISH”, Trevisini Editore; fotocopie fornite dalla docente.
CONTENUTI DISCIPLINARI SVILUPPATI
Modulo 1 • Simple present and present continuous • Presentperfect
• Pastsimple
• Future with to be going to
• Future with will
• The passive
Modulo 2: • The three states of matter
• Types of materials
• Properties of materials
• Machine tools
• The lathe
• Drillingmachines
- Grindingmachines
Modulo 3: • British institutions: Government / the Monarchy / Parliament / the Prime Minister
• The government of the USA: the Constitution / the President / Political parties and election of the President
• A land of democracy
Modulo 4: • The Social Networks • Defend the planet!
Modulo 5: • British inventors and inventions in the 20th century • Mechatronics
Documento del 15 maggio 5º MAT 13
SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE
Docente Prof. Claudio Eleuteri
CONTENUTI DISCIPLINARI SVILUPPATI
ATTIVITA’ PRATICA
Consolidamento e coordinamento Schemi Motori di bas e - Spostamenti liberi e guidati in uno spazio. - Esercitazioni di equilibrio statico e dinamico. - Giochi spontanei di rapidità e collaborazione con i compagni. Potenziamento fisiologico: - la resistenza generale: la corsa di durata e la frequenza cardiaca. - Il potenziamento a carico naturale: metodo delle serie e delle ripetizioni, il lavoro in circuito. - Il potenziamento con sovraccarico: principi metodologici e tecnica esecutiva, esercitazioni. - Allungamento muscolare e la mobilità articolare (esercizi vari). I giochi di squadra: - Pallavolo: i fondamentali individuali (tecnica esecutiva – esercitazioni); palleggio, bagher, servizio e schiacciata. Attività di gioco. - Pallacanestro: i fondamentali individuali, gare a staffetta di tiro - Calcio a 5 : i fondamentali individuali (tecnica esecutiva – esercitazioni); . Attività di gioco. Atletica leggera: - La velocità: la partenza, andature e prove sui 50 e 100 mt. - Il mezzofondo veloce: prove sui 500 mt. - I lanci: didattica e prove di getto del peso
ATTIVITA’ TEORICA
Nozioni di primo soccorso : - Come si presta il primo soccorso - Come trattare i traumi piu comuni - Le emergenze e le urgenze
Atletica Leggera - Le discipline cenni storici - La corsa su pista (velocità fondo e mezzofondo) - I lanci (peso, giavellotto, martello, disco) - I salti (salto in alto, salto in lungo, salto triplo, salto con l’asta - La marcia - Le attrezzature - I record del mondo e le specialità olimpiche
L’apparato scheletrico muscolare Ossa lunghe, corte, piatte. La struttura delle ossa: - tessuto osseo, - la cartilagine, - il midollo osseo. Come è fatto lo scheletro: - ossa della testa, del tronco, - la colonna vertebrale, mal di schiena e lombalgia, - ossa degli arti superiori, ossa degli arti inferiori. Paramorfismi e Dismorfismi.
Documento del 15 maggio 5º MAT 14
LABORATORI TECNOLOGI CI ED ESERCITAZIONI
Docente Prof. Aldo Biondi
CONTENUTI DISCIPLINARI SVILUPPATI
MODULO 1° Norme
antinfortunistiche
I concetti fondamentali della legislazione antinfortunistica. I rischi nell’ambiente di lavoro. La direttiva macchina
MODULO 2° METROLOGIA
Strumenti di controllo e di misura. Esercitazioni di misurazioni
MODULO 3° Montaggio e
smontaggio di impianti
termoidraulici
Leggere il disegno e istallare un impianto. Individuare il guasto intervenire in modo appropriato.
MODULO 4° Lavorazioni al
Tornio
Tornitura cilindrica esterna ed interna. Tornitura conica esterna ed interna. Tornitura piana. Filettatura: Metrica e Whitworth esterna ed interna. Realizzazione di accoppiamenti in tolleranza.
MODULO 5° Lavorazioni
alla fresatrice
Fresatrice orizzontale e verticale. Frese. Divisore universale.
MODULO 6° Lavorazioni al
trapano
Trapano a colonna. Esecuzione della foratura di un pezzo.
MODULO 7° Macchine
utensili CNC
Principi di funzionamento delle C. N. C. elementi di programmazione.
MODULO 8° Saldatura
• Procedimenti di saldatura, norme di sicurezza e controlli.
Documento del 15 maggio 5º MAT 15
TECNOLOGIE E TECNICHE DI INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE
Docente Prof. Paolo G. Marchetti – I.T.P. Prof. Aldo Biondi
Libro di testo Tecnologie e tecniche di installazione e manutenzione vol. 2 – A.A. V.V. – Ed. Hoepli
CONTENUTI DISCIPLINARI SVILUPPATI
Modulo 1: Metodi di manutenzione
• Metodi di manutenzione tradizionali • Metodi di manutenzione • Ingegneria della manutenzione • TPM (Total productivemaintenance)
Modulo 2: Ricerca e diagnosi dei guasti
• Classificazione dei guasti di un sistema • Criteri generali di ricerca guasti • Metodi di analisi delle informazioni • Prove non distruttive
Modulo 3: Affidabilità
• Definizione di affidabilità • Parametri fondamentali (MTBF, ecc.) • Disponibilità di un sistema • Criteri di classificazione dei guasti: • Tasso di guasto e probabilità di guasto • Affidabilità di un sistema: sistemi in serie e in parallelo • L'albero dei guasti (FTA) • Analisi di criticità (FMECA)
Modulo 4: Considerazioni economiche
• Valutazioni della qualità e dei costi • Tipi di costo • Costo di fermo macchina
Obiettivi raggiunti
La classe ha ottenuto mediamente un profitto discreto in merito agli obiettivi prefissati raggiungendo un livello di apprendimento medio. Solo alcuni studenti in grado di rielaborare in modo critico quanto appreso.
Metodologia Lezione frontale, lezione dialogata, esercitazioni, realizzazione di schemi
Strumenti e spazi di lavoro
Libro di testo, dispense fornite dal docente, materiale audiovisivo
Strumenti di valutazione adottati
Verifiche scritte a risposta aperta ed a risposta chiusa, esercizi, interrogazioni, risoluzione di problemi.
Documento del 15 maggio 5º MAT 16
TECNOLOGIE MECCANICHE E APPLICAZIONI
Docente Prof. Paolo Giuseppe Marchetti - ITP Prof. Aldo Biondi
Libro di testo Tecnologie meccaniche e applicazioni vol. 3 – Caligaris, Fava, Tomasello, Pivetta – Ed. Hoepli
CONTENUTI DISCIPLINARI SVILUPPATI
Modulo 1: la resistenza dei materiali
• La resistenza meccanica dei materiali • La prova di trazione • Esempi di prova di trazione su materiali di impiego comune
Modulo 2: le sollecitazioni semplici
• Tensione ammissibile e coefficiente di sicurezza • Trazione e compressione • Flessione • Taglio e torsione • Strutture sollecitate a fatica
Modulo 3: automazione pneumatica
• Impianti per la produzione di aria compressa (cenni) • Attuatori a semplice e doppio effetto • Distributori ad azionamento meccanico o pneumatico • Fine corsa ad azionamento meccanico o pneumatico • Automazione: circuiti di base • Segnali bloccanti: metodo a cascata
Modulo 4: automazione elettropneumatica
• Valvole e distributori a comando elettropneumatico • Semplici circuiti pneumatici a controllo elettrico
Obiettivi raggiunti La classe ha ottenuto mediamente un profitto discreto in merito agli obiettivi prefissati raggiungendo un livello di apprendimento medio. Solo alcuni studenti in grado di rielaborare in modo critico quanto appreso.
Metodologia Lezione frontale, lezione dialogata, esercitazioni, realizzazione di schemi
Strumenti e spazi di lavoro
Libro di testo, dispense fornite dal docente, materiale audiovisivo
Strumenti di valutazione adottati
Verifiche scritte a risposta aperta ed a risposta chiusa, esercizi, interrogazioni, risoluzione di problemi.
Documento del 15 maggio 5º MAT 17
TECNOLOGIE ELETTRICHE ELETTRONICHE E APPLICAZIONI
Docente Prof. Vittorio Pucci - ITP Prof. Francesco Ciabocco
CONTENUTI DISCIPLINARI SVILUPPATI
Modulo 1:Sicurezza elettrica
Sicurezza in laboratorio
Sicurezza negli impianti elettrici
Moduli 2: Amplificazione
Amplificatore operazionale
Parametri caratteristici degli amplificatori
Amplificatori in cascata
Amplificatore differenziale
Amplificatore Invertente
Amplificatore non invertente
Sommatore
Convertitore DAC Digitale Analogico
Modulo 3: Diodo Fisica dei semiconduttori
Diodo a giunzione
Principi di funzionamento
Caratteristica corrente-tensione
Circuiti equivalenti
Retta di carico e punti di lavoro
Modulo 4: Il Transistore BJT
Principi e zone di funzionamento
Caratteristica di ingresso, retta di carico e punto di lavoro
Caratteristica di uscita retta di carico e punto di lavoro
Transistore come interruttore analogico e digitale
Modulo 5: Impianti elettrici
Cenni sul dimensionamento degli impianti elettrici
Casi di studio:
Dimensionamento di un impianto elettrico di una unità immobiliare
Modulo 6: Impianti fotovoltaici
Cenni sul dimensionamento degli impianti fotovoltaici
Caso di studio:
Cenni sul dimensionamento dell’impianto fotovoltaico di una unità immobiliare
Modulo 7: Macchine elettriche
Cenni sui principi di funzionamento delle macchine elettriche
Documento del 15 maggio 5º MAT 18
Finalità formative La realizzazione dei percorsi in alternanza (art. 3, D.L.vo n. 77/05) è affidata a convenzioni
specifiche stipulate dalle istituzioni scolastiche o formative con «le imprese, o con le
rispettive associazioni di rappresentanza, o con le camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura, o con gli enti pubblici e privati, ivi inclusi quelli del terzo settore,
disponibili ad accogliere gli studenti per periodi di apprendimento in situazione lavorativa».
Possono comunque essere interpellati come partner anche le Università, gli enti locali, i
Musei, le associazioni no profit, le cooperative, studi professionali. Dette convenzioni
regolano «i rapporti e le responsabilità dei diversi soggetti coinvolti nei percorsi in
alternanza, ivi compresi gli aspetti relativi alla tutela della salute e della sicurezza dei
partecipanti».
Come deliberato dal collegio docenti si riportano di seguito le finalità formative del progetto
alternanza scuola-lavoro.
L’Ipsia “Renzo Frau” di Sarnano ha avuto in passato e ha tuttora in corso esperienze di
integrazione con il mondo del lavoro.
In collaborazione con le imprese e le associazioni di rappresentanza è stato elaborato, ai
sensi dell’art. 4 della Legge n°53/2003 il progetto di “Alternanza Scuola – Lavoro”.
Questo progetto si configura come un’attività formativa che tiene conto delle
trasformazioni in atto sia nel mondo della scuola sia in quello del lavoro e, coinvolgendo le
imprese nella formazione, offre allo studente una modalità che assicura, oltre alle
conoscenze di base, l’acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro.
Obiettivi
a) Obiettivi cognitivi:
• Verificare, ampliare, integrare le conoscenze apprese a scuola, in un contesto
operativo-produttivo;
• Apprendere nuovi dati, nuove procedure, nuovi linguaggi;
• Scoprire le regole generali che presiedono ad una struttura aziendale come sistema
organizzativo.
6. AREA PROFESSIONALIZZANTE
TIPOLOGIA: Progetto alternanza scuola lavoro
Documento del 15 maggio 5º MAT 19
b) Obiettivi operativi:
• Verificare le abilità acquisite a scuola in una realtà operativa diversamente
strutturata;
• Acquisire operatività e competenze specifiche.
c) Obiettivi educativo - formativi:
• Sapersi inserire in un diverso contesto in modo positivo ed attivo;
• Saper trovare un proprio spazio in una struttura organizzata, che è diversa rispetto
a quella scolastica;
• Migliorare le proprie capacità di relazione;
• Acquisire consapevolezza e rafforzare le motivazioni allo studio
Articolazione del progetto
Il progetto di alternanza scuola-lavoro ha visto i ragazzi coinvolti in stage aziendali, per un
impegno lavorativo pari a 320 ore nel triennio.
L’alunno Porfiri ha prolungato per ulteriori 4 settimane la convenzione con l’azienda
ospitante.
Tale traguardo è stato raggiunto nei tre anni scolastici 2014/2015, 2015/2016 e 2016/2017.
Per ogni anno scolastico gli alunni si sono recati per tre settimane consecutive presso
aziende del settore presenti nel territorio, salvo che per il quinto anno, in cui hanno
effettuato due settimane. Le ore programmate per lo stage sono state fino a 8 ore
giornaliere. Gli allievi, durante l’attività, erano regolarmente coperti da assicurazione
contro gli infortuni sul lavoro.
In questa esperienza lavorativa gli alunni sono stati seguiti da un tutor aziendale e da un
tutor scolastico responsabile del loro processo formativo.
Verifica del percorso
Al termine di ciascun anno è stato effettuato un monitoraggio al fine di valutare in termini di
apprendimento, di abilità e conoscenza i livelli raggiunti dai singoli allievi. I risultati
conseguiti sono stati di buon livello.
Documento del 15 maggio 5º MAT 20
La valutazione intesa come verifica delle ipotesi di lavoro, si è svolta durante il corso
dell’anno sia “in itinere” (valutazione formativa) per l’accertamento dei micro-obiettivi, che
in sede sommativa per controllare e misurare il grado di apprendimento dell’allievo in
relazione agli obiettivi predeterminati.
Il Consiglio di Classe ha ritenuto delineare in modo corretto i criteri di valutazione e/o
misurazione, dichiarandoli e facendoli conoscere agli studenti, non solo per una scelta di
trasparenza dell’azione didattica, ma anche e soprattutto per consentire ai fruitori di quella
azione un controllo dei propri apprendimenti ed una incentivazione dei meccanismi di
autovalutazione.
A seconda del tipo di prova sono stati utilizzati indicatori di valutazione differenziati che
riassumiamo qui di seguito.
Per leprove scritte sono stati utilizzati i seguenti indicatori:
• la correttezza e proprietà nell’uso della lingua
• l’aderenza alla traccia
• la conoscenza e l’approfondimento dei contenuti
• la coerenza interna
• la conoscenza lessicale (termini tecnici)
• la capacità di schematizzazione, anche grafica
• la capacità di risolvere semplici problemi
• la capacità di analisi e sintesi
• le capacità critiche
• l’originalità e creatività dei contenuti esposti
Per quanto riguarda le prove orali invece abbiamo:
• la proprietà logica e di linguaggio, anche tecnico
• la conoscenza e l’approfondimento dei contenuti
• la capacità di utilizzare i contenuti
• la capacità di collegamento interdisciplinare
7. VALUTAZIONE
INDICATORI DI VALUTAZIONE
Documento del 15 maggio 5º MAT 21
• la capacità di analisi e sintesi
Per quanto riguarda le prove pratiche gli indicatori utilizzati sono:
• la conoscenza e l’approfondimento dei contenuti
• l’originalità e creatività dei contenuti esposti
• la capacità di schematizzazione
• manualità, padronanza delle apparecchiature, orientamento in laboratorio
Scala di valutazione
Il Consiglio di Classe, in fase di programmazione iniziale, ha deciso di adottare per la
valutazione una scala in decimi, con la possibilità di arrotondamento alla prima cifra
decimale, mentre si è adottata la scala in 15.mi nelle simulazioni delle prove scritte
d’esame.
Documento del 15 maggio 5º MAT 22
Per la valutazione delle prove ci si è avvalsi della griglia di seguito riportata.
Nella valutazione in itinere è possibile usare anche il voto in decimi con arrotondamento
alla prima cifra decimale.
7.1 GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLE PROVE DURANTE L’ANNO SCOLASTICO
Documento del 15 maggio 5º MAT 23
Curva Giambò
X PercMax
Y Voto
Min. Suff. Max.
0,0 0,5 1,0
1,0 6,0
10,0
Documento del 15 maggio 5º MAT 24
7.2 PROSPETTO DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA SCRITTA
INDICATORI DESCRITTORI PESI LIVELLI PUNTEGGIO MAX
CONOSCENZE: correttezza nell’uso della lingua
• Correttezza ortografica • Correttezza morfosintattica • Proprietà e ricchezza lessicale
4 0-5 20
ABILITÀ: conoscenza e sviluppo dei concetti espressi nell’interazione orale e nella produzione scritta
• Coesione • Coerenza • Pertinenza • Padronanza dell’argomento • Ampiezza della trattazione.
3 0-5 15
COMPETENZE: capacità elaborative, logiche e critiche
Tipologia A
• Comprensione globale del testo
• Interpretazione analitica
• Capacità rielaborative e critiche
• Contestualizzazione
3 0-5 15 Tipologia B
• Rispetto dei vincoli comunicativi:
• Destinatario • Scopo • Collocazione • Estensione
• Capacità di utilizzare la documentazione.
• Comprensione • Selezione • Interpretazione
• Capacità di argomentazione
Tipologia C
• Pertinenza delle conoscenze
• Capacità di contestualizzazione
• Capacità di argomentazione
Tipologia D
• Significatività ed originalità delle idee
• Problematizzazione • Capacità critiche
Documento del 15 maggio 5º MAT 25
INDICATORI
CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE
Conoscenza dei contenuti disciplinari. Conoscenza dei termini tecnici.
Possesso delle abilità anche di carattere applicativo o di elaborazione grafica. Saper risolvere quesiti. Utilizzo termini tecnici.
Capacità elaborative logiche critiche.
LIVELLI INDICATORI
0 = Prestazione assolutamente nulla 0,5= prestazione quasi nulla 1 = Prestazione gravemente insufficiente 1,5= Prestazione insufficiente 2 = Prestazione scarsa 2,5= Prestazione mediocre
3 = Prestazione sufficiente 3,5 = Prestazione discreta 4 = Prestazione buona 4,5 = Prestazione ottima 5 = Prestazione eccellente
PESI INDICATORI
CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE
4 3 3
GRIGLIA DI VALUTAZIONE
INDICATORI CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE Punteggio grezzo massimo 100 punti
PESI 4 3 3 Punteggio grezzo totale
Percentuale punteggio
grezzo totale
Voto/15
DISCIPLINA
Alunno 1
Alunno 2
7.3 PROSPETTO DI VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA SCRITTA
Documento del 15 maggio 5º MAT 26
INDICATORI
CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE
Conoscenza dei contenuti disciplinari. Conoscenza dei termini tecnici.
Possesso delle abilità anche di carattere applicativo o di elaborazione grafica. Saper risolvere quesiti. Utilizzo termini tecnici.
Capacità elaborative logiche critiche.
LIVELLI INDICATORI
0 = Prestazione assolutamente nulla 0,5= prestazione quasi nulla 1 = Prestazione gravemente insufficiente 1,5= Prestazione insufficiente 2 = Prestazione scarsa 2,5= Prestazione mediocre
3 = Prestazione sufficiente 3,5 = Prestazione discreta 4 = Prestazione buona 4,5 = Prestazione ottima 5 = Prestazione eccellente
PESI INDICATORI
CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE
4 3 3
GRIGLIA DI VALUTAZIONE
INDICATORI CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE Punteggio grezzo massimo 100 punti
PESI 4 3 3 Punteggio grezzo totale
Percentuale punteggio
grezzo totale
Voto/15
DISCIPLINA
Alunno 1
Alunno 2
7.4 PROSPETTO DI VALUTAZIONE DELLA TERZA PROVA SCRITTA
Documento del 15 maggio 5º MAT 27
TABELLA DI CONVERSIONE DELLA 1 a – 2a – 3a PROVA
Punteggio massimo 15
Punteggio sufficiente 10 (punteggio grezzo percentuale 0,5)
Punteggio grezzo percentuale
Punteggio in 15-esimi corrispondente
0÷2 1
3÷6 2
7÷11 3
12÷16 4
17÷22 5
23÷27 6
28÷33 7
34÷39 8
40÷46 9
47÷53 10
54÷61 11
62÷70 12
71÷80 13
81÷92 14
93÷100 15
Y(punteggio in 15/esimi)= -8*X2+22*X+1 con X=punteggio grezzo
7.5 TABELLA CONVERSIONE PUNTEGGIO GREZZO IN VOTO IN 15-ESIMI
Documento del 15 maggio 5º MAT 28
INDICATORI
CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE
Conoscenza dei contenuti disciplinari Conoscenza dei termini tecnici
Possesso delle abilità anche di carattere applicativo Saper risolvere quesiti Utilizzo termini tecnici
Capacità elaborative logiche critiche
LIVELLI INDICATORI
0 = Prestazione assolutamente nulla 0,5= prestazione quasi nulla 1 = Prestazione gravemente insufficiente 1,5= Prestazione insufficiente 2 = Prestazione scarsa 2,5= Prestazione mediocre
3 = Prestazione sufficiente 3,5 = Prestazione discreta 4 = Prestazione buona 4,5 = Prestazione ottima 5 = Prestazione eccellente
PESI INDICATORI
CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE
4 3 3
7.6 GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO
Documento del 15 maggio 5º MAT 29
GRIGLIA DI VALUTAZIONE
INDICATORI CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE Punteggio grezzo massimo 100 punti
PESI 4 3 3 Punteggio grezzo totale
Percentuale punteggio
grezzo totale
Voto/30
DISCIPLINA
Alunno 1
Alunno 2
TABELLA DI CONVERSIONE DEL COLLOQUIO
Punteggio massimo 30
Punteggio sufficiente 20 (Punteggio grezzo percentuale 49 – 52)
Punteggio grezzo %
Voto Punteggio grezzo %
Voto Punteggio grezzo %
Voto
0÷1 1 23÷25 11 53÷56 21
2÷3 2 26÷28 12 57÷59 22
4÷5 3 29÷30 13 60÷64 23
6÷8 4 31÷33 14 65÷68 24
9÷10 5 34÷36 15 69÷73 25
11÷12 6 37÷39 16 74÷78 26
13÷15 7 40÷42 17 79÷83 27
16÷17 8 43÷45 18 84÷89 28
18÷20 9 46÷48 19 90÷96 29
21÷22 10 49÷52 20 97÷100 30
Documento del 15 maggio 5º MAT 30
Per la prova scritta di Italiano si è scelto di far esercitare gli allievi sulle seguenti tipologie di prove indicate dal Ministero:
• Tipologia A - Analisi del testo • Tipologia B - Redazione di un “saggio breve” o di un “articolo di giornale” • Tipologia C - Tema di argomento storico • Tipologia D - Tema di ordine generale
Per lo svolgimento della prova è stata utilizzata la traccia della prima prova dell’esame di stato, sessione ordinaria 2011. Gli alunni assenti il giorno della simulazione si sono esercitati il 29 aprile sulla traccia della sessione 2014. Il testo completo di tali prove è disponibile nell'appendice A. La prova di simulazione si è svolta in data 22 aprile 2017 Durante la prova gli studenti hanno potuto utilizzare il dizionario di italiano.
Per la prova scritta di "Tecnologie e tecniche di installazione e manutenzione di apparati, impianti e servizi tecnici industriali e civili" si è scelto di far esercitare gli allievi sulla seguente traccia:
• seconda prova scritta della sessione ordinaria dell' anno 2016 per l'indirizzo Manutenzione e assistenza tecnica opzione apparati, impianti e servizi tecnici industriali e civili, curvatura meccanica (codice M762)
Il testo completo di tali prove è disponibile nell'appendice B. La prova di simulazione si è svolta in data 21 aprile 2017. La stessa prova è stata successivamente somministrata all'alunno Marani il 10 maggio. Durante la prova gli studenti hanno potuto consultare i manuali tecnici
Il Consiglio di Classe ha deciso di proporre come simulazione per la terza prova 10 quesiti (2 quesiti per ogni disciplina) e ha coinvolto le seguenti discipline. Per la prima simulazione del 30 marzo 2017:
• Lingua e letteratura inglese
SIMULAZIONE SECONDA PROVA SCRITTA
SIMULAZIONE TERZA PROVA SCRITTA
8. SIMULAZIONE PROVE SCRITTE
SIMULAZIONE PRIMA PROVA SCRITTA
Documento del 15 maggio 5º MAT 31
• Scienze motorie e sportive • Storia • Tecnologie elettrico-elettroniche ed applicazioni • Tecnologie meccaniche ed applicazioni
Durata della prova: 3 ore Per la seconda simulazione del 5 maggio 2017:
• Lingua e letteratura inglese • Scienze motorie e sportive • Matematica • Tecnologie elettrico-elettroniche ed applicazioni • Tecnologie meccaniche ed applicazioni
Durata della prova: 3,5 ore E’ stato consentito l’uso del dizionario di inglese, di manuali tecnici, della calcolatrice, del vocabolario di italiano. I testi delle due prove simulate effettuate sono riportati nelle pagine seguenti.
Documento del 15 maggio 5º MAT 32
INGLESE
1.Choose two materials, describe their properties and tell how they can be transformed (by means of what tools?). 2. Why are the USA considered the “land of democracy”?
TECNOLOGIE MECCANICHE E APPLICAZIONI
1) Collegare e completare i componenti assegnati in modo che, premuti insieme i pulsanti S1 e S2, lo stelo esca e rientri quando almeno uno dei pulsanti viene rilasciato. Indicare, inoltre, il nome dei componenti utilizzati. A:..................................
D:..................................
V:..................................
S1:................................
S2:................................
2) Collegare e completare i componenti assegnati in modo che premendo uno dei due pulsanti S1 od S2 lo stelo esca, completi la sua corsa e rientri. Indicare, inoltre, il nome dei componenti utilizzati.
A:..................................
D:..................................
a0:.................................
a1:.................................
V:..................................
S1:................................
S2:................................
PRIMA SIMULAZIONE 3º PROVA SCRITTA (30/03/2017)
Documento del 15 maggio 5º MAT 33
STORIA 1. Individua quali furono gli schieramenti e il “casus belli” all’origine della I guerra mondiale. 2. Ricostruisci sinteticamente quali furono le origini del movimento fascista nell’Italia del primo dopoguerra.
SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE
1. Qual è l’obiettivo del primo soccorso e come è strutturata la catena del soccorso? 2. Cosa sono le ustioni, come sono classificate e quali interventi si possono effettuare o meno per prestare un primo soccorso?
TECNOLOGIE ELETTRICHE E APPLICAZIONI
1. Dato il circuito di figura
- Descrivere i componenti principali - Descrivere i principi e le relazioni fondamentali del trasformatore monofase - Indicando i valori tipici dell’alimentazione elettrica italiana in Vpk, determinare il numero di spire del trasformatore abbassatore che consente di avere sul carico un valore di picco VpR2 = 13,8 [V] - Assegnando a Vpk = 6,5 [KV] tensione di uscita di una centrale idroelettrica, determinare il numero di spire del trasformatore elevatore che consente di avere sul carico un valore di picco VpR2
= 20 [KV]. 2. Dato il circuito di figura
- Descrivere i principi di funzionamento del transistore BJT
- Determinare il valore di Rb tale che la corrente che circola in base Ib= 3,5Ib SAT
T1
0:0
V1
0 Vpk 0 Hz 0°
R21.8kΩ
XSC1
A B
Ext Trig+
+
_
_ + _
XSC2
A B
Ext Trig+
+
_
_ + _
Q1
2N2222A
Rb
0Ω
Rc2.2kΩ
Vin1kHz 6.5 V
Vcc8.6 V
Documento del 15 maggio 5º MAT 34
INGLESE
1.Describe parts and purposes of the lathe. 2. What is the difference between the British and the American Head of State?
TECNOLOGIE MECCANICHE E APPLICAZIONI 1) Dopo aver individuato i componenti presenti nello schema in figura descrivere il comportamento di ognuno di essi dopo aver azionato il componente nº6 una prima ed una seconda volta
N. Denominazione
1
2
3
4
5
6
Dopo il primo azionamento................................................................................................................
Dopo il secondo azionamento................................................................................................................
2) dato il ciclo automatico A+/A-/B+/B- tracciare il prospetto (diagramma fasi/segnali) ed il ciclogramma; verificare quindi se esistono segnali bloccanti ed eventualmente indicare quali I segnali bloccanti presenti sono i seguenti: …..................................................................................... (se non sono presenti segnali bloccanti scrivere “nessuno”).
SECONDA SIMULAZIONE 3º PROVA SCRITTA (05/05/2017)
Documento del 15 maggio 5º MAT 35
MATEMATICA
1. Data la funzione
calcola : a) dominio b) limiti (per x-> ∞ e per x-> -1 ) ed eventuali asintoti orizzontali o verticali. 2. Calcola il segno della funzione :
SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE
1. Quali sono e come sono divise le discipline dell'atletica leggera? Elenca tutte le specialità
2. Descrivi regole e tecnica del getto del peso
TECNOLOGIE ELETTRICHE E APPLICAZIONI
1. Dato il sommatore invertente di figura
.Descrivere i componenti principali e la funzione sinusoidale del generatore
.Descrivere le ipotesi esemplificative per la risoluzione del circuito, il metodo e le leggi applicate.
.Determinare il valore di Vout, Iout, P3.7 [KΩ]
.Tracciare l’andamento di massima della tensione Vout ottenuta
U1
741
3
2
4
7
6
51
R1
133kΩ
R2
47kΩR3
33kΩR43.5kΩ
V1
62 Vpk 10kHz 60° E2
18 V
V-
I+
I-
V+E1(t)
Documento del 15 maggio 5º MAT 36
2. Dato il sommatore non invertente di figura
1) Descrivere le tipologie dell’Amplificatore Operazionale, le principali applicazioni ed i componenti fondamentali
2) Descrivere le ipotesi esemplificative per la risoluzione del circuito, il metodo e le leggi applicate.
3) Determinare il valore di Vout, Iout, P4.6 [KΩ] 4) Tracciare l’andamento di massima della tensione Vout ottenuta
U2
741
3
2
4
7
6
51
R5
143kΩ
R6
54kΩR7
41kΩR84.6kΩ
V2
47 Vpk 10kHz 60°
Ea12 V
Ra1237kΩ
R91237kΩ
V-
I+
I-
V+
Documento del 15 maggio 5º MAT 37
Cognome e nome Argomento tesina
Cardinali Lorenzo Made in Italy
De Paolis Luca L'alternanza scuola-lavoro
Marani Martino Cinematografia e fumetto
Morè Manolo Pannello fotovoltaico
Nori Michael La termoidraulica
Pesaresi Luca L'Alfa Romeo
Porfiri Cristian New Holland
Tardella Luigi Caldarola
Virgili Matteo La carabina
9. TESINE
ARGOMENTO TESINE
Documento del 15 maggio 5º MAT 38
Oltre alle attività legate agli stage dell’Area Professionale, gli allievi hanno partecipato alle
seguenti attività:
- Orientamento alla prosecuzione degli studi con uscita didattica presso l’ Università
di Camerino;
- Orientamento alla prosecuzione degli studi con uscita didattica al Salone
Internazionale dell’Orientamento tenutosi al Pacacongressi di Rimini
- Attività di orientamento per i ragazzi della scuola secondaria di primo grado in visita
presso la sede di San Ginesio dell’Ipsia Renzo Frau di Sarnano;
- Attività di orientamento per i ragazzi della scuola secondaria di primo grado svolta
presso alcune scuole secondarie di primo grado delle province di Macerata e
Fermo;
- Incontro con rappresentati della Marina Italiana per la descrizione delle Carriere
Militari;
- Incontri con le aziende;
- Viaggio d'istruzione in Campania, 8-11 maggio 2017
- Visita della Galleria d’Arte Moderna di Palazzo Bonaccorsi a Macerata e in
particolare sezioni di arte futurista e arredamento futurista (Casa Zampini, Ivo
Pannaggi). Visita alle collezioni di Arte del 900 di Palazzo Ricci, Macerata. Uscita
del 2 maggio 2017
Il giorno 27 maggio inoltre gli studenti parteciperanno alla terza edizione del Premio
sapere e saper fare indetto dalla sede di San Ginesio dell’IPSIA Renzo Frau di Sarnano.
10. ATTIVITÀ ALTERNATIVE ALLA DIDATTICA SVOLTE NEL BIENNIO POST- QUALIFICA
Documento del 15 maggio 5º MAT 39
Il Consiglio di Classe condivide il presente Documento in ogni sua parte e lo sottoscrive. Disciplina Docente Firma
Matematica Prof. Sauro Contratti
Religione Prof. Marcello Lambertucci
Lingua e letteratura italiana Prof. Sandro Princiotta
Storia Prof. Sandro Princiotta
Lingua e cultura inglese Prof. Lisa Soravito
Scienze motorie e sportive Prof. Claudio Eleuteri
Laboratorio tecnologico ed esercitazioni
Prof. Aldo Biondi
ITP laboratorio di elettronica Prof. Francesco Ciabocco
Tecnologie e tecniche di installazione e manutenzione
Prof. Paolo G. Marchetti
Tecnologie meccaniche e applicazioni
Prof. Paolo G. Marchetti
Tecnologie elettrico-elettroniche e applicazioni
Prof. Vittorio Pucci
Docente specializzato Prof. Matteo Polci
Docente specializzato Prof. Maria Luisa Petracci
San Ginesio, 15 Maggio 2017 Il Dirigente
(Prof. Nazzareno Miele)
_______________________
Pag. 1/7 Sessione ordinaria 2011 Prima prova scritta
Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca
P000 - ESAMI DI STATO CONCLUSIVI DEI CORSI DI STUDIO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
PROVA DI ITALIANO (per tutti gli indirizzi: di ordinamento e sperimentali)
Svolgi la prova, scegliendo una delle quattro tipologie qui proposte.
TIPOLOGIA A - ANALISI DEL TESTO
Giuseppe Ungaretti, Lucca (da L’Allegria) Edizione: G. Ungaretti, Vita d’un uomo. Tutte le poesie, a cura di C. Ossola, Mondadori, Milano 2009, p. 133
1 A casa mia, in Egitto, dopo cena, recitato il rosario, mia madre ci parlava di questi posti. 2 La mia infanzia ne fu tutta meravigliata. 3 La città ha un traffico timorato e fanatico. 4 In queste mura non ci si sta che di passaggio. 5 Qui la meta è partire. 6 Mi sono seduto al fresco sulla porta dell’osteria con della gente che mi parla di California
come d’un suo podere. 7 Mi scopro con terrore nei connotati di queste persone. 8 Ora lo sento scorrere caldo nelle mie vene, il sangue dei miei morti. 9 Ho preso anch’io una zappa. 10 Nelle cosce fumanti della terra mi scopro a ridere. 11 Addio desideri, nostalgie. 12 So di passato e d’avvenire quanto un uomo può saperne. 13 Conosco ormai il mio destino, e la mia origine. 14 Non mi rimane più nulla da profanare, nulla da sognare. 15 Ho goduto di tutto, e sofferto. 16 Non mi rimane che rassegnarmi a morire. 17 Alleverò dunque tranquillamente una prole. 18 Quando un appetito maligno mi spingeva negli amori mortali, lodavo la vita. 19 Ora che considero, anch’io, l’amore come una garanzia della specie, ho in vista la morte.
Giuseppe Ungaretti nacque ad Alessandria d’Egitto nel 1888, da genitori emigrati da Lucca ed è morto a Milano nel 1970. Nel 1912 lasciò per sempre l’Egitto. A Parigi approfondì la sua preparazione letteraria e conobbe personalmente importanti artisti e scrittori. Partecipò alla guerra mondiale come soldato semplice. Risalgono a quell’epoca le poesie raccolte ne Il Porto Sepolto, 1916 e poi confluite, insieme ad altre, in Allegria di Naufragi, 1919. La poesia che si propone raggiunse la redazione definitiva nel 1936, attraverso diverse stesure a partire dal 1919.
Pag. 2/7 Sessione ordinaria 2011 Prima prova scritta
Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca
omprensione complessiva 1. C Dopo una prima lettura, riassumi il contenuto informativo del testo.
2. A nalisi del testo 2.1 Soffermati sugli aspetti linguistico-lessicali della poesia e, in particolare, sugli aggettivi. 2.2 Spiega l’espressione “La mia infanzia ne fu tutta meravigliata” (2). 2.3 Individua gli elementi che caratterizzano la città (3-5). 2.4 Il poeta evoca una scoperta che lo terrorizza (7). Quali le ragioni del “terrore”? 2.5 Il poeta contrappone agli “amori mortali” (18) “l’amore come una garanzia della specie” (19).
Spiega la contrapposizione. 2.6 Esponi le tue osservazioni in un commento personale di sufficiente ampiezza.
3. I nterpretazione complessiva e approfondimenti Sulla base dell’analisi condotta, proponi una tua interpretazione complessiva della poesia e
approfondiscila con opportuni collegamenti ad altri testi di Ungaretti o a testi di altri autori. Alternativamente, puoi fare riferimento alla situazione storico-culturale dell’epoca o a situazioni del nostro tempo, sviluppando i confronti che ti interessano.
TIPOLOGIA B - REDAZIONE DI UN “SAGGIO BREVE” O DI UN “ARTICOLO DI GIORNALE” (puoi scegliere uno degli argomenti relativi ai quattro ambiti proposti)
CONSEGNE
Sviluppa l’argomento scelto o in forma di «saggio breve» o di «articolo di giornale», utilizzando, in tutto o in parte, e nei modi che ritieni opportuni, i documenti e i dati forniti.
Se scegli la forma del «saggio breve» argomenta la tua trattazione, anche con opportuni riferimenti alle tue conoscenze ed esperienze di studio.
Premetti al saggio un titolo coerente e, se vuoi, suddividilo in paragrafi. Se scegli la forma dell’«articolo di giornale», indica il titolo dell’articolo e il tipo di giornale sul quale pensi
che l’articolo debba essere pubblicato. Per entrambe le forme di scrittura non superare cinque colonne di metà di foglio protocollo.
1. AMBITO ARTISTICO - LETTERARIO
ARGOMENTO: Amore, odio, passione.
G. KLIMT, Il bacio, 1907-08 G. DE CHIRICO, Ettore e
Andromaca, 1917 P. PICASSO, Gli amanti, 1923
«Tra l’altre distinzioni e privilegi che le erano stati concessi, per compensarla di non poter esser badessa, c’era anche quello di stare in un quartiere a parte. Quel lato del monastero era contiguo a una casa abitata da un giovine, scellerato di professione, uno de’ tanti, che, in que’ tempi, e co’ loro sgherri, e con l’alleanze d’altri scellerati, potevano, fino a un certo segno, ridersi della forza pubblica e delle leggi. Il nostro manoscritto lo nomina Egidio, senza parlar del casato. Costui, da una sua finestrina che dominava un cortiletto di quel quartiere, avendo veduta Gertrude qualche volta passare o girandolar lì, per ozio, allettato anzi che atterrito dai pericoli e dall’empietà dell’impresa, un giorno osò rivolgerle il discorso. La sventurata rispose.»
Alessandro MANZONI, I promessi sposi, 1840-42
Pag. 3/7 Sessione ordinaria 2011 Prima prova scritta
Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca
«Ed avrebbe voluto strapparsi gli occhi per non vedere quelli della Lupa, che quando gli si ficcavano ne’ suoi gli facevano perdere l’anima ed il corpo. Non sapeva più che fare per svincolarsi dall’incantesimo. Pagò delle messe alle anime del Purgatorio e andò a chiedere aiuto al parroco e al brigadiere. A Pasqua andò a confessarsi, e fece pubblicamente sei palmi di lingua a strasciconi sui ciottoli del sacrato innanzi alla chiesa, in penitenza, e poi, come la Lupa tornava a tentarlo: - Sentite! le disse, non ci venite più nell’aia, perché se tornate a cercarmi, com’è vero Iddio, vi ammazzo! - Ammazzami, rispose la Lupa, ché non me ne importa; ma senza di te non voglio starci. Ei come la scorse da lontano, in mezzo a’ seminati verdi, lasciò di zappare la vigna, e andò a staccare la scure dall’olmo. La Lupa lo vide venire, pallido e stralunato, colla scure che luccicava al sole, e non si arretrò di un sol passo, non chinò gli occhi, seguitò ad andargli incontro, con le mani piene di manipoli di papaveri rossi, e mangiandoselo con gli occhi neri. - Ah! malanno all’anima vostra! balbettò Nanni.»
Giovanni VERGA, La Lupa, in Vita dei campi, 1880 «Ella pareva colpita dal suono insolito della voce di Giorgio; e un vago sbigottimento cominciava a invaderla. – Ma vieni! Ed egli le si appressò con le mani tese. Rapidamente l’afferrò per i polsi, la trascinò per un piccolo tratto; poi la strinse tra le braccia, con un balzo, tentando di piegarla verso l’abisso. – No, no, no... Con uno sforzo rabbioso ella resistette, si divincolò, riuscì a liberarsi, saltò indietro anelando e tremando. – Sei pazzo? – gridò con l’ira nella gola. – Sei pazzo? Ma, come se lo vide venire di nuovo addosso senza parlare, come si sentì afferrata con una violenza più acre e trascinata ancóra verso il pericolo, ella comprese tutto in un gran lampo sinistro che le folgorò l’anima di terrore. – No, no, Giorgio! Lasciami! Lasciami! Ancóra un minuto! Ascolta! Ascolta! Un minuto! Voglio dirti... Ella supplicava, folle di terrore, divincolandosi. Sperava di trattenerlo, d’impietosirlo. – Un minuto! Ascolta! Ti amo! Perdonami! Perdonami! Ella balbettava parole incoerenti, disperata, sentendosi vincere, perdendo terreno, vedendo la morte. – Assassino! – urlò allora furibonda. E si difese con le unghie, con i morsi, come una fiera. – Assassino! – urlò sentendosi afferrare per i capelli, stramazzando al suolo su l’orlo dell’abisso, perduta. Il cane latrava contro il viluppo. Fu una lotta breve e feroce come tra nemici implacabili che avessero covato fino a quell’ora nel profondo dell’anima un odio supremo. E precipitarono nella morte avvinti.»
Gabriele D’ANNUNZIO, Il trionfo della morte, 1894
«Emilio poté esperimentare quanto importante sia il possesso di una donna lungamente desiderata. In quella memorabile sera egli poteva credere d’essersi mutato ben due volte nell’intima sua natura. Era sparita la sconsolata inerzia che l’aveva spinto a ricercare Angiolina, ma erasi anche annullato l’entusiasmo che lo aveva fatto singhiozzare di felicità e di tristezza. Il maschio era oramai soddisfatto ma, all’infuori di quella soddisfazione, egli veramente non ne aveva sentita altra. Aveva posseduto la donna che odiava, non quella ch’egli amava. Oh, ingannatrice! Non era né la prima, né – come voleva dargli ad intendere – la seconda volta ch’ella passava per un letto d’amore. Non valeva la pena di adirarsene perché l’aveva saputo da lungo tempo. Ma il possesso gli aveva data una grande libertà di giudizio sulla donna che gli si era sottomessa. – Non sognerò mai più – pensò uscendo da quella casa. E poco dopo, guardandola, illuminata da pallidi riflessi lunari: – Forse non ci ritornerò mai più. – Non era una decisione. Perché l’avrebbe dovuta prendere? Il tutto mancava d’importanza.»
Italo SVEVO, Senilità, 19272 (1a ed. 1898)
Pag. 4/7 Sessione ordinaria 2011 Prima prova scritta
Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca
2. AMBITO SOCIO - ECONOMICO
ARGOMENTO: Siamo quel che mangiamo?
DOCUMENTI
«“Le evidenze scientifiche pubblicate nell’ultimo anno non lasciano dubbi - dice Massimo Volpe, presidente della Siprec (Società Italiana per la Prevenzione Cardiovascolare) - la vita sedentaria è un rischio per il cuore. Se a questo si aggiunge che spesso si mangia male, il quadro generale peggiora. Commettiamo troppi peccati di gola, trascuriamo la dieta mediterranea e gli alimenti cardine di una sana alimentazione. Pochissimi sanno davvero giudicare la salubrità di un alimento, molti si nutrono in modo disorganizzato”. Il 95 per cento, continua l’esperto, dichiara che il pranzo è il pasto più importante, ma poi l’80 per cento sceglie una pasta molto condita accompagnata dal pane. Un italiano su due mangia carne magra, ma c’è un buon 20 per cento che sceglie carni grasse più volte alla settimana; il 45 per cento consuma formaggi come minimo tre volte alla settimana. Uno su tre, poi, mangia pesce appena una volta alla settimana, mentre andrebbe consumato almeno due, tre volte. “Dobbiamo modificare le nostre abitudini - dice il cardiologo - e renderci conto che la salute del cuore si costruisce mattone dopo mattone, proprio come una casa. Sia il medico che il paziente possono imparare a fare prevenzione”.»
Adele SARNO, Otto ore seduti? Il cuore rischia doppio. Arriva l’auto-test per la prevenzione, “la Repubblica” – 1 aprile 2011 «Mercoledì 17 novembre 2010. La quinta sessione del Comitato Intergovernativo dell’UNESCO [...] ha iscritto la Dieta Mediterranea nella prestigiosa lista (sc. del patrimonio culturale immateriale dell’umanità). [...] La Dieta Mediterranea rappresenta un insieme di competenze, conoscenze, pratiche e tradizioni che vanno dal paesaggio alla tavola, includendo le colture, la raccolta, la pesca, la conservazione, la trasformazione, la preparazione e, in particolare, il consumo di cibo. La Dieta Mediterranea è caratterizzata da un modello nutrizionale rimasto costante nel tempo e nello spazio, costituito principalmente da olio di oliva, cereali, frutta fresca o secca, e verdure, una moderata quantità di pesce, latticini e carne, e molti condimenti e spezie, il tutto accompagnato da vino o infusi, sempre in rispetto delle tradizioni di ogni comunità. Tuttavia, la Dieta Mediterranea (dal greco diaita, o stile di vita) è molto più che un semplice alimento. Essa promuove l’interazione sociale, poiché il pasto in comune è alla base dei costumi sociali e delle festività condivise da una data comunità, e ha dato luogo a un notevole corpus di conoscenze, canzoni, massime, racconti e leggende. La Dieta si fonda nel rispetto per il territorio e la biodiversità, e garantisce la conservazione e lo sviluppo delle attività tradizionali e dei mestieri collegati alla pesca e all’agricoltura nelle comunità del Mediterraneo.»
CNI-UNESCO, La Dieta Mediterranea è patrimonio immateriale dell’Umanità, www.unesco.it
«La politica alimentare [...] si deve basare sul concetto che l’energia primaria della vita è il cibo. Se il cibo è energia allora dobbiamo prendere atto che l’attuale sistema di produzione alimentare è fallimentare. […] Il vero problema è che da un lato c’è una visione centralizzata dell’agricoltura, fatta di monoculture e allevamenti intensivi altamente insostenibili, e dall’altro è stata completamente rifiutata la logica olistica, che dovrebbe essere innata in agricoltura, per sposare logiche meccaniciste e riduzioniste. Una visione meccanicista finisce con il ridurre il valore del cibo a una mera commodity, una semplice merce. È per questo che per quanto riguarda il cibo abbiamo ormai perso la percezione della differenza tra valore e prezzo: facciamo tutti molta attenzione a quanto costa, ma non più al suo profondo significato. […] Scambiare il prezzo del cibo con il suo valore ci ha distrutto l’anima. Se il cibo è una merce non importa se lo sprechiamo. In una società consumistica tutto si butta e tutto si può sostituire, anzi, si deve sostituire. Ma il cibo non funziona così.»
Carlo PETRINI in Petrini-Rifkin. Il nuovo patto per la natura, “la Repubblica” - 9 giugno 2010
«Mangiare mentre si legge la posta, si gioca o si lavora al pc può avere serie conseguenze sulla nostra forma fisica. [...] Secondo quanto riportato dalla rivista American Journal of Clinical Nutrition, chi mangia svolgendo altre attività, sia questa navigare in internet o sui profili degli amici su Facebook, è più propenso ad esagerare con le quantità in quanto non ha il senso delle calorie che sta realmente introducendo e inoltre ha più voglia di dolci. [...] Quindi nonostante sia costume sempre più diffuso quello di mangiare rimanendo “connessi” col mondo intorno a noi, per chi ci tiene a non mettere su chili di troppo, meglio evitare le distrazioni durante i pasti e focalizzare l’attenzione su quello che si sta consumando.»
Silvia MAGLIONI, Mangiare davanti al computer fa male alla linea, www.leonardo.it
Pag. 5/7 Sessione ordinaria 2011 Prima prova scritta
Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca
3. AMBITO STORICO - POLITICO
ARGOMENTO: Destra e Sinistra.
DOCUMENTI
«Se mi si concede che il criterio rilevante per distinguere la destra e la sinistra è il diverso atteggiamento rispetto all’ideale dell’eguaglianza, e il criterio rilevante per distinguere l’ala moderata e quella estremista, tanto nella destra quanto nella sinistra, è il diverso atteggiamento rispetto alla libertà, si può ripartire schematicamente lo spettro in cui si collocano dottrine e movimenti politici, in queste quattro parti: a) all’estrema sinistra stanno i movimenti insieme egualitari e autoritari, di cui l’esempio storico più importante, tanto da essere diventato un’astratta categoria applicabile, ed effettivamente applicata, a periodi e situazioni storiche diverse è il giacobinismo; b) al centro-sinistra, dottrine e movimenti insieme egualitari e libertari, per i quali potremmo oggi usare l’espressione «socialismo liberale», per comprendervi tutti i partiti socialdemocratici, pur nelle loro diverse prassi politiche; c) al centro-destra, dottrine e movimenti insieme libertari e inegualitari, entro cui rientrano i partiti conservatori, che si distinguono dalle destre reazionarie per la loro fedeltà al metodo democratico, ma, rispetto all’ideale dell’eguaglianza, si attestano e si arrestano sull’eguaglianza di fronte alla legge, che implica unicamente il dovere da parte del giudice di applicare imparzialmente la legge; d) all’estrema destra, dottrine e movimenti antiliberali e antiegualitari, di cui credo sia superfluo indicare esempi storici ben noti come il fascismo e il nazismo.»
Norberto BOBBIO, Destra e sinistra. Ragioni e significati di una distinzione politica, Donzelli editore, Roma 1994
«Se destra e sinistra non esistono bisogna inventarle. Sembra questo il precetto cruciale della politica nei nostri giorni. Sia che si pensi in termini liberali che in termini illiberali. Nel primo senso infatti, il modello di riferimento è sempre di tipo bipolare. Laburisti e conservatori, democratici o repubblicani, gollisti o socialisti, liberaldemocratici o socialdemocratici: la struttura binaria della politica nelle liberaldemocrazie d’occidente sembra un dato acquisito. E dunque la scelta tra destrorsi o sinistrorsi, tra centro-destra e centro-sinistra è invocata come l’inevitabile evoluzione di ogni sistema. Ma anche il pensiero critico verso il modello liberale si è sempre svolto all’insegna dell’invocazione di un dualismo che ricalca i termini di destra e di sinistra. Il marxismo si fonda sulla lotta di classe e sulla contrapposizione tra proletariato e borghesia, capitalismo-socialismo o democrazia progressiva e regime reazionario. E rischia di rigenerarsi nel bipolarismo tra nord e sud del mondo, tra occidente e paesi poveri e proletari. Ma anche le dottrine del nazionalismo, della destra classica e non solo, si riconoscono lungo l’asse segnato da Schmitt nell’opposizione tra amico e nemico. La politica nasce a partire da quel conflitto. Da noi la matrice cattolica ha temperato entrambe le posizioni, marxista e nazionalista, ma ha anche temperato il bipolarismo liberale. Il «centro» come luogo di mediazione e di purificazione del conflitto, nasce da noi nell’ambito di una visione cattolica, ecumenica, fondata sull’et et e non sull’aut aut. Ma la secolarizzazione, la scristianizzazione della società italiana, conduce a due effetti opposti: la ripresa forte del bipolarismo tra destra e sinistra o la neutralizzazione della politica e dunque del conflitto, attraverso un nuovo luogo di mediazione e di depotenziamento delle categorie di destra e di sinistra. Questo nuovo luogo di spoliticizzazione è rappresentato dal centrismo pragmatico e tecnocratico. Attualmente la nostra democrazia è aperta ad entrambe le ipotesi.»
Marcello VENEZIANI, Sinistra e destra. Risposta a Norberto Bobbio, Vallecchi Editore, Firenze 1995
«Eppure, persino nel caso italiano, così frastagliato e frammentato, sarebbe possibile riconoscere, per chi fosse disposto a osservare le cose con un minimo di obiettività, le stesse divisioni valoriali che sono presenti in tante altre democrazie. Se destra e sinistra significano qualcosa, infatti, esse indicano posizioni diverse su due problemi: le libertà economiche e i diritti civili. Quanto al tema economico, la destra predilige normalmente la libertà rispetto alla eguaglianza e la sinistra l’eguaglianza rispetto alla libertà: la destra è, in materia economica, più «liberale» e la sinistra più «socialista». In tema di diritti civili, invece, le parti si invertono: la sinistra è più «libertaria» (si tratti di matrimoni fra omosessuali o di concessioni di diritti agli immigrati) e la destra è più «tradizionalista». Questa divisione fra una destra liberale e tradizionalista e una sinistra socialista e libertaria la si ritrova ovunque nel mondo occidentale. Variamente declinata a seconda delle specificità storiche di ciascun Paese.»
Angelo PANEBIANCO, Le ragioni degli altri, “Corriere della Sera” - 17 aprile 2011
«La netta distinzione e contrapposizione tra destra e sinistra è stata una caratteristica dell’Italia repubblicana fino al 1992 (con la non secondaria eccezione del consociativismo), una caratteristica ereditata dal conflitto fra fascismo e antifascismo; mentre nell’Italia liberale si è manifestata in maniera radicale in pochi casi critici: nel conflitto fra Cavour e Garibaldi e negli anni immediatamente successivi, nella crisi di fine secolo, nel primo dopoguerra. A questi
Pag. 6/7 Sessione ordinaria 2011 Prima prova scritta
Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca
casi si devono aggiungere le quattro volte (1878, 1892, 1901, 1911) nelle quali furono formati ministeri di sinistra contrapposti alla destra. Ma di norma la contrapposizione mancò perché questa esaltava la lotta politica che invece i detentori liberali del potere vollero quasi sempre contenere o annullare. È vero che col socialismo si affermò una sinistra di classe che, in quanto tale, era intrinsecamente contrapposta alla destra. Ma la natura di classe e, nelle intenzioni, rivoluzionaria del socialismo e poi del comunismo non costituì mai una reale alternativa di potere. Quasi sempre destra e sinistra sono state entrambe deboli e si sono confuse fra loro nella maggioranza parlamentare, secondo la fisiologia del sistema politico nel quale si governava stando al centro, e spesso secondo le sue degenerazioni trasformistiche. Talvolta destra e sinistra si sono confuse nella stessa persona: tipico, ma non unico, è il caso di Giolitti che, soprattutto fra il 1903 e il 1909, fece la sua consueta politica di sinistra, di allargamento delle basi sociali dello Stato, usando strumenti di destra, cioè gli umori conservatori, di norma prevalenti nella sua maggioranza di governo, e la burocrazia, conservatrice quasi per definizione. In alcuni casi la confusione fra destra e sinistra ha acquistato un carattere diverso, si è realizzata con l’uso che la prima ha fatto della seconda, per allargare l’egemonia e consolidare il potere. I due casi più importanti sono stati quello di Crispi che ha usato, insieme al trasformismo ereditato da Depretis, la tradizione garibaldina, e quello di Mussolini che ha usato la sua formazione e il suo temperamento di rivoluzionario. Quando ciò avveniva, la sinistra conferiva alla destra un carattere particolarmente aggressivo (evidente nel fascismo) perché, privata degli ideali umanistici che ne costituivano e ne costituiscono l’essenza, sopravviveva solo nei suoi comportamenti variamente sovversivi.»
Giampiero CAROCCI, Destra e sinistra nella storia d’Italia, Laterza, Roma-Bari 2002
4 . AMBITO TECNICO - SCIENTIFICO
ARGOMENTO: Enrico Fermi, fisico.
«Due dati ci permettono di valutare l’importanza del campo di ricerca aperto da Enrico Fermi con il suo lavoro. Il primo riguarda i premi Nobel, una misura rozza ma efficace dell’importanza di un determinato settore della ricerca scientifica e dei progressi in esso conseguiti: più di dieci Nobel per la fisica sono stati attribuiti a scoperte relative alle interazioni deboli. Se Fermi non avesse ottenuto il Nobel per le sue ricerche sui neutroni ne avrebbe ben meritato uno per la scoperta delle interazioni deboli. Una seconda valutazione dell’importanza della scoperta di Enrico Fermi si può dedurre dal fatto che oltre la metà degli esperimenti attualmente in corso o in preparazione con acceleratori di particelle — al CERN di Ginevra, al Fermilab di Chicago, a Stanford come a Frascati come a Tsukuba in Giappone o a Novosibirsk in Russia — sono dedicati a studiare vari aspetti delle interazioni deboli. La stessa prevalenza degli studi sulle interazioni deboli si riscontra nei programmi sperimentali dei grandi laboratori sotterranei, come quello italiano del Gran Sasso, quello giapponese di Kamioka, ed altri ancora nel Canada e negli Stati Uniti. La teoria di Fermi delle interazioni deboli è ormai confluita nella più generale teoria delle particelle elementari che va sotto il nome di “Modello Standard”. […] È però importante ricordare che la teoria di Fermi mantiene ancora oggi il suo valore, sia per la validità delle soluzioni proposte sia come stimolo per una serie di ricerche che hanno impegnato i fisici per quasi settant’anni, e che ancora li impegneranno nei decenni a venire. In questa teoria si riflette la grandezza di Fermi, la firma di un grande maestro.»
Nicola CABIBBO, Le interazioni deboli, in Carlo BERNARDINI - Luisa BONOLIS (a cura di), Conoscere Fermi nel centenario della nascita 29 settembre 1901 - 2001, Editrice Compositori, Bologna 2001
«Enrico Fermi nasce a Roma nel 1901. La sua produzione scientifica inizia nel 1921 e termina con la sua morte nel 1954. All’inizio della sua attività, la fisica conosce due sole forze fondamentali della natura, la gravitazione e l’elettromagnetismo, e due sole particelle elementari costituenti la materia, i nuclei di idrogeno (protoni) e gli elettroni. A metà degli anni Cinquanta le forze fondamentali sono diventate quattro, con l’aggiunta delle interazioni nucleari forte e debole, e le particelle elementari note sono ormai una trentina. In poco meno di trent’anni la concezione della materia subisce un mutamento così radicale e inusitato da rendere tale periodo, per la rapidità e la quantità delle conoscenze acquisite, forse unico nella storia del pensiero scientifico occidentale. Le ricerche di Fermi segnarono profondamente questo trentennio, non solo per la quantità e l’importanza dei risultati ottenuti ma soprattutto per il loro ruolo storico. Esistono infatti traguardi scientifici di enorme valore che giungono al termine di lunghe e pazienti ricerche e che coronano un ben definito progetto iniziale, ma ci sono anche scoperte apparentemente meno straordinarie che obbligano a inattese risistemazioni del sapere acquisito, scardinano principî metodologici e conoscenze unanimemente accettate e imprimono alla ricerca direzioni nuove e del tutto impreviste. Nel suo itinerario di scienziato […] Fermi raggiunse entrambi gli obiettivi.»
Giuseppe BRUZZANITI, Enrico Fermi. Il genio obbediente, Einaudi, Torino 2007
Pag. 7/7 Sessione ordinaria 2011 Prima prova scritta
Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca
«Dalla lettura dei giornali di qualche settimana fa avrai probabilmente capito a quale genere di lavoro ci siamo dedicati in questi ultimi anni. È stato un lavoro di notevole interesse scientifico e l’aver contribuito a troncare una guerra che minacciava di tirar avanti per mesi o per anni è stato indubbiamente motivo di una certa soddisfazione. Noi tutti speriamo che l’uso futuro di queste nuove invenzioni sia su base ragionevole e serva a qualche cosa di meglio che a rendere le relazioni internazionali ancora più difficili di quello che sono state fino ad ora. I giornali hanno pubblicato un certo numero di dettagli sul lavoro di questi ultimi anni e tali dettagli, naturalmente, non sono più segreti. Ti interesserà sapere, se non lo sai già dai giornali italiani, che verso la fine del 1942 abbiamo costruito a Chicago la prima macchina per produrre una reazione a catena con uranio e grafite. È diventato d’uso comune chiamare queste macchine «pile». Dopo la prima pila sperimentale molte altre ne sono state costruite di grande potenza. Dal punto di vista della fisica, come ti puoi immaginare, queste pile rappresentano una ideale sorgente di neutroni che abbiamo usato tra l’altro per molte esperienze di fisica nucleare e che probabilmente verranno usate ancora di più per questo scopo ora che la guerra è finita.»
Lettera di Enrico Fermi a Edoardo Amaldi del 28 agosto 1945 (in Edoardo AMALDI, Da via Panisperna all’America, Editori Riuniti, Roma 1997)
«Vorrei discutere con voi la crisi che la scienza attraversa da due anni a questa parte. In larga misura questa crisi è dovuta all’improvvisa consapevolezza, di parte dell’opinione pubblica e del Governo, del tremendo ruolo che la Scienza può avere nelle cose umane. L’importanza di questo ruolo era già nota. Ma il drammatico impatto portato dalla costruzione della bomba atomica lo ha portato nella pubblica consapevolezza in maniera così vivida che gli scienziati si sono trovati, inaspettatamente e talora contro la propria volontà, ad essere sotto i riflettori […] C’è una grande penuria di uomini di scienza ben preparati […] Ora le iscrizioni di studenti nei dipartimenti scientifici sono tornate a essere abbondanti. Spero che ben pochi di questi studenti siano attratti dal nuovo fascino che la scienza ha acquistato. La professione del ricercatore deve tornare alla sua tradizione di ricerca per l’amore di scoprire nuove verità. Poiché in tutte le direzioni siamo circondati dall’ignoto e la vocazione dell’uomo di scienza è di spostare in avanti le frontiere della nostra conoscenza in tutte le direzioni, non solo in quelle che promettono più immediati compensi o applausi.»
Discorso tenuto da Enrico Fermi nel 1947 (in Giulio MALTESE, Ritorno a Chicago: Enrico Fermi e la nascita della fisica delle alte energie nel secondo dopoguerra (1946-1954), in Atti del XXI Congresso Nazionale di Storia della Fisica e dell’Astronomia, Dipartimento di Fisica, Università della Calabria, Arcavacata di Rende (CS), 6, 7 e 8 giugno 2001)
T IPOLOGIA C - TEMA DI ARGOMENTO STORICO
Lo storico Eric J. Hobsbawm definisce Secolo breve gli anni che vanno dall’esplosione della prima guerra mondiale fino al collasso dell’URSS. A suo giudizio, “la struttura del Secolo breve appare come quella di un trittico o di un sandwich storico. A un’Età della catastrofe, che va dal 1914 sino ai postumi della seconda guerra mondiale, hanno fatto seguito una trentina d’anni di straordinaria crescita economica e di trasformazione sociale, che probabilmente hanno modificato la società umana più profondamente di qualunque altro periodo di analoga brevità. Guardando indietro, quegli anni possono essere considerati come una specie di Età dell’oro, e così furono visti non appena giunsero al termine all’inizio degli anni ’70. L’ultima parte del secolo è stata una nuova epoca di decomposizione, di incertezza e di crisi – e addirittura, per larghe parti del mondo come l’Africa, l’ex URSS e le ex nazioni socialiste dell’Europa orientale, un’Età di catastrofe”.
Il candidato valuti criticamente la periodizzazione proposta da Hobsbawm e si soffermi sugli eventi che a suo parere caratterizzano gli anni ’70 del Novecento. T IPOLOGIA D - TEMA DI ORDINE GENERALE
«Nel futuro ognuno sarà famoso al mondo per quindici minuti».
Il candidato, prendendo spunto da questa “previsione” di Andy Warhol, analizzi il valore assegnato alla “fama” (effimera o meno) nella società odierna e rifletta sul concetto di “fama” proposto dall’industria televisiva (Reality e Talent show) o diffuso dai social media (Twitter, Facebook, YouTube, Weblog, ecc.).
___________________________ Durata massima della prova: 6 ore. È consentito soltanto l’uso del dizionario italiano. Non è consentito lasciare l’Istituto prima che siano trascorse 3 ore dalla dettatura del tema.
Pag. 1/7 Sessione ordinaria 2014
Prima prova scritta
Ministero dell’Istruzione, dell’ Università e della Ricerca
P000 - ESAMI DI STATO CONCLUSIVI DEI CORSI DI STUDIO DI ISTRUZIONE
SECONDARIA SUPERIORE
PROVA DI ITALIANO
(per tutti gli indirizzi: di ordinamento e sperimentali)
Svolgi la prova, scegliendo una delle quattro tipologie qui proposte.
TIPOLOGIA A - ANALISI DEL TESTO
Salvatore Quasimodo, Ride la gazza, nera sugli aranci, in Ed è subito sera.
Edizione: S. Quasimodo, Poesie e discorsi sulla poesia, a cura di G. Finzi, Mondadori, Milano1996
1 Forse è un segno vero della vita: 11 non più mia, arsi, remoti simulacri.
2 intorno a me fanciulli con leggeri 12 E tu vento del sud forte di zàgare,
3 moti del capo danzano in un gioco 13 spingi la luna dove nudi dormono
4 di cadenze e di voci lungo il prato 14 fanciulli, forza il puledro sui campi
5 della chiesa. Pietà della sera, ombre 15 umidi d‟orme di cavalle, apri
6 riaccese sopra l‟erba così verde, 16 il mare, alza le nuvole dagli alberi:
7 bellissime nel fuoco della luna! 17 già l‟airone s‟avanza verso l‟acqua
8 Memoria vi concede breve sonno; 18 e fiuta lento il fango tra le spine,
9 ora, destatevi. Ecco, scroscia il pozzo 19 ride la gazza, nera sugli aranci.
10 per la prima marea. Questa è l‟ora:
Salvatore Quasimodo. Nato a Modica (Ragusa) nel 1901, morto nel 1968, consegue il premio Nobel per la letteratura
nel 1959. L‟evoluzione della sua poesia riflette la storia della poesia contemporanea italiana, dall‟Ermetismo ad un
discorso poetico più ampio. Le raccolte poetiche degli anni Trenta confluiscono in Ed è subito sera (1942). Le sue
traduzioni dei poeti greci dell‟antichità sono spesso poesia originale (Lirici greci, 1940). Nelle raccolte Giorno dopo
giorno (1947), La vita non è sogno (1949), Il falso e vero verde (1954 e 1956), La terra impareggiabile (1958), Dare e
avere (1966) si avverte l‟esigenza del poeta di volgersi ad un colloquio aperto con gli uomini.
Nella lirica Ride la gazza, nera sugli aranci, la rievocazione della Sicilia si fonde con quella dell‟infanzia e della
comunione con la natura, in contrasto con il dolore presente della vita.
1. Comprensione del testo
Dopo un‟attenta lettura, riassumi il contenuto del testo.
2. Analisi del testo
2.1 Chiarisci il primo verso della poesia.
2.2 Spiega l‟espressione Pietà della sera (v. 5).
2.3 Qual è il significato dell‟espressione ombre / riaccese (vv. 5-6)?
2.4 Soffermati sul motivo della memoria (v. 8).
2.5 Spiega l‟espressione arsi, remoti simulacri (v. 11).
2.6 In quali scene si fa evidente l‟atmosfera mitica e con quali espressioni?
2.7 Soffermati sul motivo della natura, presente nella seconda parte della poesia.
3. Interpretazione complessiva ed approfondimenti
Le tematiche della fanciullezza, della memoria e della comunione con la natura si fondono nella poesia,
accentuate da sapienti scelte stilistiche. Riflettendo su questa lirica commenta nell‟insieme il testo dal punto
di vista del contenuto e della forma. Approfondisci poi l‟interpretazione complessiva della poesia con
opportuni collegamenti ad altri testi di Quasimodo e/o a testi di altri autori del Novecento.
Pag. 2/7 Sessione ordinaria 2014
Prima prova scritta
Ministero dell’Istruzione, dell’ Università e della Ricerca
TIPOLOGIA B - REDAZIONE DI UN “SAGGIO BREVE” O DI UN “ARTICOLO DI GIORNALE”
(puoi scegliere uno degli argomenti relativi ai quattro ambiti proposti)
CONSEGNE
Sviluppa l’argomento scelto o in forma di «saggio breve» o di «articolo di giornale», utilizzando, in tutto o in
parte, e nei modi che ritieni opportuni, i documenti e i dati forniti.
Se scegli la forma del «saggio breve» argomenta la tua trattazione, anche con opportuni riferimenti alle tue
conoscenze ed esperienze di studio.
Premetti al saggio un titolo coerente e, se vuoi, suddividilo in paragrafi.
Se scegli la forma dell’«articolo di giornale», indica il titolo dell’articolo e il tipo di giornale sul quale pensi
che l’articolo debba essere pubblicato. Per entrambe le forme di scrittura non superare cinque colonne di metà di foglio protocollo.
1. AMBITO ARTISTICO - LETTERARIO
ARGOMENTO: Il dono.
DOCUMENTI
ORATORIO DI SAN SILVESTRO - Roma
Donazione di Costantino, 1248
Jacques-Louis DAVID
Antioco e Stratonice, 1774
PARMIGIANINO
Adorazione dei Magi, 1529 circa
«La madre aveva steso una tovaglia di lino, per terra, su una stuoia di giunco, e altre stuoie attorno. E, secondo l‟uso
antico, aveva messo fuori, sotto la tettoia del cortile, un piatto di carne e un vaso di vino cotto dove galleggiavano
fette di buccia d‟arancio, perché l‟anima del marito, se mai tornava in questo mondo, avesse da sfamarsi. Felle andò a
vedere: collocò il piatto ed il vaso più in alto, sopra un‟asse della tettoia, perché i cani randagi non li toccassero; poi
guardò ancora verso la casa dei vicini. Si vedeva sempre luce alla finestra, ma tutto era silenzio; il padre non doveva
essere ancora tornato col suo regalo misterioso. Felle rientrò in casa, e prese parte attiva alla cena. In mezzo alla
mensa sorgeva una piccola torre di focacce tonde e lucide che parevano d‟avorio: ciascuno dei commensali ogni tanto
si sporgeva in avanti e ne tirava una a sé: anche l‟arrosto, tagliato a grosse fette, stava in certi larghi vassoi di legno e
di creta: e ognuno si serviva da sé, a sua volontà. […] Ma quando fu sazio e sentì bisogno di muoversi, ripensò ai suoi
vicini di casa: che mai accadeva da loro? E il padre era tornato col dono? Una curiosità invincibile lo spinse ad uscire
ancora nel cortile, ad avvicinarsi e spiare. Del resto la porticina era socchiusa: dentro la cucina le bambine stavano
ancora intorno al focolare ed il padre, arrivato tardi ma sempre in tempo, arrostiva allo spiedo la coscia del porchetto
donato dai vicini di casa. Ma il regalo comprato da lui, dal padre, dov‟era? – Vieni avanti, e va su a vedere – gli disse
l‟uomo, indovinando il pensiero di lui. Felle entrò, salì la scaletta di legno, e nella cameretta su, vide la madre di Lia
assopita nel letto di legno, e Lia inginocchiata davanti ad un canestro. E dentro il canestro, fra pannolini caldi, stava
un bambino appena nato, un bel bambino rosso, con due riccioli sulle tempie e gli occhi già aperti. – È il nostro primo
fratellino – mormorò Lia. – Mio padre l‟ha comprato a mezzanotte precisa, mentre le campane suonavano il “Gloria”.
Le sue ossa, quindi, non si disgiungeranno mai, ed egli le ritroverà intatte, il giorno del Giudizio Universale. Ecco il
dono che Gesù ci ha fatto questa notte.» Grazia DELEDDA, Il dono di Natale, 1930, in G. D., Le novelle, 4, La Biblioteca dell‟identità de L‟Unione Sarda, Cagliari 2012
«Gli uomini disapprendono l‟arte del dono. C‟è qualcosa di assurdo e di incredibile nella violazione del principio di
scambio; spesso anche i bambini squadrano diffidenti il donatore, come se il regalo non fosse che un trucco per vendere
loro spazzole o sapone. In compenso si esercita la charity, la beneficenza amministrata, che tampona
programmaticamente le ferite visibili della società. Nel suo esercizio organizzato l‟impulso umano non ha più il minimo
posto: anzi la donazione è necessariamente congiunta all‟umiliazione, attraverso la distribuzione, il calcolo esatto dei
bisogni, in cui il beneficato viene trattato come un oggetto. Anche il dono privato è sceso al livello di una funzione
sociale, a cui si destina una certa somma del proprio bilancio, e che si adempie di mala voglia, con una scettica
Pag. 3/7 Sessione ordinaria 2014
Prima prova scritta
Ministero dell’Istruzione, dell’ Università e della Ricerca
valutazione dell‟altro e con la minor fatica possibile. La vera felicità del dono è tutta nell‟immaginazione della felicità del
destinatario: e ciò significa scegliere, impiegare tempo, uscire dai propri binari, pensare l‟altro come un soggetto: il
contrario della smemoratezza. Di tutto ciò quasi nessuno è più capace. Nel migliore dei casi uno regala ciò che
desidererebbe per sé, ma di qualità leggermente inferiore. La decadenza del dono si esprime nella penosa invenzione
degli articoli da regalo, che presuppongono già che non si sappia che cosa regalare, perché, in realtà, non si ha nessuna
voglia di farlo. Queste merci sono irrelate come i loro acquirenti: fondi di magazzino fin dal primo giorno.» Theodor W. ADORNO, Minima moralia. Meditazioni della vita offesa, trad. it., Einaudi, Torino 1994 (ed. originale 1951)
«La Rete di certo promuove la diffusione di una nuova cultura del dono, dello scambio reciproco (o quasi). Possiamo
percorrere strade aperte, sconfinate, che offrono nuove possibilità di stabilire contatti e anche di dare vita a forme di
aggregazione fondate sostanzialmente sul dono, ma che rimangono racchiuse in piccole nicchie, microcosmi con cui
giocare o dove si può apprendere, nei quali ci si mostra, si costruiscono e si modificano identità, si condividono
interessi, si elaborano linguaggi. Un dono costretto quindi dentro piccole mura fatte di specchi, trasparenti, che
riflettono e amplificano la luce e i legami, ma che non sempre riescono a sopravvivere alle intemperie, agli improvvisi
venti del mondo contemporaneo. E quando si spezzano, non si può fare altro che costruire qualcosa di simile, un po‟
più in là. Una delle caratteristiche della Rete è quella di dare vita a comunità immaginate, che non sempre necessitano
di relazioni tra gli individui.» Marco AIME e Anna COSSETTA, Il dono al tempo di Internet, Einaudi, Torino 2010
«Difficilmente si diventa una persona generosa da soli: la generosità è una cosa che si impara. […] Quando un
dono s‟inserisce in una catena di reciprocità generalizzata, si lascia meno facilmente interpretare come un
fenomeno puramente individualistico e interessato. Nel caso di una reciprocità diretta, invece, la tentazione è forte
di assimilare lo scambio di doni a una variante dello scambio mercantile. […] È così che, in un mercoledì del mese
di luglio 2007, Barbara Bunnell diventa la prima paziente nella storia a ricevere un rene all‟interno di una catena di
reciprocità generalizzata. Dopo che il primo donatore regala il suo rene a Barb, Ron Bunnell, il marito di Barb,
darà un suo rene ad Angela Heckman; poi la madre di Angela darà un suo rene a qualcun altro ancora, e così via, in
una catena continua che aiuterà altre sette persone. All‟inizio di questa catena c‟è un giovane uomo, Matt Jones,
che accetta di donare un rene “senza perché”; cioè non per salvare dalla dialisi una persona cara, ma solo per la
gioia di aiutare sconosciuti.» Mark ANSPACH, Cosa significa ricambiare? Dono e reciprocità, in AA.VV., Cosa significa donare?, Guida, Napoli 2011
«Da una lettura sommaria e superficiale si può concludere che oggi non c‟è più posto per il dono ma solo per il mercato,
lo scambio utilitaristico, addirittura possiamo dire che il dono è solo un modo per simulare gratuità e disinteresse là dove
regna invece la legge del tornaconto. In un‟epoca di abbondanza e di opulenza si può addirittura praticare l‟atto del dono
per comprare l‟altro, per neutralizzarlo e togliergli la sua piena libertà. Si può perfino usare il dono - pensate agli «aiuti
umanitari» - per nascondere il male operante in una realtà che è la guerra. […] Ma c‟è pure una forte banalizzazione del
dono che viene depotenziato e stravolto anche se lo si chiama «carità»: oggi si «dona» con un sms una briciola a quelli
che i mass media ci indicano come soggetti - lontani! - per i quali vale la pena provare emozioni... Dei rischi e delle
possibili perversioni del dono noi siamo avvertiti: il dono può essere rifiutato con atteggiamenti di violenza o
nell‟indifferenza distratta; il dono può essere ricevuto senza destare gratitudine; il dono può essere sperperato: donare,
infatti, è azione che richiede di assumere un rischio. Ma il dono può anche essere pervertito, può diventare uno strumento
di pressione che incide sul destinatario, può trasformarsi in strumento di controllo, può incatenare la libertà dell‟altro
invece di suscitarla. I cristiani sanno come nella storia perfino il dono di Dio, la grazia, abbia potuto e possa essere
presentato come una cattura dell‟uomo, un‟azione di un Dio perverso, crudele, che incute paura e infonde sensi di colpa.
Situazione dunque disperata, la nostra oggi? No! Donare è un‟arte che è sempre stata difficile: l‟essere umano ne è
capace perché è capace di rapporto con l‟altro, ma resta vero che questo «donare se stessi» - perché di questo si tratta, non
solo di dare ciò che si ha, ciò che si possiede, ma di dare ciò che si è - richiede una convinzione profonda nei confronti
dell‟altro. Donare significa per definizione consegnare un bene nelle mani di un altro senza ricevere in cambio alcunché.
Bastano queste poche parole per distinguere il «donare» dal «dare», perché nel dare c‟è la vendita, lo scambio, il prestito.
Nel donare c‟è un soggetto, il donatore, che nella libertà, non costretto, e per generosità, per amore, fa un dono all‟altro,
indipendentemente dalla risposta di questo. Potrà darsi che il destinatario risponda al donatore e si inneschi un rapporto
reciproco, ma può anche darsi che il dono non sia accolto o non susciti alcuna reazione di gratitudine. Donare appare
dunque un movimento asimmetrico che nasce da spontaneità e libertà.» Enzo BIANCHI, Dono. Senza reciprocità – Festival filosofia – Carpi, 16/09/2012 – http://www.vita.it/non-profit/volontariato
Pag. 4/7 Sessione ordinaria 2014
Prima prova scritta
Ministero dell’Istruzione, dell’ Università e della Ricerca
2. AMBITO SOCIO - ECONOMICO
ARGOMENTO: Le nuove responsabilità.
DOCUMENTI
«Tanto la storiografia quanto la climatologia hanno tratto un grande impulso dall‟atterraggio sulla Luna del 1969. Fu
allora, infatti, che la fragilità della terra divenne visibile. Da quel momento la protezione della natura e dell‟ambiente
ha acquistato un‟importanza sempre maggiore, assumendo anzi il carattere di una vera e propria industria. Le
associazioni e le istituzioni ambientaliste lavorano sulla base di campagne di sensibilizzazione che, quanto a
professionalità, non sono seconde a quelle delle multinazionali. In particolare, a partire dagli anni novanta il timore
del Riscaldamento globale ha rimpiazzato i precedenti, come quello per la Moria dei boschi o quello per il Buco
nell’ozono. Ora, per la prima volta, alla sbarra non è più solo l‟industria, ma ogni consumatore finale. In pratica ogni
abitante della Terra è colpevole: il boscimano sudafricano, che incendia la savana per cacciare o per guadagnare
terreno coltivabile, e il fazendero argentino, i cui manzi producono metano, il coltivatore di riso a Bali e il banchiere
cinese, che fa i suoi affari in uno studio dotato di aria condizionata.» Wolfgang BEHRINGER, Storia culturale del clima, Bollati Boringhieri, Torino 2013 (prima ed. originale 2007)
«Crescita demografica e scelta coercitiva.
Anche se le paure maltusiane di lungo periodo per la produzione alimentare sono infondate, o almeno premature, ci
sono però buone ragioni per preoccuparsi, in generale, per il tasso di crescita della popolazione mondiale. Non si può
dubitare che, nell‟ultimo secolo, questo tasso abbia notevolmente accelerato: la popolazione mondiale ha impiegato
milioni di anni per raggiungere il primo miliardo, poi in 123 è arrivata al secondo, al terzo in 33, al quarto in 14, al
quinto in 13, e secondo le proiezioni delle Nazioni Unite il sesto promette di arrivare in altri 11. Il numero degli
abitanti del pianeta è cresciuto di 923 milioni solo nel decennio 1980-90, e questo aumento corrisponde quasi alla
popolazione complessiva di tutto il mondo all‟epoca di Malthus. Quanto agli anni Novanta, al loro termine pare non
abbiano registrato un‟espansione molto inferiore. Se un simile andamento proseguisse, la terra, sicuramente, sarebbe
sovraffollata in modo spaventoso prima ancora della fine del ventunesimo secolo. Molti segni indicano in modo
chiaro, tuttavia, che il tasso di crescita della popolazione mondiale sta cominciando a rallentare, per cui dobbiamo
chiederci: si rafforzeranno le ragioni della frenata? E, in caso affermativo, a quale ritmo? E non meno importante è
un‟altra domanda: è necessario un intervento pubblico per agevolare il rallentamento?» Amartya SEN, Lo sviluppo è libertà. Perché non c’è crescita senza democrazia, Mondadori, Milano 2012 (ed. originale 1999)
«L‟apprendistato della coesistenza con l‟altro, l‟escluso dalla costruzione della nostra tradizione, ci inizia a una
coesistenza mondiale che corrisponde a una delle sfide della nostra epoca. Aprire uno spazio all‟altro, a un mondo
differente dal nostro, all‟interno stesso della nostra propria tradizione, è il primo, e il più difficile, gesto
multiculturale. Incontrare lo straniero fuori dalle nostre frontiere è relativamente facile, e soddisfa anche le nostre
aspirazioni, finché possiamo rientrare da noi e appropriarci fra noi ciò che abbiamo così scoperto. Essere costretti a
restringere e modificare questo «da noi», il nostro modo di essere «a casa», è molto più difficile, soprattutto senza
che ciò provochi un‟infedeltà a noi stessi. […] Finché l‟altro non sarà riconosciuto e rispettato come ponte fra
natura e cultura, com‟è, prima, il caso per l‟altro genere, ogni tentativo di mondializzazione democratica resterà un
imperativo morale senza realizzazione concreta. Finché l‟universale non sarà considerato essere due, e l‟umanità
un luogo di coesistenza culturalmente feconda fra due generi irriducibilmente differenti, sempre una cultura vorrà
imporre il suo colore ed i suoi valori all‟altro, anche mediante la sua morale e la sua religione.» Luce IRIGARAY, Condividere il mondo, Bollati Boringhieri, Torino 2009 (ed. originale 2008)
«Ogni essere umano deve disporre di una “cittadinanza mondiale”. Nessuno deve essere più “apolide”. Ciascuno deve
sentirsi a casa propria sulla terra. Chiunque deve avere il diritto di lasciare il proprio paese d‟origine e di essere
accolto, almeno temporaneamente, in qualsiasi altro luogo. […] Reciprocamente, ogni essere umano ha dei doveri nei
confronti degli altri essere umani, delle generazioni che verranno, delle altre specie viventi e del pianeta. L‟umanità ha
in particolare il dovere di mostrare empatia verso le generazioni future e verso le altre specie necessarie alla sua
sopravvivenza. Deve quindi considerare come suo dovere creare le condizioni perché le prossime generazioni e le
altre specie possano esercitare i loro diritti. Deve disporre di un accesso a tutte le sue risorse e, in particolare, alla
ricchezza accumulata.» Jacques ATTALI, Domani, chi governerà il mondo?, Fazi Editore, Roma 2012 (ed. originale 2011)
Pag. 5/7 Sessione ordinaria 2014
Prima prova scritta
Ministero dell’Istruzione, dell’ Università e della Ricerca
3. AMBITO STORICO - POLITICO
ARGOMENTO: Violenza e non-violenza: due volti del Novecento.
DOCUMENTI
«Successivamente alla prima guerra mondiale, il Mito dell‟Esperienza della Guerra aveva dato al conflitto una
nuova dimensione come strumento di rigenerazione nazionale e personale. Il prolungarsi degli atteggiamenti degli
anni di guerra in tempo di pace incoraggiò una certa brutalizzazione della politica, un‟accentuata indifferenza per
la vita umana. Non erano soltanto la perdurante visibilità e lo status elevato dell‟istituzione militare in paesi come
la Germania a stimolare una certa spietatezza. Si trattava soprattutto di un atteggiamento mentale derivato dalla
guerra, e dall‟accettazione della guerra stessa. L‟effetto del processo di brutalizzazione sviluppatosi nel periodo tra
le due guerre fu di eccitare gli uomini, di spingerli all‟azione contro il nemico politico, oppure di ottundere la
sensibilità di uomini e donne di fronte allo spettacolo della crudeltà umana e alla morte. […] Dopo il 1918,
nessuna nazione poté sfuggire completamente al processo di brutalizzazione; in buona parte dell‟Europa, gli anni
dell‟immediato dopoguerra videro una crescita della criminalità e dell‟attivismo politico. Da un capo all‟altro
dell‟Europa, parve a molti che la Grande Guerra non fosse mai finita, ma si fosse prolungata nel periodo tra il
primo e il secondo conflitto mondiale. Il vocabolario della battaglia politica, il desiderio di distruggere totalmente
il nemico politico, e il modo in cui questi avversari venivano dipinti: tutto sembrò continuare la prima guerra
mondiale, anche se stavolta perlopiù contro nemici diversi (e interni).» George L. MOSSE, Le guerre mondiali. Dalla tragedia al mito dei caduti, trad. it., Roma-Bari 1990
«Per quale funzione la violenza possa, a ragione, apparire così minacciosa per il diritto e possa essere tanto temuta
da esso, si mostrerà con esattezza proprio là dove le è ancora permesso di manifestarsi secondo l‟attuale
ordinamento giuridico. È questo il caso della lotta di classe nella forma del diritto di sciopero garantito ai
lavoratori. I lavoratori organizzati sono oggi, accanto agli Stati, il solo soggetto di diritto cui spetti un diritto alla
violenza. Contro questo modo di vedere si può certamente obiettare che l‟omissione di azioni, un non-agire, come
in fin dei conti è lo sciopero, non dovrebbe affatto essere definita come violenza. Questa considerazione ha
certamente facilitato al potere statale la concessione del diritto di sciopero, quando ormai non si poteva più evitare.
Ma poiché non è incondizionata, essa non vale illimitatamente.» Walter BENJAMIN, Per la critica della violenza, 1921, trad. it., Alegre, Roma 2010
«Molto tempo prima che Konrad Lorenz scoprisse la funzione di stimolo vitale dell‟aggressività nel regno animale, la
violenza era esaltata come una manifestazione della forza della vita e segnatamente della sua creatività. Sorel, ispirato
dall‟élan vital di Bergson, mirava a una filosofia della creatività destinata ai «produttori» e polemicamente rivolta contro
la società dei consumi e i suoi intellettuali; tutti e due, a suo avviso, gruppi parassitari. […] Nel bene e nel male – e credo
che non manchino ragioni per essere preoccupati come per nutrire speranze – la classe veramente nuova e potenzialmente
rivoluzionaria della società sarà composta di intellettuali, e il loro potere virtuale, non ancora materializzato, è molto
grande, forse troppo grande per il bene dell‟umanità. Ma queste sono considerazioni che lasciano il tempo che trovano.
Comunque sia, in questo contesto ci interessa soprattutto lo strano revival delle filosofie vitalistiche di Bergson e di
Nietzsche nella loro versione soreliana. Tutti sappiamo fino a che punto questa combinazione di violenza, vita e creatività
sia presente nell‟inquieta situazione mentale della generazione odierna. Non c‟è dubbio che l‟accento posto sulla pura
fattualità del vivere, e quindi sul fare l‟amore inteso come la più gloriosa manifestazione della vita, sia una reazione alla
possibilità reale che venga costruita una macchina infernale capace di mettere fine alla vita sulla terra. Ma le categorie in
cui i nuovi glorificatori della vita riconoscono se stessi non sono nuove. Vedere la produttività della società
nell‟immagine della „creatività‟ della vita è cosa vecchia almeno quanto Marx, credere nella violenza come forza vitale è
cosa vecchia almeno quanto Bergson.» Hannah ARENDT, Sulla violenza, trad. it., Guanda, Parma 1996 (ed. originale 1969)
«Non sono un visionario. Affermo di essere un idealista pratico. La religione della non violenza non è fatta solo
per i Rishi [saggi] e i santi. È fatta anche per la gente comune. La non violenza è la legge della nostra specie, come
la violenza è la legge dei bruti. Lo spirito resta dormiente nel bruto, ed egli non conosce altra legge che quella della
forza fisica. La dignità dell‟uomo esige ubbidienza a una legge più alta, alla forza dello spirito. […] Nella sua
condizione dinamica, non violenza significa sofferenza consapevole. Non vuol dire sottomettersi docilmente alla
volontà del malvagio, ma opporsi con tutta l‟anima alla volontà del tiranno. Agendo secondo questa legge del
nostro essere, è possibile al singolo individuo sfidare tutta la potenza di un impero ingiusto per salvare il proprio
Pag. 6/7 Sessione ordinaria 2014
Prima prova scritta
Ministero dell’Istruzione, dell’ Università e della Ricerca
onore, la religione, l‟anima, e porre le basi della caduta di questo impero o della sua rigenerazione. E così non
propugno che l‟India pratichi la non violenza perché è debole. Voglio che pratichi la non violenza essendo
consapevole della propria forza e del proprio potere. […] La mia missione è di convertire ogni indiano, ogni
inglese e infine il mondo alla non violenza nel regolare i reciproci rapporti, siano essi politici, economici, sociali o
religiosi. Se mi si accusa di essere troppo ambizioso, mi confesserò colpevole. Se mi si dice che il mio sogno non
potrà mai attuarsi, risponderò che “è possibile” e proseguirò per la mia strada.» Mohandas K. GANDHI, Antiche come le montagne, Edizioni di Comunità, Milano 1975
«Sono felice di unirmi a voi in questa che passerà alla storia come la più grande dimostrazione per la libertà nella
storia del nostro paese. […] Siamo anche venuti in questo santuario per ricordare all‟America l‟urgenza appassionata
dell‟adesso. Questo non è il momento in cui ci si possa permettere che le cose si raffreddino o che si trangugi il
tranquillante del gradualismo. Questo è il momento di realizzare le promesse della democrazia; questo è il momento
di levarsi dall‟oscura e desolata valle della segregazione al sentiero radioso della giustizia; questo è il momento di
elevare la nostra nazione dalle sabbie mobili dell‟ingiustizia razziale alla solida roccia della fratellanza; questo è il
tempo di rendere vera la giustizia per tutti i figli di Dio. […] Non ci sarà in America né riposo né tranquillità fino a
quando ai negri non saranno concessi i loro diritti di cittadini. I turbini della rivolta continueranno a scuotere le
fondamenta della nostra nazione fino a quando non sarà sorto il giorno luminoso della giustizia. Ma c‟è qualcosa che
debbo dire alla mia gente che si trova qui sulla tiepida soglia che conduce al palazzo della giustizia. In questo nostro
procedere verso la giusta meta non dobbiamo macchiarci di azioni ingiuste. Cerchiamo di non soddisfare la nostra sete
di libertà bevendo alla coppa dell‟odio e del risentimento. Dovremo per sempre condurre la nostra lotta al piano alto
della dignità e della disciplina. Non dovremo permettere che la nostra protesta creativa degeneri in violenza fisica.
Dovremo continuamente elevarci alle maestose vette di chi risponde alla forza fisica con la forza dell‟anima.» Martin Luther KING - http://www.repubblica.it/esteri/2013/08/28/news/martin_luther-king-discorso-65443575/
4. AMBITO TECNICO - SCIENTIFICO
ARGOMENTO: Tecnologia pervasiva.
DOCUMENTI
«Anche la Silicon Valley ha la sua religione. E potrebbe presto diventare il paradigma dominante tra i vertici e gli addetti
ai lavori della culla dell‟innovazione contemporanea. È il «transumanismo» e si può definire, scrive il saggista Roberto
Manzocco in “Esseri Umani 2.0” (Springer, pp. 354), come «un sistema coerente di fantasie razionali parascientifiche»,
su cui la scienza cioè non può ancora pronunciarsi, «che fungono da risposta laica alle aspirazioni escatologiche delle
religioni tradizionali». Per convincersene basta scorrerne i capisaldi: il potenziamento delle nostre capacità fisiche e
psichiche; l‟eliminazione di ogni forma di sofferenza; la sconfitta dell‟invecchiamento e della morte. Ciò che piace ai
geek della Valley è che questi grandiosi progetti di superamento dell‟umano nel “post-umano” si devono, e possono,
realizzare tramite la tecnologia. E tecniche, la cui fattibilità è ancora tutta da scoprire, come il “mind uploading”, ossia il
trasferimento della coscienza su supporti non biologici, e le “nanomacchine”, robot grandi come virus in grado di riparare
le cellule cancerose o i danni da malattia degenerativa direttamente a livello molecolare.» Fabio CHIUSI, TRANS UMANO la trionferà, “l‟Espresso” – 6 febbraio 2014
«Lord Martin Rees, docente di Astrofisica all‟Università di Cambridge e astronomo della Regina, la vede un po‟
diversamente: i robot sono utili per lavorare in ambienti proibitivi per l‟uomo – piattaforme petrolifere in fiamme,
miniere semidistrutte da un crollo, centrali in avaria che perdono sostanze radioattive – oltre che per svolgere mestieri
ripetitivi. Ma devono restare al livello di «utili idioti: la loro intelligenza artificiale va limitata, non devono poter svolgere
mestieri intellettuali complessi». L‟astronomo della Corte d‟Inghilterra, occhi rivolti più alle glorie del passato che alle
speranze e alle incognite di un futuro comunque problematico, propone una ricetta che sa di luddismo. Una ricetta
anacronistica ed estrema che si spiega con l‟angoscia che prende molti di noi davanti alla rapidità con la quale la civiltà
dei robot – della quale abbiamo favoleggiato per decenni e che sembrava destinata a restare nei libri di fantascienza – sta
entrando nelle nostre vite. Che i robot stiano uscendo dalle fabbriche lo sappiamo da tempo: il bancomat è un bancario
trasformato in macchina, in servizio notte e giorno. In molti supermercati il cassiere non c‟è più, sostituito da sensori,
lettori di codici a barre, sistemi di pagamento automatizzati. In Giappone e Francia si moltiplicano treni e metropolitane
guidate da un computer (è così la nuova Linea 5 della metropolitana di Milano), così come tutti i convogli che si
muovono all‟interno dei grandi aeroporti del mondo sono, ormai, senza conducente.» Massimo GAGGI, E il robot prepara cocktail e fa la guerra, “Corriere della Sera. la Lettura” – 26 gennaio 2014
Pag. 7/7 Sessione ordinaria 2014
Prima prova scritta
Ministero dell’Istruzione, dell’ Università e della Ricerca
«Per molto tempo al centro dell‟attenzione sono state le tecnologie e gli interrogativi che si portano dietro: «Meglio i
tablet o i netbook?», «Android, iOs o Windows?», seguiti da domande sempre più dettagliate «Quanto costano, come
si usano, quali app…». Intanto i docenti hanno visto le classi invase da Lim, proiettori interattivi, pc, registri
elettronici o tablet, senza riuscire a comprendere quale ruolo avrebbero dovuto assumere, soprattutto di fronte a
ragazzi tecnologicamente avanzati che li guardavano con grandi speranze e aspettative. Per gli studenti si apre una
grande opportunità: finalmente nessuno proibisce più di andare in internet, di comunicare tramite chat, di prendere
appunti in quaderni digitali o leggere libri elettronici.» Dianora BARDI, La tecnologia da sola non fa scuola, “Il Sole 24 ORE. nòva” – 12 gennaio 2014
«Passando dal tempo che ritorna al tempo che invecchia, dal tempo ciclico della natura regolato dal sigillo della necessità
al tempo progettuale della tecnica percorso dal desiderio e dall‟intenzione dell‟uomo, la storia subisce un sussulto. Non
più decadenza da una mitica età dell‟oro, ma progresso verso un avvenire senza meta. La progettualità tecnica, infatti,
dice avanzamento ma non senso della storia. La contrazione tra “recente passato” e “immediato futuro”, in cui si
raccoglie il suo operare, non concede di scorgere fini ultimi, ma solo progressi nell‟ordine del proprio potenziamento.
Null‟altro, infatti, vuole la tecnica se non la propria crescita, un semplice “sì” a se stessa. L‟orizzonte si spoglia dei suoi
confini. Inizio e fine non si congiungono più come nel ciclo del tempo, e neppure si dilatano come nel senso del tempo.
Le mitologie perdono la loro forza persuasiva. Tecnica vuol dire, da subito, congedo dagli dèi.» Umberto GALIMBERTI, Psiche e techne. L’uomo nell’età della tecnica, Feltrinelli, Milano 2002
TIPOLOGIA C - TEMA DI ARGOMENTO STORICO
L‟Europa del 1914 e l‟Europa del 2014: quali le differenze?
Il candidato esamini la questione sotto almeno tre dei seguenti profili: forme istituzionali degli Stati principali;
stratificazione sociale; rapporti fra cittadini e istituzioni; sistemi di alleanze; rapporti fra gli Stati europei; rapporti
fra l‟Europa e il resto del mondo.
TIPOLOGIA D - TEMA DI ORDINE GENERALE
«Siamo un Paese straordinario e bellissimo, ma allo stesso tempo molto fragile. È fragile il paesaggio e sono fragili le
città, in particolare le periferie dove nessuno ha speso tempo e denaro per far manutenzione. Ma sono proprio le
periferie la città del futuro, quella dove si concentra l‟energia umana e quella che lasceremo in eredità ai nostri figli.
C‟è bisogno di una gigantesca opera di rammendo e ci vogliono delle idee. […] Le periferie sono la città del futuro,
non fotogeniche d‟accordo, anzi spesso un deserto o un dormitorio, ma ricche di umanità e quindi il destino delle città
sono le periferie. […] Spesso alla parola “periferia” si associa il termine degrado. Mi chiedo: questo vogliamo lasciare
in eredità? Le periferie sono la grande scommessa urbana dei prossimi decenni. Diventeranno o no pezzi di città?»
Renzo PIANO, Il rammendo delle periferie, “Il Sole 24 ORE” del 26 gennaio 2014
Rifletti criticamente su questa posizione di Renzo Piano, articolando in modo motivato le tue considerazioni e
convinzioni al riguardo.
___________________________
Durata massima della prova: 6 ore.
È consentito l‟uso del dizionario italiano.
È consentito l‟uso del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i candidati di madrelingua non italiana.
Non è consentito lasciare l‟Istituto prima che siano trascorse 3 ore dalla dettatura del tema.
Pag. 1/2 Sessione ordinaria 2016
Seconda prova scritta
Ministero dell’Istruzione, dell’ Università e della Ricerca
M762 – ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
Indirizzo: IPAM - MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA
OPZIONE APPARATI, IMPIANTI E SERVIZI TECNICI INDUSTRIALI E CIVILI
CURVATURA MECCANICA
Tema di: TECNOLOGIE, INSTALLAZIONE, MANUTENZIONE, APPARATI,
IMPIANTI CIVILI E INDUSTRIALI
Il candidato svolga la prima parte della prova e due dei quesiti proposti nella seconda parte.
PRIMA PARTE
Con il termine macchina si indica, in campo tecnologico, un dispositivo composto da diversi
componenti, a volte complesso, che ha lo scopo di compiere un lavoro, potenziando il lavoro fatto
dall’uomo, o in grado di trasformare l’energia da una forma ad un’altra. Sono esempi di macchina i
torni, le fresatrici, i trapani, ma anche le caldaie, i compressori, i frigoriferi.
Il candidato, dopo aver scelto una delle macchine studiate durante il proprio percorso di studio:
ne dia una definizione, elenchi e descriva i componenti principali e spieghi come questi
concorrono al funzionamento della macchina stessa;
predisponga un piano di manutenzione della macchina, evidenziando la periodicità degli
interventi, gli strumenti da utilizzare, i rischi connessi alle attività da svolgere e tutto quanto
concorra ad eseguire la manutenzione in sicurezza;
faccia un stima dei costi di manutenzione annuali legati alla macchina, elaborando il relativo
preventivo di spesa.
Eventuali dati non espressamente presenti nel testo possono essere assunti dal candidato, purché
risultino contestualizzati e giustificati appropriatamente.
SECONDA PARTE
1. Il candidato, facendo riferimento ad un’attività pratica svolta in ambiente scolastico o durante
un’esperienza lavorativa e/o di stage, descriva un intervento di smontaggio e rimontaggio di un
componente tecnico, spiegando le successive fasi dell’intervento. Si delinei la strategia operativa,
mettendo in risalto gli attrezzi necessari, i dispositivi di sicurezza da adottare, eventuale materiale
di consumo o pezzi di ricambio da utilizzare. Elabori inoltre un documento di collaudo che
garantisca, al termine dell’intervento, il corretto funzionamento del dispositivo.
2. Un impianto di generazione dell’aria compressa è alimentato da due compressori che possono
lavorare contemporaneamente o alternativamente, a seconda della portata di aria richiesta
dall’utenza. Si chiede al candidato di scegliere, tra le tipologie di manutenzione previste dalla
normativa, quelle che si ritengono più idonee, motivando le scelte fatte. Si chiede inoltre un
parere sulla telemanutenzione e/o teleassistenza, valutando se tale tecnologia potrebbe fornire un
valido supporto al servizio di manutenzione richiesto.
Pag. 2/2 Sessione ordinaria 2016
Seconda prova scritta
Ministero dell’Istruzione, dell’ Università e della Ricerca
M762 – ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
Indirizzo: IPAM - MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA
OPZIONE APPARATI, IMPIANTI E SERVIZI TECNICI INDUSTRIALI E CIVILI
CURVATURA MECCANICA
Tema di: TECNOLOGIE, INSTALLAZIONE, MANUTENZIONE, APPARATI,
IMPIANTI CIVILI E INDUSTRIALI
3. Il termine inglese “troubleshooting” indica il processo di identificazione ed eliminazione di un
guasto. Il processo deve essere sequenziale, logico, progressivo ed è necessario per un approccio
sistematico ad una manutenzione efficace. Il candidato predisponga un foglio di diagnosi atto a
selezionare, catalogare, filtrare le cause di guasto di un impianto o di una macchina, allo scopo
di ridurre al minimo il numero di cause possibili. Si contestualizzi eventualmente il foglio di
diagnosi richiesto mediante un caso applicativo.
4. Un’officina meccanica è provvista di 18 torni uguali funzionanti nella fase dei guasti casuali. In
un intervallo di tempo di 1500 ore si verificano 6 guasti ed in particolare dopo 250, 600, 680,
720, 1230 e 1350 ore. Si chiede al candidato di calcolare il tasso di guasto delle macchine e di
calcolarne l’affidabilità nell’intervallo di tempo considerato. Rappresenti inoltre la curva
dell’affidabilità, descrivendone le diverse fasi.
___________________________
Durata massima della prova: 6 ore.
È consentito soltanto l’uso di manuali tecnici e di calcolatrici non programmabili.
È consentito l’uso del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i candidati di madrelingua non italiana.
Non è consentito lasciare l’Istituto prima che siano trascorse 3 ore dalla dettatura del tema.