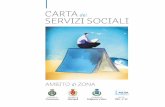DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE · 2015/2016 e 2016/2017 era composta rispettivamente da 22 e 26...
Transcript of DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE · 2015/2016 e 2016/2017 era composta rispettivamente da 22 e 26...
MD10P8.2_01/rev.03 pag.1 di 55
DOCUMENTO DEL
CONSIGLIO DI CLASSE
Settore ECONOMICO
Indirizzo AMMINISTRAZIONE, FINANZA E MARKETING
Articolazione SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI
Classe QUINTA Sezione A
Anno Scolastico 2017-2018
Pubblicizzazione mediante pubblicazione nella sezione "studenti" del sito web
dell’Istituto e nella "bacheca" delle classi quinte del registro elettronico in data 15
maggio 2018
COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE
DISCIPLINA DOCENTE
Lingua e letteratura italiana Manoni Francesca
Storia Manoni Francesca
Lingua inglese Lucci Sabrina
Economia Aziendale Ludovico Elisabetta
Diritto Ballante Ivana
Economia Politica Ballante Ivana
Matematica Gianangeli M.Rita
Informatica Bavosi Mauro
Laboratorio di informatica Favi Carlo
Scienze motorie e sportive Di Marino Marina
Religione Contadini Michele
MD10P8.2_01/rev.03 pag.2 di 55
INDICE
1. OBIETTIVI GENERALI DELL’INDIRIZZO DI STUDI 3
1.1 RISULTATI DI APPRENDIMENTO 3
2. PROFILO DELLA CLASSE E LA PROGRAMMAZIONE 4
2.1 IL PROFILO DELLA CLASSE 4
2.2 ARGOMENTI PLURIDISCIPLINARI 5
2.3 METODO DI LAVORO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 5
2.4 LA PROGRAMMAZIONE DELLE SINGOLE DISCIPLINE. 7
3. ATTIVITA’ CURRICULARI, EXTRACURRICULARI E INTEGRATIVE 7
4. VALUTAZIONE 8
5. ALLEGATI 9
MD10P8.2_01/rev.03 pag.3 di 55
1. OBIETTIVI GENERALI DELL’INDIRIZZO DI STUDI
A conclusione del percorso quinquennale il Diplomato in “Amministrazione, Finanza e
Marketing” articolazione “Sistemi informativi aziendali”, oltre a possedere una solida base
culturale a carattere scientifico e tecnologico in linea con le indicazioni dell’Unione europea, ha
competenze generali nel campo dei macrofenomeni economici nazionali ed internazionali, della
normativa civilistica e fiscale, dei sistemi e processi aziendali (organizzazione, pianificazione,
programmazione, amministrazione, finanza e controllo), degli strumenti di marketing, dei
prodotti assicurativo-finanziari e dell’economia sociale. Integra le competenze dell’ambito
professionale specifico con quelle linguistiche e informatiche per operare nel sistema
informativo dell’azienda e contribuire sia all’innovazione sia al miglioramento organizzativo e
tecnologico dell’impresa inserita nel contesto internazionale.
Il profilo si caratterizza per il riferimento sia nell’ambito della gestione del sistema informativo
aziendale sia nella valutazione, nella scelta e nell’adattamento di software applicativi. Tali
attività sono tese a migliorare l’efficienza aziendale attraverso la realizzazione di nuove
procedure, con particolare riguardo al sistema di archiviazione, all’organizzazione della
comunicazione in rete e alla sicurezza informatica.
1.1 RISULTATI DI APPRENDIMENTO SPECIFICATI IN TERMINI DI COMPETENZE DA CONSEGUIRE A CONCLUSIONE DELL’ANNO SCOLASTICO
La programmazione del Consiglio di Classe è basata sui risultati di apprendimento definiti in
termini di competenze, abilità e conoscenze, contenuti nella mappa delle competenze e nella
matrice competenze/discipline del quinto anno, parti integranti del presente documento, non
allegate ma depositate in segreteria didattica e pubblicate nel sito della scuola.
MD10P8.2_01/rev.03 pag.4 di 55
2. PROFILO DELLA CLASSE E LA PROGRAMMAZIONE
2.1 IL PROFILO DELLA CLASSE
Evoluzione della classe nel triennio
La classe attualmente si compone di 11 studenti, 9 maschi e 2 femmine, ma negli anni scolastici
2015/2016 e 2016/2017 era composta rispettivamente da 22 e 26 alunni in quanto articolata con il
corso turistico.
terza articolata Sia /Tur
22 alunni provenienti da
varie seconde
quarta articolata Sia /Tur 26 alunni di cui 13 Sia 2 respinti
quinta 11
Permanenza dei docenti
Nel corso degli anni c’è stato un avvicendamento dei docenti e come si può desumere dalla
tabella sottostante nessun docente, eccetto diritto ed economia politica, scienze motorie e
religione, ha avuto una continuità triennale.
disciplina terzo quarto quinto
Lingua e letteratura italiana Cinti Gabrilella Cinti Gabrilella Manoni Francesca
Storia Cinti Gabriella Cinti Gabrilella Manoni Francesca
Lingua inglese Socci Gioietta lucci Sabrina Lucci Sabrina
Economia Aziendale Scarcia Sonia Ludovico Elisabetta Ludovico Elisabetta
Diritto Ballante Ivana Ballante Ivana Ballante Ivana
Economia Politica Ballante Ivana Ballante Ivana Ballante Ivana
Matematica Galdenzi Francesca Gianangeli Maria Rita Gianangeli Maria Rita
Informatica Pigini Marcello
Laboratorio di informaticaFavi Carlo
Scienze motorie e sportive
ReligioneDi Marino Marina
Contadini Michele
anno
Mastantuono Catia Franca
Bavosi Mauro
Partecipazione
La classe si è rivelata aperta ai rapporti umani con i docenti e al dialogo educativo tuttavia si è
dimostrata poco incline ad affrontare le singole discipline con apporto personale e critico. Solo un
gruppo ristretto ha collaborato in modo approfondito e costruttivo.
Impegno
Alcuni alunni hanno studiato costantemente e con interesse le tematiche affrontate ma ci sono
stati casi in cui l’impegno è stato saltuario, inadeguato e finalizzato alle verifiche. I lavori assegnati
non sempre sono stati svolti e portati a termine e questo ha comportato, nonostante l’esiguo
MD10P8.2_01/rev.03 pag.5 di 55
numero di alunni, un rallentamento nello svolgimento del programma in alcune discipline e di
conseguenza a un minor numero di esercitazioni.
Le attività extracurriculari di cui molte legate all’ alternanza scuola lavoro e la sospensione delle
lezioni per motivi legati al maltempo hanno ovviamente limitato lo svolgimento dei programmi
disciplinari e il loro approfondimento
Il profitto mediamente è più che sufficiente anche se ci sono situazioni con lacune di base
soprattutto nel settore economico e informatico
Metodo di studio
Per quanto riguarda il metodo di studio alcuni alunni sono riusciti a rielaborare i contenuti e ad
apportare proprie considerazioni personali. Un numero più ampio necessita della guida dei
docenti in quanto il metodo di studio è mnemonico e finalizzato al raggiungimento di risultati
essenziali.
2.2 ARGOMENTI PLURIDISCIPLINARI
ARGOMENTI DISCIPLINE
Contabilità analitica, ammortamenti e problemi di scelta Matematica – Economia Aziendale
Evoluzione dello Stato e delle sue forme politiche Storia - Diritto
La Seconda Guerra Mondiale. La ricerca operativa Italiano – Storia - Matematica
Sistemi di rete Informatica - Inglese
Il decadentismo estetico di fine 800 Inglese - Italiano
2.3 METODO DI LAVORO DEL CONSIGLIO DI CLASSE
I docenti hanno utilizzato le seguenti metodologie didattiche:
Disciplina lezione frontale
lezione guidata
ricerca indivi-duale
lavoro di
gruppo
analisi
di casi
problem solving
simula-zione
attività laborato-
riale altro
Italiano X X
Storia X X
Inglese X X x
Informatica X X X X X X
Economia aziendale X X X X X
MD10P8.2_01/rev.03 pag.6 di 55
Disciplina lezione frontale
lezione guidata
ricerca indivi-duale
lavoro di
gruppo
analisi
di casi
problem solving
simula-zione
attività laborato-
riale altro
Diritto x x x x
Economia politica x x x x
Matematica X X x x x x
Sc.motorie X x x x
Religione X X X
Tenuto conto:
• degli orientamenti forniti nelle LINEE GUIDA per il passaggio al Nuovo Ordinamento degli
Istituti Tecnici che prevedono l’insegnamento in lingua inglese di una disciplina non
linguistica (DNL) compresa nell’area di indirizzo del quinto anno,
• che l’insegnamento è finalizzato a potenziare le conoscenze e le abilità proprie della
disciplina da veicolare in lingua inglese attraverso la contemporanea acquisizione dei
diversi codici linguistici,
• della totale assenza di docenti DNL in possesso delle necessarie competenze linguistiche e
metodologiche all’interno dell’organico dell’Istituto Tecnico Cuppari,
• che il Consiglio di classe ha individuato Informatica come disciplina non linguistica
compresa nell’area di indirizzo del quinto anno per l’insegnamento in lingua inglese, le
modalità operative e i contenuti da sviluppare con la metodologia CLIL.
L’insegnamento in lingua inglese di alcuni contenuti di Informatica è avvenuto attraverso letture
specifiche relative ad aspetti tecnologici riguardanti il web e le reti.
A supporto delle metodologie didattiche sono stati utilizzati i seguenti strumenti:
disciplina testi dispense documenti autentici
laboratori audiovisivi tecnologie
multimediali altro
Italiano X x
Storia x
Inglese x x x x
Informatica X X X X
Economia aziendale X X X X C.C
Diritto x X x
Economia politica x x x
MD10P8.2_01/rev.03 pag.7 di 55
disciplina testi dispense documenti autentici
laboratori audiovisivi tecnologie
multimediali altro
Matematica X X x
Sc.motorie x x
Religione X X X
2.4 LA PROGRAMMAZIONE DELLE SINGOLE DISCIPLINE.
I risultati di apprendimento disciplinari, concordati nelle riunioni di dipartimento e formulati in
coerenza con quelli individuati dal Consiglio di Classe, sono esplicitati da ciascun docente nella
programmazione didattica disciplinare e nelle unità di apprendimento, parti integranti del
presente documento, non allegate ma depositate in segreteria didattica e pubblicate nel sito della
scuola, con l’indicazione delle conoscenze e abilità inerenti le competenze da conseguire.
I programmi svolti delle singole discipline sono riportati nelle schede allegate (All. 1), dove,
inoltre, sono indicati i criteri di selezione dei contenuti.
3. ATTIVITA’ CURRICULARI, EXTRACURRICULARI E INTEGRATIVE • Alternanza scuola lavoro svolta nel triennio
• Contamination Lab (CLab), percorso di accompagnamento e formazione alla cultura
d’impresa e all’imprenditorialità
• Formazione specifica sulla sicurezza nel posto di lavoro
• Attività di orientamento al lavoro (confartigianato)
• Attività sportive
• Certificazioni di lingua straniera: PET
• Olimpiadi della matematica
• Viaggi di istruzione: Stage linguistico a Malta (terza), Inghilterra in IV , Praga (quinta)
• Attività di orientamento universitario
• Dibattiti e convegni :
- “Lectio magistralis” Prof. Paolo Grossi, Presidente della Corte Costituzionale.
- Celebrazione del 70° anniversario dell’entrata in vigore della Costituzione italiana
intervento del Prof. Alberto Fabbri dell’Università di Urbino sul tema “I diritti fondamentali
dell’uomo nella Costituzione Repubblicana”.
- Conferenza sulla Legge Elettorale
- Regione Marche - Giornata informativa su Trasparenza amministrativa e anticorruzione
- Lasciami volare” - Incontro testimonianza con Giampietro Ghidini
- “Bullismo e cyberbullismo”: incontri con Polizia Postale e Polizia Locale
- Incontro pubblico con Carlo Cottarelli, Direttore esecutivo del Fondo Monetario
Internazionale
• Proiezioni di film in lingua
• Incontri con esperti (Educazione finanziaria, Avis, Fondi europei alle imprese)
MD10P8.2_01/rev.03 pag.8 di 55
4. VALUTAZIONE
Il Collegio dei Docenti ha stabilito i seguenti indicatori dei livelli di padronanza.
Voto / 10
CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE
9 - 10 Complete, ben
articolate ed
approfondite
Scelta e gestione autonoma
di metodi, strumenti e
informazioni per svolgere
compiti e risolvere problemi,
anche in situazioni complesse
Risolvere problemi specifici in un campo di
lavoro o di studio.
Sapersi gestire autonomamente nel
quadro delle istruzioni in un contesto di
lavoro o di studio, di solito prevedibili, ma
soggette a cambiamenti.
Assumere responsabilità in un gruppo di
lavoro per il conseguimento di risultati
8 Sostanzialmente
complete, con spunti di
approfondimento
Scelta e gestione di metodi,
strumenti e informazioni per
svolgere compiti e risolvere
problemi
Svolgere compiti e risolvere problemi
scegliendo e applicando metodi di base,
strumenti, materiali ed informazioni.
Assumere la responsabilità di portare a
termine compiti nell’ambito dello studio e
del lavoro, anche di gruppo.
Adeguare il proprio comportamento alle
circostanze nella soluzione dei problemi
7 Di base corrette e
chiare
Applicazione corretta di
conoscenze acquisite per
svolgere compiti e risolvere
problemi ricorrenti
Svolgere compiti e risolvere problemi
ricorrenti, usando strumenti e regole
semplici sotto la supervisione, con un
certo grado di autonomia
6 Generali di base,
essenziali, senza errori
determinanti
Applicazione guidata di
conoscenze di base
necessarie a svolgere compiti
semplici
Svolgere compiti semplici sotto la diretta
supervisione in un contesto strutturato
5 Superficiali ed
incomplete, con
qualche errore
Applicazione parziale di
conoscenze essenziali con
alcuni errori
Svolgere in modo non autonomo e non
adeguato compiti anche semplici
3 - 4 Lacunose con errori
gravi e diffusi
Applicazione di conoscenze
solo su pochi argomenti con
frequenti e gravi errori
Svolgere in modo incostante, inadeguato e
non autonomo compiti semplici
LE PROVE SIA SCRITTE CHE ORALI, NON SVOLTE O COMPLETAMENTE ERRATE, SARANNO VALUTATE 1-2/10
MD10P8.2_01/rev.03 pag.9 di 55
Per quanto riguarda la tipologia e la valutazione delle prove effettuate a carattere
Pluridisciplinare si rinvia agli allegati (All.2)
5. ALLEGATI
1. Programmi svolti delle singole discipline;
2. Testi delle simulazioni di terza prova, griglie di valutazione;
I COMPONENTI IL CONSIGLIO DI CLASSE
NOME E COGNOME FIRMA
Manoni Francesca
Lucci Sabrina
Ludovico Elisabetta
Ballante Ivana
Gianangeli M.Rita
Bavosi Mauro
Favi Carlo
Di Marino Marina
Contadini Michele
Jesi, 8 maggio 2018
MD10P8.2_01/rev.03 pag.11 di 55
All. 1
Istituto Tecnico Statale
“PIETRO CUPPARI”
Jesi
Settore ECONOMICO
Indirizzo AMMINISTRAZIONE, FINANZA E MARKETING
Articolazione SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI
Classe Quinta Sezione A
Disciplina
LINGUA E LETTERATURA ITALIANA
Prof. Manoni Francesca
Anno Scolastico 2017/2018
MD10P8.2_01/rev.03 pag.12 di 55
Criteri di selezione dei contenuti
Programma ministeriale
Programma svolto
G.Leopardi: concezione di vita e poetica
Idilli: L’infinito
Operette morali: Dialogo della natura e di un islandese, Dialogo di Colombo e Gutierrez
Canti pisano-recanatesi: A Silvia, Il passero solitario, Il sabato del villaggio, La quiete dopo la
tempesta
La ginestra: alcuni versi
La figura dell’artista: perdita dell’aura e dell’aureola
L’ età del Realismo: Scapigliatura, Naturalismo, Verismo
Alle origini della poesia moderna: simbolismo e allegorismo in Baudelaire
Lettura di : Corrispondenze
Il cigno (alcuni versi), L’albatro
Giovanni Verga
Poetica dell’autore. I vinti. Bisogni materiali e valori ideali; l’amore passione in Vita dei campi.
Il tema della roba in Novelle rusticane.
L’idillio familiare, la duplicità di toni, spazio e tempo, la legge dell’ostrica, il tema dell’esclusione
nei Malavoglia.
I personaggi e le vicende di Mastro don Gesualdo: un romanzo senza idillio, lo spazio e il tempo
degli affari.
Novelle: Nedda
Da Vita dei campi : Prefazione a “L’amante di Gramigna” (Dedicatoria a Salvatore Farina)
Rosso Malpelo
La lupa
Da Novelle rusticane :
La roba
Libertà
Da “I Malavoglia” :
Prefazione
MD10P8.2_01/rev.03 pag.13 di 55
Letture antologiche
Da Mastro don Gesualdo :
La morte di Gesualdo
Decadentismo. L’estetismo e l’eroe decadente, il superuomo, il naturalismo panico in D’Annunzio.
La poesia delle “piccole cose”; il nido e la patria; il rapporto con i morti; il rapporto con la natura e
l’incubo funebre nel Pascoli.
Gabriele D’Annunzio
Significato dei romanzi :
Il piacere
L’innocente
Le vergini delle rocce
Da Alcione :
La sera fiesolana
La pioggia nel pineto
Giovanni Pascoli
Testi in prosa :
Il fanciullino
La grande proletaria si è mossa
Da Myricae :
Lavandare
X Agosto
Il lampo
L’assiuolo
Temporale
Dai “Canti di Castelvecchio”
La tovaglia
Il gelsomino notturno
Nebbia
La poesia (alcuni versi)
Crepuscolari e futuristi
MD10P8.2_01/rev.03 pag.14 di 55
Il romanzo del ‘900: caratteristiche
Il romanzo del ‘900 in Italia
Vita e arte in Pirandello. Il testamento. P. e il fascismo. La poetica dell’umorismo, il relativismo
filosofico, il contrasto vita-forma, l’uomo senza identità, il surrealismo, teatro del grottesco e
metateatro.
L’inetto di Svevo.
Luigi Pirandello
Letture dal saggio L’umorismo
Significato dei romanzi :
L’esclusa
I vecchi e i giovani
Il fu Mattia Pascal
Uno, nessuno, centomila
Da Novelle per un anno :
Il treno ha fischiato
C’è qualcuno che ride
Teatro :
Così è se vi pare
I sei personaggi in cerca d’autore
Italo Svevo:
La coscienza di Zeno (letture antologiche)
Caratteri fondamentali della lirica ermetica; l’esperienza della trincea nella lirica di Ungaretti, il
valore della parola poetica.
Il male di vivere, il tema della memoria, il pessimismo e il rigore morale nella poesia di Montale.
L’ esperienza della guerra nella poesia di Quasimodo.
Giuseppe Ungaretti
Da Allegria di naufragi :
S. Martino del Carso
Natale
Veglia
Mattina
Soldati
Fratelli
Eugenio Montale
MD10P8.2_01/rev.03 pag.15 di 55
Da Ossi di seppia :
Cigola la carrucola
Non chiederci la parola
Da “L e occasioni”:
La casa dei doganieri
Da “La bufera ed altro” :
Piccolo testamento
S.Quasimodo:
Alle fronde dei salici
Milano, agosto 1943
Gli alunni Il docente
Prof.ssa Francesca Manoni
MD10P8.2_01/rev.03 pag.16 di 55
All. 1
Istituto Tecnico Statale
“PIETRO CUPPARI”
Jesi
Settore ECONOMICO
Indirizzo AMMINISTRAZIONE, FINANZA E MARKETING
Articolazione SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI
Classe Quinta Sezione A
Disciplina
STORIA
Prof. Manoni Francesca
Anno Scolastico 2017/2018
MD10P8.2_01/rev.03 pag.17 di 55
Criteri di selezione dei contenuti
Programma ministeriale
Programma svolto
Seconda rivoluzione industriale e imperialismo: sviluppo industriale, concentrazione
capitalistica, cause colonialismo.
La crisi di fine secolo. L’età giolittiana: il sistema giolittiano e la sua crisi.
La prima guerra mondiale e il dopoguerra:
cause del conflitto e principali tappe; la guerra di trincea; i trattati di pace; il biennio rosso;
avvento del fascismo; la Repubblica di Weimar.
La rivoluzione russa: la figura di Lenin e il suo ruolo.
La grande crisi: cause ed effetti della crisi negli Usa e in Europa; il New Deal.
L’età dei totalitarismi: fascismo, nazismo, stalinismo.
Lo stato fascista: esempio di totalitarismo imperfetto, la società, la cultura, le scelte
economiche, politica estera, leggi razziali.
Hitler e l’avvento del nazismo: la rapida ascesa del Fuhrer, la società, l’economia, la politica
estera.
Lo stalinismo : scelte economiche e politiche.
Guerra civile spagnola: il fronte popolare e la vittoria di Francisco Franco.
La seconda guerra mondiale.
Le responsabilità, intervento italiano, campagna di Russia, intervento Usa, la Resistenza, il
crollo del fascismo, l’armistizio, la Repubblica di Salò, la sconfitta della Germania e dei suoi
alleati.
MD10P8.2_01/rev.03 pag.18 di 55
Il secondo dopoguerra e l’età della guerra fredda. Assetto bipolare, ONU, dottrina Truman,
sovietizzazione dell’Europa dell’Est, piano Marshall, divisione della Germania.
Gli alunni Il docente
Prof.ssa Francesca Manoni
MD10P8.2_01/rev.03 pag.19 di 55
All. 1
Istituto Tecnico Statale
“PIETRO CUPPARI”
Jesi
Settore ECONOMICO
Indirizzo AMMINISTRAZIONE, FINANZA E MARKETING
Articolazione SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI
Classe Quinta Sezione A
Disciplina
Lingua e Civiltà Inglese
Prof.ssa Lucci Sabrina
Anno Scolastico 2017/2018
MD10P8.2_01/rev.03 pag.20 di 55
Programma svolto Lingua Inglese
Dal testo in adozione Information Technology-Understanding Personal Computers and
Telecommunications di Bernardini/Haskell, ed Loescher, sono stati trattati i
seguenti nuovi argomenti:
Module 4: The Internet
• Unit 1: The Internet. History & Definition
• Unit 2 : Browsers and Search Engines
Reading comprehension: Spam, Spam, Spam
• Unit 3: Messages, Mail and Attachments
• Unit 4: Copyright, Piracy and Privacy
Reading comprehension: Hackers and Identify Theft
Module 5: Programs and Programming
• Unit 2: Visual Studio- Building Applications for Windows
• Unit 3: Creating a Website
Module 6: Telecommunications
• Unit 1: Describing Telecommunications
• Unit 2: Establishing Connections
• Unit 4: Bandwidth and Performance
Reading comprehension: ADSL and other implementations
Module 7: Networks and Protocols
• Unit 1: Networks-Overview
Reading comprehension: Routers
• Unit 2: Ethernet
• Unit 3: Wired and Wireless
• Unit 4: Types of Networks
Sono stati inoltre affrontati approfondimenti relativi a:
• Deep Web
• Dark Web
• The Internet of Things
MD10P8.2_01/rev.03 pag.21 di 55
Contenuti di storia e letteratura (fotocopie):
• The Industrial Revolution
• The Victorian Compromise, John Stuart and Utilitarianism, Workhouses,
• Victorian Literature:
(1) C.Dickens: life and works, style and themes;
Oliver Twist (plot, themes, style).
Lettura ed analisi del brano “Oliver wants some more”
(2) Oscar Wilde (Life, works, the decadent aesthete, the novelist, the playwright)
The Picture of Dorian Gray (plot, themes, style).
Lettura ed analisi del brano “The picture of Dorian Gray”
Film in lingua
Contenuti di civiltà (fotocopie)
� The European Union
� Brexit
� British political institutions
Gli alunni Il docente
Prof.ssa Sabrina Lucci
MD10P8.2_01/rev.03 pag.22 di 55
All. 1
Istituto Tecnico Statale
“PIETRO CUPPARI”
Jesi
Settore ECONOMICO
Indirizzo AMMINISTRAZIONE, FINANZA E MARKETING
Articolazione SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI
Classe Quinta Sezione A
Disciplina
Economia Aziendale
Prof.ssa Ludovico Elisabetta
Anno Scolastico 2017/2018
MD10P8.2_01/rev.03 pag.23 di 55
Criteri di selezione dei contenuti
Il programma di studi del quinto anno di corso è stato rivisto e ristrutturato con l’obiettivo di
semplificare e snellire, per quanto possibile, il lavoro da svolgere, eliminando contenuti obsoleti,
argomenti molto specialistici, parti che richiedono applicazioni meccanicistiche.
La selezione dei contenuti tiene conto:
• del programma svolto nel corso del precedente anno scolastico;
• dei prerequisiti disciplinari acquisiti dalla classe;
• dell’evoluzione dei metodi di “gestione” delle moderne aziende;
• dell’ampiezza dei contenuti e del grado di complessità della disciplina;
• dello stato della normativa;
• della nuova normativa che regola gli esami di Stato
Libro di testo in adozione
Autore : P. Boni – P. Ghigini – C. Robecchi – B. Trivellato
Titolo: Master 5 in economia aziendale
Editore: Scuola & Azienda
Codice Civile
MD10P8.2_01/rev.03 pag.24 di 55
Programma svolto
Unità A ASPETTI ECONOMICO-AZIENDALI DELLE IMPRESE INDUSTRIALI
Lezione 1 Le imprese industriali: generalità e classificazioni
Lezione 2 La gestione delle imprese industriali e i suoi processi
Lezione 3 Settori e aspetti della gestione industriale
Lezione 4 La contabilità generale e il piano dei conti delle imprese
industriali
Lezione 5 Le scritture relative alle immobilizzazioni:
- caratteristiche e tipologie dei beni strumentali, l’acquisizione
dei beni strumentali,
- le operazioni di leasing: aspetti tecnici, economici e contabili
- l’acquisizione delle immobilizzazioni immateriali
- I costi connessi alle immobilizzazioni dei beni strumentali
- La dismissione dei beni strumentali
- I beni strumentali e il bilancio.
Lezione 6 I contributi pubblici alle imprese
Lezione 7 Assestamenti di fine esercizio:
- completamento e integrazioni.
- TFR e previdenza complementare
- Inserimento voci relative al personale nel bilancio
d’esercizio.
- Calcolo dei ratei relativi al mutuo ipotecario
- Il Prestito obbligazionario valutato al valore nominale
- Il disaggio su prestiti e la tecnica dei risconti come indicato
dall’OIC
Lezione 8 Assestamenti di fine esercizio:
- rettificazioni e ammortamenti.
- la valutazione delle rimanenze art. 2426 c.c.
- criterio costo medio ponderato, costo lifo e costo fifo
- valutazione al costo di acquisto o di produzione.
Lezione 9 Scritture di fine periodo
Lezione 10 - Il bilancio d’esercizio:
- le funzioni del bilancio, i principi giuridici del bilancio, la
clausola generale, i principi di redazione del bilancio,
principi contabili.
- lo stato patrimoniale, Il conto economico, la Nota
integrativa, Rendiconto finanziario delle disponibilità
MD10P8.2_01/rev.03 pag.25 di 55
liquide
- I criteri di valutazione.
- Il bilancio in forma abbreviata e il bilancio delle micro
imprese.
- La revisione della contabilità e del bilancio: norme e
procedura
Unità B LE ANALISI DI BILANCIO PER INDICI E PER FLUSSI
Lezione 1 L’interpretazione della gestione e le analisi di bilancio
- Le analisi di bilancio
- Le analisi per indici: metodologia
Lezione 2 Le analisi per indici: la riclassificazione finanziaria dello Stato
Patrimoniale
Lezione 3 La rielaborazione del Conto Economico
- La rielaborazione “a valore aggiunto” e “a costi e ricavi
- della produzione venduta”
Lezione 4 L’analisi della struttura patrimoniale dell’azienda
- La composizione degli impieghi e delle fonti
Lezione 5 L’analisi della situazione finanziaria
- Analisi della solidità e della liquidità, indici di rotazione, di
durata
Lezione 6 L’analisi della situazione economica
- Gli indici di redditività e produttività
Lezione 7 Il coordinamento degli indici di bilancio
- L’analisi del ROE e del ROI
Lezione 9 L’analisi di bilancio per flussi: generalità
- I concetti di fondo e di flusso
- I flussi di CCN
- I vari tipi di variazioni
Lezione 10 La metodologia dell’analisi dei flussi di CCN
- La riclassificazione degli Stati Patrimoniali
- Le variazioni reddituali
- Il flusso di CCN della gestione reddituale
- Le variazioni finanziarie “patrimoniali”
Lezione 11
Il rendiconto delle variazioni di CCN
- La sezione I e II del rendiconto
- L’interpretazione del rendiconto
Lezione 12 Il rendiconto delle variazioni di liquidità
Unità C LE IMPOSTE SUL REDDITO DI IMPRESA
Lezione 1 Il reddito fiscale di impresa
MD10P8.2_01/rev.03 pag.26 di 55
Lezione 2 I Ricavi e le plusvalenze
Lezione 3 I dividendi
Lezione 4 La valutazione fiscale del magazzino
Lezione 5 L’ammortamento
Lezione 6 Le manutenzioni e riparazioni
Lezione 7 La svalutazione dei crediti commerciali
Lezione 10 La liquidazione e versamento dell’ires. L’irap e la sua
determinazione
Unità D LA PIANIFICAZIONE STRATEGICA E IL SISTEMA DI PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO DIGESTIONE
Lezione 1 Il controllo dei costi: la contabilità analitica
- I rendimenti dei fattori produttivi
- La contabilità analitica
Lezione 2 I costi: classificazioni e configurazioni
Lezione 3 La metodologia del calcolo dei costi di prodotto
- La raccolta e la localizzazione dei costi
- L’imputazione dei costi
Lezione 4 La contabilità analitica a costi pieni o full costing
Lezione 5 La contabilità analitica a costi variabili o direct costing
Lezione 8 I costi nelle decisioni aziendali
- Problemi di convenienza
Lezione 9 La break-even analysis
- Procedimento grafico
- Procedimento matematico
- margine di sicurezza
Lezione 10 La gestione strategica di impresa
Lezione 11 la definizione degli obiettivi e l’analisi dell’ambiente
- La mission
- Gli obiettivi
- l’analisi dell’ambiente esterno
- l’analisi dell’ambiente interno
Lezione 12 La formulazione e la realizzazione del piano strategico
Lezione 15 Il controllo di gestione e i suoi strumenti
Lezione 16 Il budget annuale e la sua articolazione
Lezione 17 La formazione dei budget settoriali e il budget del risultato
operativo
Lezione 18 Il budget degli investimenti e il budget finanziario (cenni)
MD10P8.2_01/rev.03 pag.27 di 55
Lezione 19 Il budget d’esercizio (parte teorica)
Lezione 20 Il controllo budgetario e il sistema di reporting
Lezione 21 L’analisi degli scostamenti nei costi
Lezione 22 L’analisi degli scostamenti nei ricavi
Unità G RENDICONTAZIONE SOCIALE E AMBIENTALE
Lezione 1 La responsabilità sociale dell’impresa e la creazione di valore
condiviso
Lezione 2 La comunicazione della responsabilità sociale e ambientale
d’impresa
Lezione 3 Il bilancio sociale ambientale d’impresa
Gli alunni Il docente
Prof.ssa Elisabetta Ludovico
MD10P8.2_01/rev.03 pag.28 di 55
All. 1
Istituto Tecnico Statale
“PIETRO CUPPARI”
Jesi
Settore ECONOMICO
Indirizzo SERVIZI INFORMATIVI AZIENDALI
Classe Quinta Sezione B
Disciplina
DIRITTO
Prof. Ballante Ivana
Anno Scolastico 2017/2018
MD10P8.2_01/rev.03 pag.29 di 55
Programma svolto di Diritto Libro di testo: G. Zagrebelsky, G.Oberto, G.Stalla, C.Trucco – Diritto per il quinto anno; Edizioni Le Monnier Scuola.
1 La Costituzione: nascita, caratteri, struttura
La rifondazione dello Stato dopo il fascismo. La tregua “Istituzionale” e il Referendum
Istituzionale. ll compromesso Costituzionale fra le forze politiche. Le condizioni del successo
dell’Assemblea Costituente. La struttura della Costituzione.
2 I principi fondamentali della Costituzione
La democrazia e la sovranità popolare. La democrazia competitiva. Le garanzie della
Costituzione. I diritti e le libertà dei singoli. Tipi di libertà. I doveri. Uguaglianza formale e
Sostanziale. L’internazionalismo.
3 I principi della forma di Governo
I caratteri della forma di Governo. La separazione dei poteri. La rappresentanza. Democrazia
diretta e rappresentativa. Il diritto di voto. Il sistema parlamentare. Il ruolo dei partiti politici.
4 Il Parlamento
Il bicameralismo. Differenza tra Camera e Senato. La legislatura e lo scioglimento anticipato
delle Camere. La posizione del Parlamentare: rappresentanza politica, le immunità
parlamentari e l’indennità. Gruppi politici e Commissioni. L’iter di formazione delle leggi
ordinarie e delle leggi costituzionali. Il referendum costituzionale e abrogativo.
5 Il Governo
La formazione del Governo. Il rapporto di fiducia e la revoca della fiducia. Le crisi di Governo.
Struttura e poteri del Governo. I disegni di legge, i decreti legge e legislativi del Governo. I
poteri regolamentari.
MD10P8.2_01/rev.03 pag.30 di 55
6 I Giudici e la funzione giurisdizionale.
I Giudici e la giurisdizione. Magistrature ordinarie e speciali. Giurisdizione civile e penale. Gli
organi della giurisdizione ordinaria. La soggezione dei Giudici solo alla legge. Il Consiglio
Superiore della Magistratura. L’indipendenza dei Giudici. I principi costituzionali in materia di
giurisdizione: giudice naturale, imparzialità del giudice, diritto di azione e alla difesa, la
motivazione delle decisioni del giudice, i gradi del giudizio, l’irretroattività della legge penale.
7 Il Presidente della Repubblica
Caratteri generali della carica: garante della Costituzione e rappresentante dell’Unità
nazionale. Elezione, durata in carica, supplenza. I principali poteri del Presidente della
Repubblica in rapporto al Parlamento, Governo e Magistratura. Gli atti, le responsabilità e la
controfirma ministeriale.
8 La Corte Costituzionale
Struttura e funzionamento della Corte Costituzionale. Competenze. Il giudizio di
costituzionalità delle leggi. Il giudizio incidentale e il giudizio principale. Sentenze di
accoglimento e di rigetto.
Gli alunni Il docente
Prof.ssa Ivana ballante
MD10P8.2_01/rev.03 pag.31 di 55
All. 1
Istituto Tecnico Statale
“PIETRO CUPPARI”
Jesi
Settore ECONOMICO
Indirizzo SERVIZI INFORMATIVI AZIENDALI
Classe Quinta Sezione B
Disciplina
ECONOMIA POLITICA
Prof. Ballante Ivana
Anno Scolastico 2016/2017
MD10P8.2_01/rev.03 pag.32 di 55
Programma svolto di Economia politica Libro di testo: Crocetti-Cernesi – Economia Pubblica: una questione di scelte- Edizioni Tramontana
1 Nozione di attività finanziaria dello Stato. Il ruolo dello Stato ed evoluzione storica
dell’attività finanziaria. Finanza neutrale e finanza funzionale. Nozione di soggetto
pubblico e gli organi costituzionali nazionali. Gli Enti pubblici territoriali e autarchici.
2 Le funzioni svolte dal soggetto pubblico nel sistema economico. La correzione dei
fallimenti del mercato e il soddisfacimento dei bisogni collettivi. La funzione
redistributiva del reddito. Le diverse modalità dell’intervento pubblico nell’economia.
3 L’intervento pubblico diretto e la regolamentazione del mercato. L’alternanza tra
pubblico e privato nei sistemi economici misti. La dicotomia Stato-Mercato.
4 Gli obiettivi della politica economica: la stabilità economica, lo sviluppo, l’occupazione,
lotta all’inflazione.
5 Il fenomeno della spesa pubblica. La spesa pubblica come strumento di politica
economica e di erogazione dei servizi pubblici. La classificazione delle spese pubbliche.
Le cause dell’eccessiva espansione della spesa pubblica e ragioni della difficoltà del
controllo. Gli effetti negativi di un’eccessiva espansione della spesa pubblica.
6 Le entrate pubbliche e relativa classificazione. Le entrate di diritto privato: prezzi privati,
pubblici e politici.
7 Le entrate di diritto pubblico: imposta, tassa e contributo fiscale. Pressione tributaria,
fiscale e finanziaria. Gli effetti economici dell’elevata pressione fiscale.
8 L’imposta: presupposto ed elementi. Classificazione delle imposte: imposte dirette e
indirette, reali e personali, generali e speciali, proporzionali, progressive e regressive.
I diversi tipi di progressività dell’imposta.
9 I principi giuridici dell’imposta: generalità (o universalità), uniformità, progressività. I
criteri di determinazione della capacità contributiva. I principi amministrativi
dell’imposta: certezza, comodità, economicità.
MD10P8.2_01/rev.03 pag.33 di 55
10 Gli effetti microeconomici dell’imposta: rimozione positiva e negativa, evasione fiscale,
elusione, traslazione.
11 Il bilancio dello Stato e relative classificazioni. I principi del bilancio. Le fasi del processo
del bilancio preventivo. L’esercizio provvisorio.
Gli alunni Il docente
Prof.ssa Ivana ballante
MD10P8.2_01/rev.03 pag.34 di 55
All. 1
Istituto Tecnico Statale
“PIETRO CUPPARI”
Jesi
Settore ECONOMICO
Indirizzo AMMINISTRAZIONE, FINANZA E MARKETING
Articolazione SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI
Classe Quinta Sezione A
Disciplina
Matematica
Prof. Gianangeli M.Rita
Anno Scolastico 2017/2018
MD10P8.2_01/rev.03 pag.35 di 55
Criteri di selezione dei contenuti
Gli argomenti trattati nel programma sono stati scelti, non solo in base alle conoscenze
pregresse e capacità in generale della classe, ma soprattutto in relazione ad un discorso
interdisciplinare in particolare con Economia Aziendale. Programma svolto
ARGOMENTI:
1.Ripasso delle basi e dei concetti del calcolo matematico
� Dominio di funzioni razionali e semplici funzioni irrazionali
� Derivate : derivate e teoremi relativi.
2. Gli integrali
� Concetto di integrazione di una funzione
� L’integrale indefinito; integrali immediati.
� L’integrale definito
� Il calcolo delle aree di superfici piane.
3. Ricerca Operativa
� Definizione,generalità e scopi, classificazione dei problemi di scelta e fasi principali
� Scelta in condizioni di certezza, con effetti immediati: problemi di massimizzazione
dell’utile e determinazione del B.E.P.
� Minimizzazione della funzione obiettivo con la determinazione del punto di minimo
costo
� Il problema delle scorte e la determinazione del lotto economico d’acquisto
� Determinazione del lotto economico con sconti sulle quantità ordinate
� Problemi nel discreto: scelta fra più alternative.
� Scelta in condizioni di certezza, con effetti differiti: il criterio dell’attualizzazione(R.E.A.) per investimenti finanziari e per sostituzione di
macchinari con durate uguali e con durate diverse. Scelta fra leasing e mutuo.
� Criterio del tasso effettivo d’impiego (o tasso interno di rendimento) � Scelta in condizioni di incertezza, con effetti immediati : il criterio del valor medio.
4. Programmazione Lineare
� Caratteristiche e fasi principali
� Disequazioni e sistemi di disequazioni in due variabili
� Problemi a due variabili con il metodo grafico
� Massimizzazione o minimizzazione della funzione obiettivo a due variabili
� Il metodo del simplesso per risolvere problemi in n variabili
� Applicazione del metodo del simplesso a problemi di massimo
Gli alunni Il docente
Prof.ssa Maria Rita Gianangeli
MD10P8.2_01/rev.03 pag.36 di 55
All. 1
Istituto Tecnico Statale
“PIETRO CUPPARI”
Jesi
Settore ECONOMICO
Indirizzo AMMINISTRAZIONE, FINANZA E MARKETING
Articolazione SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI
Classe Quinta Sezione A
Disciplina
INFORMATICA
Prof. Bavosi Mauro
Anno Scolastico 2017/2018
MD10P8.2_01/rev.03 pag.37 di 55
Programma effettivamente svolto
Prof. Mauro Bavosi
I.T.P Prof. Carlo Favi
Pagine WEB dinamiche
1) HTML e CSS
Brevi nozioni sulla struttura di un Ipertesto. La struttura generale di una pagina web. I
principali tag per la gestione del testo, struttura di un documento e immagini.
Formattazione di una pagina web mediante attributi. I collegamenti ipertestuali. La
struttura di un sito WEB.
I CSS. Le motivazioni per l’introduzione dei CSS. CSS in linea, a cascata, incorporati e
relativa precedenza. Le classi.
Sviluppo di pagine WEB mediante editor di testo e ambiente VB.NeT
2) ASP.NET
Le pagine WEB dinamiche. I form. Costruzione di pagine dinamiche mediante vb.net. Le
classi ADO: gli oggetti Connection, Command, DataReader per l’accesso al Database.
3) SQL
Ripasso SQL (Query Language). Le operazioni di inserimento, aggiornamento e
cancellazione in un database mediante INSERT, UPDATE, DELETE.
I sistemi di Rete
1) Nozioni di base sulle reti Il passaggio dalle architetture basate su Mainframe alle architetture di Rete. I vantaggi
dei sistemi distribuiti rispetto ai sistemi centralizzati. Classificazione di una rete in base a
• estensione
• topologia logica e fisica
• paradigma di funzionamento (client/server e peer to peer)
2) Il modello OSI
Il modello ISO/OSI e le motivazioni che hanno portato alla sua definizione. I livelli OSI
e le relative specifiche.
3) Il Cablaggio Strutturato
Obiettivi dell’adozione di uno standard per il cablaggio di una LAN. I mezzi trasmissivi
(UTP, Fibra ottica) e le specifiche generali che devono essere rispettate nelle distanze (si
richiede che lo studente sappia valutare la scelta corretta del mezzo trasmissivo in base
MD10P8.2_01/rev.03 pag.38 di 55
alle distanze ed eventuali disturbi elettromagnetici). Cenni generali sugli standard
americani TIA/EIA, ISO/IEC ed europeo CEI EN: implementazione gerarchica del
cablaggio mediante centri stella. I componenti passivi per i centri stella. Unificazione
degli standard
4) Componenti di rete per il cablaggio
NIC, Repeater, Hub, Bridge, Switch e Router e cenni alle rispettive specifiche di
funzionamento.
Il protocollo Ethernet in trasmissione e ricezione. Brevi cenni sul protocollo Token Ring.
5) Il TCP/IP
Reti a commutazione di circuito ed a commutazione di pacchetto. Il TCP/IP. Confronto
tra TCP/IP e OSI.
Gli indirizzi IPv4 e le classi. Gli indirizzi riservati. Cenni sull'IPv6. La funzione della subnet
mask. Porte e Socket.
Protocolli connection oriented e connectionless: Il TCP e l’UDP. I protocolli di livello
applicazione: POP3, SMTP, FTP, HTTP, HTTPS.
Gateway e Proxy Server. VPN. Nozioni generali sui WEB Server. Intranet ed Extranet.
Hosting e housing. I Content Managment System: caratteristiche e uso per la creazione
di un sito WEB.
Internet ed il WEB 2.0: siti web dinamici, blog e forum, social network.
6) Sicurezza Informatica
Principi generali di crittografia. Cifratura per trasposizione e per sostituzione.
Crittografia a chiave simmetrica e asimmetrica
La crittografia ed il suo utilizzo nel campo della sicurezza informatica: Crittografia
asimmetrica. Gestione della sicurezza nelle reti WiFi. Il Firewall.
Tipologia di attacchi ad un sistema informatico. Il Malware: classificazione delle
minacce e relativa tipologia di rischio collegato. Tecniche per la prevenzione e gestione
dei rischi.
7) Reti e Pubblica Amministrazione
E-government. La firma digitale: definizione, validità, utilizzo nell'ambito della pubblica
amministrazione. Posta Elettronica Certificata.
8) Privacy e Proprietà intellettuale
Nozioni generali sulle normative relative alla privacy e sul trattamento dei dati
personali. Il diritto d'autore: copyright e copyleft; il software open source. Il P2P.
MD10P8.2_01/rev.03 pag.39 di 55
9) Sistemi informativi aziendali Sistema informativo aziendale e sistema informatico aziendale. Modelli per i sistemi
informativi aziendali. Strumenti software per la gestione Aziendale: il ciclo PDCA, MRP e
MRP2, I Data Wharehouse, ERP. I servizi Cloud per le aziende.
Gli alunni Il docente
Prof. Mauro Bavosi
MD10P8.2_01/rev.03 pag.40 di 55
All. 1
Istituto Tecnico Statale
“PIETRO CUPPARI”
Jesi
Settore ECONOMICO
Indirizzo AMMINISTRAZIONE, FINANZA E MARKETING
Articolazione SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI
Classe Quinta Sezione A
Disciplina
SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE
Prof. Di Marino Marina
Anno Scolastico 2017/2018
MD10P8.2_01/rev.03 pag.41 di 55
Criteri di selezione dei contenuti
In relazione alle indicazioni ministeriali, alle attrezzature disponibili, al livello iniziale di
competenze, si è cercato di fornire alla classe gli stimoli necessari per una completa e
consapevole partecipazione alle lezioni. Partendo dal vissuto motorio degli allievi, con adeguata
gradualità, si è operato per unità di apprendimento con costanti verifiche formative, ponendo
alla fine di ogni percorso una verifica sommativa. La sintesi, oltre che alla conoscenza e
competenza dei vari contenuti affrontati, è stata finalizzata al miglioramento della gestione
consapevole ed efficace del corpo.
Programma svolto
Potenziamento delle capacità condizionali e affinamento delle capacità coordinative:
esercizi di mobilità articolare e di stretching, attività di forza a carico naturale e con adeguato
aumento del carico, esercizi di tonificazione, utilizzo di manubri e palle medicinali; esercizi di
velocità, rapidità di reazione e di psico cinetica; attività di resistenza generale aerobica, con
saltelli e andature diversificate, con alternanza di ritmo, esercizi di educazione respiratoria.
Proposte di attività finalizzate all'attuazione di gesti economici e precisi, in relazione alle singole
attività. Ripasso dei fondamentali del corpo libero.
Attrezzi
Esercizi specifici e di riporto con alcuni attrezzi, progettazione ed esecuzione di una
combinazione non strutturata, per gruppi di lavoro, libera scelta dell’attrezzo (funicella, quadro,
trave, palloni, cerchi, manubri, palle medicinali, spalliera, nastro.
Cavallo: salto in basso con lancio e ripresa della palla seguito da capovolta saltata nel cerchio e
capovolta con lancio e ripresa della palla.
Acrosport
Esercizi di controllo del proprio corpo in situazioni di disequilibrio, al suolo.
Attività posturale mirata al controllo delle posizioni. Bilanciamenti in coppia, prese e appoggi,
sequenze di figure e piramidi più evolute. Assistenza diretta ed indiretta. Combinazione
espressiva di figure statiche di gruppo, mantenendo le posture corrette e l'equilibrio,
contribuendo alla realizzazione dell'intera forma ideata o scelta.
MD10P8.2_01/rev.03 pag.42 di 55
Attività sportive:
Pratica dei principali giochi sportivi, applicazione di regole e regolamenti, nel rispetto del fair
play. Giochi presportivi anche non codificati, percorsi, circuiti, staffette di varia tipologia,
finalizzati al miglioramento delle capacità motorie, della cooperazione e della collaborazione,
dell'autocontrollo, della consapevolezza motoria, dell'affinamento di gesti tecnici.
Elaborazione individuale, organizzazione e guida della classe in un riscaldamento generale,
rispettandone principi e fasi.
Scelta libera, individuale e proposta di: attività di stretching e/o
elaborazione e conduzione della classe in un percorso/circuito/gioco, ideato dagli studenti.
Preparazione: le attività sono state precedute da esercizi propedeutici specifici e sono stati
utilizzati per il conseguimento di obiettivi diversi i seguenti attrezzi: bacchette, funicelle, palle
mediche, cerchi, trave, pedana, spalliera, fit ball, palloni, palline, cavallo, ostacoli vari.
Atletica: tecnica del getto del peso
Prevenzione e Primo soccorso:
Norme di comportamento funzionali alla sicurezza e alla prevenzione degli infortuni .
Applicazione delle tecniche di primo soccorso su manichini: rianimazione cardio polmonare il
B.L.S., l'ostruzione delle vie aeree nell'adulto e nell'infante, la manovra di Heimlich.
Alimentazione: i principi nutritivi, la piramide alimentare.
Gli alunni Il docente
Prof.ssa Marino Di Marino
MD10P8.2_01/rev.03 pag.43 di 55
All. 1
Istituto Tecnico Statale
“PIETRO CUPPARI”
Jesi
Settore ECONOMICO
Indirizzo
SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI
Classe Quinta Sezione A
Disciplina
RELIGIONE
Prof. CONTADINI MICHELE
Anno Scolastico 2017/2018
MD10P8.2_01/rev.03 pag.44 di 55
Criteri di selezione dei contenuti
Secondo il programma svolto durante l’anno.
Programma svolto
Uda 1: Dio controverso: a) cercatori di Dio: lo stupore, le domande, l'esperienza (quella
mistica in particolare), le aspirazioni dell’uomo, la ragione (tre prove di S. Tommaso:
movimento, causalità, ordine). B) L'esperienza mistica di A.Frossard. C) L'ateismo e le sue
forme. Il secolarismo. Il concetto di laicità. D) i volti di Dio: le religioni; la critica alle religioni
e la risposta cristiana; il volto cristiano di Dio. E) Fenomeni parareligiosi: spiritismo e
satanismo.
Uda 2: L’etica della vita: a) la bioetica; b) la fecondazione artificiale, posizioni a confronto. Il
magistero della Chiesa; c) l’aborto , posizioni a confronto. Il magistero della Chiesa; d) la
clonazione, posizioni a confronto. Il magistero della Chiesa; e) l’eutanasia, posizioni a
confronto. Il magistero della Chiesa; f) la sessualità tra natura e cultura.
Uda 3: L’etica della pace: a) guerra, pace e pacifismo; b) i messaggi del papa per la giornata
mondiale della pace; c) la teoria della nonviolenza; d) giustizia e carità; l’economia solidale;
la convivialità delle differenze.
Gli alunni Il docente
Prof. Michele Contadini
MD10P8.2_01/rev.03 pag.45 di 55
ALLEGATO 2
TESTI DELLE SIMULAZIONI DI TERZA PROVA
GRIGLIE DI VALUTAZIONE
MD10P8.2_01/rev.03 pag.46 di 55
Prima simulazione: 16 marzo 2018
Tipologia B. Durata 180 minuti.
Durante lo svolgimento della prova è stato consentito:
• l'utilizzo del dizionario monolingue di inglese
• l'uso della calcolatrice scientifica non programmabile
Economia politica 1. Gli organi nazionali di indirizzo politico che hanno la funzione di stabilire obiettivi e strumenti
della politica economica
2. I bisogni collettivi e distinzione tra servizi pubblici indivisibili e divisibili
3. La funzione anticongiunturale della politica economica e conseguenze della politica fiscale
espansiva
Lingua inglese
Answer the following questions.
1. Write about the Victorian Age as an age of compromise (max 10 lines)
2. Write about the main themes of Dicken’s novels (max 10 lines)
3. Describe what a Browser is.. (max 10 lines)
Economia aziendale 1. l’articolo 2426 c.c pone alla base della valutazione il criterio del “costo”. Descrivi i casi in cui è
possibile utilizzare criteri alternativi al costo ed evidenzia i riflessi in bilancio.
2. il conto economico civilistico necessita di rielaborazione per l’analisi economica dell’impresa.
Argomenta sinteticamente tale affermazione e descrivi, in modo dettagliato, il conto
economico rielaborato a valore aggiunto.
3. dopo aver spiegato l’importanza, le finalità e i requisiti della COAN, individua le differenze
con la CO.GE.
Matematica 1. Classificare e risolvere il seguente problema (max 3 righe).
Un’impresa di trasporti, che può effettuare con ogni automezzo servizi di trasporto merci fino a
80’000 q-km al mese, ricava 20€ per ogni q-km. I costi per ogni automezzo sono dati da una
spesa fissa di 3600€ più una spesa variabile unitaria per q-km espressa da: 5 + 0.0001x ,dove x
è il numero di q-km trasportati al mese. Determinare:
a) il numero dei q-km mensili che dà il massimo utile;
b) il numero minimo di q-km mensili necessari per non subire perdite
c) l’utile max.
Rappresentare graficamente e risolvere il problema; commentare bene il grafico ed i risultati
ottenuti.
2)Dopo aver spiegato le problematiche del magazzino nel problema delle scorte e come si
arriva ad una situazione ottimale, si risolva il seguente problema:
Una fabbrica smaltisce 80'000 pezzi al mese. Ogni rifornimento costa 1800 € e che il
magazzinaggio costa invece 0,012€ al giorno.
Determinare il lotto economico d’acquisto e il relativo costo minimo in queste due ipotesi:
MD10P8.2_01/rev.03 pag.47 di 55
a) il magazzino può contenere al massimo 30'000 pezzi;
b) il magazzino può contenere al massimo 25'000 pezzi.
Rappresentare graficamente e risolvere il problema; commentare bene il grafico ed i risultati
ottenuti.
1) Scrivere la definizione di primitiva F(x) di una funzione e spiega il significato di c che si deve
aggiungere alla funzione primitiva. Ora si calcoli l’integrale definito dopo aver descritto cosa
rappresenta il risultato ottenuto:
�
�� �x − 2��
2dx
Seconda simulazione: 27 aprile 2018
Tipologia B. Durata 180 minuti.
Durante lo svolgimento della prova è stato consentito:
• l'utilizzo del dizionario monolingue di inglese
• l'uso della calcolatrice scientifica non programmabile
Economia politica 1. Dopo aver definito la spesa pubblica e il fabbisogno finanziario, analizza gli effetti di
un’eccessiva espansione della spesa pubblica
2. I prezzi come fonte di entrata originaria
3. La tassa: definizione, caratteristiche e tipologia
Lingua inglese
1. In the preface to The Picture of Dorian Gray, Oscar Wilde says that “all art is quite useless”.
Explain the meaning of this statement with reference to Wilde’s aesthetic ideas. (max 10 lines)
2. What does "The picture of Dorian Grey" tell about? (max 10 lines)
3. Describe the difference between Deep Web and Dark Web (max 10 lines)
Economia aziendale 1. L’impresa industriale Gamma spa stipula in data 1/10/n un contratto di leasing su un
macchinario versando un maxicanone iniziale di 4.000 euro. Il contratto prevede il pagamento di 6
canoni trimestrali di 1.000 euro ciascuno a partire dall’1/12/n e un prezzo di riscatto di 600 euro.
Presenta:
• il calcolo dei costi di competenza nei diversi anni di durata del contratto;
• gli effetti sullo Stato patrimoniale e sul Conto economico di bilancio negli anni di durata del
contratto.
2. Spiega il significato, il metodo di calcolo e la scomposizione del ROI
3. Dopo aver definito il budget spiega le sue funzioni
MD10P8.2_01/rev.03 pag.48 di 55
Matematica 1. Spiegare quali tipi di problemi sono risolvibili con il criterio del valor medio e come viene effettuata
la scelta dell’alternativa. Se si è disposti ad accettare un rischio a quale parametro si fa riferimento? ( max
8 righe). Risolvere il seguente problema.
Un’azienda produce una merce con 2 tipi di processi lavorativi L1 e L2. I guadagni dati dalla
vendita della merce sono dati dalle seguenti relazioni:
y1= 12x – 0,05x2 + 2500
y2= 45x -3200
dove x indica la quantità di merce prodotta. Determina la scelta più conveniente sapendo che le
probabilità di vendita sono stimate come nella seguente tabella:
Quantità 100 150 200 250
probabilità 0,15 0,25 0,40 0,20
2. Illustrare il problema delle scorte: indicare gli elementi da prendere in considerazione nella
funzione obiettivo e descrivere le ipotesi che permettono la formulazione del modello
matematico, facendo riferimento anche alla rappresentazione grafica.(max 10 righe)
3. Spiegare che cosa si definisce con il r.e.a. e a quali tipi di problemi si può applicare.
Spiegare inoltre perché la scelta con questo criterio è soggettiva (max 6 righe).
Risolvere il seguente problema:
Un’impresa deve decidere l’acquisto di una attrezzatura scegliendola fra due diversi tipi con le
seguenti caratteristiche:
Tipo A : costo iniziale € 24.000 ; spese annue di esercizio € 1.500 , durata 8 anni; valore di
recupero € 2.100.
Tipo B : costo iniziale €35.000; spese annue di esercizio € 1.200 , durata 12 anni; valore di
recupero € 3.200.
Valutare la scelta più conveniente al tasso annuo del 10%.
MD10P8.2_01/rev.03 pag.49 di 55
Griglia di valutazione della terza prova scritta (disponibile in supporto informatico Excel)
Come indicato nelle immagini seguenti la griglia prevede tre indicatori per ogni quesito;
ogni voce viene valutata da 0 a 6. Il punteggio grezzo percentuale viene trasformato in
quindicesimi mediante una formula parabolica che fissa tre corrispondenze (vedi
immagine di lato).
La griglia ha un supporto informatico (Excel) che il calcolo delle valutazione e la produzione delle schede alunno.
Scheda alunno
ritorna
Materia pesoDescrizione
n nome 1 2 3 1 2 3 1 2 3 Voto % Voto 15i Ind.1 7
1 AQUILI NICOLA #DIV/0! #DIV/0!
2 BAIONI IGOR #DIV/0! #DIV/0!
3 CARDINALI LORENZO #DIV/0! #DIV/0!
4 DOTTORI VALERIO #DIV/0! #DIV/0!
5 MANDOLINI MATTEO #DIV/0! #DIV/0!
6 MATTEI FABIOLA #DIV/0! #DIV/0! Ind.2 9
7 MAZZUFFERI LEONARDO #DIV/0! #DIV/0!
8 NOVELLI NICOLO' #DIV/0! #DIV/0!
9 PELONZI GIACOMO #DIV/0! #DIV/0!
10 SCARPINO STEFANO #DIV/0! #DIV/0!
11 TANASA DANIELA LARISA #DIV/0! #DIV/0! Ind.3 4
12
13
14
15
16
17 min 0
18 max 6
19 0 Risposta in bianco
20 1 gravemente insufficiente
21 2 insufficiente
22 3 sufficiente
23 4 discreto
24 5 buono
25 6 ottimo
26
27
28
29
30 #DIV/0! #DIV/0!
Quesito 3
Chiarezza e
correttezza di
esposizione
Valutazione terza prova scritta - Esame di stato a.s. 2017-18
Conoscenza, intesa
come acquisizione
di contenuti
Capacità di
util izzare in
concreto le
conoscenze
acquisite e
competenza intesa
come abil ità di
Quesito 1 Quesito 2
Grezzo % Voto in 15i
0% 1 49,50% 9,45
100% 15
MD10P8.2_01/rev.03 pag.50 di 55
Alunno/a: Cognome Nome 1
Ritorna
classe: 5A SIA 15i
0% -0,01% 0
0,00% 2,59% 1
2,60% 7,69% 2
7,70% 12,99% 3
13,00% 18,49% 4
Indicatore 1 peso 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 18,50% 24,19% 5
70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0
24,20% 30,19% 6
Indicatore 2 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 30,20% 36,39% 7
9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0
36,40% 42,99% 8
Indicatore 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 43,00% 49,89% 9
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,049,90% 57,29% 10
20 Voto % 0% 0% 0% 0% 57,30% 65,19% 11
La Commissione Voto 15i 1 1 1 1 65,20% 73,79% 12
73,80% 83,29% 13
Ris pos ta in bia nco 0 83,30% 93,99% 14
gravemente insuffici ente 1 94,00% 100,00% 15
ins ufficiente 2 Voto grezzo % x: percentuale; y:voto
suffici ente 3 Voto in 15i y=-6,081 x²+20,081 x+1
dis creto 4
buono 5
ottimo 6
voto %
Corrispondenze % - 15
medie
Valutazione terza prova scritta - Esame di stato a.s. 2017-2018
Se
con
da
lin
gu
a
Ma
tem
ati
ca
Ec.
Po
litic
a
1
ECO_AZIEN
Conos cenza, intes a come a cquis izione di
contenuti
Ca pa cità di uti l i zza re in concreto le
conos cenze acqui s i te e competenza
i ntes a come a bi l i tà di rie laborare
cri tica mente tal i conos cenze
Chiarezza e correttezza di es posi zione
Seconda lingua Matematica Ec.Politica
0,0%
EC
O_
AZ
IEN
MD10P8.2_01/rev.03 pag.51 di 55
Griglia di valutazione della prima prova scritta (disponibile in supporto informatico)
CANDIDATO/A ………………………………………………………………….……………………………………..… SEZ. ……….…
TRACCIA SVOLTA: Tipologia � A - Analisi del testo
� B - Saggio breve /articolo di giornale � Ambito artistico - letterario � Ambito socio – economico � Ambito storico – politico � Ambito tecnico – scientifico
� C - Tema di argomento storico
� D - Tema di argomento generale
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA SCRITTA
N INDICATORI e DESCRITTORI VAL. PESI PUNT.
1 Correttezza nell’uso della lingua, proprietà e ricchezza lessicale; ricchezza e varietà dello stile
4
2 Possesso delle conoscenze relative all'argomento e al quadro di riferimento. Qualità e quantità delle informazioni relative all'argomento e sua contestualizzazione. Pertinenza delle informazioni utilizzate.
6
3
Attitudini allo sviluppo critico delle questioni proposte e alla costruzione di un discorso organico e coerente. Individuazione del nucleo delle tematiche proposte. Pertinenza delle argomentazioni e valutazioni personali a sostegno delle tesi addotte. Rielaborazione critica dei contenuti. Coesione e compiutezza della trattazione.
5
4 Conoscenze e competenze idonee a individuare la natura del testo e delle sue strutture formali. Comprensione, interpretazione del testo. Possesso ed utilizzazione degli strumenti di decodifica.
A
5
5 Capacità di comprendere e utilizzare i materiali forniti nel rispetto della tipologia prescelta. Utilizzazione del corredo documentario. Strutturazione del testo finale, tenendo
presenti le consegne (destinatario, titolo, limite di stesura…). Consequenzialità della trattazione.
B1 – B2 5
6 Aderenza alla traccia. Capacità di svolgere autonomamente il tema proposto. Consequenzialità della trattazione. Riferimento a fonti (soprattutto tipologia C). Apporto personale (soprattutto tipologia D).
C – D
5
Per ciascuno dei 4 indicatori, viene attribuito un punteggio da 1 a 5, adottando la seguente scala:0 valutazione nulla; 1 gravemente insufficiente; 2 insufficiente; 3 sufficiente; 4 discreta/buona; 5 ottima.
TOTALE P. GREZZO (P. MAX = 100)
VOTO =
Banda 0-8 9-14 15-20 21-26 27-32 33-38 39-44 45-49 50-55 56-62 63-69 70-75 76-80 81-92 93-
100
Voto in
quindicesimi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
MD10P8.2_01/rev.03 pag.52 di 55
Griglia di valutazione della seconda prova scritta. Modificabile in rapporto alla tipologia della prova 1. Prima parte (obbligatoria)
Descrittore Peso Valutazione Pt. Tot.
Analisi del Problema 6 Del tutto assente 0 0
Superficiale, gravemente
carente
1 6
Affetta da errori gravi 2 12
Nel complesso corretta,
anche in presenza di errori
non gravi
3 18
Corretta, anche con la
presenza di qualche
imprecisione
4 24
Corretta e completa delle
opportune ipotesi aggiuntive
5 30
Conoscenze 7 Nessuna conoscenza degli
argomenti necessari alla
risoluzione del problema
0 0
Frammentaria e parziale 1 7
Superficiale con lacune gravi 2 14
Sufficiente con qualche
lacuna
3 21
Buona in tutti gli argomenti 4 28
Completa ed esaustiva 5 35
Competenze 5 Nessuna capacità di
applicazione delle tecnologie
necessarie
0 0
Le soluzioni proposte sono
affette da gravi errori
1 5
Soluzioni affette da alcuni
gravi errori
2 10
La soluzione degli esercizi è
affetta da qualche errore non
grave
3 15
Soluzione corrette, possono
essere presenti imprecisioni o
qualche errore di scarsa
gravità
4 20
Soluzioni corrette e
ottimizzate. In presenza della
documentazione necessaria
5 25
Completezza della
risoluzione
3 Esercizio non svolto 0 0
Esercizio svolto solo in
piccola parte, solo accennato
1 3
Esercizio svolto parzialmente 2 6
Esercizio svolto per la
maggior parte
3 9
Esercizio svolto quasi per
intero
4 12
Esercizio svolto in tutte le sue
parti
5 15
Punteggio Grezzo Max Primo Esercizio: 105
MD10P8.2_01/rev.03 pag.53 di 55
Esercizi a scelta del Candidato Esercizio n. ___ Analisi di problematiche relativa al Sistema Informatico Aziendale
Descrittore Peso Valutazione Pt.
Tot.
Analisi del
Problema
3
Del tutto assente 0 0
Superficiale,
gravemente carente
1 3
Affetta da errori gravi 2 6
Nel complesso corretta,
anche se sono presenti
errori non gravi
3 9
Corretta, anche con la
presenza di qualche
imprecisione
4 12
Corretta e completa 5 15
Conoscenze 5 Nessuna conoscenza
degli argomenti
necessari alla
risoluzione del
problema
0 0
Frammentaria e
parziale
1 5
Superficiale con lacune
gravi
2 10
Sufficiente con qualche
lacuna
3 15
Buona in tutti gli
argomenti
4 20
Completa ed esaustiva 5 25
Capacità
argomentativa
2 Nessuna capacità
argomentativa o
assenza totale di
argomentazioni
0 0
Scarsa 1 2
Lo svolgimento
presenta delle
incoerenze o
contraddizioni
2 4
Esposizione chiara in
presenza di qualche
aspetto non
sufficientemente
chiarito
3 6
Esposizione corretta e
lineare, qualche
imprecisione
4 8
Esposizione chiara ed
esaustiva
5 10
Esercizi a scelta del Candidato Esercizio n. ___ Analisi di problematiche relativa al Sistema Informatico Aziendale
Descrittore Peso Valutazione Pt. Tot.
Analisi del
Problema
3
Del tutto assente 0 0
Superficiale, gravemente
carente
1 3
Affetta da errori gravi 2 6
Nel complesso corretta,
anche se sono presenti
errori non gravi
3 9
Corretta, anche con la
presenza di qualche
imprecisione
4 12
Corretta e completa 5 15
Conoscenze 5 Nessuna conoscenza
degli argomenti necessari
alla risoluzione del
problema
0 0
Frammentaria e parziale 1 5
Superficiale con lacune
gravi
2 10
Sufficiente con qualche
lacuna
3 15
Buona in tutti gli
argomenti
4 20
Completa ed esaustiva 5 25
Capacità
argomentativa
2 Nessuna capacità
argomentativa o assenza
totale di argomentazioni
0 0
Scarsa 1 2
Lo svolgimento presenta
delle incoerenze o
contraddizioni
2 4
Esposizione chiara in
presenza di qualche
aspetto non
sufficientemente chiarito
3 6
Esposizione corretta e
lineare, qualche
imprecisione
4 8
Esposizione chiara ed
esaustiva
5 10
Esercizi a scelta del Candidato Esercizio n. ___ Analisi di problematiche relativa al Sistema Informatico Aziendale
Descrittore Peso Valutazione Pt. Tot.
Analisi del
Problema
3
Del tutto assente 0 0
Superficiale, gravemente
carente
1 3
Affetta da errori gravi 2 6
Nel complesso corretta,
anche se sono presenti
errori non gravi
3 9
Corretta, anche con la
presenza di qualche
imprecisione
4 12
Corretta e completa 5 15
Conoscenze 5 Nessuna conoscenza
degli argomenti necessari
alla risoluzione del
problema
0 0
Frammentaria e parziale 1 5
Superficiale con lacune
gravi
2 10
Sufficiente con qualche
lacuna
3 15
Buona in tutti gli
argomenti
4 20
Completa ed esaustiva 5 25
Capacità
argomentativa
2 Nessuna capacità
argomentativa o assenza
totale di argomentazioni
0 0
Scarsa 1 2
Lo svolgimento presenta
delle incoerenze o
contraddizioni
2 4
Esposizione chiara in
presenza di qualche
aspetto non
sufficientemente chiarito
3 6
Esposizione corretta e
lineare, qualche
imprecisione
4 8
Esposizione chiara ed
esaustiva
5 10
MD10P8.2_01/rev.03 pag.54 di 55
Punteggio grezzo massimo per ogni quesito della seconda parte è di 50 punti. In totale la
seconda parte permette di totalizzare, al massimo, 100 punti, che sommati al punteggio della
prima parte danno come punteggio massimo per l’intera prova 205 punti.
Il punteggio in 15-esimi si ottiene calcolando la percentuale x=PGrezzo/PMax e applicando la
formula:
Voto = ax 2+ bx + c
dove a = - 4,16157 b=18,16157 c=1
Parte a scelta del candidato Implementazione di una parte di sito web dinamico
Descrittore Peso Valutazione Pt
.
Tot.
Analisi del
Problema
3
Del tutto assente 0 0
Superficiale, gravemente carente 1 3
Affetta da errori gravi 2 6
Nel complesso corretta, anche se
sono presenti errori non gravi
3 9
Corretta, anche con la presenza di
qualche imprecisione
4 12
Corretta e completa 5 15
Conoscenze 3 Nessuna conoscenza degli argomenti
necessari alla risoluzione del problema
0 0
Frammentaria e parziale 1 3
Superficiale, Lacune gravi 2 6
Sufficiente con qualche lacuna 3 9
Buona in tutti gli argomenti 4 12
Completa ed esaustiva 5 15
Competenze 4 Nessuna capacità di applicazione
delle tecnologie necessarie
0 0
Le soluzioni proposte sono affette da
gravi errori e/o sono state svolte solo in
minima parte
1 4
Soluzioni affette da alcuni gravi errori
e/o alcune sono significative sono
mancanti
2 8
La soluzione degli esercizi è affetta da
qualche errore non grave, e/o si è risposto
alla quasi totalità dei quesiti
3 12
Soluzione corrette, possono essere
presenti imprecisioni o qualche errore di
scarsa gravità
4 16
Soluzioni corrette e ottimizzate. In
presenza della documentazione
necessaria
5 20
MD10P8.2_01/rev.03 pag.55 di 55
Griglia di valutazione del colloquio (disponibile in supporto informatico Excel)
Valutazione COLLOQUIO - Esame di stato a.s. 2017-2018
Alunno/a:
Indicatore 1 da a Valutazione
Organizzazione della risposta in relazione al quesito posto
gravemente insufficiente 0,0 3,8
insufficiente 3,8 7,5 sufficiente 7,5 9,8 discreto/buono 9,8 12,8
peso = 15 buono/ottimo 12,8 15,0
Indicatore 2 da a Valutazione
Conoscenza dei contenuti disciplinari richiesti
gravemente insufficiente 0,0 12,5
insufficiente 12,5 25,0
sufficiente 25,0 32,5 discreto/buono 32,5 42,5
peso = 50 buono/ottimo 42,5 50,0 Indicatore 3 da a Valutazione
Capacità di argomentare, rielaborare, sintetizzare
gravemente insufficiente 0,0 6,3
insufficiente 6,3 12,5 sufficiente 12,5 16,3
discreto/buono 16,3 21,3
peso = 25 buono/ottimo 21,3 25,0
Indicatore 4 da a Valutazione
Competenza linguistica nell'uso del linguaggio specifico
gravemente insufficiente 0,0 2,5
insufficiente 2,5 5,0 sufficiente 5,0 6,5 discreto/buono 6,5 8,5
peso = 10 buono/ottimo 8,5 10,0 somma pesi Punteggio grezzo:
100 Punteggio in 30i:
tabella di conversione 0% 1,5% 3 Ipotesi di conversione
P.Grezzo-->P.30i 2% 3,5% 4 Grezzo % Voto in 30i
4% 6,5% 5 0% 1 7% 9,5% 6 49% 19,45
10% 11,5% 7 100% 30 12% 14,5% 8 15% 17,5% 9 18% 20,5% 10 21% 23,5% 11 24% 26,5% 12 27% 29,5% 13 30% 32,5% 14 33% 35,5% 15 36% 38,5% 16 39% 42,5% 17 43% 45,5% 18 46% 49,5% 19 50% 52,5% 20 53% 56,5% 21 57% 60,5% 22 61% 65,5% 23 66% 69,5% 24 70% 74,5% 25 75% 79,5% 26 80% 84,5% 27 85% 90,5% 28 91% 96,5% 29 97% 100,0% 30