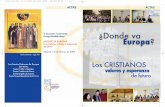DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE - liceopercoto.ud.it · 2009-2010 28 11promossi (2 con aiuto in...
Transcript of DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE - liceopercoto.ud.it · 2009-2010 28 11promossi (2 con aiuto in...

1
ANNO SCOLASTICO 2013-2014
DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE
Indirizzo pedagogico
Classe 5 DP
COORDINATORI
Prof.ssa ANNALISA FILIPPONI –
Prof.ssa GIULIANA MICHELUTTI
SEGRETARIO:
Prof.ssa ANNA RITA FERRARA

2
INDICE pag 3 Documento del consiglio di classe pag.8 Allegati: griglie di valutazione PROGRAMMI Italiano Storia Inglese Filosofia Scienze Umane Matematica Fisica Scienze Sperimentali Linguaggi non verbali e multimediali Educazione musicale Educazione motoria Religione RELAZIONI Italiano Storia Inglese Filosofia Scienze Umane Matematica Fisica Scienze Sperimentali Linguaggi non verbali e multimediali Educazione musicale Educazione motoria Religione

3
CLASSE 5 DP Coordinatori di classe: prof.ssa Annalisa Filipponi (01/09/2013- 28/04/2014) prof.ssa Giuliana Michelutti (dal 29/04/2014) Italiano e Storia: Michelutti Giuliana Inglese: Di Raffaele Raffella Filosofia: Filipponi Annalisa Fisica e Matematica: Ferrara Anna Rita Scienze umane: Novello Lauretta Scienze sperimentali: Zuccolo Enza Linguaggi non verbali: Zottig Pintor Lino Educazione fisica: Pascale Giuseppe Educazione musicale: Di Giorgio Angelo Religione: Di Benedetto Patrizia I docenti Di Raffaele, Novello, Zuccolo fanno parte della Commissione esaminatrice 1) PRESENTAZIONE SINTETICA DELLA CLASSE: La classe 5^ DP è composta da 21 alunni, di cui 3 maschi e 18 femmine; 16 allievi sono in corso regolare di studi, due presentano una ripetenza, tre ne presentano due. Degli allievi in corso non regolare di studi una proveniva da altro indirizzo dello stesso istituto, mentre gli altri provengono da altre scuole Dell’attuale gruppo classe 15 allievi provengono dal gruppo originario della classe prima. La storia della classe è riassunta nella seguente tabella. A. S. N. ALUNNI RISULTATO FINALE NOTE 2009-2010 28 11promossi (2 con aiuto in ingl), 12 sospesi,
di cui 11 promossi a settembre (6 con v.d.c) 4 non promossi a giugno, 1 non promosso a settembre.
2010-2011 23 12 promossi (9 s.d. 1 con v.d.c., 2 con aiuto ingl e mat.), 10 sospesi
1 nuovo alunno proveniente da altra scuola: 1 non ammesso, 10 promossi a settembre (5 con v.d.c.)
2011-2012 26 15 promossi (13 s.d., 2 v.d.c. per ingl), 5 sospesi.
4 nuovi allievi, provenienti da altra scuola, 6 non ammessi, 5 promossi a settembre (4 con v.d.c.)
2012-13 21 12 promossi (1 con aiuto in Sc. um.), 9 sospesi
Un allievo trasferito in altra scuola; 9 promossi a settembre, con v.d.c.
2013-14 21 Nessuna variazione
La storia della classe è caratterizzata quindi da una discreta stabilità, con un buon gruppo di allievi coesi fin dall’inizio. Dalla classe quarta il gruppo non ha subito variazioni. Ciò ha creato una buona coesione interna e un clima di amicizia, con ricadute positive nel processo di apprendimento. Nel corso del triennio la classe ha evidenziato un soddisfacente percorso di crescita e maturazione nell’impegno, nella responsabilità e nella collaborazione a livello di gruppo e in buona parte anche a livello individuale, ha mantenuto un atteggiamento collaborativo in ambito scolastico ed extrascolastico, partecipando a diverse proposte nell’ambito delle materie di indirizzo1, richiedenti anche un impegno in orario pomeridiano per visite a diverse realtà sociali presenti sul territorio; ha dimostrato interesse alle iniziative collaterali all’attività scolastica: attività ginniche (un’allieva ha partecipato ai giochi sportivi in Polonia con la squadra di pallavolo), attività teatrali (un allievo è
1 Vedasi allegato “Educazione alla legalità”

4
nel gruppo teatrale della scuola), conferenze e visite a carattere scientifico, ricerche personali e di gruppo. Tuttavia a questa buona disposizione verso un’apertura alla società circostante non tutti i ragazzi hanno mantenuto un impegno continuo nel modo di affrontare l’attività didattica curricolare in tutte le discipline. L’atteggiamento degli allievi è sempre stato positivo e rispettoso nei confronti dei compagni e degli insegnanti e cordiale e accogliente verso i nuovi allievi aggiuntisi nel corso del quinquennio. 2) CONTINUITÀ DIDATTICA NEL TRIENNIO: Nel triennio il consiglio di classe è rimasto stabile, senza alcun cambiamento. 3) PROFILO FINALE DELLA CLASSE : Il Consiglio esprime un giudizio positivo sull’andamento didattico-disciplinare della classe: in generale essa si è mostrata motivata al dialogo educativo ed interessata alle attività proposte, ma non tutti gli allievi hanno pienamente sviluppato le proprie potenzialità in tutte le discipline. Quasi tutti gli allievi hanno dimostrato un a apprezzabile livello motivazionale intrinseco, con partecipazione, impegno e studio domestico sufficientemente costanti, lodevole in alcuni casi. Il livello delle conoscenze disciplinari appare nel complesso soddisfacente, con alcuni studenti molto preparati e il linguaggio specifico risulta migliorato nel corso del triennio, con alcune criticità in ambito scientifico. Nel triennio alcuni obiettivi di contenuto sono stati rivisti in alcuni discipline in relazione al ritmo degli apprendimenti e il livello di competenza e conoscenza acquisito nelle singole discipline di carattere generale non per tutti gli allievi risulta pienamente rispondente agli standard richiesti; è stata privilegiata l’acquisizione di competenze di lettura critica degli eventi, di argomentazione, di collegamento interdisciplinare. Tali competenze sono state acquisite a livello diverso in rapporto all’impegno e alla maturazione personale di ogni allievo. Relativamente al profitto, la maggior parte degli allievi ha conseguito risultati positivi. 4) COMPRESENZA: Fisica (Ferrara) e Linguaggi non verbali (Zottig Pintor): Le interrelazioni tra fenomeni fisici e l’arte dalla fine dell’Ottocento al secondo dopoguerra. 5) OBIETTIVI EDUCATIVI E FORMATIVI E TRASVERSALI: In conformità con l’impianto pedagogico e procedurale che regola il Liceo Pedagogico, il Consiglio della classe 5^DP ha operato in considerazione dei seguenti obiettivi generali:
• acquisire la consapevolezza dello studio come strumento di crescita; • aumentare la propria motivazione allo studio • acquisire maggior controllo e consapevolezza, imparando ad autovalutarsi • acquisire la capacità di ascoltare e il rispetto delle regole e delle consegne, • intrattenere rapporti interpersonali improntati a correttezza e rispetto nello scambio di idee e
di collaborazione a progetti comuni • sviluppare la flessibilità del pensiero; acquisire capacità di analisi e sintesi • sviluppare a competenza linguistica, potenziando i linguaggi specifici di ogni disciplina • sviluppo della capacità di collegamento interdisciplinare • abituarsi all’uso dei manuali e di altri strumenti di ricerca • acquisire un metodo di studio autonomo ed efficace.

5
Collegamenti interdisciplinari: L’Etica, un aspetto della cittadinanza. Il percorso si è sviluppato tra bioetica ed eugenetica, potenzialità delle nuove tecnologie riproduttive e i limiti legislativi nazionali (scienze naturali); nel corso delle attività la tematica si è ampliata a considerare l’etica ambientale (storia) e la sostenibilità ecologica (storia, scienze, cittadinanza). Ogni qualvolta se ne è presentata l’opportunità gli insegnanti hanno proposto le connessioni tra le problematiche proposte e i contenuti inerenti alle discipline in tutti i possibili punti di incontro, non soltanto durante le compresenze, al fine di favorire negli studenti la costruzione corretta di proprie mappe mentali nei vari campi del sapere, nonché la consapevolezza che esistono di versi aspetti di uno stesso argomento, diverse prospettive di analisi e risposte diversificate. La metodologia di trattazione ha avuto anche l’obiettivo di promuovere un atteggiamento critico consapevole e sviluppare capacità argomentative fondate. Il Consiglio di Classe ritiene che nel complesso gli obiettivi previsti siano stati raggiunti dal gruppo–classe in modo didatticamente e culturalmente adeguato, sulla base di un livello comune di conoscenze, competenze e capacità. 6) INTERVENTI DIDATTICI EDUCATIVI EFFETTUATI (sostegno, recupero, potenziamento): a) Interventi di sostegno: personalizzati e in itinere per gli studenti in difficoltà, a cura dei docenti di classe b) Interventi di recupero: Tipo A (orario curricolare) e Tipo C (lavoro autonomo adeguatamente organizzato) nelle seguenti discipline: Inglese, matematica, Fisica, Scienze Umane, rivolti a 13 allievi. c) Interventi di potenziamento: alcuni (4) allievi hanno seguito dei moduli integrativi di chimica. periodo (settembre/dicembre) Materie Allievi Tip. Rec. Situaz. Debiti
Situaz. Debiti
n. studenti 13 Fisica 4 C al 7/03/14 al 29/04/14 Inglese 8 C 5 DS
6 DNS 13 in valutazione
Matematica 9 C Sc. umane 6 C Periodo gennaio/aprile Fisica 2 11DS
11DNS n. studenti 12 Inglese 7 Matematica 8 Sc. Umane 4 Scienze 2 8) ATTIVITÀ EXTRA – PARA - INTERCURRICOLARI EFFETTI VAMENTE SVOLTE : Tra i progetti finalizzati al coinvolgimento attivo degli alunni vanno ricordati
o progetto tutoring e scuola aperta (2 allieve) o AFDS, partecipazione alle giornate del dono del sangue (Alcuni allievi) o Concorso Solidarmente: la cultura della solidarietà o Progetto UEPE (Ufficio Esecuzione Penale Esterna): Il piacere della legalità o Partecipazione a spettacoli teatrali e visione di film in lingua inglese, nel corso del triennio
9) ADESIONE DELLA CLASSE ALLE INIZIATIVE DELLA SCUO LA : Gli alunni hanno risposto positivamente alle iniziative cui la scuola, nel corso del quinquennio, li ha sollecitati, dimostrando talora qualità pregevoli di interesse e partecipazione. Da segnalare:

6
anno scolastico 2010-2011
• Progetto “Il giornale: scrivere un articolo”: sei ore con la giornalista Gabriella Scrufari, del Messaggero Veneto, con lavori di gruppo misti classi 2 e 3 DP:
• Progetto CLIL in friulano Anno scolastico 2011-2012
• Progetto “Zero Poverty”, con supporto della Caritas: visita al cento di accoglienza Fogolâr. • Stage di tirocinio osservativo in classe 4^, svolto in diversi asili nido del Comune di Udine. • Le opere del Palladio: visita a Vicenza, Maser, Bassano del Grappa. • Visita alla centrale di trigenerazione presso il centro commerciale Terminal nord.
Anno scolastico 2013-2014 • 28/09/13 performance teatrale UEPE all’auditorium Zanon • 9/10/13 Visione del film Vajont - l’intervento dell’uomo sull’ambiente (più introduzione e
discussione), interdisciplinare tra storia, scienze, filosofia • 22/10/13 Visita alla biennale di Venezia • 23/10/13 conferenza con operatori CRSE sul disagio psichico • 6/11/13 Visita a Trieste: il sincrotrone Elettra, l’osservatorio geofisico e la Grotta gigante. • 27/11/13 gruppi di lettura (operatori disagio psichico) + conferenza • 20/12/13 premiazione concorso Solidarmente • 16/1/14 visita alla Comunità Nove – Udine • 22/1/14 Visita alla mostra fotografica di R. Capa “La realtà di fronte”, villa Manin di Passariano
(reportage di guerre) • 5/2/14 conferenza Serge Latouche: La teoria della decrescita felice (la sostenibilità ambienTALE) • 13/2/14 Lezione accademica su “Il calice e la spada” di R. Eisler: lezione in lingua inglese tenuta
dalla prof.ssa A. Riem, docente di letteratura inglese all’Università di Udine • 15/2/14 conferenza Mauro Ferrari: Nanotecnologie e cura dei tumori • 17/2/14 inizio del progetto “Capacità di decodificazione linguistica di base”: esercitazione sulle
prove di ammissione alla facoltà di Scienze della formazione • 20/2/14 Progetto ABCEuro, l’Europa e le sue prospettive • 20/3/14 Spettacolo “Lina e le altre” (le donne della Costituzione), di M, Somaglino, al teatro San
Giorgio • 28/3/14 uscita alla Comunità Nove • 8/4/14 spettacolo “Magazzino 18” di S. Cristicchi, al teatro Giovanni da Udine, con successiva
conferenza il 9/4/14 • Gruppi di lettura: incontri pomeridiani di lettura di testi scritti da operatori e personale del CSM
(Centro di Salute Mentale) • Progetto “Il piacere della legalità? Due mondi a confronto”: conferenze, visite in carcere e attività
varie (vedasi allegato) • Visite a istituzioni scolastiche: classi del progetto Montessori
10 ) METODOLOGIE DIDATTICHE ATTUATE E STRUMENTI: Il Consiglio di classe, fatte salve le specifiche metodologie assunte dai singoli docenti nelle discipline di appartenenza, per le quali si rimanda alle relazioni finali, ha individuato alcune linee metodologiche comuni:
• i programmi di ogni disciplina si sviluppano sui versanti sia delle conoscenze teoriche sia delle abilità, per costruire il connettivo tra la dimensione conoscitiva e la dimensione operativa e sviluppare adeguate competenze;
• nell’approccio alle varie tematiche si è cercato di coinvolgere la classe facendo ricorso il più possibile a metodologie che prevedono la partecipazione attiva del gruppo classe;
• le tecniche didattiche utilizzate vanno dalla lezione frontale con l’ausilio del libro di testo alle tecniche di problem solving, scoperta guidata, problemi stimolo, lavori di gruppo, uso dei laboratori di informatica, elaborazione di presentazioni individuali.

7
11 ) MODALITÀ DI VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO: Per monitorare le conoscenze, le abilità e le competenze acquisite dagli allievi durante l'anno scolastico sono stati utilizzati tutti gli strumenti utili a tale fine, quali test a risposta multipla, vero o falso, a completamento, colloqui, relazioni e verifiche scritte. L'esito delle verifiche è stato notificato e motivato sistematicamente agli allievi. Il giudizio finale ha tenuto conto, oltre alle valutazioni sommative attribuite secondo i criteri generali presenti nel P.O.F., anche della partecipazione e dell'impegno tenuti da ciascun allievo durante tutto il corso dell'anno scolastico nonché dei progressi effettuati in relazione allo stato di partenza. CRITERI PER LA VALUTAZIONE (da P.O.F.) VOTO
LIVELLO RAGGIUNTO
9/10 CONOSCENZE: approfondite, integrate da ricerche personali
COMPETENZE: esposizione esaustiva e critica con piena padronanza dei registri linguistici CAPACITẦ: critiche e creative, confronti nell’ambito disciplinare e/o pluridisciplinare
8 CONOSCENZE: complete e sicure COMPETENZE: espressione corretta e fluida, applicazione precisa, impostazione puntuale, uso del linguaggio specifico CAPACITẦ: critiche, di collegamento e di sintesi
7 CONOSCENZE: comprensione sicura degli argomenti COMPETENZE: corretta e fluente l’esposizione, di livello discreto ma appropriato l’utilizzo del linguaggio specifico, applicazione autonoma delle conoscenze, con qualche imperfezione. CAPACITẦ: critiche, di collegamento e di sintesi
6 CONOSCENZE: comprensione dei contenuti essenziali COMPETENZE: espressione sufficientemente fluida e corretta anche se non specifica CAPACITẦ: rielaborative e di sintesi accettabile.
5 CONOSCENZE: parzialmente acquisite COMPETENZE: esposizione talvolta incerta, linguaggio non sempre appropriato CAPACITẦ: rielaborazione modesta con sintesi non adeguata
4 CONOSCENZE: errate e/o carenze concettuali COMPETENZE: esposizione non appropriata, faticosa e sconnessa CAPACITẦ: carenze logiche, scarse quelle di rielaborazione
3 CONOSCENZE: gravemente errate e/o rilevanti carenze concettuali COMPETENZE: pressoché nulle CAPACITẦ: pressoché nulle
2/1 Come sopra, con rifiuto sistematico a sostenere prove orali e/o scritte
Gli elementi cardine, di cui si è tenuto conto per le valutazioni scritte e orali, si possono riassumere nelle seguenti richieste:
• possesso di un almeno sufficiente livello di conoscenze e informazioni multidisciplinari, con attenzione agli aspetti qualitativi più che nozionistico-quantitativi;
• capacità di critica e di riflessione sulle conoscenze apprese. 12) SIMULAZIONE DI TERZA PROVA - valutazione in 15/15: Sono state effettuate due simulazioni della terza prova d’esame, rispettivamente in data 5/12/13 e in data 25/03/14. Sono state anche effettuate una simulazione di prima prova (durata 5 ore, in data 13/3/14) e due simulazioni di seconda prova (durata 3 ore, in data: 29/1/14 e 16/4/14) Prima simulazione: tipologia B (3 quesiti a risposta breve per ogni disciplina, righe 8-12, tempo: ore 3. Allievi della classe n.21, Presenti:n.21. Discipline coinvolte: Inglese (voto medio 11,6/15), Fisica (voto medio 9,3/15), Filosofia (voto medio 10,5/15) LL.nn.vv. (voto medio 12,75/15). La valutazione complessiva per allievo ha prodotto il seguente risultato:

8
o valutazione complessivamente sufficiente(10/15): 12 allievi su 21 o voto più basso attribuito 8/15 (2 allievi) o voto più alto attribuito 14/15 (1 allievi) o punteggio medio di 11/15
Seconda simulazione 23/03/14): Tipologia B Allievi della classe n.21, Presenti:n.21. Discipline coinvolte: Musica (voto medio 11,4/15), Matematica (voto medio 9,3 /15), Scienze (voto medio 10,7/15), Storia (voto medio 11,7 /15). La valutazione complessiva per allievo ha prodotto il seguente risultato:
o valutazione complessivamente sufficiente (10/15): 18 allievi su 21 o voto più basso attribuito 8/15 (1 allievo) o voto più alto attribuito 13 /15 (2 allievi) o punteggio medio di 11/15
Allegati in cartaceo: Il percorso “Educazione alla legalità” (allegato D) Materiali di lettura (allegato E) 13) INDICATORI CORREZIONE PRIMA PROVA: allegato A 14) INDICATORI CORREZIONE SECONDA PROVA: allegato B 15) INDICATORI CORREZIONE TERZA PROVA TIPOLOGIA: allegato C Udine, 15 maggio 2014
Il Coordinatore Prof.ssa Giuliana Michelutti

9
ALLEGATO A - TABELLA DI VALUTAZIONE PRIMA PROVA PRIMA PROVA – tipologia B (saggio breve) Allievo Coefficiente Punteggio Indicatori B M Al Rispondenza alle consegne date e alle indicazioni di lavoro 1 2 3 Corretto utilizzo dei documenti di supporto, con rielaborazione di dati e riferimenti forniti e delle conoscenze acquisite.
1 2 3
Articolazione e coerenza dell’argomentazione 1 2 3 Pertinenza del registro linguistico e correttezza morfosintattica 1 2 3 Originalità delle argomentazioni, autonomia di giudizio, elaborazione critica.
1 2 3
Punteggio totale PRIMA PROVA – tipologia B (articolo di giornale) Allievo Coefficiente Indicatori B M Al Punteggio Rispondenza alle consegne date (titolo, lunghezza, destinazione editoriale
0.5 1 2
Corretto e pertinente utilizzo dei documenti di supporto 1 2 3 Articolazione e coerenza dell’argomentazione 1 2 3 Originalità dell’elaborazione e autonomia di giudizio 1 2 3 Pertinenza del registro linguistico e correttezza morfosintattica 1 1,5 2 Caratterizzazione del registro e dello stile ed eventuali capacità divergenti e creative
0.5 1 2
Punteggio totale PRIMA PROVA – tipologia A Analisi del testo Classe 5 Allievo Coefficiente Indicatori Descrittori Bs M Al Punteggio
Aspetti di: contenuto
Lettura e decodifica del testo: aderenza o fedeltà della parafrasi o dell’esposizione del contenuto
1 2 3
analisi Esaustività dell’analisi o del commento 1 2 3 Elaborazione critica, riflessioni, pertinenza dell’approfondimento
1 2 3
forma Sviluppo argomentativo (coerenza e coesione) 1 2 3 Pertinenza del registro linguistico e correttezza morfosintattica
1 2 3
Punteggio totale PRIMA PROVA – tipologia C e D (Tema di Storia e di ordine generale) Classe 5 Allievo Coefficiente Indicatori Descrittori Bs M Al Punteggio Conoscenze Correttezza e pertinenza dei contenuti (a carattere
mono e pluridisciplinare) 1 2 3
Capacità elaborative logico-critiche e creative
Organizzazione del testo: coerenza e coesione 1 2 3 Sviluppo delle argomentazioni 1 2 3
Originalità, autonomia di giudizio e di rielaborazione critica
1 2 3
Competenze linguistiche
Proprietà morfosintattica e lessicale 1 2 3
Punteggio totale

10
ALLEGATO B - GRIGLIA VALUTAZIONE SECONDA PROVA Conoscenza Punti 5
La conoscenza degli argomenti proposti nella traccia risulta pienamente pertinente, ampia, coerente e articolata
5
La conoscenza degli argomenti proposti nella traccia risulta pertinente, adeguata, coerente e articolata
4
La conoscenza degli argomenti proposti nella traccia risulta discretamente pertinente, adeguata e coerente
3
La conoscenza degli argomenti proposti nella traccia risulta sufficientemente pertinente e sufficientemente coerente
2
La conoscenza degli argomenti proposti nella traccia risulta essere parziale, non pienamente pertinente e coerente
1
La conoscenza degli argomenti proposti nella traccia risulta essere errata 0 Analisi Punti 3
Il contenuto è stato analizzato approfonditamente 3 Il contenuto è stato analizzato discretamente, con qualche lacuna 2 Il contenuto è stato analizzato solo superficialmente 1 Il contenuto è stato analizzato solo parzialmente 0
Linguaggio specifico Punti 2
Il linguaggio risulta ricco e con un buon uso del linguaggio specifico 2 Il linguaggio risulta parzialmente appropriato 1 Il linguaggio non è appropriato 0
Collegamenti Punti 3
I collegamenti risultano pertinenti e la trattazione è sicura e organica 3 I collegamenti risultano superficiali ma la trattazione è organica 2 I collegamenti risultano superficiali e la trattazione non sempre organica 1 Non sono presenti collegamenti 0
Competenza linguistica Punti 2
La competenza linguistica è adeguata 2 La competenza linguistica è sufficiente 1 La competenza linguistica non è adeguata 0
ALLEGATO C - Griglia correzione terza prova tipolog ia: B Griglia di valutazione 3^ prova: tipologia B Data …………………… Materia …………………… Docente ………………………. Candidato: ………………………… Descrittori
punteggi I quesito II quesito III quesito
Coerenza e coesione della risposta in relazione alla domanda
Max 3 punto
Completezza e correttezza della risposta in relazione alle conoscenze
Max 7 punti
Correttezza formale e pertinenza del lessico
Max 5 punti
Punteggio singolo
Punteggio totale (media)

11
ANNO SCOLASTICO 2013-2014
PROGRAMMI SVOLTI E RELAZIONI
Indirizzo pedagogico
Classe 5 DP

12
PROGRAMMI SVOLTI
ITALIANO Docente: GIULIANA MICHELUTTI Contenuti disciplinari analitici IL SECONDO OTTOCENTO: POSITIVISMO E DECADENTISMO Il contesto: Il Positivismo. La crisi della ragione: l’irrazionalismo. F. Nietzsche. I letterati e la società borghese. Le poetiche della narrativa. Le poetiche della lirica. Narrativa e poesia Il Realismo e il Naturalismo francese. La narrativa da Flaubert al naturalismo. La reazione al naturalismo e l’estetismo. Il romanzo decadente. In Italia: il verismo. Il romanzo decadente: Fogazzaro. La nascita della lirica moderna: simbolismo, parnassianesimo, i poeti maledetti, la scapigliatura, il realismo. La letteratura per l’infanzia. AUTORI Giovanni Verga. Poetica e opere: le novelle e il ciclo dei Vinti. Un romanzo sperimentale: I Malavoglia. Giosuè Carducci. Il poeta professore. La scelta del classicismo. Temi e forme. Giovanni Pascoli. La visione del mondo. La poetica: l’eroe e il fanciullino, il poeta – veggente, il poeta della natura. Le opere, i temi, le soluzioni formali. temi e stile. La critica. Gabriele D’Annunzio. La vita come un’opera d’arte. L’esteta e il superuomo. Il teatro. La produzione poetica. Il notturno. IL PRIMO NOVECENTO Il contesto. I caratteri del periodo. La frattura tra cultura scientifica e umanistica. Filosofia, scienze umane, psicoanalisi: Bergson, Freud. Narrativa e poesia in Europa e in Italia Le avanguardie. Il futurismo: Marinetti, Majakowskij. La nuova poesia. La lirica pura e altre tendenza. Apollinaire. La narrativa della crisi. Kafka, Proust, Joyce, Woolf, Musil, Hemingway. La lirica in Italia nel primo ventennio: Crepuscolari, Futuristi, Vociani. La lirica in Italia fra le due guerre. Il classicismo. L’ermetismo. La narrativa in Italia. La prosa d’arte. Il realismo. Le avanguardie. Le forme del romanzo: il romanzo psicologico, realista, fantastico AUTORI Luigi Pirandello La vita, le idee, la poetica, il romanzo psicologico e il teatro del Novecento. Italo Svevo Vita, idee, opere. Giuseppe Ungaretti Vita e opere. Eugenio Montale Vita e opere.

13
NEOREALISMO E LETTERATURA CONTEMPORANEA Le tematiche della letteratura neorealista e la reazione. Il contesto e i generi della narrativa. Vittorini, Pavese (cenni) La narrativa di memoria. Primo Levi (cenni) Contenuti non ancora trattati al 10/05/2014 Dopo il neorealismo: Gadda, Morante, Pasolini (cenni) Italo Calvino: uno scrittore poliedrico La contemporaneità: la letteratura del disimpegno e la letteratura dal mondo. Letture personali LA DIVINA COMMEDIA (opere) Paradiso: tre canti: lettura, commento. Testi: Armellini, Colombo, LETTERATURA LETTERATURE, vol. I, Il secondo Ottocento; vol. II, Il Novecento (due volumi, versione rossa) Zanichelli; Divina Commedia, (qualsiasi edizione) Materiali forniti dall’insegnante (schede in allegato cartaceo) F.to I rappresentanti degli studenti F.to Il docente G. Michelutti
ELENCO DELLE LETTURE: Realismo e Naturalismo francese Flaubert, Rappresentare e basta; da Madame Bovary, Le insofferenze di M.me Bovary Zola, Il romanzo sperimentale; da L’assomoir, La stireria Estetismo e parnassianesimo Wilde, La menzogna è lo scopo legittimo dell’arte Simbolismo, parnassianesimo, poeti maledetti Baudelaire, Perdita d’aureola, dai Fiori del male: L’albatro, Corrispondenze, Spleen Rimbaud, Bisogna essere veggenti. Verlaine, Languore Scapigliatura, realismo Praga, Preludio Camerana, Cerco la strofa Guerrini, Sciopero in risaia Classicismo Carducci, Inno a Satana; da Rime nuove, Congedo, Pianto antico, San Martino; da Odi barbare: Alla stazione in una mattina d’autunno; schede: Traversando la Maremma toscana Verismo Capuana, Precocità Verga, da Novelle rusticane: Libertà; da Vita dei campi, Rosso Malpelo, Fantasticheria (L’ideale dell’ostrica), Cavalleria rusticana; dai Malavoglia: Come le dita di una mano, Ora è tempo di andarsene; da Mastro don Gesualdo, Morte di mastro don Gesualdo Decadentismo Pascoli, La grande proletaria s’è mossa, È dentro di noi un fanciullino; da Myricae: L’assiuolo, Temporale, Patria, X agosto, Novembre, Lavandare; da Primi poemetti, La siepe(I), Digitale purpurea; da Canti di Castelvecchio, La mia sera, Il gelsomino notturno.

14
D’Annunzio, da Alcyone, La pioggia nel pineto; I pastori (scheda), dal Piacere, la vita come opera d’arte; da Maia, La quadriga imperiale, dal Poema paradisiaco Consolazione, dal Trionfo della morte, Tu mi sei ignota; L’ultimo atto (simulazione di prima prova) Futurismo e dintorni Marinetti, Manifesto del Futurismo; da Zang Tumb Tuum, Correzione di bozze Majakovskij, La guerra è dichiarata Palazzeschi, Lasciatemi divertire; da Il codice di Perelà, Perelà uomo di fumo Apollinaire, da Calligrammi, La piccola auto Crepuscolari Corazzini, Desolazione del povero poeta sentimentale Gozzano, La signorina Felicita, L’amica di nonna Speranza (I), Elogio degli amori ancillari (scheda) Moretti, A Cesena (scheda) Vociani Rebora, Il carro vuoto, Dall’imagine tesa. Sbarbaro, Liguria Serra,Esame di coscienza di un letterato Isolati Saba; Città vecchia, La capra; Trieste, Ed amai nuovamente, Goal, Mio padre è stato per me “l’assassino”, Ritratto della mia bambina, Ulisse Penna, Interno Pavese, Esterno Ermetismo Quasimodo, Dormono selve, Uomo del mio tempo, schede: Oboe sommerso, Alle fronde dei salici, Sereni, Non sa più nulla Narrativa Virginia Woolf, Il romanzo moderno, da Al faro: Sì, certamente, se domani è bello Kafka, da Il processo, La fine Hemingway, Addio alle armi (inizio) Moravia, da Gli indifferenti, La vita non cambia (inizio) Lussu, da Marcia su Roma, Al confino, Pirandello, da Novelle per un anno, La carriola; da Uno, nessuno e centomila, Quel caro Gengè; Sei personaggi in cerca d’autore; Enrico IV (finale); Svevo, da La coscienza di Zeno, Prefazione, Il fumo; da Senilità, La metamorfosi di Angiolina, La conquista Poesia Montale, da la farfalla di Dinard, Racconto d’uno sconosciuto; da Ossi di seppia: Non chiederci la parola, I limoni, Spesso il male di vivere, da Le occasioni: La casa dei doganieri, Non recidere, forbice, quel volto; da Satura, Ho sceso, dandoti il braccio; da Diario del 71 e del 72: Per finire. Ungaretti, dal Porto sepolto, Commiato; dall’Allegria, I fiumi, Veglia, San Martino dl Carso, Vanità; da Sentimento del tempo; L’isola, La madre; da Il dolore, Giorno per giorno.. Ungaretti, Ritrovare un ordine, pag. 394; Montale, È ancora possibile la poesia? Pag. 441 Secondo Novecento Pier Paolo Pasolini, La civiltà dei consumi

15
Testi non ancora letti al 10/05/2014 Italo Calvino, La gallina di reparto; Il divertimento è una cosa seria; da Il cavaliere inesistente:Era schierato l’esercito di Francia, da la giornata d’uno scrutatore: Questo modo d’essere è l’amore Claudio Magris, dalla Prefazione di L’infinito viaggiare. F.to I rappresentanti degli studenti F.to Il docente G. Michelutti
STORIA Docente: GIULIANA MICHELUTTI Contenuti disciplinari analitici IL PRIMO NOVECENTO E LA PRIMA GUERRA MONDIALE L’imperialismo e la crisi dell’equilibrio europeo La Belle Epoque. Colonialismo e imperialismo. La Germania di Guglielmo II e il nuovo sistema di alleanze Lo scenario extraeuropeo La Russia degli zar. La guerra tra Russia e Giappone e la rivoluzione del 1905. Crescita economica e imperialismo degli Stati Uniti. L’Italia giolittiana La legislazione sociale di Giolitti e lo sviluppo industriale dell’Italia. Politica interna e politica estera La prima guerra mondiale Le cause della guerra. 1914: il fallimento della guerra lampo. L’Italia in guerra: 1915-16, la guerra di posizione. Il 1917 sui diversi fronti. Verso la fine della guerra La Rivoluzione russa Le rivoluzioni del 1917. Lenin alla guida dello Stato sovietico Il primo dopoguerra La conferenza di pace: i 14 punti di Wilson. Il nuovo volto dell’Europa. Il Vicino Oriente. I paesi afroasiatici verso l’indipendenza; la rivoluzione maoista in Cina. Il nuovo ruolo degli Stati Uniti e l’ascesa economica. La crisi del 1929 e gli effetti mondiali L’Europa tra democrazia e dittatura In Italia La questione di Fiume. La crisi del liberalismo e il biennio rosso L’ET Ầ DEI TOTALITARISMI In Italia . Nascita ed evoluzione del fascismo. Il regime. Politica intera e politica estera. L’Unione sovietica: il comunismo al potere. La nascita dell’URSS. Stalin e la dittatura La Germania: La repubblica di Weimer. Hitler e il nazionalsocialismo; la Germania nazista La Spagna: La Spagna tra democrazia e franchismo. La guerra civile spagnola

16
LA SECONDA GUERRA MONDIALE La seconda guerra mondiale: 1939-1942 Verso la guerra. Gli inizi. L’intervento italiano. Il ruolo dell’URSS.L’offensiva dell’Asse nella primavera 1941 La Shoah. L’intervento degli Stati Uniti. La controffensiva alleata La seconda guerra mondiale: 1942-1945 La conferenza di Casablanca Il 1943 in Italia. La Resistenza in Europa e in Italia La guerra in Europa (1944-45). La guerra in Italia (1944-45).La fine del conflitto. UN NUOVO ORDINE MONDIALE Il mondo bipolare La periodizzazione del secondo dopoguerra. Le due Europe. Nato e Patto di Varsavia. La guerra fredda. Il piano Marshall. Il panorama mondiale nella “guerra fredda”. L’età della distensione Contenuti non ancora trattati al 10/05/2014 L’Italia del dopoguerra Il trattato di pace. La questione di Trieste. La repubblica. La ricostruzione. Il centro-sinistra. Il “miracolo economico”. Testo: BRANCATI, PAGLIARANI, Voci della storia 3, La Nuova Italia, Milano
F.to I rappresentanti degli studenti F.to Il docente G. Michelutti
LINGUA INGLESE
Docente: RAFFAELLA DI RAFFAELE Contenuti disciplinari analitici: Lingua: Ripasso dei tempi verbali esaminati durante i precedenti anni scolastici: present s/c, present perfect s/c, past s/c, past perfect s, future forms, present and past conditional, passive voice. Modal verbs, Phrasal verbs. Ripasso in itinere di tutte le strutture e le funzioni che di volta in volta si è reso necessario riesaminare, prendendo spunto dalla correzione degli errori più comuni nelle prove scritte o orali. Letteratura e civiltà: Modulo psicologia : Violence: Behind closed doors A.Bronte: The Tenant of Wildfell Hall T. Hardy : The Mayor of Casterbridge S. L. Shank: Every 15 seconds

17
P. W. Cook: Help for battered men Modulo scienze: The Responsibility of Science M. Shelley:Frankenstein R.L. Stevenson: Dr. Jekill and Mr. Hyde Ethical boundaries: A. Ross: Dr. Frankenstein,I presume? H. G. Wells: The Island of Doctor Moreau D. Brown: Angels and Demons fonte Washingtonpost.com: Of mice,men and in-between. N. Hawthorne: The Liquor of Youth Modulo scienze sociali: Is poverty still with us J. Swift: A Modest Proposal C. Dickens: Bleak House H. Roy: Hunger and poverty: a universal shame United nations Millennium Declaration Modulo “Figure femminili nella letteratura inglese” T. Hardy : Tess of the d’Urbervilles J. Joyce: Eveline Modulo “Studenti a teatro” O. Wilde;The Picture of Dorian Gray Altri riferimenti letterari: The Romantic Novel: E. Bronte : Wuthering Heights Victorian Theatre: O. Wilde: The Importance of Being Earnest R. Eisler”The Chalice and the Spade” (conferenza in lingua inglese) Sono state delineate le caratteristiche fondamentali, funzionali allo sviluppo dei moduli sopraccitati,dei periodi letterari a cui gli autori ed i brani appartengono. Programma che si intende svolgere fino all’11 giugno: W. Conard Holton: Rich map, poor map J. D. Sachs:The poverty that kills Make Poverty History:The UK campaign F. McCourt: Angela’s Ashes Testi adottati: “Spotlight on you” vol 2, diPapa, Shelly - ed. Zanichelli “Themes and Links” di Lerro, Marro, Walters-ed. Europass “Litfest” di Perrucchi, Pajalich, Lynch - ed. Europass “Working with grammar –Gold multimedia edition”- ed. Longman F.to I rappresentanti degli studenti F.to Il docente R. Di Raffaele

18
FILOSOFIA Docente: ANNALISA FILIPPONI Contenuti disciplinari analitici G. W. F. HEGEL: Le tesi di fondo del sistema. Idea, natura e spirito. La dialettica. La Fenomenologia dello spirito. Coscienza, Autocoscienza (Signoria e servitù; la coscienza infelice) Ragione. L’Enciclopedia delle scienze filosofiche. La logica (cenni). La filosofia della natura (cenni). La filosofia dello spirito: lo spirito soggettivo, lo spirito oggettivo, lo spirito assoluto Filosofia e storia della filosofia. A. SCHOPENHAUER: Il mondo della rappresentazione come “velo di Maya”. La scoperta della via d’accesso alla cosa in sé. Caratteri e manifestazioni della “ volontà di vivere”. Il pessimismo. Dolore, piacere e noia. La sofferenza universale. L’illusione dell’amore. Le vie della liberazione: l’arte, l’etica della pietà e l’ascesi. K. MARX: Caratteristiche del marxismo. La critica del “misticismo logico” di Hegel. La critica della civiltà moderna e del liberalismo: emancipazione politica e umana. La critica dell’economia borghese e la problematica dell’alienazione. L’interpretazione della religione in chiave sociale. La concezione materialistica della storia. La sintesi del Manifesto. Il Capitale. La rivoluzione e la dittatura del proletariato. Le fasi della futura società comunista. S. KIERKEGAARD : L’esistenza come possibilità e fede. La verità del “singolo”: il rifiuto dell’hegelismo e “l’infinita differenza qualitativa” tra l’uomo e Dio. Gli stadi dell’esistenza: la vita estetica, la vita etica e la vita religiosa. L’angoscia. Disperazione e fede. F. NIETZSCHE: Nazificazione e denazificazione. Fasi o periodi del filosofare nietzscheano. Il periodo giovanile. Tragedia e filosofia. Il periodo “illuministico” Il metodo genealogico e la filosofia del mattino. La “morte di Dio” e la fine delle illusioni metafisiche. Il periodo di Zarathustra. La filosofia del meriggio (cenni). Il superuomo. L’eterno ritorno. L’ultimo Nietzsche. La “trasva- lutazione dei valori”. La volontà di potenza. Il problema del nichilismo e del suo superamento. M. HEIDEGGER : Il primo Heidegger. Essere ed esistenza. L’analitica esistenziale. Fenomenologia, ermeneutica dell’Esserci, ontologia. . L’Esserci come essere-nel-mondo e la visione ambientale preveggente. L’esistenza in autentica. L’esistenza autentica. L’Esserci come cura. L’essere-per-la-morte. La “voce della coscienza”. Il tempo e la storia. L’incompiutezza di Essere e tempo.

19
Si propone di completare il programma con i seguenti autori: Il secondo Heidegger. La svolta. Dopo Essere e tempo: la differenza ontologica, il nulla e l’essenza della verità.. La metafisica. L’oblio dell’essere e il nichilismo. La centralità dell’essere e la polemica antiumanistica e antiesistenzialistica. Arte, linguaggio e poesia. La tecnica. Il superamento della metafisica. K. R. POPPER: Le dottrine epistemologiche. Il problema della demarcazione e il principio di falsificabilità. Le asserzioni-base e l’immagine della scienza come “costruzione su palafitte”. L’asimmetria tra verificabilità e falsificabilità e la teoria della corroborazione. La riabilitazione della metafisica. La critica epistemologica al marxismo e alla psicoanalisi. Inesistenza ed esistenza del metodo. Il procedimento per “congetture e confutazioni”. Il rifiuto dell’induzione e la teoria della mente come un “faro” e non come “recipiente”. Mente e corpo. Nuvole e orologi. Le dottrine politiche: Storicismo, utopia e violenza; la teoria della democrazia; il riformismo gradualista. F.to I rappresentanti degli studenti F.to Prof. Annalisa Filipponi
SCIENZE UMANE Docente: LAURETTA NOVELLO Contenuti disciplinari analitici: Testo: U. AVALLE, M. MARANZANA, Pensare ed educare, 3, Paravia, Torino, 2005
• Il Positivismo e l’educazione o Il Positivismo europeo: Comte, Durkheim, Spencer. o La pedagogia italiana dell’età del Positivismo: Cattaneo.
• La pedagogia e l’educazione europea oltre il Positivismo o La pedagogia di K. Marx. o L’educazione dell’oltreuomo: F. Nietzsche o L’attualismo pedagogico: G. Gentile o L’educazione e l’inconscio: S. Freud
• L’attivismo pedagogico e le “scuole nuove” o Un precursore: Lev Tolstoj e la scuola non-direttiva di Jasnaja Poljana o In Italia: le sorelle Agazzi e l’educazione infantile materna
• Dewey e l’attivismo americano o Esperienza e attivismo pedagogico: J. Dewey
• L’attivismo scientifico europeo: o Interesse e ambiente: Decroly o Maria Montessori e la “Casa dei bambini”
• La psicopedagogia del Novecento o La scuola psicanalitica in Inghilterra: Anna Freud e Melanie Klein (cenni) o La prosecuzione della psicoanalisi negli Stati Uniti: Erik Erikson e Bruno Bettelheim o In Svizzera: J. Piaget e la psicologia genetica.

20
o In Russia, la socialità dello sviluppo: L. Vygotskij • La psicopedagogia americana
o Dallo strutturalismo alla pedagogia come cultura: Bruner • Una nuova epistemologia pedagogica
o Il pensiero della complessità: E. Morin • Critica della scuola e pedagogie alternative
o Don Milani e l’esperienza di Barbiana o La pedagogia non-direttiva: Rogers
Lettura integrale (facoltativa) E. Morin, La testa ben fatta, Raffaello Cortina Editore, Milano, 2000 Approfondimento Inter-poli-trans-disciplinarietà pagg.111-123 (lettura obbligatoria) Lettura integrale (facoltativa) Z. Bauman, Vita liquida, Editori Laterza, Bari, 2009 Approfondimento: Vivere in un mondo liquido-moderno pagg. VII-XXIII (lettura obbligatoria) Lettura di alcuni brani da M. Serres, Non è un mondo per vecchi, Bollati Boringhieri editore, Torino, 2013
Testo: A. BIANCHI, P. DI GIOVANNI, Psicologia Oggi, Paravia, Milano, 2005
• Unità 17: La Personalità o Da che cosa dipende la personalità o Teorie classiche della personalità
• Unità 18: Salute e malattia mentale o Normalità e patologia o Le malattie mentali
________________________________________________________________________________ *La strategia di Lisbona e gli obiettivi 2020 * Il vero, il bello, il bene: le basi dell’educazione di tutti gli esseri umani –Howard Gardner intervistato da John Brockman *L’infanzia sta scomparendo, ormai si diventa subito grandi –Neil Postman intervistato da Francesca Leoni, 2001 *questa parte del programma sarà svolta dopo il 10 maggio 2014 F.to I rappresentanti degli studenti F.to Il docente Lauretta Novello
MATEMATICA Docente: ANNA RITA FERRARA Contenuti disciplinari analitici Ripasso: l’algebra di secondo grado, equazioni e disequazioni razionali intere e fratte

21
Insiemi numerici: Intervalli limitati ed illimitati, aperti e chiusi; intorni; punti di accumulazione. Funzioni di una variabile: dominio (trovare il dominio di funzioni razionali intere e fratte; funzioni irrazionali quadratiche intere e fratte; semplici funzioni logaritmiche e esponenziali); segno e zeri di una funzione (funzioni razionali intere e fratte; funzioni irrazionali intere e fratte); codominio; funzioni iniettive, suriettive, biettive; funzioni monotone (funzione crescente e decrescente); funzioni pari e dispari; classificazione delle funzioni matematiche. (Dal grafico ricavare le proprietà della funzione). Limiti e continuità : definizione intuitiva di limite; definizioni di limite finito o infinito al finito o ad infinito (verifica di limite finito al finito per semplici funzioni razionali intere e fratte); limite destro e sinistro. Operazioni sui limiti (calcolo di limiti di funzioni razionali intere e fratte; funzioni irrazionali intere e fratte; semplici funzioni esponenziali). Forme indeterminate. Definizione di continuità di una funzione in un punto ed in un insieme. Classificazione dei punti di discontinuità (di I, II e III specie). Applicazione del calcolo di limiti per la ricerca degli eventuali asintoti orizzontali, verticali, obliqui di una funzione razionale e irrazionale quadratica intere e fratte. Derivata di una funzione: Rapporto incrementale, significato geometrico del rapporto incrementale, definizione di derivata. Derivabilità di una funzione in un punto e derivata di una funzione (applicando la definizione) Calcolo di derivate: derivata della funzione costante , derivata della funzione potenza, derivata del prodotto di una costante per una funzione, derivata di una somma, di un quoziente, di un prodotto di funzioni, derivata di una funzione composta. La continuità e la derivabilità. Studio della derivata prima: massimi e minimi relativi e assoluti di una funzione, funzioni crescenti e decrescenti, flessi a tangente orizzontale. Contenuti previsti dal 10 maggio al termine dell’attività didattica Derivata seconda di una funzione: concavità di una curva e ricerca dei flessi obliqui. Analisi dei casi di non derivabilità di una funzione in un punto: punti angolosi. Studio completo di semplici funzioni razionali intere e fratte per la determinazione del suo grafico. Testo in uso: Elementi di matematica a colori, Leonardo-Sasso, Petrini
F.to I rappresentanti degli studenti F.to Il docente Anna Rita Ferrara
FISICA Docente: ANNA RITA FERRARA Contenuti disciplinari analitici Cariche elettriche e la legge di Coulomb
• La definizione operativa della carica • Unità di misura della carica nel SI • Convenzioni sui segni delle cariche • Elettrizzazione per strofinio • Elettrizzazione per contatto

22
• Elettrizzazione per induzione • Elettrizzazione per orientamento • Conduttori e isolanti • La conservazione della carica elettrica • L’elettroscopio a foglie • La legge di Coulomb • Il principio di sovrapposizione
Il campo elettrico • Il vettore campo elettrico • Il campo elettrico prodotto da una carica puntiforme e da più cariche • Rappresentazione del campo elettrico attraverso le linee di campo • Le proprietà delle linee di campo
Il potenziale elettrico • L’energia potenziale elettrica • Il potenziale elettrico e la sua unità di misura • La differenza di potenziale • Il lavoro di un campo elettrico • Relazione tra campo elettrico e differenza di potenziale • Le superfici equipotenziali
La corrente elettrica • Intensità e verso della corrente • L’unità di misura della corrente nel SI • Elementi fondamentali di un circuito elettrico • La capacità dei conduttori • I condensatori piani • Potenza elettrica • La prima legge di Ohm • La legge di Kirchhoff • Collegamenti in serie e in parallelo di resistori • La seconda legge di Ohm • La resistività • L’ effetto Joule
Fenomeni magnetici fondamentali e campo magnetico • Fenomeni di magnetismo naturale • Attrazione e ripulsione tra poli magnetici • Caratteristiche del campo magnetico • Le linee del campo magnetico • Analogie e differenze tra campo elettrico e campo magnetico • L’esperienza di Oersted e le interazioni tra magneti e correnti • L’esperienza di Faraday e la forza tra fili percorsi da corrente • Intensità del campo magnetico e sua unità di misura • Legge di Biot-Savart • Campo nel centro di una spira circolare • Campo in un solenoide • Campo magnetico nella materia • La permeabilità magnetica relativa • La forza di Lorentz

23
Contenuti previsti dal 10 maggio al termine dell’attività didattica Induzione elettromagnetica
• La corrente indotta e l’induzione elettromagnetica • Il flusso del campo magnetico • Il flusso e le linee del campo magnetico • La legge di Faraday-Newmann-Lenz
F.to I rappresentanti degli studenti F.to Il docente Anna Rita Ferrara
SCIENZE (BIOLOGIA UMANA) Docente: ENZA ZUCCOLO Contenuti disciplinari analitici Organizzazione del corpo umano
L' organizzazione generale del corpo, i tessuti Il concetto di omeostasi Meccanismi di regolazione della temperatura corporea Principali caratteristiche e funzioni dei tessuti: epiteliale, connettivo, muscolare, nervoso Struttura e caratteristiche dei tessuti osseo e cartilagineo Le funzioni del tessuto osseo: sostegno, banca del calcio, funzione del midollo osseo
Il sistema respiratorio Struttura dell' apparato respiratorio nell' organismo umano La meccanica respiratoria Il trasporto e lo scambio dei gas La regolazione della respirazione
Il sistema circolatorio Composizione e funzioni del sangue I vasi sanguigni: arterie,vene e capillari La struttura del cuore e la regolazione del battito cardiaco La circolazione doppia e completa
Il sistema immunitario Le difese immunitarie non specifiche, l’infiammazione La risposta immunitaria mediata da cellule La risposta immunitaria mediata da anticorpi Struttura e funzione degli anticorpi La vaccinazione e la sieroterapia Cenni alle allergie, alle malattie autoimmuni, all’AIDS Il trapianto degli organi I gruppi sanguigni, il fattore Rh
Il sistema escretore Struttura del rene e del nefrone Filtrazione, secrezione e riassorbimento Regolazione ormonale del bilancio idrico
Il sistema endocrino Ruolo degli ormoni Principali funzioni degli ormoni di: ippotalamo, ipofisi, tiroide e paratiroidi, surrenali
Il sistema nervoso

24
Struttura della cellula nervosa Il potenziale d' azione e le caratteristiche dell' impulso nervoso Sinapsi e neurotrasmettitori Struttura del S.N. centrale e periferico, somatico e autonomo La struttura e le funzioni dell’encefalo
La corteccia cerebrale e alcune importanti aree funzionali le sostanze psicoattive (oppioidi, cocaina, anfetamine, ecstasy, cannabinoidi, LSD), modalità di azione ed effetti Gli organi di senso: struttura di occhio e orecchio
La riproduzione umana Significato biologico di riproduzione sessuata Anatomia degli apparati riproduttori della donna e dell' uomo La regolazione ormonale nella donna e nell’uomo Lo sviluppo dell’embrione umano: fecondazione, impianto, ruolo delle membrane extraembrionali Cenni alle principali tecniche di procreazione assistita anche in relazione ai limiti della legislazione italiana in proposito
Contenuti che si prevede di svolgere dal 15/5/14 alla fine dell' anno scolastico: L' apparato digerente
Organi e ghiandole dell' apparato digerente La digestione e l' assorbimento Cenni ai principi nutritivi e al significato di dieta equilibrata
Testo: H. Curtis, N.S.Barnes – Invito alla biologia vol.B - Zanichelli F.to I rappresentanti degli studenti F.to Il docente Enza Zuccolo
.
LINGUAGGI NON VERBALI E MULTIMEDIALI Docente: LINO ZOTTIG-PINTOR Contenuti disciplinari analitici NEOCLASSICISMO - Canova Amore e psiche 1793 Paolina Bonaparte 1804 – 07 - J. L. David Il giuramento degli Orazi 1784 - 85 La morte di Marat 1793 ROMANTICISMO - Goya 3 maggio 1808 – Fucilazione alla montagna del Principe Pio - Friedrich Croce in montagna - Turner Bufera di neve: Annibale e il suo esercito attraversano le Alpi - Ingres La grande odalisca

25
- Géricault La zattera della medusa 1819 - Delacroix Libertà che guida il popolo IL REALISMO - Courbet Funerale a Ornans - Fattori Il campo di battaglia dopo la battaglia di Magenta IMPRESSIONISMO - Manet Colazione sull’erba 1863 Il Bar delle Folies-Bergères 1881-82 Olympia 1863 - Monet La Grenouillere 1869 - Degas Classe di danza 1873-75 - Renoir Ballo al Moulin de la Galette POSTIMPRESSIONISMO - Cèzanne Le grandi bagnanti 1985 - Seurat Domenica alla Grande Jatte 1884-86 - Gauguin La visione dopo il sermone - 1888 - Van Gogh I mangiatori di patate 1885 Campo di grano con corvi 1890 -Toulouse-Lautrec La Goule arriva al Moulin Rouge con due donne - 1892 LE AVANGUARDIE: - Klimt Giuditta II - 1909 -La Secessione Viennese - L’art nouveau - I Fauves - Matisse Armonia in rosso – 1908 L’espressionismo - Kirchner Potsdamer Platz - 1914 - Munch L’urlo 1893 - Kokoschka La sposa del vento - 1914 - Schiele L’abbraccio 1917 - Picasso Les demoiselles d’Avignon 1907 Guernica 1937 - Braque “Le quotidien”, violino e pipa – 1912 Modigliani -Ritratto di Lunia Czechowska – 1917 Chagall Passeggiata – 1917-18 Il Doganiere – Henry Rousseau L’incantatrice di serpenti Il Futurismo - Marinetti - Boccioni La città che sale 1910-11 Forme uniche della continuità nello spazio 1913 - Balla Dinamismo di un cane al guinzaglio 1912 Il Dadaismo

26
- Duchamp Fontana 1916 L.H.O.O.Q. 1919 - Ray Le violon d’Ingres 1924 * Si prevede un eventuale ulteriore approfondimento, da completarsi entro la fine dell’anno scolastico, sulle seguenti opere: Surrealismo - Mirò Il carnevale di arlecchino 1924 - Magritte L’uso della parola 1928-29 - Dalì La persistenza della memoria L’Astrattismo - Kandinskij Primo acquerello astratto - 1910 Composizione VII 1913 F.to I rappresentanti degli studenti F.to Il docente Lino Zottig-Pintor
EDUCAZIONE MUSICALE Docente: ANGELO DI GIORGIO Contenuti disciplinari analitici 1 - TEORIA: Concetto di tonalità, scale maggiori, scale minori. Accordi maggiori e minori. Ricerca della tonalità (maggiore e minore). Le chiavi musicali. Chiave di basso, di violino e doppio pentagramma. Tempi semplici e composti. Gruppi irregolari: terzina e duina. 2 – STORIA DELLA MUSICA: Il Romanticismo: la musica romantica ed i suoi caratteri; confronto con le caratteristiche della musica del periodo classico. Il melodramma in Italia e in Germania. Gioacchino Rossini, ascolto dell’opera Il Barbiere di Siviglia. Ascolto dell’opera Rigoletto di G. Verdi e dell’opera L’Oro del Reno di R. Wagner. La musica strumentale. Il poema sinfonico: Danza macabra di C. Saint Saens, Così parlò Zarathustra di R. Strauss, Sheherazade di N. Rimskij Korsakov, Quadri di un’esposizione di M. Musorgskij. L’orchestra nel periodo romantico. Schubert e la musica da salotto. Ascolto dei lieder: Il re degli Elfi, La rosellina e La trota. Chopin, il pianoforte romantico. La figura del virtuoso nel romanticismo: Paganini e Listz. Le scuole nazionali: la situazione della musica nei paesi nordici e nella Russia con “Il gruppo dei cinque”. Ciaikovski e il balletto, Lo Schiaccianoci. Verso il novecento. Il verismo in Italia con Puccini e Leoncavallo e in Francia con Bizet. Cenni sul contenuto dalla Tosca, dalla Boheme e dalla Madama Butterfly di Puccini. Ascolto dell’opera Pagliacci di R. Leoncavallo.

27
L’impressionismo in Francia con C. Debussy, esempio con Des pas sur la neige per pianoforte, Danses per arpa e orchestra .
La musica contemporanea, l’espressionismo e la scuola di Vienna. A. Schoenberg e la dodecafonia. Ascolto di “Un sopravvissuto di Varsavia” e “Pierrot Lunaire
(Colombina) di A. Schoenberg. Stravinskij e il balletto, ascolto del balletto La Sagra della Primavera. La musica futurista, ascolto “Risveglio di una città” di L. Russolo e Aviatore di F.B. Pratella. Il secondo dopoguerra e le avanguardie. La musica concreta, la musica elettronica. Ascolto di Visage di L. Berio. 3 – Scansione RITMICA e SOLFEGGIO parlato di cellule ritmiche nei tempi semplici e composti con movimento della mano. Si sono proposti come solfeggi parlati estratti di composizioni degli autori studiati o di esercizi dal libro di testo (p.148 - 149). In particolare uso del doppio pentagramma negli esercizi dal n.1 al n. 6 di pag.208 a pag.212. 4-LA DIDATTICA Le metodologie didattiche: Dalcroze, Orff, Kodaly, Willems. L’educazione musicale nella scuola primaria. La voce e i suoi timbri (es.7 pag. 77 vol.B) Modelli espressivi e intonazione (es.8 pag. 81 vol.B) F.to I rappresentanti degli studenti F.to Il docente Angelo Di Giorgio
EDUCAZIONE FISICA
Docente: GIUSEPPE PASCALE OBIETTIVI Potenziamento fisiologico (corsa) Rappresenta il presupposto per il normale svolgimento delle attività che si andranno a sviluppare durante l’anno scolastico In questo ambito ho curato:
• il miglioramento della funzione degli apparati respiratori e cardiovascolare; • sviluppo della potenza muscolare; • mobilità e scioltezza muscolare ed articolare; • la velocità intesa come capacità di compiere azioni coordinate nel più breve tempo possibile.
Rielaborazione e Consolidamento degli Schemi motori Con attività in ambiente naturale se possibile e con esercizi, a corpo libero, ai piccoli e ai grandi attrezzi,asse d’equilibrio ho inteso affinare la coordinazione dinamica e la lateralità e consolidare e ampliare il bagaglio motorio degli alunni. Avviamento alla pratica sportiva Conoscenza e pratica dei fondamentali individuali e di squadra degli sport praticati durante l’a.s. Atletica leggera conoscenza e pratica dei preatletici generali; corsa ,salto in lungo cenni sulle altre specialità, attività in ambiente naturale(se previste nel p.o.f. della scuola).

28
Contenuti disciplinari analitici I Quadrimestre
- Attività ed esercizi a carico naturale o con basso carico addizionale - Attività ed esercizi di opposizione e resistenza - Attività ed esercizi con piccoli attrezzi e ai grandi attrezzi codificati e non codificati - Attività ed esercizi per il controllo segmentario, per il rilassamento, per il controllo della respirazione - Attività sportive individuali da scegliere tra atletica leggera, ginnastica artistica, ginnastica aerobica, badminton, tennis-tavolo, - Attività sportive di squadra da scegliere tra: pallacanestro, pallavolo, pallamano, pallatamburello, calcio etc.
II Quadrimestre
- Conoscenze fondamentali sui corretti comportamenti ai fini della tutela della salute - Aspetti teorici dell’anatomia e fisiologia umana applicata all’attività motoria(in breve) - Conoscenze teoriche sulle capacità motorie - Conoscenze e competenze teoriche e pratiche degli sport individuali e di squadra svolti durante l’anno.
F.to I rappresentanti degli studenti F.to Il docente Giuseppe Pascale
RELIGIONE Docente: Patrizia Di Benedetto Contenuti disciplinari analitici A) La cristianità nel Novecento. B) Il concetto di Pace dopo la caduta del muro di Berlino. C)Il martirio della Russia cristiana 1917-1991. D) L'eclissi di Dio nel'900. L'ateismo e le sue forme. E) “L'aver cura” come risposta alla condizione umana segnata dalla fragilità. Da completare F) Il Concilio Vaticano II: un Concilio per il mondo, voluto dal Papa Giovanni XXIII. G) Solidarietà e responsabilità del cristiano nei confronti delle nuove povertà. H) Documenti del Magistero:Dignitatis Humanae, Gaudium et spes, Caritas in Veritate. F.to I rappresentanti degli studenti F.to Il docente Patrizia Di Benedetto

29
RELAZIONI FINALI
ITALIANO
Docente: GIULIANA MICHELUTTI 1 – Conoscenze, competenze, capacità - livello delle conoscenze e delle competenze specifiche della disciplina Sono stati perseguiti i seguenti obiettivi specifici:
• Ricostruire il quadro culturale di un’epoca, collegandolo agli aspetti storici, economici, antropologici. Saper operare confronti tra due epoche
• Esporre il profilo biografico e culturale di un autore, inserendolo nella sua epoca. • Contestualizzare i testi scelti e riconoscerne genere e caratteristiche tematiche, formali,
stilistiche. • Operare semplici parafrasi e riassunti di testi. Utilizzare i dati dei documenti per
rielaborazioni personali dei contenuti trattati. Elaborare riflessioni personali sui testi proposti.
• Costruire testi coerenti, coesi, corretti, scorrevoli. Le conoscenze sono state raggiunte a livello sufficienti (4 allievi), discreto (14), buoni (3). Le competenze sono da discrete a buone in rapporto a diversificate potenzialità e alla personale propensione allo studio. L’ atteggiamento verso lo studio è stato discreto, per alcuni studenti buono. - capacità espressive, logiche, operative, critiche Tutti gli allievi hanno raggiunto almeno un sufficiente livello di rielaborazione ed esposizione autonoma di quanto appreso, nonché una discreta capacità argomentativa sugli argomenti di studio. - interesse ed impegno nella partecipazione al dialogo educativo La classe è stata disciplinata, collaborativa e interessata alla partecipazione e al dialogo educativo, con interventi pertinenti e attivi verso le problematiche proposte. Pochi allievi hanno dimostrato uno studio domestico superficiale o dispersivo. 2. Metodi e mezzi Metodi: lezione frontale di contestualizzazione, discussione collettiva di problemi storici e culturali e confronti con l’attualità; letture collettive, schematizzazioni, elaborazione di mappe concettuali; analisi di testi (brani scelti dal libro di testo o da altre fonti); ricerca di collegamenti interdisciplinari (arte, filosofia); lavoro/esercitazioni di gruppo o individuali; studio domestico. Mezzi: utilizzo di libro di testo, di appunti,. 3. Spazi utilizzati. Aula scolastica. 4. Criteri e strumenti di valutazione adottati Colloquio lungo o breve, esposizione orale o elaborato scritto su: testi espositivi e argomentativi, analisi e commento di testi letterari, di documenti iconici, di schemi/mappe concettuali, prove semistrutturate. Criteri di valutazione: i criteri e la corrispondenza numerica sono desunti dal P.O.F. d’istituto. F.to il docente G. Michelutti

30
STORIA Docente: GIULIANA MICHELUTTI
1 – Conoscenze, competenze, capacità - livello delle conoscenze e delle competenze specifiche della disciplina Sono stati perseguiti i seguenti obiettivi: • saper individuare le caratteristiche che contraddistinguono un’epoca storica; • saper periodizzare gli eventi e inserirli nell’epoca storica di pertinenza; • saper collegare concetti e contenuti studiati relativamente ad epoche storiche diverse; • saper utilizzare strumenti: atlanti storici e geografici; schemi, tabelle, grafici, documenti; • comprendere e usare il lessico specifico • comprendere e usare il lessico specifico della disciplina • comprendere che le conoscenze acquisite in altre aree disciplinari sono inseribili in un quadro
storico secondo collegamenti diacronici e sincronici. Le conoscenze sono state raggiunte a livello sufficienti (3 allievi), discreto (12), buono (4), ottimo (1). L’ atteggiamento verso lo studio è stato generalmente adeguato. - capacità espressive, logiche, operative, critiche Tutti gli allievi dimostrano un discreto senso critico e sufficiente capacità argomentativa. -- interesse ed impegno nella partecipazione al dialogo educativo La classe è stata disciplinata, collaborativa e interessata alle problematiche trattate. 2. Metodi e mezzi Metodi: lezione frontale di contestualizzazione, discussione collettiva di problemi storici e confronti con l’attualità; letture collettive, ricerca di parole chiave, schematizzazioni; elaborazione di linee del tempo e mappe concettuali; utilizzo di libro di testo, di appunti,; lavoro/esercitazioni di gruppo o individuali; ricerca di collegamenti interdisciplinari (arte, filosofia)studio domestico. Mezzi: utilizzo di carte geografiche, del libro di testo, di appunti,. 3. Spazi utilizzati. Aula scolastica 4. Criteri e strumenti di valutazione adottati: tipologia delle verifiche: verifica con prove scritte semistrutturate o strutturate a risposta multipla/chiusa/aperta/a completamento/ con opzione V/F; domande a risposta aperta con motivazione; trattazioni sintetiche; elaborazione e produzione di un testo orale o scritto su argomenti del modulo; verifica dialogica orale Criteri di valutazione: i criteri e la corrispondenza numerica sono desunti dal P.O.F. d’istituto. F.to il docente G. Michelutti

31
LINGUA INGLESE Docente: Raffaella Di Raffaele Conoscenze, competenze, capacità Il percorso del gruppo classe, con cui ho lavorato per l’intero triennio, è stato regolare, pur con l’inserimento di alcuni nuovi discenti. L’atteggiamento degli studenti nei confronti della disciplina è stato via via sempre più positivo, nonostante le difficoltà incontrate, soprattutto nella parte grammaticale. L’interesse è cresciuto e il grado di attenzione in classe è sempre stato nel complesso più che discreto. Anche l’impegno, sia domestico che scolastico, si è fatto più costante da parte della maggioranza della classe. In termini di preparazione disciplinare specifica la classe ha raggiunto un profitto nel complesso sufficiente, con qualche punta di eccellenza, grazie all'impegno profuso. Quasi tutti gli allievi hanno conseguito una padronanza della lingua sufficiente ad esprimere oralmente i contenuti proposti, mentre nella produzione scritta permangono, per alcuni, errori grammaticali e sintattici, anche elementari. Per i giudizi individuali più dettagliati si rimanda al registro personale della docente. Metodi e mezzi Il metodo privilegiato è stato quello comunicativo, cercando di coinvolgere costantemente gli allievi in scambi linguistici per aumentare il loro interesse e la partecipazione. Per quanto riguarda i testi di letteratura e di civiltà, si è partiti dall’analisi del testo di lettura, contestualizzando successivamente lo stesso nella produzione letteraria dell’autore e, quindi, collocandolo nel contesto storico, sociale e culturale di appartenenza, operando anche collegamenti e confronti con altre opere letterarie e altre culture. Si è cercato inoltre di avvicinarsi agli interessi specifici degli studenti trattando argomenti collegati con i programmi specifici dell’indirizzo di studi .Per questo il programma svolto è sostanzialmente suddiviso in moduli tematici. Le lezioni si sono prevalentemente svolte in lingua inglese. Mezzi Lezioni frontali (per introdurre l’argomento, per presentare periodi storici); Lavoro a coppie (per svolgere esercizi di comprensione o sintesi); Lettura intensiva (tecniche di skimming, scanning, individuazione di sequenze, completamento di griglie per attuare analisi o sintesi) Risposta a domande aperte, redazione di riassunti, commenti, saggi brevi sugli argomenti oggetto di studio; Colloqui e discussione di tematiche in classe; Correzione e commenti sulle verifiche svolte, Libri di testo in adozione; dizionario monolingue e bilingue; fotocopie appunti integrativi; video in lingua inglese. Lavoro da svolgere autonomamente a casa. Criteri e strumenti di valutazione adottati L’attività di verifica si è incentrata su due obiettivi di fondo: 1) verificare e certificare i progressi nell’acquisizione e nella rielaborazione dei contenuti disciplinari; 2) migliorare e rendere consapevoli gli studenti nell’acquisizione dei processi metodologici del proprio apprendere. Le verifiche, si sono svolte attraverso prove scritte con esercitazioni prevalentemente orientate all’esame di Stato, (simulazioni della 3a prova tip B) e interrogazioni orali. La valutazione si è basata su: La conoscenza specifica dei contenuti proposti e la corretta focalizzazione degli stessi;

32
La padronanza della lingua e la proprietà di linguaggio disciplinare; La capacità di sintesi efficace; Il miglioramento conseguito da ciascun allievo per ogni obiettivo.
Spazi utilizzati (Laboratori, biblioteca, stage, viaggi e visite guidate, mostre, ecc.)
La classe ha partecipato allo spettacolo in lingua inglese “The Picture of Dorian Gray” di O.Wilde a cura del Palketto Stage e alla conferenza in lingua inglese della prof. A. Riem sul libro dell'antropologa R. Eisler “The Chalice and the Spade”. Uso sporadico del laboratorio linguistico finalizzato al recupero grammaticale.
F.to il docente R. Di Raffaele
FILOSOFIA Docente: Annalisa Filipponi Conoscenze, competenze, capacità La classe 5^Dp ha avuto un percorso didattico in Filosofia regolare. L’interesse per i contenuti proposti in tutti e tre gli anni scolastici, è stato costante e spesso sono stati richiesti approfondimenti e sono state discusse tematiche emerse che hanno suscitano curiosità. Durante lo svolgimento delle lezioni gli allievi hanno sempre mantenuto un atteggiamento attento. Gli alunni, in particolare per quanto concerne un gruppo classe, hanno evidenziato un buon livello di partecipazione e sono stati frequenti gli interventi e le domande, in particolare attinenti agli approfondimenti correlati con argomenti di attualità. Le competenze argomentative sono apparse di buon livello in alcuni allievi, mentre permangono alcune incertezze espositive in altri. Sono state frequenti le occasioni di dialogo e di approfondimenti in classe finalizzate alla costruzione di maggior sicurezza logico-espressiva. In generale possono definirsi soddisfacenti i livelli di conoscenze e competenze specifici della discipina acquisiti dalla maggior parte del gruppo classe, più incerti o mnemonici solo per alcuni allievi. Metodi e mezzi I percorsi didattici sono stati proposti mettendo l’accento sull’esigenza di una formazione culturale completa degli allievi e sulla loro educazione alla responsabilità. Queste finalità sono state possibili grazie ad un approccio storico-critico-problematico alla filosofia e ad una riflessione sui presupposti e sul senso dei diversi saperi. Alla luce di tutto ciò, pur senza trascurare il necessario riferimento all’aspetto storico della filosofia, si è messo soprattutto l’accento sulla struttura logico-concettuale ed epistemologica della disciplina, quale via via è emersa dallo studio dei diversi autori e delle diverse correnti. Degli autori si sono letti, nella misura del possibile, i testi più significativi per l’insieme di problemi che, di volta in volta, sono stati messi a fuoco, senza dimenticare di fornire i quadri concettuali d’insieme in cui collocarli. Si è fatto spesso ricorso ai DVD della raccolta “Il caffè filosofico” (la Filosofia raccontata dai filosofi) ed agli articoli di approfondimento filosofico apparsi sui maggiori quotidiani nazionali.

33
Criteri e strumenti di valutazione adottati Le verifiche nelle varie forme (tradizionale interrogazione, partecipazione, prove semistrutturate) sono state più di 2 per quadrimestre e sono state tese ad evidenziare sia lo strumento della comunicazione, sia la capacità argomentativa, sia l’impegno e la capacità di riflessione tipici della disciplina. Si è tenuto inoltre conto della partecipazione e del contributo dato alla costruzione di una riflessione critico-filosofica lungo lo svolgimento delle lezioni e della capacità di esprimere in modo corretto collegamenti interdisciplinari e riflessioni personali. La sintesi valutativa è stata espressa con voti dal 4 (livello minimo di conoscenze e competenze acquisite) al 10 (livello massimo di conoscenze e competenze acquisite) Spazi utilizzati Si è occasionalmente utilizzata l’aula multimediale.
La docente Annalisa Filipponi
SCIENZE UMANE Docente: LAURETTA NOVELLO
1. COMPETENZE, ABILITÀ E CONOSCENZE
La classe, in cui la docente è subentrata in classe seconda, ha iniziato l’anno conclusivo del ciclo di studi presentando generalmente un livello di conoscenze e di abilità discreto; un gruppo evidenziava una preparazione sufficiente.
Le attività programmate durante l’anno hanno avuto come obiettivo il raggiungimento delle seguenti competenze in ambito psicologico:
o Essere consapevoli della peculiarità di uno studio scientifico della personalità e delle funzioni psichiche, con particolare sensibilità alla complessità e ai limiti di questa scienza e della continua evoluzione dei suoi risultati.
o Acquisire consapevolezza della opportunità e del valore di un approccio multidisciplinare ai problemi psico-sociali.
E in ambito pedagogico: o Saper riconoscere l’educazione come radicale condizione modificativa dell’esperienza
umana. o Saper contestualizzare i fenomeni educativi nella loro complessità storica, sociale,
istituzionale e culturale. o Saper utilizzare in modo appropriato il linguaggio delle scienze dell’educazione.
Un gruppo di studenti ha dimostrato di possedere queste competenze e di saperle riutilizzare in diversi ambiti; la maggioranza le ha raggiunte ad un livello essenziale.

34
Gli studenti si sono impegnati a migliorare il proprio metodo di studio e di lavoro, alcuni hanno utilizzato uno studio mnemonico per acquisire le nozioni utili a superare le verifiche di conoscenza.
Le verifiche di competenza hanno dimostrato che un buon gruppo di allievi è in grado di fare collegamenti e sa utilizzare le conoscenze in maniera trasversale, alcuni rimangono molto ancorati allo studio sul manuale e devono essere guidati a fare riflessioni con domande specifiche.
Queste sono le abilità poste in ambito psicologico:
o Essere in grado di indicare e distinguere i principali temi di ricerca pertinenti in particolare le aree della psicologia sociale, evolutiva, educativa.
o Saper indicare i campi di ricerca delle principali scuole psicologiche operanti nelle aree sopra citate e alcuni dei principali autori di riferimento.
o Essere in grado di utilizzare la terminologia e il lessico appropriati per la definizione dei concetti psicologici connessi ai temi trattati.
E in ambito pedagogico o Saper cogliere l’educazione come processo di crescita umana nell’integrazione
individuo-società. o Saper contestualizzare teorie e sistemi formativi in rapporto alle situazioni storiche e ai
relativi modelli culturali.
Buona parte degli studenti ha raggiunto –a diversi livelli- queste abilità, una parte necessita della
guida del docente per orientarsi fra i problemi delle scienze umane trattati.
2. Metodi e mezzi
La lezione frontale è stata utilizzata per introdurre gli argomenti da approfondire in un’ottica di apprendimento critico-costruttivo: molti studenti si sono impegnati regolarmente in approfondimenti personali dimostrando un atteggiamento attivo.
Le attività di recupero sono state proposte successivamente alle verifiche individuando con il singolo studente gli aspetti e le modalità risultati poco efficaci, cercando di introdurre alcuni cambiamenti nel metodo.
Alcuni argomenti sono stati introdotti o approfonditi utilizzando dvd (lezioni multimediali di docenti universitari) o interviste significative o presentazioni power point e prezi realizzate dalla docente, altri contenuti sono stati presentati prendendo spunto da articoli pubblicati su riviste specializzate o da saggi di filosofi contemporanei. E’ stata sempre presentata una bibliografia essenziale inerente gli argomenti trattati, per stimolare l'approfondimento personale attraverso la lettura di testi extrascolastici, suggerimenti –quest’ultimi- seguiti da alcuni studenti.
Durante l’anno sono state assegnate numerose esercitazioni scritte utilizzando consegne tratte da tracce affidate negli anni scorsi agli Esami di Stato.
3. Spazi

35
E’ stato utilizzato il laboratorio di informatica, alcuni studenti hanno partecipato alla visita guidata alle classi Montessori, un gruppo si è impegnato in alcuni pomeriggi per le attività con i detenuti in carcere (vedi allegato documento 15 maggio), tutta la classe ha effettuato una visita al Dipartimento di Salute Mentale di Udine Sud.
4. Criteri e strumenti di valutazione adottati
Per quanto riguarda la valutazione sono state sottoposte varie verifiche scritte (di conoscenza e di competenza) e colloqui orali, esposizioni orali di argomenti di studio o di approfondimenti personali. I criteri di valutazione hanno tenuto conto dei seguenti elementi:
• conoscenza dei contenuti • correttezza linguistica e uso del linguaggio specifico • capacità di analisi rispetto ai contenuti acquisiti • capacità di sintesi rispetto ai contenuti acquisiti • capacità di elaborazione autonoma e critica dei contenuti acquisiti • capacità di evidenziare collegamenti significativi inter e intradisciplinari • grado di partecipazione durante la lezione
Gli studenti hanno svolto due simulazioni di seconda prova (svolgimento di un tema, scelta di una traccia fra tre assegnate negli anni scorsi all’Esame di Stato, tempo concesso 3 ore)
29 gennaio 2014 : valutazione sufficiente 11 studenti
16 aprile 2014: valutazione sufficiente 20 studenti
F.to Il docente Lauretta Novello
MATEMATICA Docente: Ferrara Anna Rita 1. Conoscenze, competenze, capacità Non tutti gli allievi hanno raggiunto gli obiettivi minimi fissati in sede di Dipartimento ovvero, per quanto attiene alle: Conoscenze:
• Nozioni elementari di topologia in R • Concetti fondamentali sulle funzioni • Nozioni di limite al finito e ad infinito applicate alle funzioni razionali, irrazionali ed a
semplici funzioni esponenziali e logaritmiche; forme indeterminate e loro applicazioni. • Concetto di continuità e di discontinuità di una funzione in un punto. • Derivata di una funzione; relazione tra segno della derivata prima di una funzione ed
intervalli di monotonia della stessa; relazione tra segno della derivata seconda di una funzione e sua concavità.
• Studio di funzioni razionali intere e razionali fratte (campo di esistenza, eventuali simmetrie, intersezioni con gli assi, segno, studio del comportamento della funzione alla frontiera del

36
campo di esistenza: ricerca di eventuali asintoti orizzontali, obliqui, verticali; studio delle derivate prima e seconda);
per quanto riguarda le Competenze: • Acquisizione di sufficienti capacità di analisi e di sintesi. • Acquisizione di sufficienti capacità di argomentazione logica.
infine, in relazione alle Capacità: • Sufficiente controllo degli strumenti algebrici. • Uso di un lessico matematico sufficientemente pertinente. • Capacità di affrontare esercizi inerenti alle conoscenze di cui sopra, pur restando entro
tipologie schematizzate in classe. Osservazione: Per quanto riguarda il comportamento si sottolinea che,mediamente, c’è una buona attenzione e partecipazione durante le lezioni in classe. Per alcuni la parabola dell’attenzione discende troppo rapidamente e qualcuno mostra difficoltà a seguire la lezione. C’è un gruppo di alunni fortemente impegnato nello studio e con sicure capacità intellettuali, pertanto, solo una parte di allievi ha ottenuto mediamente una valutazione complessivamente sufficiente, gruppo nel quale spiccano per un profitto di livello discreto poche individualità grazie ad uno studio costante, motivato e approfondito che li ha caratterizzati per tutto il triennio. Il resto della classe presenta una certa lentezza nell’impadronirsi dei concetti man mano spiegati, costringendo l’insegnante a frequenti soste per ritornare indietro e ripetere, più volte, i concetti (fornendo ulteriori esempi): pertanto talune unità didattiche hanno richiesto tempi di apprendimento un po’ lunghi e quindi lo sviluppo del programma previsto non è avvenuto in modo regolare. Inoltre una parte non riesce ad essere del tutto autonoma nella rielaborazione e nell’esecuzione di esercizi di medio livello, mentre un’altra, poco numerosa, presenta ancora qualche difficoltà sia nello studio che nell’applicazione. Nella simulazione di terza prova effettuata e negli esercizi proposti nelle verifiche le carenze in ambito logico emergono prepotentemente:se le richieste sono standardizzate e di pura conoscenza mnemonica i risultati sono vicini alla sufficienza, se viene richiesta una rielaborazione personale dei contenuti in un contesto diverso o con una formulazione più articolata i risultati sono inadeguati. Si sottolinea infine che il programma è stato decurtato di alcune parti relative soprattutto alle dimostrazione dei teoremi, a causa della perdita di ore dovuta a vari motivi tra i quali partecipazione ad attività non inerenti alla disciplina. È da precisare poi che non tutti gli allievi che avevano contratto un debito relativo alle insufficienze del primo quadrimestre lo hanno saldato.
2. Metodi e mezzi Ampio spazio è stato assegnato alla lezione frontale, non trascurando tuttavia la discussione in classe sugli argomenti trattati e sugli esercizi proposti. In genere prima delle verifiche è stata eseguita una attività di recupero in itinere sugli argomenti precedentemente svolti, questo per chiarire eventuali dubbi applicativi e all’inizio di ogni lezione sono stati corretti alla lavagna gli esercizi assegnati per casa in cui gli allievi hanno rilevato qualche difficoltà operativa. Nella correzione in classe degli esercizi più significativi delle verifiche ho cercato di mettere in evidenza gli errori più comuni rilevati nella prova. Questa correzione è stata anche utilizzata come modalità di recupero in itinere. Partendo dalle caratteristiche degli allievi, poco inclini all’astrazione, i concetti sono stati sviluppati con un approccio il più possibile intuitivo; definizioni e teoremi sono stati peraltro sempre riportati alla lavagna facendo uso del linguaggio naturale e, dove possibile, di quello sintetico. Lo strumento didattico più utilizzato è stato il libro di testo coadiuvato dalla lavagna 3. Criteri e strumenti di valutazione adottati

37
Per valutare il grado di apprendimento e le capacità raggiunte dagli alunni sono state utilizzate varie tipologie di verifica:
• Esercitazioni scritte • Colloqui: nelle verifiche orali gli allievi sono stati prevalentemente abituati allo svolgimento di
esercizi e meno frequentemente all’esposizione di definizioni e teoremi L’esito delle verifiche è stato notificato e motivato sistematicamente agli allievi. La valutazione finale ha tenuto conto, oltre che dei risultati conseguiti nelle prove oggettive, anche della partecipazione al dialogo educativo, della progressione dei risultati, dell’impegno dimostrato in aula ed a casa. 4. Spazi utilizzati: Il programma è stato svolto interamente in aula. F.to il docente A. Ferrara
FISICA Docente: Ferrara Anna Rita 1. Conoscenze, competenze, capacità Una buona parte della classe ha seguito il corso raggiungendo discreti risultati, un’altra ha conoscenze vaghe e incomplete per un impegno non sempre adeguato e per la notevole difficoltà nell’approcciarsi agli argomenti trattati. Buono è il comportamento, ma non sempre adeguata la partecipazione al dialogo educativo. La maggior parte degli alunni ha mostrato migliori abilità sul piano teorico piuttosto che su quello applicativo; di fatto, avendo riscontrato grosse difficoltà da parte degli alunni nell’applicare le conoscenze acquisite, è stato dato più spazio alla trattazione teorica degli argomenti, curando gli aspetti espositivi e di coerenza delle argomentazioni. Comunque, in generale, permangono difficoltà nell’uso del linguaggio specifico e di una rielaborazione personale ed autonoma delle conoscenze apprese: se le richieste sono standardizzate e di pura conoscenza mnemonica i risultati sono per la gran parte più che sufficienti, se viene richiesta una rielaborazione personale dei contenuti in un contesto diverso o con una formulazione più articolata i risultati non sempre sono adeguati. È da precisare poi che non tutti gli allievi che avevano contratto un debito relativo alle insufficienze del primo quadrimestre lo hanno saldato. CONOSCENZE
• La carica elettrica e la legge di Coulomb • I l campo elettrico • Il potenziale elettrico • La corrente elettrica Fenomeni magnetici fondamentali • Il campo magnetico • Induzione elettromagnetica
COMPETENZE • Comprendere la differenza tra cariche positive e negative • Distinguere tra elettrizzazione per strofinio, per contatto e per induzione • Comprendere il ruolo di una carica di prova • Rappresentare l’andamento di un campo elettrico disegnandone le linee di forza • Distinguere verso reale e verso convenzionale della corrente nei circuiti • Distinguere i collegamenti dei conduttori in serie e in parallelo • Riconoscere le proprietà dei nodi • Confrontare le caratteristiche del campo magnetico e di quello elettrico • Rappresentare l’andamento di un campo magnetico disegnandone le linee di forza

38
• Spiegare come avviene la produzione di corrente indotta CAPACITA’
• Esprimere le leggi fisiche in linguaggio formale • Interpretare relazioni tra variabili nelle leggi fisiche
2. Metodi e mezzi: La lezione frontale è stata senza dubbio lo strumento maggiormente utilizzato per la presentazione degli argomenti seppur sempre accompagnata da approfondimenti e chiarimenti dialettici atti a coinvolgere l’intera classe nel dialogo scolastico. Oltre al libro di testo gli allievi hanno fatto largo uso di appunti presi durante le spiegazioni. 3. Criteri e strumenti di valutazione adottati: Le valutazioni globali sono state effettuate tenendo presente le diverse forme di apprendimento, nonché il loro livello, la forma espositiva e la partecipazione al dialogo educativo. Gli elementi di giudizio sono stati tratti sia da verifiche sommative (compiti scritti con quesiti di carattere teorico) ed interrogazioni orali. Per le verifiche formative si è tenuto in considerazione non solo la partecipazione al dialogo scolastico, ma anche la pertinenza degli interventi, la loro profondità e la chiarezza. 4.Spazi utilizzati: L’aula della 5Dp. F.to il docente A. Ferrara
SCIENZE Docente: Enza Zuccolo
1) Conoscenze, competenze,capacità Conoscenze Conoscere il piano strutturale dell' organismo umano nella sequenza cellule, tessuti, organi, sistemi. Conoscere la morfologia funzionale degli apparati dell' organismo umano. Conoscere il concetto di regolazione dell'equilibrio interno dell'organismo. Conoscere alcuni aspetti importanti della fisiologia umana in relazione ai comportamenti sociali e in relazione ai progressi della medicina. Competenze Sapersi orientare all' interno degli argomenti svolti sapendo individuare relazioni e collegamenti. Saper rielaborare i contenuti in modo logico, individuando gli elementi fondamentali di un argomento e operando opportune sintesi. Capacità Saper esprimere i contenuti con coerenza e con l' uso di una terminologia specifica e corretta. Saper riflettere criticamente su alcuni degli aspetti sociali legati agli sviluppi della ricerca scientifica. La classe ha seguito le lezioni con interesse e discreta partecipazione. Ha acquisito adeguate conoscenze della struttura e del funzionamento del corpo umano, e pur se a diversi livelli di approfondimento, sa descrivere le relazioni fondamentali tra morfologia e funzione degli organi e sa mettere in relazione i contenuti appresi seguendo percorsi logici di ragionamento. Nel complesso si esprime in modo sufficientemente corretto utilizzando il lessico specifico. In alcune componenti della classe sono presenti buone capacità di rielaborazione autonoma e critica.

39
2) Metodi e mezzi Sono state svolte prevalentemente lezioni frontali supportate dalle osservazioni di schemi e figure del libro di testo che ha costituito il principale riferimento per la trattazione dei contenuti. Per favorire la comprensione degli argomenti e fornire opportune integrazioni durante lo svolgimento dei vari argomenti è stato fatto uso di proiezione di video e animazioni il cui contenuto veniva adeguatamente commentato. Si è fatto anche ricorso all' osservazione di modellini anatomici e preparati istologici, limitatamente al materiale a disposizione. Durante le lezioni l' insegnante ha costantemente stimolato il coinvolgimento e la partecipazione degli alunni con domande mirate e richiami alle conoscenze già acquisite e ha guidato la classe attraverso i vari argomenti con una particolare attenzione al percorso logico e all'uso della terminologia specifica. 3) Criteri e strumenti di valutazione adottati La valutazione fa riferimento ai seguenti criteri: -acquisizione e comprensione delle conoscenze proposte -capacità di analisi, sintesi, collegamento e applicazione delle conoscenze acquisite -abilità espressiva e competenza lessicale -capacità di riflessione critica Gli strumenti di valutazione adottati sono stati le verifiche orali e le verifiche scritte con valenza orale. Le verifiche scritte sono state effettuate con test sia del tipo risposta breve che scelta multipla e sono state svolte in un tempo massimo di 60 minuti. Hanno verificato il grado di apprendimento dei contenuti, la conoscenza e l' uso della terminologia specifica, la capacità di argomentazione sintetica e pertinente alla domanda. Le verifiche orali sono state impostate soprattutto sotto forma di discussione per accertare oltre alle conoscenze anche le capacità di collegamento fra gli argomenti, il livello di elaborazione autonoma raggiunto, la capacità espressiva ed eventualmente la riflessione critica personale. Sono state oggetto di valutazione anche le esposizioni orali di argomenti di approfondimento individuale. Sono inoltre presi in considerazione per la valutazione finale elementi quali l' attenzione, la partecipazione alle lezioni, l’impegno nello studio. Spazi utilizzati Visione del film “Vajont” di Martinelli e concetto di rischio idrogeologico. Visita guidata ad Elettra-la macchina di luce- a Trieste e visita guidata alla Grotta gigante. Partecipazione alla conferenza del prof. Ferrari sulle nanotecnologie. Partecipazione alla conferenza di Serge Latouche sulla decrescita per uno sviluppo sostenibile. Partecipazione alla donazione del sangue F.to il docente E. Zuccolo

40
LINGUAGGI NON VERBALI E MULTIMEDIALI
DOCENTE: prof. ZOTTIG-PINTOR Lino In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi in termini di: 1) Conoscenze, competenze,capacità: Conoscenza delle coordinate storico – culturali entro cui si forma ed esprime l’opera d’arte e dei codici visuali; competenze riguardo i linguaggi espressivi dei periodi e degli artisti, i significati delle opere e le poetiche; capacità di riconoscere gli aspetti formali e compositivi delle singole opere; lessico specifico della disciplina. Gli alunni possiedono una conoscenza complessiva sufficiente degli argomenti svolti. Conoscono gli aspetti fondamentali della biografia degli artisti e delle loro opere più significative delle quali sanno condurre l’analisi e individuare i significati. Hanno mediamente acquisito una sufficiente proprietà di linguaggio specifico sia nella produzione orale che in quella scritta. 2) Metodi e mezzi: Si è fatto ricorso ad un tipo di lezione prevalentemente frontale, di facile acquisizione dei dati, alternando l’informazione all’osservazione e alla lettura dell’opera, allo scopo di favorire il potenziamento delle abilità di analisi, di riflessione e di critica. Testo in uso: A. Bacchetta – S. Guastalla – E. Parente . “ PRIMI PIANI “ vol. 4 + vol. 5 - ed. Archimede 3) Criteri e strumenti di valutazione adottati: Verifiche:
• un’interrogazione o più per i casi non positivi o non del tutto positivi; • interventi dal posto; • verifiche scritte di storia dell’arte;
Valutazione: Le verifiche sia orali che scritte hanno consentito di misurare e valutare l’apprendimento nonché la realizzazione degli obiettivi prefissati per la classe, non tralasciando l’impegno, interesse e partecipazione. La valutazione ha tenuto conto dei criteri prefissati dal P.O.F. e adattati alle esigenze della materia. 4) Spazi utilizzati: la maggior parte delle lezioni sono state effettuate in classe. F.to il docente L. Zottig-Pintor
EDUCAZIONE MUSICALE Docente: Di Giorgio Angelo Gli allievi della classe 5^ DP hanno dimostrato un interessamento costante nello studio della materia mantenendo un’attenzione partecipativa, rendendosi disponibili ed interessati verso gran parte degli argomenti svolti. Hanno partecipato con un atteggiamento costruttivo al dialogo educativo. I risultati ottenuti sono stati buoni da gran parte degli alunni, alcuni ottimi e alcuni sufficienti.

41
In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi in termini di: 1) Conoscenze, competenze,capacità: a - Analizzare in modo induttivo le cellule ritmiche più complesse necessarie a comporre un discorso musicale. b - Prendere sempre più coscienza del linguaggio musicale attraverso la conoscenza degli elementi teorici ed artistici più complessi. c - Comprendere la storicità degli eventi sonori (in una sintesi storica) attraverso ascolti guidati. d - Riconoscere, attraverso ascolti guidati:
• le voci umane • le forme musicali semplici, complesse e polifoniche • gli strumenti musicali
2) Metodi e mezzi: Il modo di procedere per il raggiungimento degli obiettivi e per l'acquisizione dei contenuti è stato il più possibile induttivo: partendo da una globale esperienza d'ascolto o di produzione si è mirato all’organizzazione del sapere musicale, con la progressiva assunzione da parte dello studente di un modo ragionato e personale di pensare la musica. I concetti storici e teorico - grammaticali sono stati innestati nella reale esperienza della musica; in pratica gli apprendimenti relativi sono stati scaturiti dai momenti dell'ascolto e della produzione. Durante le lezioni, sono stati usati gli usuali sussidi didattici ed audiovisivi. I libri di testo usati: Nuove esperienze sonore (vol. A e B ) di R. Castello –ed Minerva Italica 3) Criteri e strumenti di valutazione adottati: Alla fine di ogni itinerario tematico svolto è stata eseguita una prova sommativa. In fase di valutazione sono state prese in esame la conoscenza dei contenuti, la capacità di rielaborazione personale, la capacità di inserire le conoscenze in una formulazione più ampia, la capacità di affinamento dell’espressione personale attraverso il linguaggio musicale. Sono stati utilizzati gli strumenti previsti dall'azione didattica: prove orali, scritte e pratiche secondo le necessità. 4) Spazi utilizzati: La classe ha potuto usufruire dell’aula attrezzata con mezzi audiovisivi. F.to il docente A. Di Giorgio
EDUCAZIONE FISICA
Docente: GIUSEPPE PASCALE In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi in termini di: 1. Conoscenze, competenze, capacità La classe è formata da 21 alunni; il livello iniziale rilevato degli allievi è risultato adeguato per le attività svolte. Ho operato per il consolidamento e il perfezionamento degli schemi motori acquisiti e curato lo sviluppo e il consolidamento delle conoscenze, competenze, capacità nell’ambito specifico della disciplina ottenendo i seguenti risultati: -conoscenze acquisite per realizzare progetti motori autonomi e finalizzati - conoscere e dosare le proprie capacità durante il lavoro motorio - esercitare capacità di autovalutazione - padroneggiare le abilità specifiche riferite a due attività sportive di squadra - Aspetti teorici dell’anatomia e fisiologia umana applicata all’attività motoria(in breve)

42
- Comprendere, applicare e autonomamente rielaborare gli esercizi proposti Con le attività sportive si sono sviluppate le competenze educative come la cooperazione, il rispetto per se e per gli altri, l’autocontrollo, la lealtà durante il gioco, l’autostima, l’abitudine a vivere il tempo libero in modo salutare. Il livello raggiunto e mediamente buono. 2. Metodi e mezzi Metodi: lezione frontale, gruppi di lavoro, processi individualizzati, attività di recupero-sostegno e integrazione, ecc) Mezzi: strumenti, materiali didattici, testo adottato, attrezzature, tecnologie audiovisive e/o multimediali, ecc.) La lezione frontale è stato l’elemento fondamentale dell’azione educativa, soprattutto durante l’introduzione e lo sviluppo dei nuovi argomenti, che richiedevano un impegno chiarificatore dal punto di vista concettuale e della comprensione dei principi generali della disciplina. La didattica è stata organizzata unità didattiche, Il programma è stato svolto in base alle capacità motorie degli allievi e alle attrezzature fornite dalla scuola. Dove necessario per i meno dotati e con difficoltà di apprendimento sono state utilizzate strategie d’insegnamento individualizzato. Ad essi sono stati concessi tempi educativi più lunghi per l’assimilazione degli schemi motori e le loro verifiche sommative sono state posticipate rispetto a quelle regolari del resto della classe, in modo che la loro valutazione è avvenuta solo dopo aver dato ad essi ogni possibilità di esercitarsi nei contenuti svolti. Non ho trascurato la possibilità di avviare attività di sostegno di recupero in caso di necessità. 3. Spazi(Laboratori, biblioteca, stage, viaggi e visite guidate, mostre, ecc) Le due palestre dell’Istituto e gli spazi esterni. In caso di corsi di tennis o di nuoto verranno utilizzati rispettivamente i campi di via del Maglio o la piscina del Palamostre. 4. Criteri e strumenti di valutazione adottati(Specificare: prove scritte, verifiche orali, prove strutturate, prove grafiche, prove pratiche, prove di laboratorio, ecc) La valutazione del profitto scolastico degli allievi in merito ai contenuti affrontati nel corso dell’anno scolastico,è basata su verifiche di tipo sommativo,( di numero congruo rispetto agli accordi stabiliti in sede di programmazione preliminare), effettuate ad intervalli distanti di tempo e su ampie unità didattiche, mediante prove pratiche, (test orali per gli alunni con esonero totale dalle lezioni pratiche),per accertare e quantificare con voto espresso in numero il grado di preparazione raggiunto ed il livello globale di maturazione degli stessi a conclusione di ogni quadrimestre.
F.to il docente A. Di Giorgio
RELIGIONE
DOCENTE: Di Benedetto Patrizia Conoscenze, competenze,capacità:
L’I.R.C., nel Secondo ciclo di Istruzione e formazione, per coloro che intendono avvalersene, offre un servizio educativo che intende, secondo le finalità e i metodi propri della Scuola, rispondere a una formazione globale della persona, con particolare riferimento agli aspetti spirituali ed etici

43
dell’esistenza, mediante una cultura attenta anche alla dimensione religiosa della vita, in vista di un efficace e responsabile inserimento in ogni ambito della vita. L’I.R.C. propone contenuti e strumenti che aiutino lo studente, in particolar modo quello orientato alla maturità, a decifrare il contesto storico,culturale e umano della società italiana ed europea, per una partecipazione attiva e responsabile alla costruzione della convivenza umana. Per questo, oltre a promuovere la conoscenza del dato storico e dottrinale, su cui si fonda la Religione Cattolica, propone agli alunni, attitudini al confronto, alla tolleranza, al dialogo, alla responsabilità e alla convivenza democratica. Nell'ultimo anno del Triennio si sono conseguiti i seguenti obiettivi specifici di apprendimento, declinati in conoscenze, competenze e capacità-abilità. In termini più specifici di Conoscenze:
Coglie la presenza e l'incidenza del Cristianesimo nella storia e nella cultura italiana ed europea, per una lettura critica del mondo contemporaneo.
Conosce il valore etico della vita umana aprendosi alla ricerca di un'autentica giustizia sociale, anche attraverso l'impegno educativo e sociale, per il Bene comune e la Pace.
Conosce le linee fondamentali della riflessione su Dio nel'900. Conosce i punti fondamentali che rendono il Concilio Ecumenico Vaticano II un evento
importante per la vita della Chiesa nel mondo contemporaneo. Riguardo alle competenze si è cercato di valorizzare al meglio la ricchezza di una visione integrale della Persona e la Dignità della stessa come fondamento dei diritti. In particolare si è lavorato sulle seguenti competenze :
• Consapevolezza dell'importanza dei temi trattati, per una crescita umana, sociale, professionale ;
• Acquisizione di un atteggiamento di confronto e di dialogo verso le differenti visioni del problema;
• Riconoscimento e rispetto di posizioni diverse dalla propria. • Rielaborazione in forma autonoma dei contenuti anche in chiave interdisciplinare. • Sviluppo di un maturo senso critico e un personale progetto di vita, riflettendo sulla propria
identità storico-culturale e nel confronto con il messaggio cristiano. Le capacità- abilità sono state sviluppate attraverso l’analisi di temi e problemi anche con un’attenzione interdisciplinare, al fine di una comprensione ragionata della posizione cristiano-cattolica. Gli allievi che hanno scelto di avvalersi dell'insegnamento di Religione in questo anno scolastico sono stati 7. Hanno seguito con buon interesse e buona partecipazione la proposta educativa. La conoscenza dei contenuti affrontati risulta diversificata e personale, dipende dalla qualità dall’impegno profuso da ciascun allievo nella rielaborazione autonoma e ragionata degli argomenti, anche in correlazione con le altre materie di studio. Nel complesso la crescita culturale e umana di tutti gli allievi si presenta buona e ottima, ciascuno secondo le proprie potenzialità e motivazioni. Buono il comportamento. Metodi e mezzi: I percorsi didattici sono stati proposti con un’attenzione particolare alla formazione culturale e umana degli allievi. In una logica di un insegnamento significativo ed essenziale, è stata scelta l'unità di apprendimento perché permette di sviluppare il lavoro in modo flessibile ed aperto ad approfondimenti ed integrazioni interdisciplinari, nonché valorizzare , all'interno della relazione educativa, le domande e l'esperienza degli allievi, maturata anche secondo lo specifico degli indirizzi.

44
Nel processo didattico di realizzazione delle unità di apprendimento, l’alternanza di lezioni frontali e scambio dialogico, affiancati da letture e riflessioni critiche su materiale scelto, anche a carattere audiovisivo, hanno reso possibile la costruzione di un ambiente partecipativo, per un apprendimento significativo. I mezzi usati sono stati: testo in adozione, saggi, articoli di riviste specializzate, fotocopie di approfondimento o integrative, materiale audiovisivo. Spazi utilizzati. Aula scolastica e aula-video. Criteri e strumenti di valutazione adottati: La valutazione in itinere e finale ha tenuto conto degli esiti formativi in termini di conoscenze, competenze e capacità. L’apprendimento delle conoscenze è stato valutato attraverso lo scambio dialogico e ha considerato la qualità delle informazioni acquisite e la capacità di riflessione ed elaborazione personale critica, mentre a livello delle competenze e capacità si è tenuto conto dell’interesse e della partecipazione alle proposte educative/didattiche, dimostrati durante il dialogo educativo. Criteri di valutazione: INSUFFICIENTE : Apprendimento: insufficiente conoscenza dei contenuti modeste capacità di analisi, sintesi e rielaborazione Partecipazione: - attenzione passiva al lavoro scolastico - impegno scarso - dispersiva al dialogo educativo - nulla alle attività proposte Interesse: - indifferenza per i valori insiti nei contenuti - nega la loro significatività Atteggiamento: rifiuta la collaborazione con il docente è chiuso al dialogo e al lavoro con i compagni SUFFICIENTE: Apprendimento: - frammentaria e superficiale conoscenza dei contenuti - normali capacità di analisi, di sintesi e rielaborazione Partecipazione: - attenzione saltuaria al lavoro scolastico - impegno discontinuo - occasionale (o solo se sollecitata od opportunistica) al dialogo educativo - modesta alle attività proposte Interesse: - passivo in relazione ai valori insiti nei contenuti - non ne rileva l’importanza Atteggiamento:

45
è abbastanza disponibile alla collaborazione con il docente talvolta aperto al dialogo con i compagni, con i quali non sempre accetta di lavorare DISCRETO: Apprendimento: - completa ma non approfondita conoscenza dei contenuti - discrete capacità di analisi, di sintesi e di rielaborazione Partecipazione: - attenzione continua al lavoro scolastico - impegno abbastanza regolare - diligente al dialogo educativo - attiva alle attività proposte Interesse: - reattivo in rapporto ai valori insiti nei contenuti - ne accetta l’importanza Atteggiamento: è disponibile alla collaborazione con il docente aperto al dialogo con i compagni, con i quali accetta di lavorare BUONO: Apprendimento: - completa ed approfondita conoscenza dei contenuti - buone capacità di analisi, di sintesi e di rielaborazione Partecipazione: - attenzione vivace al lavoro scolastico - impegno soddisfacente - creativa al dialogo educativo - responsabile alle attività proposte Interesse: - attratto dai valori insiti nei contenuti - si confronta con essi Atteggiamento:
• pronto alla collaborazione con il docente • attento al dialogo con i compagni, con i quali ha piacere di lavorare
OTTIMO: Apprendimento: - completa, coordinata e ampia conoscenza dei contenuti - notevoli capacità di analisi, di sintesi e di rielaborazione Partecipazione: - attenzione motivata al lavoro scolastico - impegno costante - propositiva e critica al dialogo educativo - intensa alle attività proposte Interesse: - considera importanti i valori insiti nei contenuti - si fa interpellare da essi Atteggiamento:
• è attivo alla collaborazione con il docente

46
• sollecito nel dialogo con i compagni, con i quali lavora sostenendoli Testo adottato: “Tutti i colori della vita” di L.Solinas, Ed.SEI.
F.to il docente P. Di Benedetto