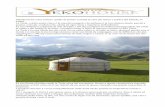Doc tecnico
-
Upload
leonardo-rallo -
Category
Documents
-
view
213 -
download
0
description
Transcript of Doc tecnico

Psicoacustica Applicatae
Teoria del SuonoDocumento tecnico
Docentiprof.ssa S.Sancassani, prof.ssa F.Brambilla
Gruppo2A.Oggianu, C. Pasca, A. P. Pittaluga, S. P. Pulizzi
10 Febbraio 2011
INDICE
1 Individuazione del target 21.1 Studio preliminare del target . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31.2 Simulazione dei personaggi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31.3 Lo studente archetipo: Vico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
2 Panoramica dei contenuti del corso 62.1 Obiettivi didattici . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
3 Osservazioni preliminari e funzionali alla fase di progettazione 83.1 Vincoli e problema di sostenibilità . . . . . . . . . . . . . . . . . 83.2 Organizzazione della classe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83.3 Docenti: carico di lavoro e coordinamento . . . . . . . . . . . . 9
1

2 CAPITOLO 1. INDIVIDUAZIONE DEL TARGET
4 Processo di apprendimento 104.1 Motivazioni della metodologia adottata . . . . . . . . . . . . . . 104.2 Percorso ad alto livello . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114.3 Primo step: Anatomia dell’apparato uditivo . . . . . . . . . . . . 124.4 Secondo step: Psicoacustica Applicata . . . . . . . . . . . . . . . 134.5 Terzo step: Teoria dei Segnali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154.6 Quarto step: linguaggio CSound . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
5 Conclusioni 17
Sommario
Questo documento è nato dall’intenzione di spiegare esaustivamen-te, da un punto di vista tecnico, le scelte metodologiche che hanno por-tato alla costruzione del corso di Laurea Magistrale in Psicoacustica Ap-plicata e Teoria del Suono del Politecnico di Milano.
In altre parole, lo scopo che ci proponiamo sarà quello di dare ri-sposta alle domande: a chi è rivolto il corso? di che cosa si tratta? inche modo verrà erogato il corso? perchè sviluppare il corso secondo unpreciso processo di apprendimento?
CA
PI
TO
LO
1INDIVIDUAZIONE DEL TARGET
In questo capitolo individueremo il target ideale del corso di studi personifi-candolo e ipotizzando un contesto di vita verosimile e quanto più reale.
Partiremo da uno studio generale che ci consentirà, attraverso la tecnicadella simulazione dei personaggi, di generare e selezionare lo studente arche-tipo che ben rappresenta il target a cui vorremo rivolgerci.

1.1. STUDIO PRELIMINARE DEL TARGET 3
1.1 Studio preliminare del target
Il corso di Laurea Magistrale si rivolge a tutti coloro che desiderano comple-tare la propria formazione, attraverso un percorso di studio compatibile conun’attività professionale a tempo pieno, per le proprie esigenze o necessità diun percorso flessibile, che non preveda i vincoli di orario o di spostamenti chesono tipici di una Laurea in “presenza” .
In particolare il corso è indirizzato:
• a operatori già inseriti nel mondo del lavoro in vista di una crescitaprofessionale e di carriera;
• a neo-laureati in discipline tecniche, scientifiche e letterarie, diplomatipresso Conservatorio di Musica che desiderano inserirsi nel mondo dellavoro senza rinunciare a un percorso di crescita formativa;
• a studenti che per ragioni personali o familiari, non possono lasciare ilproprio domicilio per frequentare un corso di Laurea in presenza;
• ai diversamente abili che desiderano un percorso formativo di altissimolivello, ma soprattutto accessibile e flessibile.
1.2 Simulazione dei personaggi
Per la simulazione degli utenti il nostro gruppo ha preferito come metodolo-gia di analisi e di lavoro la tecnica della simulazione dei personaggi. Le nostresessioni di brainstorming hanno dato vita a diverse personalità, tra le qualiabbiamo trovato maggiormente interessanti i seguenti personaggi:
• Marco: 23 anni, laurea specialistica in ingegneria informatica. La suaambizione è diventare ingegnere del suono e partecipare alla progetta-zione di grandi teatri in genere e, in particolare, delle sale multimedialiper le esposizioni di arte contemporanea del Centre Pompidou. La suaaspirazione sarebbe lavorare “gomito a gomito” con artisti del calibrodi Gabriel Orozco, Steve Reich e di tutte le grandi personalità dell’arteper le quali potrebbe esaudire qualsiasi richiesta di adattamento del-l’ambiente acustico e progettazione. Vive in un paesino della Calabria eattualmente, a causa di alcune vicissitudini familiari, non può spostarsinel nord Italia per frequentare quest’ordine di corsi. La laurea on-line loemanciperebbe da questa situazione.

4 CAPITOLO 1. INDIVIDUAZIONE DEL TARGET
• Luca: 36 anni, esperto nella gestione e conservazione del patrimonioaudiovisivo, analogico e digitale, lavora presso gli archivi RAI. Ha con-seguito una delle prime lauree triennali in ingegneria delle telecomuni-cazioni al termine degli anni ’90. Musicista autodidatta, si dedica conpassione alle tastiere, suonando volutamente ad orecchio ed evitandoogni insegnamento musicale tradizionale, allo scopo di sviluppare libe-ramente la sua visione intuitiva della musica ed un rapporto più perso-nale con gli strumenti. Vorrebbe creare una società di consulenza peril restauro e la conservazione degli archivi audio ed è quindi interessa-to ad approfondire tutte le nuove tecnologie inerenti il suono e le sueapplicazioni. Ha orari regolari da un punto di vista lavorativo, ma i pro-blemi di salute della figlia più piccola non gli consentono di ipotizzarelÕiscrizione a corsi per lavoratori che prevedano la frequenza in presen-za (anche solo sporadica). Richiede assoluta necessità di organizzare ilproprio studio in piena autonomia.
• Fabrizio: 48 anni, diplomato al conservatorio in “Pianoforte e tecniched’improvvisazione jazz”. Ha una laurea in matematica mai sfruttata sot-to profilo professionale. Dal 1995 insegna pianoforte classico e jazz,armonia moderna e tradizionale e improvvisazione presso presso unascuola media statale. Nel 1997 ha iniziato a coordinare privatamente deilaboratori informatico-musicali, individuali e collettivi , rivolti a bambi-ni dai 6 ai 12 anni. Sviluppa ogni anno dei seminari, articolati in quattroincontri d’orientamento e guida all’ascolto della musica afro-americanaed insegna “Musica elettronica”. È piuttosto libero nella gestione del suotempo e quindi sta pensando di iscriversi al corso di laurea in Ingegne-ria e Design del suono nell’intento di trovare spunti e idee per la strut-turazione dei suoi laboratori per bambini. Presenta lacune sulle linguestraniere e in particolare in inglese.
• Vico: 25 anni, possiede una laurea triennale in ing. elettronica e la cer-tificazione del livello B1 del CEF della conoscenza dell’inglese. Attual-mente lavora a tempo pieno come tecnico del suono a Cinecittà. Hapoco tempo a disposizione e poca regolarità negli orari. Ha molte diffi-coltà, quindi, a seguire un planning di studio rigido e prestabilito: nonha ritmi di lavoro cadenzati e prevedibili e necessita di molta elestici-tà nell’organizzazione dello studio. È fortemente motivato a progredirelavorativamente e ritiene che la laurea magistrale sia fondamentale perquesto. Fino ad un paio di anni prima faceva parte di una piccola bandin cui suonava come batterista. È fidanzato ma per ora non pensa almatrimonio: deve prima rendere solida la sua situazione economica.

1.3. LO STUDENTE ARCHETIPO: VICO 5
• Elena: 22 anni, è laureata in informatica frequentando anche il con-servatorio. È una pianista concertista. Vorrebbe un giorno entrare nelsettore della produzione musicale perché pensa che la musica classicanon sia sufficientemente rappresentata. Non ha ancora un impiego fis-so e quindi non sa ancora se si iscriverà ad un corso in presenza oppureproverà alternative differenti. I suoi concerti la portano spesso in giroper l’Italia e forse una soluzione online le risulterebbe comunque piùgestibile. Essendo una persona molto socievole e comunicativa predi-lige lo studio in gruppo e la collaborazione in team: immagina lo stu-dio a distanza come qualcosa di arido e triste e questo le insinua alcunidubbi.
1.3 Lo studente archetipo: Vico
Al fine di individuare uno studente che sia rappresentativo della classe di uten-za target del nostro corso, abbiamo utilizzato la tecnica di simulazione deipersonaggi isolando le seguenti cifre di merito:
• fattori personali;
• fattori culturali;
• fattori socali;
• fattori psicologici;
• conoscenze pregresse.
Dalla simulazione effettuata, abbiamo scelto Vico di cui riportiamo le ca-ratteristiche principali di seguito.
Il nostro studente archetipo si chiama Vico, ha venticinque anni ed è lau-reato in Ingegneria Elettronica e ha acquisito anche la certificazione della co-noscenza inglese pari al livello B1 del CEF. Il background culturale di Vico èorientato all’informatica e i suoi interessi sono prevalentemente rivolti nellamusica, tanto è che suona come batterista in una band locale.
Egli è spinto da forte motivazione nel portare a termine l’obiettivo di stu-dio e quindi nell’ottenimento della Laurea Magistrale, ma difficoltà legate al-l’occupazione che ricopre(tecnico del suono a Cinecittà) e alla distanza geo-grafica dalla sede universitaria dell’ateneo, generano non pochi problemi nel-l’organizzazione dello studio.
Inoltre, si pone un vincolo dato dalla mobilità legata al suo specifico la-voro, in particolare richiede spostamenti frequenti verso i luoghi dei vari set

6 CAPITOLO 2. PANORAMICA DEI CONTENUTI DEL CORSO
cinematografici, che certamente impatta in modo pesante sulle prestazioni distudio di Vico.
In generale, dobbiamo considerare che egli avrebbe grosse difficoltà a se-guire il corso nel caso gli si presentasse un piano di studio rigido e prestabilito,quindi necessita di molta elasticità nell’organizzazione dello studio a causadel poco tempo a disposizione e poca regolarità negli orari.
CA
PI
TO
LO
2PANORAMICA DEI CONTENUTI DEL
CORSO
Il corso di Laurea Magistrale in Psicoacustica applicata e Teoria del suono of-fre un percorso di formazione di base su tematiche riguardanti gli aspetti fisicie psico-percettivi dell’acquisizione, della fruizione audio e dell’acustica am-bientale, con enfasi sulla progettazione acustica attiva e passiva in ambienticomplessi. La formazione di base per il progetto di acustica ambientale e losviluppo di sistemi di alterazione attiva dell’acustica ambientale.
Obiettivi del corso
Il corso di Psicoacustica applicata e Teoria del suono propone di formare pro-fili di personale tecnico avanzato in grado di dare soluzione ai problemi chenascono nelle fasi di registrazione e post-produzione di fonti sonore per va-ri utilizzi in campo artistico e tecnico. La figura professionale che si vuoleformare è un “Ingegnere del Suono”, che abbia competenze adeguate sia perla fase di registrazione e post-produzione, sia per l’elaborazione, il processa-mento e il recupero di sorgenti sonore a livello ingegneristico.

2.1. OBIETTIVI DIDATTICI 7
Vediamo ora, a grandi linee le quattro tematiche del corso, che rappresen-tano i nostri obiettivi didattici.
2.1 Obiettivi didattici
Anatomia dell’apparato uditivo
L’anatomia dell’apparato uditivo consiste nello studio dei vari componentianatomici dell’orecchio. Verrà posta particolare attenzione alla fisiologia ealla propagazione del suono entro i distretti anatomici dell’essere umano.
Questo argomento costituirà le fondamenta teoriche del corso ed in par-ticolare sarà la base per la comprensione di come un’onda di pressione d’ariagiunga al nostro timpano, venga trasmessa e rielaborata dal cervello sotto for-ma di impulso elettrico identificato di volta in volta come “musica”, “rumore”o codificato come “voce” e quindi come “messaggio”.
Psicoacustica applicata
Il secondo tema del corso verterà sull’analisi pratica, attraverso la sperimen-tazione diretta, dei suoni e rumori sotto il profilo emozionale. Lo studentequindi sarà messo in condizione di saper rispondere alle domande: perchè al-cuni suoni sono gradevoli o sgradevoli? Quali emozioni e pensieri suscitano aseconda di come il timpano e cervello vengano sollecitati?
Teoria dei segnali
La teoria dei segnali consente allo studente di analizzare i suoni e rumori, in-vece, sotto il profilo psicoacustico per capire su quali bande di frequenza simuovono e come possono essere rielaborati a livello di segnale per otteneredi volta in volta effetti differenti. Acquisiremo cioè le competenze necessarieper manipolarli e controllarli secondo le nostre necessità.
Linguaggi di programmazione musicale: CSound
CSound è un’estensione del linguaggio C modellato per la generazione di suo-ni, rumori e interi brani musicali. Lo studente sarà chiamato a studiarne i

8CAPITOLO 3. OSSERVAZIONI PRELIMINARI E FUNZIONALI ALLA FASE DI
PROGETTAZIONE
fondamenti ed a raggiungere l’obiettivo di utilizzarlo come strumento per lagenerazione di suoni o rumori.
CA
PI
TO
LO
3OSSERVAZIONI PRELIMINARI E
FUNZIONALI ALLA FASE DI
PROGETTAZIONE
In questo capitolo spiegheremo come verrà articolato il flusso di apprendi-mento, ma prima mettiamo in evidenza quali sono i vincoli e le problematicheche dovremo tener conto in fase di progettazione.
3.1 Vincoli e problema di sostenibilità
Per delineare le modalità di fruizione del corso e di come gli studenti appren-deranno le varie tematiche proposte, dobbiamo prima considerare i vincoli disostenibilità imposti dal numero degli studenti che saranno in numero pari acento supervisionati da soli due docenti.
La problematica di sostenibilità, chiaramente, sarà trattata dal punto divista dei due docenti che dovranno gestire la classe di cento studenti.
3.2 Organizzazione della classe
Innanzitutto, le figure che caratterizzano il nostro corso sono tre:
• studenti;

3.3. DOCENTI: CARICO DI LAVORO E COORDINAMENTO 9
• docenti;
• leader.
Sarà chiesto agli studenti di riunirsi in gruppi di quattro persone, in modotale da essere già organizzati per intraprendere lo studio dei temi da affron-tare in gruppo, cioè nell’ambito di psicoacustica applicata e CSound. Quindiavremo la classe di cento individui ripartita in venticinque gruppi di quattrostudenti, in cui uno(a rotazione) assumerà il ruolo di leader o referente.
Il ruolo del leader di gruppo
I referenti raccoglieranno dubbi e problemi del gruppo, relativamente al la-voro di ricerca (o di progetto) dello step corrente. Saranno poi incaricati disottoporre queste problematiche al docente in apposite Sessioni Live.
Stileranno, infine, dei documenti di sintesi per i loro colleghi nei qualiriporteranno spiegazioni e conclusioni tratte dal docente. I gruppi, oltre almateriale già creato, avranno a disposizione per il loro studio anche questoulteriore documento preparato dal loro referente. Gli studenti potranno inol-tre accedere, per eventuali confronti e approfondimenti, anche al materialepreparato dagli altri gruppi (peer review).
Relativamente a particolari problematiche, che non risultino esaustiva-mente trattate nelle documentazioni preparate dagli studenti e messe a di-sposizione di tutti, potranno essere poste domande, tramite forum, diretta-mente al docente.
Chiunque potrà usare il forum anche se non sarà in quel momento refe-rente.
3.3 Docenti: carico di lavoro e coordinamento
Fondamentalmente i docenti dovranno assolvere i seguenti ruoli: monitorag-gio o interazione su forum e FAQ, produzione di white paper e coordinamentogenerale degli studenti.
I due docenti non seguiranno direttamente i cento studenti contempo-raneamente, ma saranno agevolati nel loro lavoro grazie alla ripartizione delcarico di domande che proverranno solo dai venticinque leader, i quali di vol-ta in volta pubblicheranno un documento unico dove saranno presenti tuttele domande raccolte, all’interno del proprio gruppo, nei quali non ci sarannoduplicati dei quesiti.
Ad esempio: il docente Tizio seguirà 13 leder e il docente Caio seguirà quin-di i 12 rimanenti.

10 CAPITOLO 4. PROCESSO DI APPRENDIMENTO
All’interno della piattaforma saranno allestite delle FAQ che permetteran-no di allineare tutti gli studenti sulla “giusta strada”, per consentire loro diavere delle linee guida imprescindibili.
CA
PI
TO
LO
4PROCESSO DI APPRENDIMENTO
Dopo aver fissato i “paletti” entro cui muoverci, ora possiamo definire il pro-cesso di apprendimento.
Gli obiettivi di apprendimento saranno raggiunti secondo questa scan-sione temporale: anatomia dell’apparato acustico, psicoacustica applicata,teoria dei segnali e laboratorio CSound.
Vogliamo che il nostro corso non sia una mera aggregazione di quattroargomenti separati, caratteristica tipica di un corso convenzionale dove l’ap-prendimento è “a compartimenti stagni”; piuttosto, lo studente utilizzer à lecompetenze mano a mano acquisite per le successive tematiche e viceversa,cio è sar à portato a ri-meditare sugli argomenti gi à studiati precedentemente.
Ad esempio: uno studente che conclude la parte di studio relativa a psicoa-custica, precedentemente supportata dalla parte di interazione di anatomia,comincia quella di teoria dei segnali, analizzando lo stesso suono o rumorequesta volta sotto un profilo strettamente matematico. Grazie agli strumentiche forniremo, lo studente potrà rivedere continuamente i concetti gi à acquisitiampliandoli e consolidandoli.
4.1 Motivazioni della metodologia adottata
L’elevato numero di studenti(100 unità) non permetterebbe, in un corso on-line gestito in modalità standard, a soli 2 docenti di supportare adeguatamen-

4.2. PERCORSO AD ALTO LIVELLO 11
te tutti i discenti.La decisione, quindi, di far interagire i professori di volta in volta con i soli
referenti di gruppo ci aiuterà ad raggiungere un doppio obiettivo. Da un lato, idocenti riusciranno a rispondere alle domande e ai dubbi più frequenti in ma-niera veloce e puntuale, dall’altro (grazie alla turnazione del ruolo del “leader)avranno la possibilità di conoscere e interagire con ognuno degli studenti inalmeno un’occasione.
Spesso capiterà, grazie al fatto che di proposito verrà dato a più gruppi lostesso tipo di lavoro da svolgere, che si inviti a modificare e migliorare i pro-getti grazie ad un lavoro di peer review, ovvero per il tramite di un continuoconfronto e controllo del lavoro dei vostri colleghi. Ciò accadrà soprattuttonelle fasi progettuali dove i professori non avrebbero tempo sufficiente percontrollare il lavoro di tutti in maniera esaustiva.
L’approccio metodologico classico, che vede il docente spiegare al discen-te che fruisce delle lezioni in modo passivo, non verrà quasi mai utilizzato.Riteniamo, infatti, che questa diversa modalità di somministrazione del cor-so, che vede lo studente come attore attivo e proattivo per tutto il percorsodi studio, consentirà di raggiungere una più piena e consapevole padronan-za della materia con maggiore divertimento sebbene probabilmente con piùfatica.
Non va inoltre trascurato che questa modalità di studio, ovvero con unostudente alla continua ricerca di nuovo e migliore materiale di approfondi-mento, lo farà confrontare con documenti sempre aggiornati.
Nelle due sezioni successive, adottando un approccio top-down, proget-teremo le interazioni studente-studente, studente-leader, studente-docente eleader-docente, dapprima guardando alle quattro tematiche come unità ato-miche, poi disarticolandole singolarmente facendo un focus sulle micro-relazionifra le varie entità in campo(studenti, docenti e leader).
4.2 Percorso ad alto livello
Il corso prenderà le mosse dalla fase di anatomia. Le competenze acquisitesulle modalità di funzionamento dell’orecchio, la sua morfologia e la perce-zione “fisica” del suono verranno utilizzate nei due step seguenti, psicoacusti-ca e teoria dei segnali, per consentire agli studenti di analizzare l’impatto chesuoni e rumori hanno sull’uomo sia per quanto riguarda le reazioni emotive(psicoacustiva) sia per quanto riguarda l’analisi prettamente matematica del-le frequenze gradevoli, sgradevoli, udibili o meno (teoria dei segnali). Alla finedi questo percorso si accederà all’ultimo step, ovvero il laboratorio CSound,ove si metteranno in gioco tutti gli approfondimenti portati avanti !no a quel

12 CAPITOLO 4. PROCESSO DI APPRENDIMENTO
momento grazie allo sviluppo di una colonna sonora che preveda non solo lascelta e la creazione di una parte musicale che possa accompagnare lo story-board proposto dall’insegnante, ma tutta la parte di acustica, rumore e mon-taggio dei dialoghi tipici di un cortometraggio o di un documentario. Si parti-rà quindi dall’eliminazione dei rumori di fondo, per passare al set-up correttodei volumi delle voci nei dialoghi, per arrivare alla ricostruzione dei rumoriprevisti dalla trama da seguire (il campanello della porta, il rumore del traffi-co, ecc...) per giungere alla vera e propria colonna squisitamente sonora e poianche musicale che accompagni e sottolinei le varie situazioni psicologicheda evocare.
Il laboratorio C-Sound sarà il vero e proprio momento di sintesi che vedràutilizzate tutte le conoscenze acquisite fino a quel momento.
Ora analizzeremo il percorso da un punto di vista micro-progettuale.
4.3 Primo step: Anatomia dell’apparato uditivo
Gli studenti lavoreranno singolarmente(il gruppo sarà solo un momento diconfronto per far emergere eventuali dubbi o incertezze da sottoporre al do-cente in Sessione Live).
Scopo attività
Lo scopo è quello di imparare il funzionamento dell’orecchio umano e la suafisiologia nella ricezione e nell’elaborazione del suono, attraverso un metododi apprendimento che secondo noi sarà avvincente senza perdere di vista icontenuti che sono effettivamente l’obiettivo da raggiungere!
Le otto fasi del processo di apprendmento
1. ciascun studente dovrà scegliere un componente anatomico dalla chec-klist stesa dal docente e marcarlo nella stessa con il proprio nome;
2. dopo aver atteso conferma dal docente, proseguiranno con lo studioautonomo del proprio componente;
3. ogni studente creerà un profilo su facebook inserendo le proprie cre-denziali, ma con l’aggiunta di un suffisso che sarà esattamente il nomedel componente;
4. nel momento in cui tutti avranno completato questa fase, verificata sem-pre tramite checklist-online, potranno passare alla fase di interazione,che consiste nell’aggiungere un solo contatto;

4.4. SECONDO STEP: PSICOACUSTICA APPLICATA 13
5. l’interazione si deve svolgere con l’biettivo di imparare finzionalità efisiologia dell’altro componente con cui si stanno relazionando;
6. quindi la fase 5 verrà reiterata tante volte quanti sono i componenti cheancora non saranno nella lista dei contatti dello studente. Potrete chie-dere l’amicizia agli altri solo quando riceveranno un token di interazio-ne, rappresentato da un’immagine raffigurante un gettone con scritto ilnome del componente con il quale hanno avuto un’interazione, dal lorosulla vostra bacheca;
7. infine, gli verrà richiesto di creare un profilo, dello stesso tipo di quel-lo di facebook, su twitter che avrà la funzione di facilitare la fase 5. diinterazione.
Abbiamo introdotto quest’ultima fase, che non è obbligatoria, in quan-to sappiamo che ci sono studenti che hanno sia limiti di tempo utile daspendere per interagire a causa del lavoro, sia limiti per i canali di co-municazione utilizzati(banda limitata, supporti con risoluzioni limita-te)che potrebbero ostacolare l’interazione che è la fase più importantedi questa tappa;
8. si dovrà ricordare che anche dopo aver avuto il token dagli altri colleghiè importante che gli studenti continuino a interagire con loro per nonperdere le conoscenze acquisite precedentemente.
Conclusione attività
La Sessione Live alla fine di questa tappa permetterà di porre delle domandesui singoli argomenti non chiariti dalle ricerche dei singoli studenti. Il leaderdi ogni gruppo pubblicherà un documento con tutte le risposte alle doman-de raccolte nel suo gruppo, e quindi ognuno di voi dovrà aggiornare il pro-prio profilo in base ai feedback dei docenti. Al termine di questa attività viverrà somministrato un test di autovalutazione, che vi chiarirà, in previsionedell’esame finale, quali sono i punti cruciali da avere ben consolidati.
4.4 Secondo step: Psicoacustica Applicata
Gli studenti lavoreranno in gruppo.

14 CAPITOLO 4. PROCESSO DI APPRENDIMENTO
Scopo attività
Lo scopo è quello di insinuare nello studente sensibilità acustica e percettiva,tramite l’ascolto di suoni, musica o rumori da interpretare.
Le sei fasi del processo di apprendmento
1. il docente sottoporrà ad ogni gruppo un file audio;
2. all’interno di ogni gruppo gli studenti dovranno ascoltare il file e succes-sivamente, tramite la compilazione di un questionario a scelta multipla,marcheranno quali aspetti emotivi sono scaturiti dall’ascolto, ovvero:stato di tristezza, paura, gioia, ecc;
3. il “risultato emotivo” di ognuno di loro verrà messo a confronto conquello degli altri elementi del proprio gruppo e infine dovranno stilareuna classifica che evidenzi qual è lo stato emotivo percepito maggior-mente all’interno del gruppo(il risultato però non deve essere pubblica-to!);
4. ogni gruppo si scambierà reciprocamente il file sul quale ha lavorato ereitera le fasi precedenti;
5. con lo stesso procedimento utilizzato in ogni gruppo, si eleggerà, perogni file musicale, qual è lo stato emotivo più quotato;
6. nell’ultima fase sarà il docente a sancire i risultati reali e a darne unaspiegazione approfondita.
Conclusione attività
La Sessione Live alla fine di questa tappa permetterà di porre delle domandesui singoli argomenti non chiariti dalle ricerche dei singoli studenti. Il leaderdi ogni gruppo pubblicherà un documento con tutte le risposte alle domanderaccolte nel suo gruppo, e quindi ogni studente dovrà aggiornare il proprioprofilo in base ai feedback dei docenti. Al termine di questa attività vi verràsomministrato un test di autovalutazione, che vi chiarirà, in previsione del-l’esame finale, quali sono i punti cruciali da avere ben consolidati. Tale testconsisterà nell’analisi di file musicali da un punto di vista psicoacustico.

4.5. TERZO STEP: TEORIA DEI SEGNALI 15
4.5 Terzo step: Teoria dei Segnali
Gli studenti lavoreranno singolarmete(il gruppo sarà solo un momento di con-fronto per far emergere eventuali dubbi o incertezze da sottoporre al docentein Sessione Live).
Scopo attività
Gli stessi suoni e rumori analizzati in Psicoacustica verranno in questa faseanalizzati da un punto di vista frequenziale e tecnico. Gli studenti impare-ranno quali intervalli di frequenze sono fondamentali per ottenere gli effettiacustici e psicologici desiderati.
Le tre fasi del processo di apprendimento
1. pubblicazione file audio su SimplyNoise rumori bianco, rosa, marronee un contesto ambientale natura caos cittadino, rumore pioggia;
2. utilizzando DrawRechnerGraph dovranno realizzare e condividere deigrafici di fraquenza e lunghezza d’onda con l’ausilio di PBase all’internodel proprio spazio virtuale
3. infine dovranno realizzare un elaborato elettronico e sonoro, rispettiva-mente con google docs e Sound Cloud, dove illustreranno le varie fasi direalizzazione del rumore e i relativi adattamenti all’interno del contestoutilizzato.
Conclusione attività
La Sessione Live alla fine di questa tappa permetterà di porre delle domandesui singoli argomenti non chiariti dalle ricerche dei singoli studenti. Il leaderdi ogni gruppo pubblicherà un documento con tutte le risposte alle domanderaccolte nel suo gruppo, e quindi ogni studente dovrà aggiornare il proprioprofilo in base ai feedback dei docenti. Al termine di questa attività gli verràsomministrato un test di autovalutazione, che chiarirà loro, in previsione del-l’esame finale, quali sono i punti cruciali da avere ben consolidati. Tale testconsisterà nell’analisi di file musicali da un punto di vista psicoacustico.
4.6 Quarto step: linguaggio CSound
Gli studenti lavoreranno in gruppo. Questa è la tappa di laboratorio.

16 CAPITOLO 4. PROCESSO DI APPRENDIMENTO
Scopo attività
L’obiettivo didattico sarà quello di far apprendere agli studenti un software dielaborazione del suono in linguaggio C. Per far ciò si sottoporrà agli studentiuna sceneggiatura di un breve cortometraggio sotto forma di storyboard. Glistudenti dovranno (mettendo in pratica le competenze acquisite negli stepprecenti e unendole allo studio del software di gestione ed elaborazione delsuono CSound) crearne la colonna sonora. Questa metodologia avrà lo sco-po di sviluppare nello studente la capacità di presentare dettagliatamente unprogetto multimediale, evidenziandone caratteristiche e funzionalità
Sarà inoltre il momento di sintesi del corso, ove tutte le competenze ac-quisite convergeranno verso un unico e organico obiettivo.
Le fasi del processo di apprendimento
1. Il processo di apprendimento avviene tramite la creazione di un pro-getto condiviso su GoogleWave che consiste nella realizzazione di unasemplice colonna sonora, della durata di alcuni minuti, per una ipoteti-ca trama di un breve cortometraggio utilizzando il linguaggio di sintesisonora CSound.
2. La realizzazione di questo progetto consiste nella scrittura di due !le ditesto rispettivamente per indicare la partitura, intesa come note musi-cali da suonare(MonoDevelop), e per speci!care gli strumenti in termi-ni di suono da far ascoltare(Audacity).
3. Dovranno essere argomentate (sulla base delle conoscenze acquisite intutti gli step del corso) le soluzioni e le scelte tecniche effettuate.
4. L’esame in presenza verterà appunto sulle soluzioni scelte dagli studentiper procedere nella stesura della loro colonna sonora.
Conclusione attività
I vari gruppi sceglieranno le loro soluzioni e procederanno alla stesura dellacolonna sonora. I dubbi tecnici ma anche “espressivi” verranno raccolti dalreferente che li sottoporrà al docente. Verrà svolta una Sessione Live ove ildocente sottolineerà i punti critici dello storyboard proposto e chiederà comesiano stati affrontati dai vari gruppi. I leader poi potranno porre i loro quesiti(di interesse comune visto che tutti avranno la stessa sceneggiatura da curare)e stileranno alla !ne un documento di sintesi fruibile da tutti.
Gli studenti potranno accedere a tutte le differenti “sintesi” che verran-no pubblicate e trovare cos“i le soluzioni ai problemi che avevano incontrato

4.6. QUARTO STEP: LINGUAGGIO CSOUND 17
tramite la tecnica della peer review. I referenti potranno infatti confrontarei loro elaborati con quelli dei colleghi per capire loro stessi se le conclusionicui saranno giunti saranno state effettivamente quelle corrette. Come anchenegli altri step del corso, possibili dubbi, se non affrontati nella documenta-zione elaborata fino a quel momento, potranno essere direttamente postati aldocente sul forum.